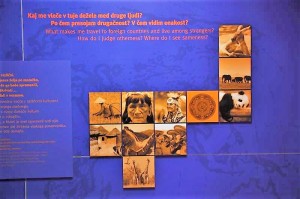di Dario Inglese
Sono appena entrato al Museo Etnografico di Slovenia (Slovenski Etnografski Muzej) a Lubiana, la capitale. È uno spazio nuovo e ben curato nel cuore del quartiere Metelkova, una vecchia area militare, riconvertita in polo artistico-culturale, da un collettivo di squatter prima e dal neonato governo sloveno poi, dopo la guerra dei dieci giorni del 1991 e la successiva indipendenza del Paese dalla Jugoslavia. È uno spazio molto curato, dicevo, organizzato su tre livelli: due piani (il terzo e il secondo) destinati alle esibizioni permanenti, uno (il piano terra) alle mostre temporanee. Motivo per cui, in biglietteria, un’impiegata un po’ annoiata mi raccomanda distrattamente di pianificare una visita “dall’alto in basso”. Accetto il consiglio.
Il lento ascensore dell’edificio mi accompagna all’ultimo piano. Ad accogliermi trovo una scolaresca seduta per terra ad ascoltare chissà quali meraviglie e un passo del celeberrimo manifesto relativista di Michel de Montaigne sui cannibali [1] stampato su una vetrata. Sono ufficialmente all’interno dello spazio espositivo e con la prima permanente, Med naravo in kulturo (Between Nature and Culture), posso partire per una classica escursione etnografica intorno al mondo: Oceania, Asia, Africa, America, Europa, più inevitabile focus sulla Slovenia. Un viaggio un po’ straniante, devo ammettere. Non ho acquistato l’audio-guida, confidando nelle didascalie che accompagnano i reperti esposti, ma evidentemente ho fatto male i miei calcoli. Non tutto è tradotto e buona parte della visita mi trasmette quella sensazione, a metà tra incolmabile distanza e sprazzi di familiarità, propria di ogni percorso etnologico. Giro, osservo e registro, pertanto, col persistente dubbio di non afferrare completamente ciò che mi circonda.
Lo stesso ascensore mi porta adesso al secondo livello. È uno spostamento di pochi metri ma l’atmosfera cambia radicalmente. La seconda mostra permanente, Jaz, mi in drugi: podobe mejega sveta (I, We and Others: Images of My World), infatti, si presenta come un curioso ibrido tra collezione etnografica e installazione artistica, articolato in sette momenti, che ha come oggetto l’essere umano e il suo stare al mondo. Si parte dall’individuo, inscindibile unione genetico-culturale, passando per i diversi noi che esso abita e incontra durante la sua esistenza (famiglia, comunità, nazione, alterità), per arrivare (tornare) al sé, il frutto delle esperienze e delle molteplici identità che ognuno sperimenta nel corso della vita. Il pannello introduttivo, fortunatamente tradotto in inglese, recita:
«I, we and others: Images of my World is an exhibition dedicated to man and his place in the world. […] It offers a breathing space among everyday obligations and a chance to contemplate yourself and others, to reflect on the world and the life that we lead. […] We do not offer simple solutions: this is a space in which to ask questions and seek your own answers […]. For is this not also a way of belonging?».
La curiosità è alta e la prima sala – quella in cui si riflette su geni e DNA in rapporto alla cultura – non tradisce le attese. La semi-oscurità del luogo è parzialmente spezzata da calde luci azzurre che convergono su una silhouette stilizzata (ma facilmente identificabile nel David di Michelangelo) circondata da decine di piccoli specchi. Dal gioco di rifrazioni che, contemporaneamente, partono da e puntano al modello, emergono due domande: Kdo sem jaz? (Who am I?); Kaj sem jaz? (What am I?). Ho appena il tempo di provare ad abbozzare una risposta che la mia attenzione è catturata da ciò che riposa ai piedi della sagoma. All’interno di una cesta si trovano centinaia di semi e quella che, a prima vista, sembra una targhetta da mercato ortofrutticolo. Solo che l’etichetta non riporta il nome del prodotto né il relativo prezzo bensì un altro quesito: kako vsako seme ve, v kaj naj zraste? (How does a seed know into what it must grow?). Che i curatori abbiano voluto stabilire un legame necessario tra disegno genotipico e modi di essere umani? Non saprei. Ho come l’impressione, però, che la metafora del chicco sia meno trasparente di quanto possa inizialmente sembrare; questa ennesima domanda inevasa, infatti, instilla più di qualche dubbio. In fondo, riflettendoci, il seme non produrrebbe nulla senza il terreno; affermare che in esso, e solo in esso, risieda l’informazione del frutto generato è solo una ricostruzione a posteriori che si concentra su un elemento anziché su una rete di relazioni. D’altra parte, ed ecco probabilmente il senso degli specchi che circondano il David, l’uomo nasce in un ambiente segnato da relazioni e lo abita insieme ai suoi simili e agli altri viventi; quanto è scritto nel suo corredo genetico non si manifesta in astratto e non sarebbe leggibile senza il suo essere nel mondo. Si può dunque dare l’uomo senza l’ambiente? Che tipo di relazione li lega? E cosa significa appartenere? Ancora tante domande.
L’esibizione – gli organizzatori sono stati chiari – non dà risposte: le sale in cui mi muovo non dispiegano una teoria di reperti da osservare ma una lista di problemi affrontati attraverso il rimando a oggetti, fotografie, pagine di diari, effetti video-sonori e installazioni artistiche che trascendono ogni legame con una tradizione etnografica specifica e sono anzi liberamente ispirati alla traiettoria biografico-letteraria del poeta Jože Dular. La mostra, però, fa ciò che un’impresa intellettuale dovrebbe sempre fare: spingere a cercare. Mentre attraverso gli spazi che si aprono davanti ai miei occhi, non riesco a non pensare alla stridente differenza tra questa esposizione e la precedente. È come se con essa il museo abbia cercato di aprirsi all’esterno sforzandosi di abbattere quelle pareti che, una volta varcate, trasformano gli oggetti esposti in qualcosa di inevitabilmente altro rispetto a ciò che essi rappresentavano fuori.
 Penso a Tim Ingold. Nei suoi termini, la prima mostra potrebbe essere definita – e, di fatto, lo è – “etnografica”: promette la conoscenza di qualcuno (o qualcosa) assegnando al visitatore un ruolo ricettivo; quel che c’è da sapere è lì pronto per essere travasato nella sua testa. La seconda performance, invece, è “antropologica” nel senso pieno del termine: uno studio con qualcuno (o qualcosa) in cui il visitatore partecipa attivamente alla generazione della conoscenza seguendo, e allo stesso tempo attivando, percorsi, suggestioni, vicoli ciechi. D’altra parte l’antropologia, per come la concepisce Ingold, è un’anti-disciplina che rifiuta la frattura tra conoscenza ed essere postulata dai procedimenti oggettivanti della scienza classicamente intesa. Mentre quest’ultima riposa nell’illusione paradossale di giungere alla verità astraendo i suoi oggetti dalla relazione costitutiva col mondo, l’antropologia trae invece la sua forza proprio dal riconoscimento del coinvolgimento pratico del suo oggetto – l’uomo – col mondo.
Penso a Tim Ingold. Nei suoi termini, la prima mostra potrebbe essere definita – e, di fatto, lo è – “etnografica”: promette la conoscenza di qualcuno (o qualcosa) assegnando al visitatore un ruolo ricettivo; quel che c’è da sapere è lì pronto per essere travasato nella sua testa. La seconda performance, invece, è “antropologica” nel senso pieno del termine: uno studio con qualcuno (o qualcosa) in cui il visitatore partecipa attivamente alla generazione della conoscenza seguendo, e allo stesso tempo attivando, percorsi, suggestioni, vicoli ciechi. D’altra parte l’antropologia, per come la concepisce Ingold, è un’anti-disciplina che rifiuta la frattura tra conoscenza ed essere postulata dai procedimenti oggettivanti della scienza classicamente intesa. Mentre quest’ultima riposa nell’illusione paradossale di giungere alla verità astraendo i suoi oggetti dalla relazione costitutiva col mondo, l’antropologia trae invece la sua forza proprio dal riconoscimento del coinvolgimento pratico del suo oggetto – l’uomo – col mondo.
«Coinvolgimento pratico dell’uomo col mondo». Resto col pensiero a Tim Ingold, al modo in cui sta trattando, uno dei pochissimi oggi in antropologia culturale, molti dei temi oggetto della mostra: il rapporto tra natura e cultura, la relazione tra uomo e ambiente, l’interdisciplinarietà come cifra stilistica della ricerca. Come i curatori di questa esibizione, infatti, lo studioso britannico sta cercando di eludere gli angusti spazi dell’etnografia per riflettere globalmente, in un periodo storico in cui i grandi affreschi teorici non vanno più di moda, su quello strano animale che è l’uomo. Estraneo a buona parte dell’agenda disciplinare odierna, egli sta guardando altrove: alla necessità di riunire la parte socio-culturale e quella fisica dell’antropologia in nome di una nuova sintesi “ecologica” che non frazioni l’essere umano in comparti distinti e, seguendone i modi di fare comunità ed entrare in relazione con l’ambiente, sia pronta ad affrontare le sfide della contemporaneità. Dialogando con la filosofia, la biologia, le neuroscienze, la psicologia, l’arte, l’architettura e l’archeologia, sta lavorando a un’antropologia che tenga insieme conoscenza e immaginazione in vista di un’azione responsabile e autenticamente politica. Sebbene Ingold non compaia tra i riferimenti della mostra, adesso i suoi scritti mi accompagnano, come una specie di audio-guida, un illuminante corrimano durante il percorso museale. Sarà bene lasciar loro un po’ di spazio.
La proposta dello studioso britannico origina da una rivendicazione eterodossa nel campo delle scienze umane: l’antropologia, in quanto scienza dell’uomo vivente, anche nella sua declinazione sociale o culturale, rientra pienamente nell’ambito della biologia. Ciò, si badi, non implica alcuna concessione alle tesi sociobiologiche. Vuol dire, al contrario, incorporare la vita sociale in una teoria dell’evoluzione: concentrarsi sugli organismi e sui processi di vita nell’ambiente riconoscendo nell’uomo il risultato in perenne divenire dell’azione congiunta di ciò che per comodità (e pigrizia intellettuale) si tende a distinguere quando si parla di natura e cultura (Ingold 2001: 81). A tal fine, Ingold rifiuta la «formidabile alleanza intellettuale tra i paradigmi teoretici del neodarwinismo in biologia, della scienza cognitiva in psicologia, e della teoria della “cultura” in antropologia» (Ingold 2001: 52). Questi tre approcci si basano sull’idea che gli esseri umani siano l’esito di una giustapposizione di parti disgiunte in cui «le forme organiche, le capacità intellettuali e le disposizioni comportamentali […] sono specificate e determinate indipendentemente e prima del loro coinvolgimento nei contesti pratici dell’attività» (ivi: 58-59).
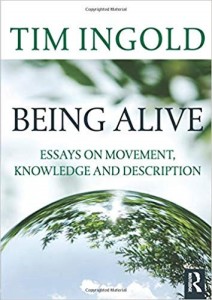 Secondo questa prospettiva (definita tesi della complementarità), corpo, mente e cultura sono solo la realizzazione di programmi preesistenti al divenire ontogenetico degli individui concreti. Il neodarwinismo, distinguendo genotipo e fenotipo, assegna al primo il ruolo di modello formale (che possiede da sé le informazioni essenziali per lo sviluppo dell’organismo) e declassa il secondo a mera espressione adattativa (ivi: 53); la psicologia cognitiva, da parte sua, immagina che prima di qualunque trasmissione d’informazione esistano meccanismi mentali innati – il language acquisition device (LAD) postulato dalla linguistica generativa, ad esempio (ivi: 55) –; la teoria antropologica, infine, concepisce la cultura «come un corpus di conoscenze che può essere trasmesso di generazione in generazione indipendentemente dalle situazioni della loro applicazione pratica e concreta» (ivi: 56).
Secondo questa prospettiva (definita tesi della complementarità), corpo, mente e cultura sono solo la realizzazione di programmi preesistenti al divenire ontogenetico degli individui concreti. Il neodarwinismo, distinguendo genotipo e fenotipo, assegna al primo il ruolo di modello formale (che possiede da sé le informazioni essenziali per lo sviluppo dell’organismo) e declassa il secondo a mera espressione adattativa (ivi: 53); la psicologia cognitiva, da parte sua, immagina che prima di qualunque trasmissione d’informazione esistano meccanismi mentali innati – il language acquisition device (LAD) postulato dalla linguistica generativa, ad esempio (ivi: 55) –; la teoria antropologica, infine, concepisce la cultura «come un corpus di conoscenze che può essere trasmesso di generazione in generazione indipendentemente dalle situazioni della loro applicazione pratica e concreta» (ivi: 56).
Questa potentissima tripartizione – figlia di una mai superata postura cartesiana – facilita indebite scivolate riduzioniste rafforzando la tendenza ad attribuire, secondo il bisogno, solo ai geni (sociobiologia) o solo alla cultura (culturalismo) ciò che invece emerge nell’inestricabile legame di questi elementi. In questo gioco – spiega Ingold – chi ha più da perdere è proprio l’antropologia: fuggendo il confronto, la disciplina rischia di far da cassa di risonanza a discorsi non suoi condannandosi alla marginalità. Anche se gli antropologi culturali si disinteressano di questioni fisiche, infatti, l’analogia del loro pensiero (soprattutto quello di matrice cognitivista) con l’ortodossia neodarwinista è evidente: gli antropologi possono anche condannare fermamente le invasioni di campo di biologi e sociobiologi (con il loro bagaglio deterministico fatto di memi e culturgen [2]) ma continuando a parlare di cultura come di un programma astrattamente tramandato si collocano, in fondo, sulla stessa lunghezza d’onda (ivi: 57).
Anche l’antropologia interpretativa, d’altra parte, non è esente da critiche. Clifford Geertz, ad esempio, cade in una fallacia analoga, accettando passivamente la tesi della complementarità, quando scrive che «noi tutti cominciamo con l’equipaggiamento naturale per vivere mille tipi di vita ma finiamo con l’averne vissuta una sola» (Geertz 1988:73). Postulando, infatti, una meccanica transizione dalla biologia alla socialità, come se il neonato umano fosse un vaso vuoto da riempire progressivamente di cultura, riafferma una teoria dello sviluppo che ignora l’ambiente e i modi in cui gli esseri umani, entrando in rapporto con esso e interagendo tra loro, si formano e apprendono. La cultura non è un ingrediente segreto aggiunto alla natura e l’uomo non nasce organismo per farsi poi persona (Ingold 2001: 81 sgg.).
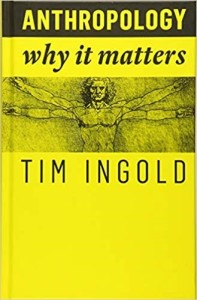 Ogni neonato viene al mondo situato in un “campo totale generativo” di relazioni (che solo a posteriori e per comodità euristica possiamo segmentare in naturali o sociali) e introietta progressivamente tale sistema di relazioni nelle strutture della sua coscienza diventando un soggetto dotato di propria identità (ivi: 100). La socialità, fatta di connessioni tra le parti, è già costitutiva della dimensione biologica [3] (intesa come dialettica tra ambiente e organismo che produce entità discrete) e persona fa rima, in tutto e per tutto, con organismo (ibidem). Secondo questa prospettiva, uomo e ambiente formano un accoppiamento strutturale all’interno del «campo morfogenetico [4]» che li vede co-implicati. Essi sono la risultante della continua generazione della forma nel mondo: «un campo che si dispiega (unfolds) nelle storie di vita degli organismi e che essi introflettono (enfold) […] nelle loro specifiche morfologie, capacità di movimento, di coscienza e di risonanza» (Ingold 2001: 79). Gli esseri umani, allora, non sono intelligibili se non cogliendoli nei modi vari (e storicamente determinati) di essere umani: forme e abilità, infatti, non sono attribuibili all’eredità genetica o a un’astratta trasmissione culturale bensì «alle potenzialità generative del sistema evolutivo, cioè dell’intero sistema di relazioni costituito dalla presenza dell’organismo, compresi i suoi geni, in un particolare ambiente» (ivi: 62). Non vi sono, in ultima analisi, genotipi, schemi cognitivi, tratti culturali e significati preesistenti a un tale “campo morfogenetico di relazioni”.
Ogni neonato viene al mondo situato in un “campo totale generativo” di relazioni (che solo a posteriori e per comodità euristica possiamo segmentare in naturali o sociali) e introietta progressivamente tale sistema di relazioni nelle strutture della sua coscienza diventando un soggetto dotato di propria identità (ivi: 100). La socialità, fatta di connessioni tra le parti, è già costitutiva della dimensione biologica [3] (intesa come dialettica tra ambiente e organismo che produce entità discrete) e persona fa rima, in tutto e per tutto, con organismo (ibidem). Secondo questa prospettiva, uomo e ambiente formano un accoppiamento strutturale all’interno del «campo morfogenetico [4]» che li vede co-implicati. Essi sono la risultante della continua generazione della forma nel mondo: «un campo che si dispiega (unfolds) nelle storie di vita degli organismi e che essi introflettono (enfold) […] nelle loro specifiche morfologie, capacità di movimento, di coscienza e di risonanza» (Ingold 2001: 79). Gli esseri umani, allora, non sono intelligibili se non cogliendoli nei modi vari (e storicamente determinati) di essere umani: forme e abilità, infatti, non sono attribuibili all’eredità genetica o a un’astratta trasmissione culturale bensì «alle potenzialità generative del sistema evolutivo, cioè dell’intero sistema di relazioni costituito dalla presenza dell’organismo, compresi i suoi geni, in un particolare ambiente» (ivi: 62). Non vi sono, in ultima analisi, genotipi, schemi cognitivi, tratti culturali e significati preesistenti a un tale “campo morfogenetico di relazioni”.
Sbarazzandosi del concetto di programma (genetico, cognitivo o culturale che sia), Ingold si rivolge alla biologia dello sviluppo, alla psicologia ecologica e alla teoria antropologica della pratica per articolare una contro-sintesi in grado di superare la distinzione tra corpo mente e cultura e, soprattutto, di non separare indebitamente l’uomo dalla sua relazione costitutiva con l’ambiente. È all’interno di questa rete, infatti, che l’organismo-persona è (ovvero diviene) e che le abilità (skills) si sviluppano:
«gli esseri umani, come gli altri animali, conoscono il mondo direttamente, muovendosi nell’ambiente e scoprendo quali attività esso possa concretamente accogliere, non rappresentandoselo nella mente. Perciò il significato non è la forma che la mente impone, attraverso schemi innati o acquisiti, al flusso dei “meri” dati sensibili, ma è piuttosto continuamente generato nei contesti relazionali del coinvolgimento pratico della gente nel mondo circostante» (ivi: 69-70).
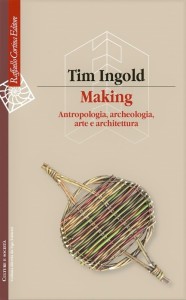 Da questo punto di vista, forme, conoscenze e tecniche non sono mai disgiunte dall’essere nel mondo ma originano nella pratica attraverso processi d’incorporazione. Come il fenotipo non è la mera espressione adattativa dell’informazione genotipica, bensì il risultato mai ultimato della co-implicazione tra geni ed ecosistema; come, ad esempio, non può darsi un bipedismo preesistente prima che il bambino impari concretamente a camminare, giacché non esiste il terreno in astratto; così nessun apprendista acquisisce in anticipo regole da applicare meccanicamente nella vita quotidiana ma, crescendo in uno spazio ontologicamente segnato da relazioni, impara a sintonizzarsi su ciò che l’ambiente consente entrando gradualmente (in un processo che dura tutta una vita) in risonanza con esso (ivi: 73).
Da questo punto di vista, forme, conoscenze e tecniche non sono mai disgiunte dall’essere nel mondo ma originano nella pratica attraverso processi d’incorporazione. Come il fenotipo non è la mera espressione adattativa dell’informazione genotipica, bensì il risultato mai ultimato della co-implicazione tra geni ed ecosistema; come, ad esempio, non può darsi un bipedismo preesistente prima che il bambino impari concretamente a camminare, giacché non esiste il terreno in astratto; così nessun apprendista acquisisce in anticipo regole da applicare meccanicamente nella vita quotidiana ma, crescendo in uno spazio ontologicamente segnato da relazioni, impara a sintonizzarsi su ciò che l’ambiente consente entrando gradualmente (in un processo che dura tutta una vita) in risonanza con esso (ivi: 73).
L’articolata impalcatura eretta da Ingold (la cui complessità meriterebbe ben altro approfondimento), quella che lo stesso autore ha definito “dwelling perspective” (prospettiva dell’abitare) [5], ha ricadute molto interessanti sul fare antropologia. Sebbene Ingold, come recentemente evidenziato in un denso contributo di Roberto Malighetti e Angela Molinari (2016: 220 sgg.), non affronti analiticamente la questione, la sua insistenza sul coinvolgimento pratico e sulle abilità incorporate dice molto sulle vie di accesso interpretativo agli universi altri. Getta luce altresì, sulla particolare posizione disciplinare di Ingold e sulla sua decisa presa di posizione, pur nella celebrazione del lavoro di terreno, contro l’appiattimento dell’antropologia sull’etnografia.
Andiamo con ordine. Da quanto sostenuto pocanzi, per lo studioso britannico la variabilità culturale risiede nella differenza di abilità generata dalle diverse relazioni che i gruppi umani intrattengono con l’ambiente durante il processo di sviluppo e apprendimento. In ogni società, scrive Ingold, «l’apprendista o novizio […] non acquisisce “cultura”, come se questa potesse essere semplicemente scaricata nella sua testa da una fonte superiore come la società, ma piuttosto s’imbarca nel processo che l’antropologa Jean Lave ha chiamato comprensione nella pratica» (2001: 75-76). Perché due persone con differenti background poste nella stessa situazione si comporteranno in modo diverso? Perché, sostiene Ingold,
«sono state addestrate a orientarsi in relazione all’ambiente e a prestare attenzione alle sue caratteristiche in modi diversi, attraverso esperienze precedenti e attraverso la risoluzione di diversi compiti che comportano specifici movimenti e sensibilità del corpo. La differenza, in altre parole, non sta nel modo in cui la gente si rappresenta l’ambiente nella propria testa, ma nei modi in cui scopre ciò che l’ambiente permette o acconsente (afford) ai fini delle proprie attività » (ivi: 73).
Se così stanno le cose, allora, l’antropologo desideroso di accedere ai mondi nativi non dovrà far altro che “immergersi”, letteralmente, in un’opera di apprendistato/formazione proprio come fanno gli indigeni (tutti gli uomini, cioè) che, di generazione in generazione, imparano a diventare membri normali di un determinato gruppo. Così facendo egli, esattamente come un bambino, imparerà a sintonizzarsi sui significati locali secondo quella che Malighetti e Molinari definiscono efficacemente (ma con una terminologia che l’antropologo britannico credo non apprezzerebbe) “etnografia dell’abitare” (Malighetti, Molinari 2016: 232). Il primato logo-centrico sancito dalla contemporanea riflessione antropologica, a questo punto, è completamente svuotato di senso. I significati nativi, infatti, non andranno rintracciati nella testa delle persone (antropologia cognitiva), non andranno letti pubblicamente arrampicandosi sulle spalle dei nativi (antropologia interpretativa), né saranno il frutto di negoziazioni dialogiche tra ricercatore e informatore (antropologia postmoderna). Essi, al contrario, emergeranno dal progressivo coinvolgimento dell’antropologo nello spazio morfogenetico in cui si trova a studiare. Da ciò si evince il grande vantaggio che l’antropologia ha rispetto alle altre discipline che studiano l’uomo: vivere a stretto contatto con altri esseri umani permette agli antropologi di non dover applicare meccanicamente metodologie utili a raccogliere dati qualitativi, bensì, secondo ciò che Gregory Bateson amava definire “deutero-apprendimento”, di dover semplicemente “imparare a imparare” (Ingold 2019: 14).
Apprendere è dunque un modo di appartenere (cfr. Malighetti, Molinari 2016: 232). Qui, in fin dei conti, riposa il valore dell’impresa antropologica: un apprendimento così concepito «non consiste tanto nel fornire fatti sul mondo, quanto nel permetterci di essere istruiti da esso» (Ingold 2019: 14). L’atto di apprendere, infatti, non mira tanto a documentare quanto a formare e ad agire responsabilmente: affinare, cioè, quel potenziale trasformativo che risiede nell’incontro tra la conoscenza delle varie possibilità di essere al mondo e l’immaginazione di tali possibilità in vista di una vita migliore per tutti gli esseri viventi nell’unico mondo che c’è dato abitare. Ecco perché, pur dichiarandosi convinto sostenitore della ricerca di campo, Ingold rifiuta l’equivalenza tra antropologia ed etnografia e l’uso di riferirsi alla seconda come fosse la metodologia per eccellenza della prima. L’antropologia, dal suo punto di vista, è studio con per apprendere da; l’etnografia, al contrario, è studio di per imparare qualcosa su. Facendo antropologia, pur partendo inevitabilmente dalle esperienze fatte, si guarda avanti speculando, a stretto contatto col mondo, sulle condizioni e le possibilità della vita degli uomini; facendo etnografia, invece, si guarda indietro, alle informazioni raccolte, ordinandole nel modo più coerente possibile per produrre un resoconto fruibile e circoscritto che abbia finalità documentativa [6] (ibidem).
Queste argomentazioni aprono spazi di riflessione epistemologica enormi. In primo luogo, come chiarisce lo stesso Ingold, la sua distinzione tra antropologia ed etnografia non intende evocare in alcun modo l’annosa separazione tra lavoro empirico e lavoro teorico. Nel suo ragionamento, infatti, non v’è alcuna nostalgia per bipartizioni vetero-positiviste tra mera raccolta di dati (etnografia) e successiva rielaborazione comparativa (antropologia). Il fatto è che l’etnografia non è un metodo, né tantomeno il metodo dell’antropologia, ma una disciplina a sé con le proprie finalità: quelli che i suoi praticanti raccolgono, per quanto utili (anche) per l’antropologia, non sono dati grezzi da trattare in separata sede ma materiali già filtrati dalla teoria (ivi: 19). La discriminante, insiste Ingold, è sempre il fine: l’etnografia documenta, l’antropologia trasforma.
In secondo luogo, se l’antropologia ha una metodologia, questa va rintracciata nella tanto bistrattata osservazione partecipante, «una pratica antropologica, non etnografica» (ibidem). Il senso che Ingold dà a questa formula si allontana una volta in più dalla vulgata disciplinare:
«l’osservazione partecipante non è assolutamente una tecnica di raccolta dei dati. Proprio al contrario, essa è consacrata a un impegno ontologico che rende impensabile l’idea stessa di raccolta dei dati. Questo impegno […] consiste nel prendere atto che dobbiamo la nostra stessa esistenza al mondo che cerchiamo di comprendere. In poche parole, l’osservazione partecipante è una modalità di conoscenza dall’interno» (ivi: 20).
L’antropologia, studiando nel mondo per cogliere ciò che esso ha da insegnare, supera l’artificiale distinzione tra conoscenza ed essere che informa le altre scienze (etnografia, con le sue procedure descrittive e oggettivanti, compresa). Quando queste trasformano, astraendoli, gli oggetti del mondo in input, infatti, restituiscono l’immagine di una conoscenza imposta dall’esterno da un soggetto, lo scienziato/l’uomo, che si pone arbitrariamente fuori dal mondo. In realtà, vivendo in mezzo agli uomini e studiando con loro, l’antropologia ha il potenziale rivoluzionario di sintonizzarsi sul flusso dell’esistenza: la conoscenza, così concepita, è «inerente alle abilità percettive e alla capacità di giudizio che si sviluppano nel corso di un coinvolgimento diretto, pratico e sensoriale con ciò che ci circonda» (ivi: 21). Ciò, secondo Ingold, toglie di mezzo anche il falso paradosso dell’osservazione partecipante: non v’è alcuna contraddizione tra osservare e partecipare perché apprendere, contemporaneamente guardando e facendo, è il modo che gli apprendisti (gli uomini) hanno per entrare in risonanza con i loro simili e con l’ambiente (ivi: 20). Tra antropologia e vita, allora, non c’è soluzione di continuità: entrambe sono questione di apprendimento o, con le parole di James Gibson (1999), di «educazione all’attenzione».
In ultima istanza, l’allontanamento dall’etnografia e il superamento, in nome dell’osservazione partecipante, della distinzione tra raccolta dei dati e successiva elaborazione teorica, renderebbero non pertinente il problema della rappresentazione in antropologia. Liberata dall’etnografia, l’antropologia
«non sarebbe più vincolata all’impegno retrospettivo verso la fedeltà descrittiva. Al contrario, essa sarebbe libera di portare modi di conoscere e sentire formati tramite incontri trasformativi con gente di diverse parti del mondo sia negli ambienti della ricerca sul campo sia al di fuori di essi, a sostegno del compito essenzialmente prospettivo – non retrospettivo – di contribuire a trovare una strada verso un futuro che sia comune a tutti noi » (ivi: 22).
Mentre il fine dell’antropologia, sostiene Ingold, è l’educazione ad altre possibilità di essere nel mondo, l’obiettivo dell’etnografia è de-scrivere (Ingold 2011: 238). Mentre l’antropologia è radicata nella ricerca di una corrispondenza tra ricercatore e nativo che prescinda dalla circoscrizione di un campo chiuso perché interessata alla comprensione dell’essere umano nell’unico mondo che c’è dato abitare (ivi: 241-242), l’etnografia non può fare a meno di «immaginare il mondo come un campo» cui arrivare e da cui andar via e, di conseguenza, di dividere arbitrariamente il momento dell’osservazione da quello della descrizione (ibidem). In sintesi: la co-implicazione desiderata dall’antropologo rende l’antropologia più simile alla pratica dell’arte e dell’artigianato che alla scrittura e le sue rappresentazioni più simili a dipinti e disegni («corrispondenze non descrittive» che non si staccano mai dal divenire osservato); la descrizione agognata dall’etnografo, invece, lo obbliga a un pendolo continuo tra campo e scrivania e alla necessità di riposizionare se stesso, attraverso la scrittura («descrizione non corrispondente»), una volta tornato a casa (ibidem).
L’antropologia può dunque colmare un grande vuoto: aggiungere alla conoscenza una buona dose di sapienza muovendosi sensibilmente sul crinale tra esperienza e immaginazione. Ecco perché è un sapere così importante. Che cosa farà allora un antropologo che non praticherà etnografia? Di sicuro – scrive Ingold – non dovrà costruire generalizzazioni partendo dalle descrizioni etnografiche né tantomeno, come indicato da Dan Sperber, dovrà «rendere conto della variabilità delle culture umane» per mezzo di «dati etnografici» (Ingold 2019: 19). Non dovrà, d’altra parte, autocondannarsi alla marginalità dedicandosi solo all’autistica analisi dei suoi testi, né cedere alla tentazione di trasformare i propri interlocutori in «portavoce inconsapevoli di filosofie della salvezza» nell’illusione che «la saggezza tradizionale delle popolazioni indigene possa in qualche modo salvare il pianeta» (ivi: 22). Dovrà, invece, rivendicare la sua vocazione speculativa facendo filosofia nel mondo, insieme alle persone:
«aprire spazi per un’indagine generosa, aperta, comparativa eppure critica sulle condizioni e sulle possibilità della vita umana […] unirsi ad altri esseri umani nelle loro speculazioni su come la vita potrebbe essere pur rimanendo saldamente ancorati a una comprensione profonda di ciò che essa è in particolari tempi e luoghi» (Ingold 2019: 22).
In ciò, lo accennavo poc’anzi, l’antropologia, più che a una scienza con i suoi procedimenti di oggettivazione, è vicina all’arte e all’artigianato. Antropologi, artigiani e artisti, infatti, lavorano (con) i materiali in un profondo coinvolgimento osservativo, partecipativo e percettivo che permette loro di rispondere attivamente (nel linguaggio di Ingold, di “corrispondere”) alle loro sollecitazioni. Essi, dunque, trattano i materiali per quello che possono di volta in volta fare o non fare e non, come gli scienziati classicamente intesi, per ciò che sono indipendentemente dai contesti d’uso (ivi: 19). In un libretto sull’importanza dell’antropologia ai giorni nostri, non a caso, Ingold chiude la sua appassionata discussione proprio con le parole di un artista, Paul Klee: «art does not reproduce the visible but makes the visible». Proprio come per l’arte, infatti, «it is not for anthropology to hold a mirror to the world. It is rather to enter the relations and processes that give rise to worldly things so as to bring them into the field of our awareness» (2018:129). Tale assunto, dovrebbe essere ormai chiaro, non va considerato solo come un riconoscimento della natura prospettica del conoscere (come un assunto eminentemente epistemologico cioè); va semmai letto in chiave ontologica.
Se il mondo è mondo in divenire; se gli esseri umani sono modi di essere umani; se, dunque, non ci sono unità discrete da scovare ma processi da seguire, ecco che l’antropologia, a discipline in-the-making (ivi: 3), ha un ruolo determinante nel cogliere significati e pratiche. L’antropologia sta proprio qui nel mondo, dove i processi si generano (ivi: 22). Per essa non ci sono campi chiusi – quelli sono indagati legittimamente e ottimamente dall’etnografia – ma un unico mondo con cui riflettere in un gioco dialettico tra esperienza di e immaginazione di forme e possibilità. Ontologia, epistemologia, etica, allora, sono votate all’azione e si saldano in un progetto politico ambizioso ed eretico rispetto al discorso disciplinare contemporaneo.
La visita è finita e adesso sono al sole a gustare un burek in un parco vicino al Museo. Se la mia fosse una comunicazione scientifica ortodossa, adesso dovrei tirare le somme e far notare, magari, come nell’affascinante affresco di Ingold non tutto torni. L’educazione all’attenzione e la risonanza permettono davvero all’antropologo di cogliere il famigerato punto di vista nativo? E nel gioco di sintonizzazioni che ne è delle inevitabili asimmetrie tra antropologi e informatori? Basta presentarsi come umili apprendisti per imparare e appartenere? Per non parlare poi della rappresentazione: siamo sicuri che scaricare il problema sull’etnografia, liberi l’antropologia dal fare i conti con la scrittura? A maggior ragione, mi vien da dire, per un’antropologia «non più vincolata all’impegno retrospettivo verso la fedeltà descrittiva»? Per il momento mi accontento di questa reiterata preterizione in forma interrogativa.
Poco prima dell’uscita dal Museo, nell’ultima sala, ho ritrovato la sagoma del David. Questa volta, però, più piccola e posta all’interno di un mosaico che richiama la familiare sfericità di un pianeta in un sistema solare. No, non possiamo guardare il mondo dall’alto, per quanto nelle nostre analisi ci sforziamo (ci illudiamo) di farlo. Il punto resta uno e ineludibile: il mondo non è un museo in cui ordinare dati trasformandoli in reperti ma uno spazio che possiamo esperire e immaginare solo vivendolo e sporcandoci le mani con gli altri che lo abitano con noi. L’inquietudine dell’antropologia, in fondo, non nasce proprio da questa consapevolezza? E la sua forza non riposa in quest’inquietudine?
Dialoghi Mediterranei, n. 38, luglio 2019
Note
[1] «Ora mi sembra, per tornare al mio discorso, che in quel popolo non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, a quanto me ne hanno riferito, se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi; sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo, l’uso perfetto e compiuto di ogni cosa» (Montaigne 2007: 272).
[2] Il concetto di “meme” è stato avanzato dal biologo Richard Dawkins per instituire un parallelismo tra evoluzione genetica e culturale. Insieme al pacchetto di geni, infatti, ogni individuo riceverebbe dai suoi predecessori un kit d’istruzioni culturali che ne determinerebbero lo sviluppo del comportamento (Dawkins 1992: 198-210). Assimilabile al “meme” è il termine proposto da Edward Wilson (il padre della sociobiologia) e Charles Lumsden: “culturgen” (Ingold 2001: 57-58).
[3] «Per socialità mi riferisco alle proprietà generative del campo relazionale all’interno del quale sono situate le persone. Voglio chiarire nel modo più assoluto che la socialità non è un tratto introdotto estrinsecamente all’interno di un biogramma umano o del suo equivalente culturale […]. Non è una proprietà pre-programmata degli individui, e nemmeno risiede nella forza della collettività opposta alle nature individuali […]. Piuttosto, come ho argomentato altrove, “la socialità è la qualità definitiva delle relazioni” […]» (Ingold 2001: 100).
[4] Ingold riprende il concetto di “campo morfogenetico” dal biologo Brian Goodwin: «un dominio spaziale in cui ciascuna parte è in uno stato che è determinato dallo stato delle parti vicine, in modo che il tutto ha una specifica struttura relazionale» (cit. in Ingold 2001: 91).
[5] Parafrasando Heidegger, Ingold distingue la sua “dwelling perspective” (prospettiva dell’abitare) da ciò che definisce “building perspective” (prospettiva del costruire). Laddove l’idea di abitare mostra come gli organismi siano sempre imbricati (embedded) nell’ecosistema, il concetto di costruire immagina individui separati dall’ambiente. Questa seconda prospettiva, inoltre, vede nell’ambiente un sostrato materiale neutro su cui gli individui esercitano la propria azione partendo da progetti mentali. A tal proposito, rimando alla lettura del saggio Abitare o costruire. Come gli uomini fanno del mondo la loro casa (2001) e, finalmente tradotto in italiano, del volume Making. Antropologia, archeologia, arte, architettura (Raffaello Cortina ed. 2019). Nel primo, negando una cesura netta tra regno della natura e regno della cultura, Ingold attenua la distinzione tra oggetti naturali e manufatti. Nel secondo, invece, propone, tra i vari argomenti, una dotta analisi di alcuni manufatti (dall’amigdala acheuleana ai cesti in vimini, fino ad arrivare alla Cattedrale di Chartres) per smontare l’idea di design imposto sulla materia bruta e mettere in discussione la posizione di chi distingue nettamente tra ideazione e realizzazione di un’opera.
[6] Per chiarire la sua posizione Ingold ricorre a un paragone ispirato ai suoi trascorsi da violoncellista dilettante. Fare antropologia, scrive, è come studiare con il celebre maestro Rostropovic per apprendere i rudimenti dello strumento e, grazie ai suoi insegnamenti, iniziare un proprio percorso di ricerca musicale. Fare etnografia, invece, è come studiare Rostropovic per documentare i segreti della sua arte. La prima pratica è trasformativa; la seconda, benché impatti sulla personalità dello studente, è descrittiva. Beninteso, non si possono stilare classifiche tra le due, si tratta solo di attività con diverse finalità (Ingold 2019: 16-17).
Riferimenti bibliografici
Dawkins R., 1992, Il gene egoista. La parte immortale di ogni essere vivente, Arnoldo Mondadori, Milano (ed. or. 1976).
de Montaigne M. E., 2012, Saggi, Bompiani, Milano (ed. or. 1580).
Geertz C., 1988, Interpretazione di culture, il Mulino, Bologna (ed. or. 1973).
Gibson J. J., 1999, Un approccio ecologico alla percezione visiva, Il Mulino, Bologna (ed. or. 1979).
Ingold T., 2001, Ecologia della cultura, Meltemi, Roma.
Ingold T., 2011, Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, Routledge, Abingdon.
Ingold T., 2018, Anthropology. Why it Matters, Polity Press, Cambridge.
Ingold T., 2019, Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura, Raffaello Cortina Editore, Milano (ed. or. 2013).
Malighetti R., Molinari A., 2016, Il metodo e l’antropologia. Il contributo di una scienza inquieta, Raffaello Cortina Editore, Milano.
__________________________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.
______________________________________________________________