Il volume di Antonello Ricci Sguardi lontani. Fotografia e etnografia della prima metà del Novecento (FrancoAngeli, Milano, 2023) è prima di tutto un contributo all’interno della nostra tradizione di studi, quella italiana, all’area disciplinare specifica e consolidata dell’antropologia visiva. A mio parere il suo rilievo consiste in primo luogo nella saldatura che compie fra oggetti di studio propri alla disciplina in senso globale (la fotografia in Boas, Malinowski, Griaule, Mead e Bateson) ad altri inerenti alla storia etnografica italiana (la fotografia in Loria, Corso e Boccassino).
Ma la saldatura non avviene solo nell’accomunare in una stessa struttura espositiva questa casistica diversa in senso areale e storico. Essa consta anche nel fatto che Ricci fa valere in tutto il suo percorso analitico alcuni attributi propri di quella antropologa “in stile italiano” su cui ha avuto più volte modo di soffermarsi. Si tratta di un posizionamento preciso riguardo ai fondamentali della disciplina che è allo stesso tempo riconosciuto come il nucleo di una eredità scientifica storicamente formata e anche una modalità del tutto attuale e viva di operare nella ricerca [1].
I saggi sulle immagini prodotte da Franz Boas, Bronislaw Malinowski, Marcel Griaule, Margaret Mead e Gregory Bateson si basano in modo stretto e originale su una letteratura densa e ben controllata dall’autore. I saggi su Renato Boccassino, Lamberto Loria e Raffaele Corso, che scandagliano gli inizi dell’esperienza italiana di fotografia etnografica, si raccordano ai primi per il tramite di una identica precisione filologica e per l’impiego in entrambi i casi di un approccio interpretativo uniforme, innervato da apporti teorici rilevanti, come quelli dovuti a Francesco Faceta (1996, 2003, 2006, 2011, 2019).
La questione euristica che sta alla base del volume è quello della conoscenza antropologica oltre la parola, della posizione effettiva della sensorialità – in questo caso della visione – nel sistema cognitivo del ricercatore e di come la disciplina, nel corso del tempo, abbia sviluppato e abbia reso cosciente a sé stessa il significato dell’uso di immagini fotografiche per restituire l’osservazione sul campo.
I tratti fondanti del saggio di Ricci sono: a) una filologia dei primi percorsi di etnografia fotografica; b) il dipanarsi, tramite sei tracce, di una riflessione sulla fotografia come strumento di conoscenza antropologica; c) il confronto fra il ruolo della fotografia nella prima demologia italiana e quello da essa ricoperto nel percorso evolutivo che va da Boas a Malinowski a Griaule e a Bateson e Mead.
Ricci inizia la sua indagine rilevando il carattere fondante attribuito allo sguardo e all’osservazione nello statuto scientifico dell’antropologia e notando che il primo passaggio della giovane antropologia positivista della seconda metà del XIX secolo è stato quello, quasi obbligato, dell’antropometria, passaggio prontamente sperimentato anche in Italia, con le problematiche implicazioni dovute all’assunzione dell’occhio dello scienziato come sguardo egemone.

Fort Rupert, 1894. “Kwakwaka’wakw man”. Foto di Franz Boas. Numero immagine 11549 American Museum of Natural History Library
Immagini e incontri etnografici
È chiaro che a Ricci interessa sondare soprattutto il lascito di una etnografia visiva post-positivista. Lasciati alle spalle i presupposti della immersione oggettivante e frutto diretto di uno sguardo egemonico, si entra nel grande e articolato mondo della fotografia come esperienza di socialità, di collaborazioni e incontri di vita. Già quando seguiamo Franz Boas non possiamo non imbatterci in George Hunt, il suo grande collaboratore nativo, e nella schiera di fotografi professionisti che mediarono tutti i rapporti dell’antropologo tedesco con gli abitanti della costa nord-occidentale dell’America.
Il punto nevralgico del training tecnico di Boas alla fotografia (e la sua dimestichezza con i principi della chimica, della meccanica e dell’ottica) è un altro punto valorizzato da Ricci. Come pure importanti sono i passi che Boas compie in sistematico allontanamento dai canoni e dagli scopi della fotografia antropometrica. C’è una forte attenzione in Ricci per tutti i passaggi sia della formazione fotografica degli antropologi indagati, sia della vita sociale delle fotografie che hanno realizzato. Un aspetto che emerge per la sua originalità e utilità nella disamina complessiva della ricerca sui nativi del nord America occidentale (vedi su Boas e i Bella Coola).
A questo focus se ne lega un altro, quello del rapporto fra la fotografia e le esposizioni e gli allestimenti museali di “quadri di vita” e la circolazione delle immagini per fini di elicitazione di risposte in situazioni di intervista etnografica e di lavoro di campo, come quello svolto a Fort Rupert, isola di Vancouver, da settembre a dicembre del 1894. A Fort Rupert Boas lavora anche col fotografo O. C. Hastings intorno al complesso cerimoniale invernale dei Kwakiutl, affrontando vari problemi tecnici: la difficoltà di fermare il movimento a causa della scarsa sensibilità delle emulsioni e della difficoltà a utilizzare fonti di illuminazione artificiali per il pericolo di incendi. Ragion per cui si allestiscono e si fotografano con la luce diurna cerimonie che altrimenti di svolgerebbero di notte Gli ambiti di ricerca fotografica saranno a conti fatti: a) la cultura materiale; b) i ritratti di tipi fisici; c) le cerimonie. Ricci ci fa notare che fu lo stesso Boas a organizzare delle feste per incontrare e stringere rapporti con i gruppi tribali. Una apple feast fu tenuta e fotografata sulla precisa falsariga di una cerimonia potlatch. Boas approfondisce visivamente il tema delle forme delle performance rituali. Le condizioni in cui avvenne questa inchiesta fotografica sono chiarite da Ira Jacknis: l’assenza di bianchi nei dintorni di Fort Rupert, il ruolo fortemente identitario del potlatch, messo da tempo fuori legge in altre zone, ma non a Fort Rupert, e infine la modalità partecipativa del rapporto di Boas con i Kwakiutl. Lo sguardo boasiano è molto ravvicinato. Le foto che ne risultano mostrano una grande attenzione ad aspetti prossemici e cinesici.
L’analisi delle immagini in Boas si conclude con quelle della spedizione da lui intrapresa ormai settantunenne, nel 1930, di nuovo a Fort Rupert, dove il Nostro filma in 16 mm. un anziano George Hunt che intaglia un totem, una donna che lavora al telaio, una madre che cura un figlio, una danzatrice impegnata in una coreografia rituale.
Ricci osserva che alle fotografie da lui prodotte Boas non riservò alcuna particolare cura di inventario, schedatura, catalogazione e archiviazione. Interessato all’impiego delle immagini come fonti di didattiche, di divulgazione e di supporto all’allestimento museale, Boas fu comunque sensibile a una “popolarizzazione” della ricerca scientifica, anche tramite la circolazione delle immagini che la documentavano, spesso mettendo in stretta relazione scritto e immagine.
Ira Jacknis osserva che per Boas esiste una “insanabile contraddizione” nella natura della fotografia, che ferma un attimo del tempo presente nello scorrere del tempo stesso. Cioè: la fotografia non permette di vedere il passato e di ricostruirlo tramite essa, se non allestendo, a favore della camera, una “ricostruzione”, cioè una messa in scena. Ed è così che Boas ricorre spesso a messe in cena, ad esempio auto-fotografandosi in atteggiamenti e pose Kwakiutl.

Isole Trobriand, 1915-1918. “Canoes – 2 men on canoe showing carved prow”. Malinowski archive, LSE Library, Malinowski 3/4/8.
Fotografia partecipante
Ricci fa cenno a un intenso dibattito svoltosi fra il 1991 e il 1993 nel “Journal of the Anthropological Society of Oxford” sul corpus di 1100 immagini realizzato da Bronislaw Malinowski nelle isole Trobriand. C’è intenzionalità nello sguardo fotografico del grande polacco. Egli riflette sull’impiego della macchina fotografica «di pari passo all’elaborazione del metodo e con la riflessione teorica sulla pratica fotografica».
Ciò significa per Ricci che la messa a punto del metodo della osservazione partecipante è avvenuta misurandosi di continuo con la riflessione sull’impiego della fotografia in essa, come nota Terence Wright (1994: 16), costante che emerge di continuo anche nei suoi Diari di campo. Insomma, l’antropologo polacco usa le immagini anche per rammemorare (e attualizzare) il suo rapporto affettivo con fidanzata e amanti che ha lasciato lontano…
C’era anche un precedente da lui tenuto presente: il lavoro di Diamond Jennes nelle Entrcasteaux negli anni 1911-12, che però aveva realizzato fotografie evoluzionistiche e catalografiche per ottenere un campionario di tipologie somatiche e razziali, caratterizzato da uno straniamento e da una distanza dai luoghi di vita delle persone riprese. Solo tre anni dopo (1914-18) Malinowski realizzava un corpus enormemente diverso, molto più “creativo” e “immersivo”.
«Il lavoro fotografico di Malinowski non fu soltanto un taccuino di appunti visivi (…) ma costituì un imprescindibile sistema di organizzazione per immagini della sua ricerca etnografica. (…) il veicolo mediante il quale (…) impostò e costruì (…) la metodologia della osservazione partecipante (…)».
La fotografia fu utilizzata per porre agli indigeni domande precise sulle azioni o eventi fotografati. «… percorrere con l’occhio un’immagine vuol dire abituarsi all’individuazione, alla selezione, alla distinzione».
Francesco Faeta ha notato «la rilevanza estetico formale della fotografia per veicolare l’importanza del dettaglio e la sua capacità di suscitare emozione e quindi attenzione» c’è qui un riferimento alla nozione di ‘punctum’ proposta da Barthes. C’è una intersezione fra la «pregnanza conoscitiva, qualità estetico-formale, fascinazione» (Faeta 1996: 33). Questa osservazione di Faeta è molto importante, a mio avviso, per definire l’asse interpretativo che Ricci utilizza nel suo lavoro. Egli, anche tramite Faeta, dimostra che è possibile leggere e interpretare la grande vicenda della fotografia etnografica in Boas, Malinowski, Griaule e Bateson-Mead, mettendo a profitto una tradizione di studi, come quella italiana, che coglie e valorizza il nesso: qualità estetica-fascinazione-conoscenza e che si è misurata col neorealismo (filmico e fotografico), come esperienza sia espressiva sia rivelatrice di una certa realtà storica ed etnografica.
In definitiva le immagini di Malinowski più che essere un post-it visivo memoriale di un’esperienza etnografica vissuta sarebbero l’espressione di «un preciso progetto etnografico in chiave visuale». Esso emerge in un intreccio intertestuale (Marano 2007: 57) di piani comunicativi (testo-didascalie-immagini), come sottolineato anche da Wright (1994: 123), malgrado gli errori, le sottovalutazioni e le indecisioni che i Diari testimoniano. Alcune immagini sono ‘iconiche’ e si sono stampate nella memoria profonda della nostra stessa disciplina, come ha notato James Clifford: si guardi la foto n. 34 (a p. 168) di Sguardi lontani, quella dell’antropologo al lavoro nella sua tenda, mentre dall’esterno i nativi lo osservano con curiosità (vedi Clifford 1997: 23-24). Le immagini di Malinowski che corredano il volume propongono la sua come una “camera partecipante”: egli fotografa imbarcato su una canoa fra l’equipaggio, ritrae una canoa cerimoniale in acque basse governata in modo da mostrare la prua decorata, l’alaggio della canoa del capo sulla spiaggia e l’intreccio della vela con fibre di pandano.
![Mission Dakar-Djibouti. Trajet en Abyssinie 1932 - 1933. Région de Gondar. “Entrée de la villa Médicis, Griaule, Lifshitz, Roux, Abba Jérôme, esclave (Dasta), Leiris, enfant, etc... [Portrait de groupe, en extérieur dans un village]”. Paris, Musée du quai Branly - Jacques Chirac, PP0041995.](http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2023/06/41_Griaule_22-535497-300x208.jpg)
Mission Dakar-Djibouti. Trajet en Abyssinie 1932 – 1933. Région de Gondar. “Entrée de la villa Médicis, Griaule, Lifshitz, Roux, Abba Jérôme, esclave (Dasta), Leiris, enfant, etc… [Portrait de groupe, en extérieur dans un village]”. Paris, Musée du quai Branly – Jacques Chirac, PP0041995.
La spedizione etnografica e la sua comunicazione
Marcel Griaule, fra il 1928 e il 1939, ha compiuto sette spedizioni nell’Africa subsahariana, da est a ovest. Il suo viatico formativo era stato la frequentazione dei cicli di lezioni di Marcel Mauss tenute dal 1925, Brevi note di etnografia descrittiva, raccolte poi nel Manuel d’Ethnographie del 1947 (Mauss 2018) dello stesso autore dove si prevede e si disciplina l’uso di fotocamera, cinepresa e audio registratore. «Le fotografie scattate – annota Mauss – non saranno mai troppe a patto che siano accompagnate da didascalie e da indicazioni precise: ora, luogo, distanza» (Mauss 2018: 29). Indicazioni da riportare sia sui film sia sul diario di campo.
Per Griaule la fotografia è la principale forma di documentazione etnografica. Egli nelle sue inchieste di campo ha realizzato più di 20 mila immagini, specializzando e migliorando costantemente il lavoro, affidandolo a fotografi e cineoperatori professionisti. Tuttavia, non ha mai mostrato di accordare alle immagini una autonomia descrittiva: esse erano considerate “documenti allegati” alle schede e agli altri materiali prodotti sul terreno. L’uso è complementare e didascalico, pensato in vista della pubblicazione, per gli allestimenti museali e per le mostre fotografiche. Una collocazione, quella della fotografia, “ambigua e ambivalente” nel contesto scientifico della ricerca. In Griaule a ciò si aggiunge anche la presenza di una dimensione artistica ed espressiva che è importante per definire un approccio peculiare all’etnologia, quello francese, influenzato dal surrealismo, una fusione fra arte e scienza definita da Clifford come “surrealismo etnografico”. Il surrealismo qui è inteso come il “compagno segreto” dell’etnografia. Per Clifford esso si colloca «… nell’estensione delle basi dell’espressione e del senso del XX secolo». I surrealisti di “Documents” ritenevano l’etnografia non un metodo e un sapere, ma piuttosto «una prospettiva rappresentativa e un atteggiamento di messa in posa e di choc culturali» (Clifford 1993: 147).
Griaule pensava che le fotografie fossero strumenti utili per restituire la ricerca in modo “oggettivo” e quindi per avvalorare la veridicità di ciò che si scriveva; quelle che corredano le spedizioni sono una ricca documentazione della cultura africana degli anni ’30 e sono anche testimonianze dello sguardo degli etnografi che mostrano le loro pratiche sul terreno, a fronte però di una totale rimozione della situazione coloniale e restituendo cioè l’alterità culturale in maniera pura e incontaminata. Gli studi di Griaule sui Dogon, verso i quali sviluppa negli anni un atteggiamento sempre più empatico e anti-assimilazionista, confermano questa rimozione. È un processo che pare abbia avuto tratti di esotizzazione e autorappresentazione in chiave “dogonista” (vedi Dio d’acqua e anche il film che Francesco di Dio ha dedicato ai funerali ‘simbolici’ Dogon di Griaule nel 1956 [2]). In ogni caso Griaule anche negli allestimenti fotografici al Musée de l’Homme cancella volutamente tutti i riferimenti visivi alla situazione coloniale.
Le foto di Griaule sono state tutte numerate. Il numero è riportato nel bordo della pellicola, della lastra o del rullo. Poi lo stesso viene annotato nel quaderno di campo. Si tratta di elementi utili per la successiva inventariazione e archiviazione dei materiali. Un procedimento simile lo troviamo in Renato Boccassino per le sue immagini in Uganda, che segue in modo rigoroso gli insegnamenti di Marcel Mauss, di cui aveva seguito i corsi.
Ci sono vari fotografi che collaborano con Griaule come Eric Lutten e Roger Mourlan. Ricci concentra la sua attenzione proprio sulle fotografie di Griaule, come le sue foto aeree e dall’alto sui santuari Dogon, che costituiscono parte importante della sua observation plurielle, basata sulla ripresa fotografica multipla. Le foto furono realizzate per una finalità espositiva, cioè per far rivivere gli oggetti nelle esposizioni fornendo indicazioni al visitatore sui seguenti campi: 1) collocazione originaria; 2) contesto di origine; 3) come l’oggetto era usato; 4) dove era tenuto; 5) se erano oggetti acquistati, documentato il loro contesto di vendita; 6) tecnica della loro costruzione; 7) il saper fare che implicavano (nella costruzione e nell’uso), vale a dire le tecniche artigianali e le tecniche corporali con l’utilizzo di riprese in sequenza.
Dalle parole di Ricci è evidente che il discorso di A.M. Cirese sui metalinguaggi museali e sulla necessità del ripensamento espositivo e comunicativo degli allestimenti italiani (Cirese 1977) abbia trovato nel rinnovamento dell’esposizione del Trocadero del 1933, voluta da Marcel Mauss e da Paul Rivet, un precedente pionieristico di utilizzo in chiave espositiva della fotografia etnografica. Una delle conseguenze di questa apertura fu la sempre più frequente pubblicazione nella stampa non specialistica di resoconti di viaggio arricchiti dalle fotografie etnografiche, destinati a un pubblico indifferenziato, e usate con il permesso e sotto il controllo di Griaule e del Museo. In questo tipo di uso divulgativo, la fotografia etnografica è collocata, nota Ricci, in una coerente linea informativa e narrativa rispetto ai testi, tale da suscitare curiosità, senso di meraviglia, attrazione per l’avventura e i viaggi e infine orgoglio nazionale per i risultati così divulgati dell’attività scientifica.
Qui si colloca una puntualizzazione importante sui rapporti fra etnografia-surrealismo: 1) i surrealisti e gli etnografi sono entrambi fautori del relativismo culturale; 2) entrambi credono in uno sfondo psichico comune a tutta l’umanità; 3) entrambi rifiutano l’idea esotica del viaggio; 4) entrambi sono appassionati di oggetti “primitivi”. In questo senso emerge l’importanza della rivista “Documents” (1929-1930) nel diffondere una nozione antiestetica di “oggetto primitivo”. Il primo resoconto scientifico della Dakar-Gibuti fu pubblicato in un numero monografico della rivista “Minotaure”. Qui si trova un articolo di Michel Leiris che si distingue per l’autonomia espressiva dell’apparato fotografico che lo correda.

Uganda del nord, 1933-1934. “Lutto (cordone ai fianchi)”. Gelatina ai sali d’argento, cm. 9×12. ICCD GFN Archivio fotografico, fondo Boccassino (RBN000037).
Le etnografie italiane alla prova dell’immagine
Cosa cambia nell’approccio di Ricci quando si passa alle etnografie visive italiane del primo Novecento? Qui il suo discorso si connota per un aspetto comparativo che da un lato collega il lavoro di Renato Boccassino a quello di Malinowski e di Griaule, e dall’altro riconosce nel lavoro di Lamberto Loria e di Raffaele Corso un uso della fotografia in vista di finalità patrimonializzanti e classificatorie che a loro volta affondano in una radice comune di esperienze enciclopediche proprie di altre imprese inventariali come quella di Scheurmeier per l’Italia e la Svizzera e di Wagner per la Sardegna (Tiragallo 2018).
Paolo Chiozzi parla di una scuola fiorentina di antropologia visuale comprendente, oltre a Loria, anche O. Beccari, E. Hillyer Giglioli, E. Modigliani, L. Cipriani e P. Mantegazza (Chiozzi 1996) in prospettiva positivista. Importante quindi il “Museo di antropologia e etnologia” di Firenze. Il rapporto fra Lamberto Loria e Raffaele Corso nasce nel 1908 con Avvertenze generali per la raccolta dei documenti etnografici enumerati, cioè un opuscolo per la raccolta dei materiali etnografici destinati alla grande mostra del 1911, ispirato, secondo Ricci, alle Notes and Queries. Il corpus fotografico calabrese, composto da immagini realizzate da R. Corso e G. De Chiara e da altri fotografi professionisti.
Lamberto Loria ha raccolto le immagini per una ricognizione generale sulle specificità culturali della nuova nazione italiana. L’orizzonte della Mostra Etnografica Italiana del cinquantenario dell’Italia unita definisce e delimita le modalità di utilizzo del linguaggio fotografico. Censire, inventariare, schedare catalogare, archiviare gli oggetti etnografici del Paese, porta alla ricorrenza di standard di ripresa e di realizzazione delle immagini. Esse sono frutto di un progetto, di un disegno omologante che se da un lato permette ai singoli raccoglitori reclutati localmente da Loria di affondare la loro presa conoscitiva e di colmare via via le secche dell’imprecisione e della labilità delle informazioni (ed è il caso del giovane Raffaele Corso, apertamente elogiato da Loria per la qualità del suo lavoro etnografico in Calabria), dall’altro lato riporta la documentazione fotografica alla ripetizione, all’iterazione di un unico modello di immagine costantemente ribadito, quello del ritratto: un’immagine frontale di una figura umana o di un artefatto riferito un aspetto della cultura materiale, dell’abbigliamento, più festivo che ordinario, e di altri eventi di carattere religioso.

Seminara (RC), s.d. Artigiano con modello della macchina a spalla per la Varia di Palmi (RC). Fotografia probabilmente raccolta da Raffaele Corso. Archivio fotografico Istituto centrale per il patrimonio immateriale (n.i. 33794).
Un’operazione, quella di Loria e Corso «totalmente collocata nella temperie culturale e scientifica del periodo», con «un interesse conoscitivo per la diversità culturale da parte di una classe agiata (…) nei confronti del popolo, perseguito secondo una sensibilità culturalmente romantica e scientificamente positivista». Come notano Lombardi Satriani e Rossi (1973) le immagini, a onta della ricchezza del corredo di note che accompagna molte di esse, mostrano un interesse rivolto sempre all’oggetto e alla sua funzione, «non all’ambiente nella quale tale oggetto viene studiato (…) i taccuini ci restituiscono sostanzialmente un mondo di cose, non di persone» (Lombardi Satriani, Rossi 1973: 46-47). È ancora al di là da venire, nota Ricci, quella pratica di antropologia “in stile italiano” post-demartiniana «fondata sulla ricerca sul campo e su una interpretazione marxista e gramsciana delle classi subalterne». Purtuttavia in Loria e Corso il metodo è spiccatamente etnografico e l’uso delle immagini è parte integrante di un progetto di ricerca, fatto importante e fondativo.
Consideriamo ora Renato Boccassino, in Uganda dal marzo 1933 al marzo 1934, impegnato nello studio degli Acioli. Ricci mostra notevole acribia nell’analisi delle fonti e dei supporti dei materiali fotografici realizzati sul campo. Si tratta di 600 scatti, di cui solo 18 riguardano strettamente l’antropologia fisica. Gli altri concernono la “cultura materiale”: casa e villaggio; economia; mestieri; economia domestica; mercato; vestiario e ornamento del corpo; armi. Oltre alla cultura materiale ci sono altre serie sulle “età della vita”: matrimonio e levirato; balli e strumenti musicali; religione e magia. Siamo di fronte a un materiale che si distingue sia per l’elevata qualità fotografica, frutto di una evidente cura con cui l’etnografo ha svolto il suo training tecnico e dell’affidabilità degli apparecchi utilizzati, anche se non all’avanguardia della tecnologia.
Inoltre emerge l’alta qualità documentale delle immagini che indicano una forte prossimità e capacità di interazione del ricercatore con i suoi interlocutori: le immagini sono “prese da vicino” e coprono nella successione degli scatti in maniera adeguata anche la dimensione del tempo e della durata. Ricci si sofferma sui materiali e i supporti fotografici e sulle tracce di inventariazione e catalogazione che essi recano, ed è di grande utilità l’attenzione alle risorse tecnologiche a disposizione di Boccassino, fra cui spicca la descrizione precisa del funzionamento dell’esposimetro Bewi “a estinzione”.
Ci sono molte tracce di affiatamento e di intesa fra Boccassino e gli Acioli: sguardi in macchina, richieste di fermare il movimento e di stare in posa. «Boccassino seguiva in maniera dettagliata e meticolosa il procedere di una cerimonia, i gesti e le posture che vi si adottavano, dando luogo a una densa etnografia visiva, seguendo una ‘grammatica’ della ripresa etnografica» (v. Faeta 2003: 121-122). Troviamo nelle immagini perizia tecnica, qualità estetica e compositiva, e inoltre forte consapevolezza metodologica sull’uso dello strumento fotografico.
Ricci vede in Boccassino uno studioso «sdoppiato». In lui esistono due diversi orientamenti, non dialoganti fra loro: «…due ideologie di ricerca e di restituzione dei suoi esiti nelle opere di impostazione storico-religiosa…». Emerge per prima la sua adesione a un indirizzo che vede nel mondo tradizionale africano, in modo «ansioso», ovunque le tracce di un monoteismo originario. Ma sono proprio le fotografie il viatico che consente di ricollocare la sua etnografia a quel livello di eccellenza che le compete, a onta della pesantezza ideologica dell’approccio a cui mostra di aderire. La sua etnografia visiva restituisce quindi un Boccassino “altro”, molto meno vincolato alle dottrine di scuola storico-culturale (padre Schmidt) che invece prevalgono in opere come Etnologia religiosa (1958).
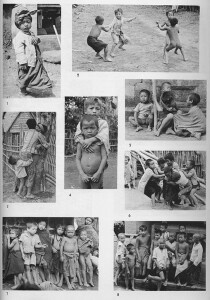
Tavola fotografica tratta da Balinese Character. A photographic Analysis (Bateson, Mead 1942, pp. 86-87).
Liberarsi del treppiede
Il volume di Ricci si chiude con la ricognizione sul lavoro etnografico visivo di Margaret Mead e Gregory Bateson. Un argomento che, a onta della grande attenzione che ha sempre destato nella disciplina, viene qui trattato con esemplare cura filologica e documentaria e con originalità di approccio interpretativo.
Ricci mostra come si siano gettate le fondamenta di una metodologia di fatto nuova e capace di evolversi, a partire dalla consapevolezza finalmente acquisita del problema conoscitivo che si cela intorno e dietro alle immagini, già colto da Bateson prima della esperienza balinese, nella sua celebre etnografia sugli Iatmul in Nuova Guinea: «La collocazione della fotografia in Naven – accompagnata da ampie didascalie, intuendo l’autore probabilmente lo statuto ambiguo della fotografia in bilico fra evidenza e incomunicabilità – lascia intravvedere l’importanza metodologica attribuita al legame dialogico fra scrittura e immagini portato alle estreme conseguenze nel successivo lavoro congiunto con Margaret Mead».
Per la prima volta foto e film furono fatti come «documenti primari della ricerca sul campo». Vedi le interessantissime note di Mead in merito alle circostanze che portarono i due ricercatori a moltiplicare in modo esponenziale (da 2000 a 25 mila!) l’impiego di fotografie nel lavoro sul campo. Balinese character (1942) consta di 759 fotografie. La selezione e la riorganizzazione della serie di immagini è avvenuta «sulla base di ciò che è stato il lavoro di campo». Il cinema è stato usato per le situazioni più dinamiche e complesse, la fotografia per le situazioni più lineari e circoscrivibili. Ricci offre una dettagliata analisi della struttura di Balinesec character. E segnala anche un articolo di Mead del 1956 sui vantaggi scientifici della fotografia rispetto al cinema.
Sguardi lontani si chiude con alcuni estratti dal dialogo che Mead e Bateson ebbero negli anni sull’uso della fotocamera e cinecamera che avevano fatto nel loro lavoro comune diversi decenni prima (Bateson, Mead 1977).
«Bateson:[3] Sì. Tra l’altro, non mi piacciono le macchine fotografiche su treppiedi, è solo vuota routine (grinding). Nell’ultima parte del progetto sulla schizofrenia avevamo camere su treppiedi che facevano solo vuota routine.
Mead: E non ti piaceva?
Bateson: Disastroso.
Mead: Perché?
Bateson: Perché credo che la documentazione fotografica debba essere una forma d’arte.
Mead: Perché? Perché non si dovrebbero avere dei documenti che non sono forme d’arte? Perché, se si tratta di una forma d’arte, è stato alterato.
Bateson: Senza dubbio è stato alterato. Non credo che esista inalterata.
Mead: Penso che sia molto importante, se si vuole essere scientifici lavorando sul comportamento, dare ad altre persone l’accesso al materiale, il più possibile paragonabile all’accesso che hai avuto tu. In questo modo non si altera il materiale. C’è un gruppo di cineasti che dicono: “Dovrebbe essere arte”, e distruggono tutto quello che stiamo cercando di fare. Perché diavolo dovrebbe essere arte?
Bateson: Beh, dovrebbe essere senza il treppiede.
Mead: Quindi tu ti mordi la coda.
Bateson: Sì.
Mead: E quindi hai introdotto una variazione che non è necessaria.
Bateson: Ho quindi tirato fuori le informazioni che ritenevo rilevanti in quel momento.
Mead: Esatto. E quindi cosa vedi in seguito?
Bateson: Se si mette quella dannata cosa su un treppiede, non si ottiene rilevanza.
Mead: No, si ottiene quello che è successo.
Bateson: Non è quello che è successo. (…)».
Come può lo studioso che si identifica o che comunque non rifiuta una identità genealogica di praticante un’antropologia “in stile italiano” confrontarsi con l’epopea costitutiva della visual anthropology dovuta alla coppia Mead-Bateson?
A mio avviso è molto importante mantenere anche qui il riferimento alla biografia e all’identità scientifica dell’autore di Sguardi lontani. Alla pratica del suo lavoro di campo che ha maturato e che vive sistematicamente[4]. Gli estratti del celebre dialogo-battibecco fra Margaret Mead e Gregory Bateson sull’uso della camera in antropologia alludono, a mio parere, a una possibile risposta, a un inserimento in quel dialogo di altre voci, di ulteriori punti di vista, in cui un approccio “in stile italiano” potrebbe articolare meglio, se non comporre la celebre diatriba e potrebbe dire che effettivamente, sì, incatenare la camera sul treppiede, come accettava Mead e come odiava Bateson, e come hanno fatto generazioni di etnografi e fotografi a partire in Italia da Loria e Corso, equivale a mettere ai margini la traccia dell’incontro etnografico. Ma anche che, treppiede o non treppiede, le immagini si caricano comunque, come nota Ricci con Faeta, di forze che includono intrecci sorprendenti fra fascinazione, incontri umani e conoscenza.
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023
Note
[1] Con Ernesto de Martino irrompe in Italia un’etnografia come sistema di comprensione del mondo, un confronto critico fra culture diverse incentrato sul problema, evocato alla Rabata, della “loro” emancipazione che diventa il “mio” problema (Ricci 2019: 32). «Il più importante dei tratti di somiglianza e di comunanza, a mio parere, [di una antropologia in stile italiano] è proprio il riferirsi alla proposta demartiniana di incontro etnografico: un’originale idea di approccio al campo, non formalizzato soltanto nel senso di una ‘cassetta degli attrezzi’, che certamente non è possibile paragonare alle istruzioni contenute in Notes and Queries in Anhtropology della British Association for the Advancement of Science, ma che marca le singole vicende di studio dando luogo a un ricco patrimonio di forme etnografiche dalla fisionomia spiccatamente italiana e realizzate in Italia» (Ricci 2019: 33). «… un’etnografia che si interroghi sulla realtà del tempo presente, non con il paradigma contemporaneista oggi sempre più pervasivo, ma con la consapevolezza della stratificazione delle cronologie riscontrabili e agenti nella vita reale di qualsiasi contesto socio-culturale» (Ricci 2019: 51).
[2] Funerailles dogon du professeur Marcel Griaule de François di Dio, 15 mm., 1956, in Jean Rouch. Une aventure africaine, cofanetto con 4 dvd, ed. Montparnasse, 2010.
[3] La traduzione è mia.
[4] Vedi il seminario on line di Antonello Ricci Forme di un’etnografia visiva condivisa, nella serie di “Incontri Ravvicinati di Etnografia Visiva” promossi e organizzati dall’Università degli Studi di Cagliari, Laboratorio di Etnografia Visiva, coordinamento di F. Tiragallo, 22 ottobre 2020.
Riferimenti bibliografici
Bateson Gregory and Mead Margaret, 1977, On the use of the Camera in Anthropology, “Studies in Visual Communication”, vol. 4, issue 2, Winter.
Bateson Gregory, Mead Margaret, 1942, Balinese Character, A photographic Analysis, New York, Special Publication of the New York Academy of Sciences.
Cirese Alberto Mario, 1977, Le operazioni museografiche come metalinguaggio, in Id., Oggetti, segni, musei, Einaudi, Torino: 35-56.
Clifford James, 1993, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino.
Clifford James, 1997, Introduzione: verità parziali, in J. Clifford, G. Marcus (a cura di), Scrivere le culture. Poetiche e politiche in etnografia, Meltemi, Roma: 23-52.
Faeta Francesco, 1996, Nelle Indie di quaggiù. Fotografie 1970-1995, Jacabook, Milano.
Id., 2003, Strategie dell’occhio. Saggi di etnografia visiva, FrancoAngeli, Milano.
Id., 2006, Fotografi e fotografie. Uno sguardo antropologico, FrancoAngeli, Milano.
Id., 2011, Le ragioni dello sguardo. Pratiche dell’osservazione, della rappresentazione e della memoria, Bollati Boringhieri, Torino.
Id., 2019, Il nascosto carattere politico. Fotografie e culture nazionali del secolo Ventesimo, FrancoAngeli, Milano.
Lombardi Satriani Luigi M., Rossi Annabella, 1973, Calabria 1908-10. La ricerca etnografica di Raffaele Corso, De Luca-Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma.
Marano Francesco, 2007, Camera etnografica. Storie e teorie di antropologia visuale, FrancoAngeli, Milano.
Mauss Marcel, 2018, Manuale di etnografia, Jacabook, Milano (ed. or. 1948).
Ricci Antonello, 2019, Note introduttive su folklore, demologia, cultura popolare, tradizioni contadine… in Id. (a cura di), L’eredità rivisitata. Storie di un’antropologia in stile italiano, CISU, Roma: 13-68.
Ricci Antonello, Sguardi lontani. Fotografia e etnografia nella prima metà del Novecento FrancoAngeli, Milano, 2023.
Tiragallo Felice, 2018, Max Leopold Wagner fotografo. La Sardegna oltre il linguaggio, in M. L. Wagner. Fotografie della Sardegna di un linguista antropologo, con testi di F. Tiragallo e S. Novellu, Ilisso, Nuoro: 7-18.
Wright Terence, 1993, The Fieldwork Photographs of Jennes and Malinowski and the Beginnings of Modern Anthropology, in “Jaso”, 22, 1: 41-58.
Wright Terence, 1994, The Anthropologist as Artist: Malinowski Trobriand’s Photographs, in T. van Meijl, P, van der Grijp (eds.), European Imagery and Colonial History of the Pacific, Nijmegen Studies in Development and Cultural Change, vol. 19: 116-130.
_____________________________________________________________________________
Felice Tiragallo è professore associato di discipline demo-etnoantropologiche presso l’Università degli Studi di Cagliari. Si occupa di mutamento culturale, di antropologia visuale e di cultura materiale. Dirige, presso l’Ateneo di Cagliari, il Laboratorio di Etnografia Visiva. Fra i suoi testi: Restare paese (2005), Visioni intenzionali (2013) e Max Leopold Wagner fotografo. La Sardegna oltre il linguaggio (2018).
______________________________________________________________








