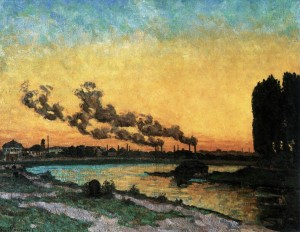Albe, nebbie, crepuscoli: la poetica delle quasi-cose in Giorgio Caproni
Posted By Comitato di Redazione On 1 marzo 2020 @ 02:13 In Cultura,Letture | No Comments
di Clarissa Arvizzigno
Rileggendo Caproni in chiave neofenomenologica [1], si rimane come immersi nella palude delle atmosfere, attanagliati da quelle entità non discrete, vaghe ed indefinite che sono le quasi-cose, quasi-cose che ci afferrano, ci circondano e ci con-fondono impedendoci di analizzarle, di scomporle nelle loro unità minime, di rintracciare il perimetro del loro percorso. Esse, infatti, costituiscono sia gli agenti che i luoghi (i sentimenti spazializzati) che agiscono sul e nel soggetto-poeta che, di volta in volta, vi interagisce immergendosi nel loro spazio di estensione. Il tessuto di questa relazione tra soggetto e ambiente si esplica in quella compagine fatta di cose e quasi-cose che chiamiamo mondo e che Caproni riporta, abilmente, sotto forma di quel tessuto di versi, parole, interiezioni che costituiscono i testi delle sue poesie.
Crepuscolarismi
Nel suo essere fenomeno, il crepuscolo è colto attraverso un’intuitiva unità di significato che mette insieme oggetto e paesaggio nella misura in cui quest’ultimo si fa paesaggio con i suoi suoni, odori, colori, sapori che lo distinguono dalle tonalità fisiche ed emotive degli altri paesaggi. Caproni, il poeta della malinconia, per dirla con Anna Dolfi [2], in “Spiaggia di sera”, contenuta in Come un’allegoria, sua prima raccolta pubblicata nel 1936 a Genova, ci offre una velata atmosfera crepuscolare:
Così sbiadito a quest’ora
lo sguardo del mare,
che appare negli occhi
(macchie d’indaco appena
celesti)
del bagnino che tira in secco
le barche.
Come una randa cade
l’ultimo lembo di sole.
Di tante risa di donne,
un pigro schiumare
bianco sull’alghe, e un fresco
vento che sala il viso
rimane.
Qui la natura fenomenica del crepuscolo è colta nelle sue macchie d’indaco appena celesti che si riflettono negli occhi di un bagnino che tira in secco le barche. I due sguardi (quello del bagnino e quello del mare) si con-fondono tra loro, in un’atmosfera che degrada verso le tinte sbiadite e cangianti della sera, in cui decade ormai anche l’ultimo lembo di sole. Sparita l’atmosfera crepuscolare, ne sopraggiungerà un’altra, fatta di echi di risa di donne, il pigro schiumare del mare, dove qui per pigro è da intendersi il suo carattere lento, senza vigore, quasi smorzato, che insiste in modo ciclico e flebile sulla costa. Ciò che dell’atmosfera del crepuscolo ormai rimane non è altro che la quasi-cosa ventosa di cui possiamo sinesteticamente percepire la freschezza e il senso di sale che con sé trasporta. Cos’è dunque il crepuscolo caproniano: le macchie indaco appena celesti del mare? L’ultimo lembo di sole? Il pigro schiumare delle onde? Il fresco vento che sala il viso? Risponderemo che il crepuscolo è tutte queste cose colte nella loro unità di significato sinesteticamente.
«Si pensi al topos artistico sia di senso comune della luce seducente e protettiva delle candele, alla spugnatura utilizzata dai primi fotografi, per sollecitare una percezione più aptica e cinestetica, ma soprattutto alla diminutio della luce e della tensione corporea tipica del crepuscolo, il quale, appunto grazie all’erosione dei contorni e alla generazione di una vaga impressione complessiva, risulta molto più favorevole della luce diurna all’insorgere di varie tonalità d’animo» [3].
Ciò che rende atmosferico il crepuscolo è il suo essere progressivamente in fieri, il suo essere lo sfaldarsi graduale della luce, il suo venire flebilmente e progressivamente confondendo le forme, erodendo i contorni, facendo precipitare, ciò che si sta percependo, nel vago. Griffero, riprendendo Schmitz e Klages, scrive che il crepuscolare si configura come «dimensione indistintamente emozionale e climatica, in ultima analisi inanalizzabile poiché “patita” intermodalmente (sinesteticamente) – ecco perché lo si può dire “fresco”, “fioco”, “segreto”, “quieto”, ecc. – “cala” (non metaforicamente!) da fuori, in virtù di una quasi cosalità naturalisticamente irriducibile, su tutto»[4].
Cerchiamo di capire il perché di queste affermazioni. Prima di tutto, bisogna chiarire come il crepuscolo sia costituito da due diverse dimensioni: quella climatica legata strettamente alle condizioni metereologiche con cui si presenta e che appare, in un certo qual modo, fisicamente più tangibile (il freddo, il vento del crepuscolo possono essere apticamente percepiti) e la dimensione emozionale. Quest’ultima, anche se fisicamente meno “tattile” (pensiamo all’emozione della nostalgia: ci tocca ma è difficile dire in che misura e in che modo si manifesti) è indissolubilmente legata alla dimensione climatica, tanto da non poter essere da questa distinta. Non è dunque possibile ragionare per e su elementi discreti, separare dimensioni climatiche ed emozionali, perché quest’ultime dipendono fortemente dalle prime, anzi, ne sono, in un certo modo, le conseguenze. Inoltre, come abbiamo precedentemente affermato, in quanto il crepuscolo è patito (ovvero sentito) come un’unità sinestetica, esso è inanalizzabile, non scomponibile. «Inibita ogni spazialità direzionale, il crepuscolo ci rende estranee anche le cose più familiari, riducendole a semplici silhouettes, suggerendo così un’irrinunciabile esperienza smaterializzante sia del percetto, sia del percipiente […]»[5]. A smaterializzarsi sarà pertanto non solamente il percetto, le cose che compongono il crepuscolo, bensì anche chi paticamente le percepisce e vi si smarrisce, confondendovisi.
Ciò che esso produrrà sarà, pertanto, una perdita di orientamento cosale. Come abbiamo prima osservato leggendo Spiaggia di sera, ciò che l’atmosfera crepuscolare produce, è un sentimento di vaghezza in cui chi percepisce si confonde nel percepito per arrivare a cogliere l’unità quasi-cosale del crepuscolo, quella sua inconfondibile paticità quasi nostalgica: «che poi l’atmosfera crepuscolare sia meno intensa nelle latitudini o stagioni in cui quasi immediata è la transizione dal giorno alla notte, come pure in una vita urbana che oggi ne inibisce l’incanto col semplice gesto di accendere la luce, non toglie che, quando insorge, riduca comunque il soggetto [6] “al suo elemento primo e ultimo: un sentire presago”»[7].
Decosalizzare la luce: albe
Volgendo lo sguardo al crepuscolo caproniano, abbiamo iniziato a vedere come questo può essere considerato atmosfera in virtù della luce che caratterizza le sue molteplici tinte.
«È certamente superfluo ribadire le potenzialità atmosferiche della luce, la prima “responsabile delle impressioni su di noi”. Che sia l’oggetto di una percezione tetica o, più spesso, la condizione olistica ed intransitiva di successive, e corrispondentemente tonalizzante, percezioni tetiche e discrete, la luce instaura infatti col percipiente, esattamente come le altre forme, una comunicazione proprio-corporea» [8].
La luce, dunque, si fa atmosfera e al contempo la crea, generando spazi emozionali. Tuttavia, c’è da chiedersi, ogni qual volta che ci troviamo di fronte alla luce, siamo sempre in presenza di un’atmosfera? La risposta è no. «Nell’atmosfericità, quindi, siamo immersi in modo speciale quando la luce, forse perfino senza cessare di essere attrattore biologico, scontorna gli oggetti, toglie loro ogni intollerabile vividezza e simmetria, impedendo di fatto la riconduzione, come tale sempre razionalizzante, delle cose al genere a cui appartengono»[9]. Ciò che rende, dunque, un’atmosfera tale è la vaghezza che la contraddistingue. La luce, per farsi atmosfera, dovrà essere capace di decosalizzare le cose, ovvero renderle quasi-cose sfumando gradualmente la materia di cui sono composte. Al contrario, una luce accecante, un forte bagliore, non possono essere considerati particolarmente favorevoli all’atmosferizzazione. Infatti, come ci suggerisce Griffero, abbagliando lo spettatore, una luce accecante non fa altro che disorientarlo generando una quasi dolorosa contrazione, che finisce soltanto con lo spostamento dell’oggetto abbagliante: «potrà pure irritare e affascinare, alludendo aniconicamente – sottraendosi per principio allo sguardo – al divino, ma difficilmente il riflesso accecante favorirà quella medietà emozionale che, a nostro parere, meglio caratterizza l’atmosferico» [10]. Siamo dunque in grado di fare esperienza dell’atmosferico attraverso fenomeni di luce mitigata. Uno di questi, allo stesso modo del crepuscolo già osservato, è costituito dall’alba.
L’alba, primo spazio emozionale del giorno, è una costante della poesia di Caproni: minacciosa, misteriosa, malinconica, l’alba finisce col divenire correlativo oggettivo di qualcos’altro, dello stato interiore del soggetto stesso. Vediamo ora come questo si realizza a partire da un testo contenuto in Come un’allegoria:
Alba
Una cosa scipita,
col suo sapore di prati
bagnati, questa mattina
nella mia bocca ancora
assopita.
Negli occhi nascono come
nell’acque degli acquitrini
le case, il ponte , gli ulivi:
senza calore.
Manca il sale
del mondo: il sole.
Il giovane Caproni descrive con sottile abilità un paesaggio atmosfericamente connotato, dove i singoli elementi (le case, il ponte, gli ulivi) sembrano risvegliarsi in mancanza di qualcosa: del sale del mondo: il sole. La mancanza di una luce abbagliante, la sua quasi assenza, non fa altro che contribuire a creare atmosfericamente una situazione emozionale: nell’atto stesso del nascere e dunque nell’atto stesso di assumere la loro natura cosale, le cose si decosalizzano, sfumando i loro contorni agli occhi di chi le percepisce. Singolare da notare è che il testo nasce con la parola ‘cosa’ (una cosa scipita) e che dunque sta progressivamente perdendo una delle proprietà che la rendeva “cosa” nel senso di “oggetto definito e definibile”. Siamo dunque nell’ambito delle quasi-cose colte nel loro essere fenomeno, mutamento progressivo. Scrive Baldacci:
«Come un’allegoria si fissa in prevalenza su due momenti topici della giornata, due fasi di passaggio: l’alba e il tramonto. Il sopore mattutino e il pallore serale, ciò che sorge e ciò che si dissolve dialogano (sino quasi a riflettersi) uno nell’altro. Così la fine della giornata porta con sé l’eco “di ingenue grida” (CA:16), il raggio della gioventù sempre in fuga, e la prima luce del mattino conserva ancora l’impronta della “notte che sbianca”» (CA: 17) [11].
Noi riusciamo a cogliere sinesteticamente il sapore dei prati nella misura in cui questi sono bagnati, come se volessimo percepirne, a livello tattile, nella freschezza che li contraddistingue, il sapore. L’impressione che il testo genera è quella di “un’inalazione del prato”, nella misura in cui, del prato stesso, riusciamo a cogliere il suo essere, qui e ora, bagnato in presenza di una bocca che, ancora assopita, sta ancora nella sua “posizione” di attesa. L’essere assopito, d’altra parte, coincide con uno svincolarsi progressivo e fenomenico dalla dimensione del sonno, e dunque dall’atmosfera della notte. Siamo dunque in un momento di passaggio tra due atmosfere, tra due diversi spazi emozionali. Per dirla con Heidegger, siamo nel momento di disvelamento dell’essere, dell’apparire dell’ἀλήθεια, della verità che si dischiude al mondo, e in questo senso, l’alba in quanto fioca e debole luce che succede alla notte, può essere intesa come prima manifestazione del giorno, primo suo disvelamento.
In questa atmosfera di progressivo permutare, gli occhi non sono altro che gli acquitrini che sorgono dalle acque, come se nascessero per riflesso di qualcosa (in questo caso dell’acqua), autogenerandosi da ciò che già potenzialmente li include dentro. In una dimensione che si fa mancanza, a mancare è il sapore-sapere del mondo (il sale), nella misura in cui per sapore dobbiamo anche intendere ciò che dà significato al mondo, che ce lo fa percepire e dunque “sapere”, conoscere quasi concretamente. Riguardo a ciò scrive Mengaldo:
«Qui, e non è la prima volta, la consonanza si stringe in paranomasia; ma, a parte che siamo in chiusura, sale è metaforico, la locuzione ricalca quella religiosa, divenuta notoria, del «sale della terra», e proprio perché si riferisce con un Witz poetico al sole, la concretizza. Dunque il circuito fonico è in funzione epigrammatica, diciamo pure intellettuale, e rovescia l’uno nell’altro astratto e concreto»[12].
Possiamo quindi considerare la coppia minima sole-sale come ciò che rende possibile la conoscenza, nella misura in cui, il conoscere si configura anche come un co-nascere. Cos’è infatti la conoscenza se non un co-nascere di nuovo al mondo, di volta in volta con occhi nuovi? Scrive B. Mattei:
«Una sorta di sensibilità anonima registra gli eventi, rivela paradossalmente un intreccio, quasi una reversibilità tra l’io e il mondo, soggetto e oggetto, vedente e visibile. La realtà sembra farsi l’altra faccia della potenza visiva del soggetto. Oppure entrambi, realtà e soggetto sembrano depotenziati, levigate superfici riflettentesi. La poesia dell’alba diviene allora celebrazione di un enigma: quello della visibilità della realtà e dell’essere, nel loro reciproco incrociarsi, nel loro permutare metamorfico»[13].
Dopo aver visto come si realizza l’alba nel primo Caproni, guardiamo ora al poeta più maturo del Passaggio di Enea e al testo Alba, con cui si apre l’intera raccolta:
Amore mio nei vapori d’un bar
all’alba, amore mio che inverno
lungo e che brivido attenderti! Qua
dove il marmo nel sangue è gelo, e sa
di rinfresco anche l’occhio, ora nell’ermo
rumore oltre la brina io quale tram
odo, che apre e richiude in eterno
le sue deserte porte?…Amore, io ho fermo
il polso: e se il bicchiere entro il fragore
sottile ha un tremitìo tra i denti, è forse
di tali rumori un’eco. Ma tu, amore,
non dirmi, ora che in vece tua già il sole
sgorga, non dirmi che da quelle porte
qui, col tuo passo, già attendo la morte.
Qui ci troviamo di fronte a un sonetto irregolare, la cui forma può essere riassunta nello schema ABAA BABB CDC CDD [14] . Come ci fa inoltre notare Luca Zuliani
«questo sonetto contiene l’unico endecasillabo presumibilmente ipometro di tutto Il Passaggio di Enea, Si tratta del secondo verso, “all’alba, amore mio che inverno”, che è regolarizzabile solo tramite la dieresi d’eccezione su «mio» e «che». Quindi pare piuttosto un ipometro intenzionale, che sarebbe reso regolare dall’aggiunta di «lungo», che apre in forte enjambement il verso successivo» [15].
All’interno di questa struttura metrica, il poeta del disincanto dipinge se stesso immerso in un’atmosfera invernale, all’alba, in una dimensione d’attesa che coincide con la stessa stagione, come se l’inverno coincidesse con un lungo letargo, con il tempo d’attesa dell’amata. Il bar, il tram suggeriscono che ci troviamo in una dimensione urbana, in luoghi di sosta, di passaggio, luoghi che sembrano far eco alla condizione esistenziale del poeta: chiuso nella sua solitudine, con un bicchiere (elemento presente in tutta la produzione caproniana, la cui immagine risulta particolarmente perturbante) di cui si sente lo stridente tremitìo tra i denti. Il bicchiere diviene allegoria di uno stato emozionale, da intendere in senso etimologico, come ci suggerisce il verbo greco ἀλλεγορὲω, parlare in altro modo, dunque: parlare per lingua d’altri. Il bicchiere ora si fa oggetto parlante, il suo essere cosa non gli impedisce di comunicare, anzi: la comunicazione diviene tanto più efficace quanto più la sua presenza si fa suono (tremitìo) che concorre a creare un’atmosfera. Scrive il poeta:
«A Roma, verso la fine del 1945. Ero in una latteria, solo, vicino alla stazione aspettavo mia moglie Rina che doveva arrivare da Genova. Una latteria di quelle con i tavoli di marmo, con le stoviglie mal rigovernate che sanno appunto di ‘rinfresco’. Mia moglie non poteva stare con me a Roma perché non trovavo casa e dovevo stare a pensione. Erano tempi tremendi. Io insegnavo» [16].
Il vissuto della poesia, dunque, coincide con il vissuto autobiografico di Caproni: un uomo solo che attende la propria donna in una stazione desolata ai primi chiarori dell’alba, ma allo stesso tempo un poeta, capace di creare spazi atmosferici attraverso l’ausilio di un repertorio di immagini connotato emotivamente. A dominare è, per dirla con Griffero, l’atmosfera del vago, resa tale, oltre che dai primi tepori dell’alba, anche dai vapori del bar che avvolgono le cose confondendole, rendendole quasi-cose:
«In Alba, questa costellazione di immagini (il bicchiere che trema, il bar, l’alba, il tram) appare compiutamente, già da subito, come una costellazione di simboli. Quindi, la poesia che, come s’è visto, segna l’apparizione di un ambiente ben definito e non un paesaggio, è anche quella che, nel contempo, trasfigura questo ambiente in un varco oltre la realtà» [17].
Il tram che apre le sue deserte porte non è altro che una dimensione liminare che consente altri accessi, varchi, forse per un indefinito aldilà, un misterioso Erebo. L’apparire del sole, invece, sembra agire come una spugna che, al suo passaggio, cancella ogni traccia dell’alba, la sua atmosfera. Esso, in virtù della sua potenza luminosa, non permette la presenza di alcuno spazio emozionale creato atmosfericamente: «L’essenziale, atmosferologicamente, è che non si tratti della luce nella presunta assoluta purezza (lux) del primo giorno (genesiaco), ma della luce diventata percepibile (lumen) perché intorbidata dalle cose su cui cade e che, almeno relativamente, smaterializza» [18].
Il tema dell’alba come atmosfera che apre a un aldilà, così come quello della porta, quale soglia liminare che congiunge due dimensioni, è inoltre ben presente anche nel Seme del piangere in Ad portam inferi:
Chi l’avrebbe mai pensato, allora,
di doverla incontrare
un’alba (così sola
e debole, e senza
l’appoggio della parola)
seduta in quella stazione,
la mano sul tavolino
freddo ad aspettare
l’ultima coincidenza
per l’ultima destinazione?
[…]
Nemmeno sa distinguere bene,
ormai, tra marito e figliolo.
Vorrebbe piangere, cerca
sul marmo il tovagliolo
già tolto, e in terra
(vagamente la guerra
le torna in mente, e fischiare
a lungo nell’alba sente
un treno militare)
Guarda fra tanto fumo
e tante bucce d’arancio
(fra tanto odore di rancio
e di pioggia) il solo
ed unico tesoro
che ha potuto salvare
e che (lei non può capire)
fra i piedi di tanta gente
i cani stanno ad annusare.
La poesia, che presenta un fluido ritmo narrativo costruito per lo più da coordinate, si apre con l’immagine di Annina, rappresentata mentre aspetta che si compia il suo destino, seduta in un bar, in attesa di iniziare il suo ultimo viaggio: la stazione è spettrale, siamo in un non-luogo immerso in un’alba anch’essa imprecisata, in cui Annina è ormai un’ombra. L’alba, qui, si fa dunque espressione di una condizione esistenziale, quasi come fosse il preludio della morte. La percezione sinestetica si realizza nuovamente: il fischio del treno militare invade la calma del giorno appena iniziato, e la sua percezione è contemporanea a quella del fumo, dell’odore di rancio e di pioggia (da notare la sinestesia “odore di pioggia”). A proposito del componimento, scrive Enrico Testa:
«Se nella teoria letteraria esistesse una nozione assimilabile a quella, corrente in fisica, di corpo radiante, un corpo cioè da cui si liberano energie ed impulsi destinati ad essere assorbiti, riflessi e poi ulteriormente diffusi da un altro sistema, Ad portam inferi meriterebbe a buon diritto – almeno riguardo al tema in questione – l’appellativo di testo radiante. Certo, va pure detto che la parentela tra questa poesia e tanti testi successivi è, in primo luogo, fondata (e potrebbe dunque essere falsificata) sul tema della morte, che funziona, per così dire, da termine mediano dell’equazione […]»[19].
Ad portam inferi irraggia una varietà di stati che ritroveremo in molti altri testi e contiene in sé il tema per eccellenza dell’intera raccolta: il lutto. È proprio grazie al lutto e per mezzo di esso se si può parlare di Annina, rievocarla, ri-disegnarne i contorni restituendo le sue forme vaghe, perdute tra nebbie albine. In questo senso, potremmo considerare Ad portam inferi, un testo-matrioska, che contiene potenzialmente dentro di sé i temi e i sentimenti atmosferici che ritroveremo sparsi non solo all’interno del Seme del piangere, ma anche nelle altre raccolte successive. D’altronde, se dobbiamo considerare la scrittura di Caproni, dobbiamo immaginarla come un ruscello in divenire: man a mano che l’esperienza del poeta matura, e la parola viene sempre più asciugata, ridotta all’essenziale, il ruscello si trasforma in fiume, capace di inglobare dentro di sé tutti i detriti che trova lungo la strada che percorre.
«Ad portam inferi, insomma, mentre segna l’apice e, forse, la chiusura della stagione del lutto personale e mentre apre al nuovo percorso che sarà contraddistinto dall’“insediarsi di un lutto cronico ormai quasi dimentico dell’oggetto stesso del suo soffrire”[20], lascia però in dote al suo autore un bagaglio – un “fagottino” – di dati immaginativi e figurali che saranno di lì a poco essenziali per la sua scrittura»[21].
L’alba, onnipresente in tutta la produzione caproniana, confonde forme e sfuma contorni delle cose, decosalizzandole, producendo un’atmosfera rarefatta, la cui funzione e il cui aspetto può essere, per certi versi, paragonato a quello della nebbia:
All’alba
Eran costretti, tutti,
a seguir lui, il solo
che avesse una lanterna.
Ma all’alba,
tutti si sono dileguati
come fa la nebbia. Tutti.
Chi qua, chi là.
(c’è chi ha preso,
pare, una strada falsa.
Chi è precipitato. È facile. )
Oh libertà, libertà.
La poesia, facente parte della raccolta Il muro della terra, descrive una scena che si svolge in un imprecisato momento prima dell’alba, dove degli “indefiniti tutti” si apprestano a seguire il solo che dall’insieme si distingue perché tiene una lanterna, configurandosi come una sorta di guida del gruppo. La cosa-lanterna contrasta con l’assenza di luce in cui si trova la gente in cammino, la sua funzione è quella di illuminare, rendere chiara l’atmosfera quasi-cosale che precede l’alba. Con un verso a gradino, introdotto da un’avversativa, Caproni è come se ponesse l’accento sul momento tempestivo in cui l’alba irrompe e si fa realtà. L’effetto che ne consegue è quello di una dispersione, di un dileguarsi della gente tra la nebbia, tra il qua e il là, in luoghi ignoti e imprecisati. Si può dunque parlare di una sorta di nebbia dell’alba, nella misura in cui questa si presenta, in tutta la sua vaghezza, come elemento di offuscata e confusa percezione e allo stesso tempo perturbante, come se, per dirla con Heidegger, l’improvviso disvelarsi della luce albina, incutesse timore e incitasse alla fuga. Come abbiamo iniziato a vedere, l’alba, in Caproni, rappresenta un elemento sfuggente da definire quanto paradossalmente oscuro: essa crea spaesamento, è vista come minaccia onnipresente, varco che congiunge la dimensione dell’al di qua con quella dell’al di là.
Abbagli
Secondo Griffero, la luce pura non contribuisce a creare atmosfere e non costituisce essa stessa una quasi-cosa. Tuttavia, cosa succede nel momento in cui si verifica un abbaglio? Leggiamo, a tal proposito, “Il cercatore di Caproni”, tratto dal Muro della terra:
Aveva posato
la sua lanterna sul prato.
aveva allargato
le braccia. Tutto
quel sole. Tutto
quel verde scintillio d’erba
per tutto il vallone.
era scoraggiato.
«Come
Può farmi lume,»
pensava. «Come
può forare la tenebra,
in tanta inondazione
di luce?»
Piangeva,
quasi. S’era
coperta la faccia.
Si premeva gli occhi.
Aveva
perso completamente,
con la speranza, ogni traccia.
Come nel precedente testo All’alba, troviamo come protagonista una misteriosa figura, di cui nulla sappiamo se non il suo tenere in mano una lanterna. Egli è il cercatore di un’imprecisata e non detta ricerca. Non conosciamo, infatti, l’oggetto della sua ricerca, che probabilmente è ignoto anche al cercatore stesso. Questo contribuisce a creare nel lettore un senso di straniamento: come realizzare una ricerca senza oggetto? E se così è: può questa dirsi tale? Su che piano ci stiamo muovendo? Chi è il misterioso personaggio che ricerca cosa? La contraddizione dinanzi alla quale ci troviamo leggendo il testo e che ci lascia spiazzati, razionalmente impreparati, non deve stupirci: ci troviamo all’interno del Muro della terra, la raccolta che ha canonizzato Caproni, nel 1975, come uno dei maggiori poeti del ‘900 e che insiste sui muri, sui limiti della ragione umana di fronte alle aporie che incontra nel suo percorso.
Deserti, selve, luoghi in cui è assente o quasi la figura umana si susseguono, lasciando al lettore un senso di sbigottimento di fronte agli accennati paesaggi che gli si profilano dinanzi, nei quali si è sempre in guardia, o in attesa di qualcosa. Se in All’alba la lanterna serviva ad illuminare un buio paesaggio creando, a sua volta, atmosfera, ne Il cercatore ci troviamo al cospetto di una luce abbagliante, in cui ogni cosa sembra essere già definita, connotata dai raggi accecanti del sole. Siamo in assenza di un’atmosfera quasi-cosale, e la lanterna, a un primo sguardo, sembrerebbe fine a se stessa, inutile: cosa fa un cercatore solo in un prato con una lanterna in mano, in un luogo aperto, colmo di una luce infinita, il cui effetto più espressionisticamente connotato all’interno del testo è quello “del verde scintillio d’erba” per tutto il vallone? Riflettendo sul testo, potremmo dire che, in realtà, il gesto del cercatore non è fuori da ogni razionalità, nella misura in cui la totale ed accecante presenza della luce è affine alla totale presenza del buio, costituendone, in un certo senso, il suo doppio.
Calvino scriveva che «vedere significa percepire delle differenze»[22], nel momento in cui non siamo più capaci di distinguere colori, sfumature, perché tutto ci appare abbagliante, stiamo forse vedendo? Non siamo piuttosto paticamente sopraffatti dalla luce? E la stessa sensazione non la proviamo, forse, in presenza delle tenebre? Del buio assoluto? Ci troviamo, in entrambi i casi, in assenza di atmosfere come le abbiamo fenomenologicamente intese e descritte: ogni gradualità e ogni contorno viene meno, non si assiste (nel caso del colore) al suo sfumare verso l’indistinto, ma al presentarsi della cosa nei suoi elementi solidi e discreti (nel caso dell’atmosfera abbagliante del giorno), o all’indistinto stesso, senza sfumature né gradazioni (nel caso della notte). Come nel buio anche nella luce, dunque, la lanterna può creare un’atmosfera quasi-cosale. In questo senso, la si proverà ad accendere per ripristinare, al contrario, uno spiraglio di buio, o per meglio dire, di ombra. Se, infatti, associamo due fonti luminose, l’una all’altra, si avrà un curioso effetto ottico: per contrasto una sembrerà più “buia” e un’altra “più luminosa”. Nel testo, che presenta un sinuoso ritmo narrativo, il movimento della luce è definito “inondazione” come se il poeta volesse porre l’accento sul moto ondulatorio e travolgente della luce che si fa qui onda. In questo senso, il gesto del coprirsi il volto potrebbe essere inteso come difesa, scudo di fronte alla forza luminosa dei raggi solari, così che le mani fungono da schermo protettivo da portare dinanzi agli occhi. I verbi tutti all’imperfetto (tipici in Caproni, volti a porre l’accento sulla narrazione) contribuiscono a rendere la continuità di una scena senza tempo, di una ricerca che si protrae all’infinito, inseguendo ormai senza speranze ciò che resta delle tracce.
Guardiamo ora alle tenebre. Nel testo sembrano avere consistenza materica: “Come/ può forare la tenebra/ in tanta inondazione/ di luce?”; tanto da poter essere forate, attraversate. A mano a mano che si procede con la lettura del Muro della terra, le aporie divengono sempre più frequenti e paradossali. In tutta la raccolta, infatti, sopravvive questa ricerca costante del varco, della traccia, di tutto ciò che è razionalmente penetrabile o, se preferiamo, perforabile. Ciò che si cerca è una via d’uscita rispetto al muro della terra, un πόρος nel senso etimologico del termine di passaggio, varco, possibilità. Fino a che punto il buio è perforabile e inoltre, fino a che punto il buio continua ad essere buio? Guardiamo ad un’altra lanterna caproniana:
La lanterna
Non porterà nemmeno
la lanterna. Là
il buio è così buio
che non c’è oscurità.
La poesia, facente parte della raccolta Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, insiste sul significato del buio e sul possibile (qualora ve ne fosse) significato dell’oggetto-lanterna. Se ne Il cercatore l’assoluta e totale presenza della luce rendeva paradossalmente necessaria la lanterna, in quest’ultimo testo, al contrario, il buio è tale da tradursi in assenza di oscurità, dunque in qualche forma di imprecisata luce. Oltre all’enigma di che cosa sia questo buio, verrà da chiedersi da dove questo provenga, in quale luogo esso dimori. A tal proposito, Caproni resta sul vago, lasciando intendere con il semplice uso del deittico là, un’indefinita lontananza, così tale da restare sullo sfondo, di rimanere essa stessa sfondo.
A proposito di oscurità, per Heidegger il fascino della Lichtunug risiede «nell’oscurità assoluta ed inilluminabile (l’extrafenomenologica luce scura) che ne è la condizione di possibilità»[23], mentre, fa notare Amoroso, tale fascino per noi risiede «nella percepibile oscurità o luminosità relativa (lucus) resa possibile dalla silva, che nasconde sì la radura – nel caso dell’opera d’arte, nella terra inesauribile rispetto al Mondo – ma genera anche “la luce mite di uno slargo nel bosco”» [24].
Nebbie
Abbiamo iniziato a vedere come agisce l’atmosfera dell’alba, in cosa consiste il suo essere quasi-cosa, il suo carattere effimero e vago, tale da con-fondere soggetto percipiente e oggetto percepito e di come Annina rappresenti l’incarnazione di questa confusione, figura liminare tra l’al di qua e l’al di là. Annina è colei che si muove tra le atmosfere e genera, a sua volta, atmosfere così che ci troviamo di volta in volta, immersi in spazi emozionali dalle tinte tenui che sembrano avvolgerci e catturarci contemporaneamente. Occupiamoci ora di un’altra atmosfera: la nebulosità:
«all’atmosfera quasi-cosale della luce contribuisce, poi, naturalmente anche la nebulosità. Può essere la “chiarezza nebbiosa”, ossia la luminosità priva di nitidezza specifica secondo Goethe del paesaggio mediterraneo, la nebbia in senso strettamente climatico, ma anche quella prodotta artificialmente (ad esempio tramite lo sfumato): in ogni caso il nebbioso tutto avvolge, sfumando e scontornando gli oggetti, suggerendo in genere, anche attraverso un’impalpabile umidità, un sentimento di oppressione tanto illocalizzato quanto onnipresente alla stregua di un velo» [25].
Nebbia
Partivo sempre in mattine
nebbiose (con vaporose
e lunghe locomotive nere),
e mi mettevo a sedere
-nel fumo della stazione-
d’angolo, in un vagone.
Partivo nell’ora albina
e umida, quando la brina
copriva ancora i binari
a lutto, e straordinari
suonavano gli ululati
degli altri treni, bagnati.
Partivo senza capire
dove mai andassi a finire.
Avevo nel capo nebbia;
nel cuore – verde – una Trebbia.
Il tempo era di prima
che avessi conosciuto Rina.
Il testo, facente parte anch’esso della raccolta Congedo di un viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, sviluppa i classici temi della poetica caproniana: il viaggio, l’alba, il lutto…la poesia di Caproni sembra non conoscere stasi: tutti si muovono e, spesso, sono in partenza per un dove imprecisato. Il tempo si distende nell’ora albina in cui possiamo percepire sinesteticamente la brina, l’umido che si sprigiona dalla terra, i treni bagnati i cui suoni cupi, ovattati, appaiono come animalizzati, realizzandosi in ululati. L’atmosfera si presenta rarefatta e nebbiosa, grigia, precaria, minacciosa nella misura in cui diviene minaccia un paesaggio desolato, costituito da cose che comunicano attraverso suoni, attraverso colori cupi. Le locomotive sono nere, come fossero dei carri mortuari che conducono verso un al di là: esse si disperdono tra i vapori, che offuscando la percezione del poeta, costituiscono delle quasi-nebbie artificiali. L’uso della parentesi (tratto abbastanza tipico in Caproni) è come se ci facesse entrare più profondamente nel discorso poetico consentendo di penetrare il suo mistero nel profondo, scavando un’altra dimensione e aprendo a nuovi spazi percettivi ed emozionali. Secondo Niccolò Scaffai: «la parentesi è una delle costanti più riconoscibili nella scrittura in versi di Caproni; il suo statuto è sospeso tra la dimensione grafica e quella stilistica, nella quale il segno si connota in relazione all’usus dell’autore e alle strutture dei testi, siano questi singole poesie o intere sequenze» [26]. L’uso della parentesi, perciò, consente una focalizzazione, quasi si volesse descrivere una scena per renderla manifesta dinanzi agli occhi del lettore: quando leggiamo “(con vaporose e lunghe locomotive nere)”, ci sembra infatti di vederle e sentirle con tutta la carica negativa di cui sono ricoperte. All’interno di un tempo del racconto tutto all’imperfetto, la parentesi consente ora una dilatazione delle cose che accadono dentro al tempo e di conseguenza alla parentesi stessa, che espandendosi ingloba e conchiude, quasi a trattenere ciò che al verso aperto sarebbe sfuggito.
Il tema dello smarrimento si fa ora essenziale in Nebbia, dove a dominare è un’atmosfera nebulosa che tutto confonde, rivelando la natura semi-cosale di ciò che ci sta intorno, tanto da generare uno stordimento in colui che si accinge ad intraprendere il viaggio: “partivo senza mai capire/ dove andassi a finire”. Ciò che è curioso è che, nonostante il viaggiatore si trovi letteralmente disperso nella nebbia, in realtà, l’atmosfera di nebulosità che egli vive, si realizza nella sua testa, nella sua mente, quasi fosse generata in modo endogeno: “avevo nel capo nebbia”. Ci chiederemo perciò se la nebulosità sia uno stato mentale o fisico, se sia «de dicto (prodotta iconicamente o quale conseguenza dello stato psicofisico del percipiente) o de re (vaghezza ontologica)». In questo caso, probabilmente, ci troviamo al cospetto di una doppia atmosfera, fisica e mentale insieme, anzi è proprio la prima che rende la seconda tale, conferendogli uno statuto emozionale. Al viaggiatore, ora, non resta altro che perdersi tra i minacciosi vapori che gli si profilano dinanzi, dietro, di lato, ovunque, saturando così lo spazio e scardinando i punti cardinali, le bussole del movimento. Scrive Böhme:
«non stupisce quindi che, avvolta in non meglio precisati fumi e vapori e soprattutto nella nebbia, un’insignificante porzione di spazio divenga, in quanto indeterminata costellazione quasi-cosale, potentemente atmosferica, capace di suggerire al massimo grado, con effetti ora angoscianti ora rassicuranti, il kantiano libero gioco delle facoltà, e paradossalmente tramite la non varietà ma la tonalità unitaria conferita al campo ottico a scapito dei dettagli. Immerso nella nebulosità, ad esempio, un albero non è che una massa scura, incombente e come emersa improvvisamente dal nulla, così da suggerire perciò quello status nascendi che rinveniamo nella transitorietà di ogni quasi-cosa» [27].
Ci troviamo, pertanto, di fronte a una smaterializzazione dello spazio circostante in cui le cose acquistano una nuova impalpabile minacciosità: «sentirsi annebbiati significa allora “patire” l’atmosfera di un mondo rattrappito, e nel quale ogni pre-visione diviene impossibile: un mondo in cui ci si trova in compagnia dei soli suoni, divenuti a loro volta minacciosamente autonomi, donde “un sentimento di irrealtà, di un fluttuare nello spazio vuoto”[28]» [29].
Le quasi-cose, allora, non sono altro che quei sentimenti spazializzati, quei paludosi e densi spazi di percezione dove si realizza la compagine del-col mondo. In altre parole, potremmo pensare le quasi-cose come delle cose in-potenza in cui il loro percorso in-fieri ha conosciuto una battuta d’arresto facendo sì che rimanessero in-definite, così che l’avverbio “quasi” sta proprio ad indicare il carattere provvisorio e sfuggente di questa intermittenza che le caratterizza.
Dialoghi Mediterranei, n. 42, marzo 2020
Note
[1] Si fa qui riferimento alla Nuova Fenomenologia di ambiente tedesco sviluppatosi intorno agli anni ’60 del ‘900 che vede tra i suoi protagonisti studiosi come E. Straus, H. Schmitz, Böhme G., poi ripresi in Italia dal filosofo T. Griffero. Cfr. “Atmosferologicamente: per un’estetica degli spazi emozionali in G. Caproni”, in Dialoghi Mediterranei, n.41, gennaio 2020.
[2] A. Dolfi, Caproni, la cosa perduta e la malinconia, San Marco dei Giustiniani, Genova, 2014.
[3] O. F. Bollnow, Le tonalità emotive, trad. di D. Bruzzone, pref. di E. Borgna, Vita e pensiero, Milano, 2009.
[4] T. Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, Bruno Mondadori, Milano, 2013: 129.
[5] E. Minkowski, Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, trad. di G. Terzian, pref. di E. Paci, Einaudi, Torino, 1971: 133-134.
[6] T. Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, cit.: 131.
[7] G. Böhme, Anmutungen. Über das Atmosphärische, Tertium, Ostfildern, 1998.
[8] G. Böhme, Arkitectur und Atmosphäre, Fink, München, 2006.
[9] T. Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, cit: 125.
[10] Ivi: 122
[11] A. Baldacci, Giorgio Caproni, L’inquietudine in versi, Franco Cesari editore, Firenze: 22-23.
[12] P. V. Mengaldo, Per la poesia di Giorgio Caproni, Introduzione all’opera in versi, I Meridiani, Mondadori, Milano, 2016: XV.
[13] B. Mattei, Otto poesie sull’alba. L’alba nella poesia di Ungaretti e Caproni, “In Limine”, n. 10, 2014.
[14] Fabio Magro fa notare come la struttura del sonetto in questione presenti una struttura affine allo schema del sonetto elisabettiano: ABAA BABb CDCC DD (Fabio Magro, Per uno studio della rima in Caproni. I sonetti, in Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2007, vol. II: 1439-1462, segnatamente: 1451).
[15] Luca Zuliani, “Alba” in G. Caproni, lingua, stile, figure, a cura di D. Colussi e P. Zublena, Quodlibet, Macerata, 2014: 176-177.
[16] G. Caproni, L’opera in versi, cit.: 1131.
[17] L. Zuliani, Alba” in G. Caproni, lingua, stile, figure, a cura di D. Colussi e P. Zublena, cit.: 187.
[18] T. Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, cit.: 123.
[19] E. Testa, Con gli occhi di Annina. La morte della distinzione, in Giorgio Caproni, Lingua, stile, figure, cit.: 55.
[20] A. Dolfi, Caproni, la cosa perduta e la malinconia, cit.: 337.
[21] E. Testa, Con gli occhi di Annina. La morte della distinzione, in Giorgio Caproni, Lingua, stile, figure, cit.: 55-56.
[22] I. Calvino, Collezione di sabbia, Garzanti, Milano, 1984: 158.
[23] T. Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, cit.: 124.
[24] L. Amoroso, La Lichtung di Heidegger come locus a (non) lucendo, in G. Vattimo, P.A. Rovatti (a cura di), Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano, 1983: 137-163.
[25] T. Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, cit.: 127.
[26] N. Scaffai, Una costante in Caproni: «l’uso (in un certo modo) della parentesi», in Giorgio Caproni, Lingua, stile, figure, a cura di Davide Colussi e Paolo Zublena, cit.: 113.
[27] G. Böhme, citato da Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, cit.: 128.
[28] O. F. Bollow, Mensh und Raum, 1963, Kohlhammer, Stuttgart 2004: 219, 221.
[29] T. Griffero, Quasi-cose, la realtà dei sentimenti, cit.:127.
______________________________________________________________
Clarissa Arvizzigno, ha conseguito una laurea triennale in Lettere (curriculum classico) presso l’Università di Palermo, discutendo una tesi dal titolo Riflettere-riflettersi: la poetica dello sguardo in Palomar e in Ora serrata retinae. Studiando il ruolo della vista come strumento fenomenologico per la conoscenza del reale, si è occupata di Italo Calvino e Valerio Magrelli esaminandone analogie e differenze soprattutto in chiave estetica. Successivamente ha conseguito la specialistica in Italianistica presso l’Università di Bologna discutendo una tesi sull’opera di Caproni letta in chiave neofenomenologica. È impegnata in ricerche su temi di estetica e di letteratura comparata. Ha collaborato con alcuni portali antimafia online: www.liberainformazione.org , www.antimafia2000.com, www.corleonedialogos.it.
_______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/albe-nebbie-crepuscoli-la-poetica-delle-quasi-cose-in-giorgio-caproni/
Click here to print.