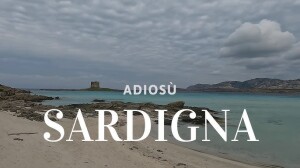I Cento fiori delle aree interne e le minacce della destra
Posted By Comitato di Redazione On 1 maggio 2024 @ 02:35 In Cultura,Società | No Comments
di Pietro Clemente
Adiosu
Adiosu si dice in Sardegna quando ci si accomiata per un lungo periodo di tempo. In queste pagine, oltre al testo di Paolo Nardini a memoria di un lontano addio, quello a Roberto Ferretti morto nel 1984, sono presenti altri due ‘adiosu’. Ed hanno tutti a che fare col Centro in periferia. La vita di Ferretti intorno alle tradizioni popolari maremmane, la sua ricerca a più direzioni, sono quasi un emblema: lui cercava la voce dei piccoli paesi tra pianura e monti, documentava e cercava di rianimare forme di teatro e riti tradizionali, saperi pratici e provava a farli confluire in un museo della Maremma.
Sono passati quarant’anni dalla sua morte. Di quel tempo di studi e di accesi dibattiti sulle tradizioni – che era anche il mio – oggi torna qualche raro slancio ma i termini sono cambiati. Proprio nell’anno in cui Ferretti chiudeva la sua vita a 36 anni in un incidente d’auto in Giordania, usciva il libro di Gianluigi Bravo, Festa contadina e società complessa. Bravo è morto nel 2021. Era del 1935, astigiano, docente a Torino. Lo abbiamo ricordato da poco in un convegno promosso da Laura Bonato dal titolo Festa contadina e società complessa. Forme e pratiche del rito quarant’anni dopo. Il libro sopracitato di Bravo è stato per me una risorsa interpretativa preziosa, che anticipava di venti anni e più problematiche ancora oggi molto vive. Quelle sui piccoli paesi, sulle zone interne, sui centri in periferia.
Più che sulla festa in sé mi aiutava a riflettere sulle metodologie portate avanti in quella ricerca, legata ad una ‘scuola antropologica piemontese’ che ha dato un contributo importante alla conoscenza. Una scuola che – forse anche in virtù dell’esperienza sociologica – ha consentito letture della società complessa assai significative. Festa contadina e società complessa nasce dal dialogo, avvenuto alla fine degli anni 70, di Bravo e di altri studiosi con A. M. Cirese e con il marxismo negli studi DEA muovendosi entro un quadro teorico e sociologico complesso legato agli studi di Luciano Gallino. Per cui offre un panorama teorico di riferimento ricco di prospettive sociali e antropologiche inedite come il pendolarismo o la reinterpretazione della festa tradizionale.
Adiosu a Gianluigi Bravo, collega prezioso e caro amico.
Il mio ‘adiosu’ va anche a Linetta Serri, che da poche settimane ha concluso il suo cammino terrestre, lei che era una grande camminatrice, e si è avviata nei sentieri dell’ignoto mondo dell’assenza. Linetta era la ‘sindaca’ di Armungia. Durante il suo mandato sono stati fatti con gli studenti dell’Università di Roma tre stage dedicati a studiare il ‘paese di Emilio Lussu’. Fu straordinaria organizzatrice ed ospite preziosa. Ed anche testimone con i racconti di sua madre sul passato e i suoi sul passato prossimo di Armungia. Raccontava il museo, la maestra Usala, Joyce Lussu, il territorio, il paesaggio, il piano regolatore. Parole piene di significato per me. Aveva scritto, dopo una ricerca attenta ed appassionata, un articolo su Dialoghi Mediterranei (settembre 2020). Il titolo Storia di una foto dà conto di una immagine di gruppo di caccia armungese in cui compariva ‘Ziu Emiliu’ come veniva chiamato Emilio Lussu [https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/storia-di-una-foto/]
In un numero di Lares dedicato agli stages sardi con base Armungia (lxxii, n. 1, gennaio-aprile 2006), Eugenio Testa, uno dei promotori sul versante dell’Università di Roma La Sapienza scriveva qualche nota di diario:
«Domenica 23. Grande girata con il fuoristrada del Comune per l’oltre Flumendosa. Guida Claudio Mascia, ci sono Linetta Serri, Gabriella Da Re, Alberto Sobrero, io e Marcello Stefanini, che è il promotore. Visitiamo posti bellissimi, che danno varie possibilità ad Armungia per rendersi attraente e fruibile per un turismo certo non di massa ma anche
non occasionale. Dopo cena ci invita Linetta (me, Alberto e Stefanini), ci offre un ottimo vino, ci fa vedere la sua casa, rivediamo sulla cartina il percorso della mattina. Ultimo bicchiere da Caccò, anche con Gigi Cabboi. Non si paga perché Caccò si dichiara milanista, e ha vinto lo scudetto».
«Dunque, autore primo degli stage didattici di ricerca sul campo che hanno portato ad Armungia, paese a qualche decina di chilometri a nord-est di Cagliari, tre gruppi di studenti dell’Università di Roma La Sapienza dal 15 al 30 maggio del 1998, dal 17 al 29 maggio del 1999 e dall’11 al 23 giugno del 2000, è stato Pietro Clemente, professore di Antropologia culturale. E questo è, appunto, certo. Ma almeno coautrice dobbiamo considerarne Linetta Serri, sindaco di Armungia, che ha saputo mobilitare la disponibilità e l’energia sue e di una parte significativa dell’Amministrazione comunale e della popolazione. Senza di questo nulla si sarebbe potuto fare, per come l’operazione-stage era stata pensata».
Grazie Linetta.
Mi sono reso conto di recente che la posta elettronica è per me uno di quei luoghi dove gli amici partiti per l’ultimo viaggio sono ancora presenti. Vivi. Le loro mail sono ancora lì nella memoria del computer. Mi posso rileggere una delle ultime lettere di Gianluigi Bravo che ricordava con dolore la morte di Giulio Angioni (docente di Antropologia culturale all’Università di Cagliari: 1939-2017).
Scrive Bravo:
«Caro Pietro, la scomparsa di Giulio mi ha molto addolorato. Come ricorderai abbiamo iniziato a lavorare insieme per una nuova demoantropologia sotto la guida di Cirese già parecchi decenni fa. Ci siamo frequentati, sono stato suo ospite e lui mio ospite. Si è discusso, ci si è confrontati, siamo cresciuti un po’ insieme. Era una persona giusta, attenta, aperta, non inutilmente aggressiva ma cordiale – me lo ricordo sorridente. Ora è finita». Gian Luigi
Anche Linetta è presente nella memoria della mia mail. Ecco una sua lettera del 2017: dove mi spiegava il percorso del suo cammino.
2017
«Quest’anno il Cammino di San Giorgio attraversa il Gerrei, tappa ad Armungia. Poi attraverso il sentiero dei minatori Villasalto fino a San Vito. Con Tommaso stiamo organizzando l’accoglienza».
E nell’anno seguente
«È “Il Cammino di San Giorgio Vescovo”. Si svolge nella seconda metà di Aprile e il tragitto parte da Suelli, perché S G era Vescovo della Diocesi di Suelli (siamo intorno all’anno mille,1050) comprendeva la Trexenta, il Sarrabus e tutta l’Ogliastra e l’interno fino a Orgosolo. Un territorio molto vasto. Il percorso segue soprattutto i toponimi (Nuraghe Piscu o sa scala de su Piscamu, cioè vescovo …) e le Chiese dedicate. L’anno scorso abbiamo attraversato il Gerrei fino alla Chiesa campestre di San Vito perché c’è un toponimo tra Armungia e Ballao: is gruttas de su piscu».
 Come vedete il cammino di San Giorgio è un mondo tutto interno al Centro in periferia. Pieno di toponimi dimenticati e bisognoso di una forte coscienza di luogo. Il camminare è diventato una forma assai diffusa di turismo lento e di conoscenza minuta del territorio, ed è nel farlo che spesso i piccoli paesi marginali diventano luoghi di riferimento importanti. Centri in periferia.
Come vedete il cammino di San Giorgio è un mondo tutto interno al Centro in periferia. Pieno di toponimi dimenticati e bisognoso di una forte coscienza di luogo. Il camminare è diventato una forma assai diffusa di turismo lento e di conoscenza minuta del territorio, ed è nel farlo che spesso i piccoli paesi marginali diventano luoghi di riferimento importanti. Centri in periferia.
Di Roberto Ferretti non ho le mail. Perché nel 1984 la posta elettronica, oggi a me assai cara, non era ancora nata e doveva attendere ancora quasi vent’anni per essere presente nelle nostre vite. Ma ho a casa il suo diario di campo relativo ad un progetto di ricerca da me diretto a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena, dove lavorò nel 1983 su leggende e fiabe. E possiedo anche una cartolina rara in cui la sua fotografia è accostata a Davide Lazzaretti, Giuseppe Trombetti, e Orlando Orlandini, un quartetto di ‘eroi culturali’ della Maremma toscana.
Cento fiori
I contributi di questo numero mostrano la grande diversità, pluralità, varietà di approcci che caratterizzano ancora oggi l’area concettuale, politica e geografica delle zone interne. Gli approcci si moltiplicano via via che scopro scritti, esperienze, libri. Non c’è un partito delle zone interne né del Centro in periferia. Sia nel senso che non c’è nessun partito politico che abbia adottato in profondità questi temi, ma anche nel senso che questo spazio di esperienza e di riflessione non ha la fisionomia di un movimento, non ha una linea, anche se ha vivaci dibattiti come quello sui borghi o sul rapporto tra pratiche economiche e simboliche o sui progetti di futuro. Ed anche io non ho una mia linea.
 Forse all’inizio del mio lavoro sul Centro in periferia, che nasceva da Armungia 2016, con la rete dei piccoli paesi, mi era parso di poterla identificare. Mi pareva che ci fosse una generazione, una comune ispirazione, una tendenza anche statistica al ritorno. Mi pareva che i ‘quarantenni’ che erano protagonisti potessero insegnarsi reciprocamente esperienze, come ad esempio le cooperative di comunità, e potessero avere comuni obiettivi da raggiungere. Ma già in questi otto anni ci sono stati riflussi, statistiche negative, eccessi di investimento istituzionale sul turismo e difetti di investimento sull’agricoltura, sulle green communities, sulle comunità energetiche, sulle comunità patrimoniali connesse a queste, oltre che l’assenza dei sindaci impegnati in altri loro progetti. Forse una volta rese palesi le iniziative locali legate al PNRR si potrà avere un quadro sulle nuove tendenze, o forse anche il senso di una occasione perduta. Intanto ne traggo la considerazione che il Centro in periferia come rubrica di Dialoghi Mediterranei, deve osservare, incoraggiare e capire. Deve fare sì che, rubando la frase alla grande campagna della Cina maoista del 56-57, ‘cento fiori fioriscano e cento scuole si confrontino’.
Forse all’inizio del mio lavoro sul Centro in periferia, che nasceva da Armungia 2016, con la rete dei piccoli paesi, mi era parso di poterla identificare. Mi pareva che ci fosse una generazione, una comune ispirazione, una tendenza anche statistica al ritorno. Mi pareva che i ‘quarantenni’ che erano protagonisti potessero insegnarsi reciprocamente esperienze, come ad esempio le cooperative di comunità, e potessero avere comuni obiettivi da raggiungere. Ma già in questi otto anni ci sono stati riflussi, statistiche negative, eccessi di investimento istituzionale sul turismo e difetti di investimento sull’agricoltura, sulle green communities, sulle comunità energetiche, sulle comunità patrimoniali connesse a queste, oltre che l’assenza dei sindaci impegnati in altri loro progetti. Forse una volta rese palesi le iniziative locali legate al PNRR si potrà avere un quadro sulle nuove tendenze, o forse anche il senso di una occasione perduta. Intanto ne traggo la considerazione che il Centro in periferia come rubrica di Dialoghi Mediterranei, deve osservare, incoraggiare e capire. Deve fare sì che, rubando la frase alla grande campagna della Cina maoista del 56-57, ‘cento fiori fioriscano e cento scuole si confrontino’.
Il senso di questo editoriale è semplicemente quello di fornire una cornice di riferimento alla diversità dei contributi pervenuti.
Il testo di Sandro Simonicca Aree protette, parchi e antropologi ci colloca nel cuore di un dibattito importante per l’antropologia, perché chiamata a riflettere su temi di grande rilievo come i parchi e a confrontarsi con i soggetti economici del territorio, per lo più diffidenti e gelosi dei loro interessi. Con questo testo si apre un dibattito molto interessante. Così l’autore sintetizza questa problematicità:
«Se si dovesse sintetizzare l’insieme dei temi qui indicati, direi che le tematiche delle aree protette riguardano culture locali il cui studio (e, con esso, il relativo impegno antropologico) registra un’evidente difficoltà di coniugazione fra spazi territorializzati, gruppi sociali e rapporto umano con la natura, con forte retroazione su quale stile etnografico sia da prediligere e su quale forma di advocacy antropologia fare propria».
Sulla stessa circostanza e sullo stesso tema era intervenuta Letizia Bindi https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/fragili-interstizi-etnografie-interspecie-pastorizia-agricoltura-aree-protette/, nel n.66 de Il centro in periferia.
Il testo di Giuseppe Lattanzi e Nicola Martellozzo, a partire dal museo dei confini nel Lazio meridionale di Sonnino, pone al centro la rilettura contemporanea dell’attività festiva, in sintonia con i temi di Gianluigi Bravo, già citati, e soprattutto con un tema che sta al cuore della dimensione del ‘Riabitare l’Italia’, quello degli aspetti sociali e simbolici che fanno da connettori della diversità di ruoli, aspirazioni e storie nelle comunità. Qui storia e presente vengono rivissuti dentro itinerari dal forte carattere di ricordo e ritorno in una storia comune. Ecco un brano:
«Più che mai paiono adatte le parole del compositore Gustav Mahler, per cui «la tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri». I sonninesi, in questo, si stanno dimostrando custodi attenti del fuoco delle loro torce, e soprattutto capaci di non congelare questa tradizione viva in una forma definitiva, e pertanto incapace di relazionarsi alla storia e ai valori in cambiamento della comunità. Oggi il nemico da cui difendere i confini di Sonnino non è più il paese vicino, ma l’oblio e la velocità con cui tutto passa».
Costantino Cossu, riflettendo sul caso di un piccolo paese sardo semi-abbandonato (Albagiara), ci racconta i momenti drammatici vissuti dalla comunità perché il governo approfitta dello spopolamento non per una rinascita delle comunità ma come luogo di scarico sociale e chimico di scorie. Un nodo che si verifica di frequente in Italia, dove la popolazione prescelta per questi abusi del suolo si batte, perché le scorie annullano la progettualità di un futuro possibile sul piano socio-economico e paesistico e riducono la popolazione del luogo al ruolo di guardiani di un presidio pericoloso. È nato un coordinamento dei comuni della zona e un comitato locale di lotta che si chiama: Poche storie, niente scorie.
Fabrizio Ferreri propone una riflessione e un rilancio del ‘pensiero meridiano’ come alternativa al tema delle zone interne visto come opposizione nord-sud e centrato su stili diversi di vita, di socialità e di pensiero. Ma il dibattito sulle zone interne non ha più ragione di essere centrato su Nord e Sud, dopo che si è constatato che le aree più spopolate d’Italia sono quelle del Nord alpino. La segnalazione e l’invito a riflettere sugli stili di vita è tuttavia sempre opportuno come anche le idee generali della vita con cui Ferreri conclude:
«La cultura occidentale si è formata sul calco della triade vero-bello-buono. Con l’apparato ideologico del capitalismo questa triade si è travasata in quella ben più brutale efficienza-bellezza- ricchezza. Il pensiero meridiano milita per un nuovo umanesimo, è pensiero del margine, della pausa, dell’incompiutezza. Il pensiero meridiano chiarisce che oggi o si riparte dagli ultimi o perdono tutti».
Olimpia Niglio segnala il dramma dello spopolamento denunciato da decenni ma sempre presente e sovente rinnovato da nuovi abbandoni e da temporanei e talora fittizi cambiamenti di direzione. I luoghi dell’abbandono chiedono di essere posti al centro di una riflessione etica ed estetica sul presente:
«Oggi tante le finestre che si aprono su questi paesaggi silenziosi e scrigni preziosi di tesori antichi che per fortuna la modernità non ha valorizzato perché diversamente avremmo perso anche le tracce di quella che è stata una produttiva comunità. Oggi non ci resta che riscoprirne i valori imparando a leggere i grandi libri di pietra caratterizzati dai borghi dove – come afferma Paul Valéry (1988:61) – “il futuro non sarà più quello di una volta”».
Due recensioni rilevanti allargano il quadro del Cip ad altri momenti della riflessione e del dibattito contemporaneo. Maddalena Burzacchi fa riferimento a una ricerca universitaria e a un convegno che ne è scaturito sui temi del ruralismo. Il suo resoconto è una rassegna accurata e ricca di indicazioni sui temi che sono sul tappeto. In specie segnala la lotta contro le monoculture agricole e una indagine cinematografica sull’estensione dei noccioleti ad uso industriale in Italia centrale. Eccone le coordinate:
«Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2024 si è svolto a Perugia, presso Palazzo Stocchi, il convegno “Illegale, informale, istituzionale. Neoruralismo e campagne globali”. L’evento, promosso dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università di Perugia e dalla Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli, è stato realizzato grazie ai contributi della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali (MIC) e del PRIN “Rethinking Urban-Rural Relations for a Sustainable Future” che ne ha costituito uno dei risultati dell’unità di ricerca di Perugia coordinata da Alexander Koensler».
Burzacchi segnala inoltre, in connessione con gli stessi partner universitari, l’uscita dell’ultimo numero della rivista Lares su “Economie informali: neoruralismo e filiere alimentari in Italia centrale”, a cura di Fabio Dei e di Dario Nardini, che recensiremo nel prossimo numero e i cui temi sono anticipati nel suddetto convegno di Perugia.
Giada Cerri dà conto di un volume dell’architetto Eleonora Martinelli in cui viene fatta una rassegna di vari progetti sociali e urbanistici legati all’ex OP di Firenze ‘San Salvi’ e racconta la battaglia che da anni viene condotta da parte della società civile col forte coordinamento del gruppo teatrale dei Chille de la Balanza, battaglia tesa a riqualificare quello spazio per non abbandonarlo alla speculazione edilizia, e per restituirlo invece all’uso pubblico e rendere pulsante la storia e la memoria degli ospedali psichiatrici.
In molti di questi scritti del CIP troviamo modi diversi di coniugare lo stesso tema dei ‘confini’, anch’esso centrale nella riflessione sul centro in periferia. I confini sono sia luoghi della storia vissuta che luoghi di esercizio del potere, e quindi spazi che vanno ripensati e riletti.
I due ultimi testi hanno una loro vita a parte dentro il CIP. Il contributo di Paolo Nardini è dedicato a ricordare Roberto Ferretti, studioso di tradizioni popolari di Grosseto e della Maremma. A distanza di quarant’anni dalla sua morte, Nardini continua a elaborare un lutto che anche io condivido. Nel raccontare la vita e il lavoro di Ferretti, lo scritto assume l’andamento di un lamento funebre, una evocazione della presenza ormai mancante. O almeno così io lo sento, convinto che del pianto funebre nelle sue varie forme abbiamo ancora bisogno.
Il contributo di Sandra Ferracuti chiude gli Atti del convegno Ci sono case che sono musei, ci sono musei che sono case, svolto il 20 e 21 ottobre del 2023 nel Museo Guatelli. Il tema trattato da Ferracuti è legato sia alla sua esperienza di museografa in un museo etnologico tedesco, sia alla riflessione su quale sia la giusta ‘casa’ degli oggetti etnologici in relazione alla violenza storica del colonialismo. Tema quest’ultimo vivo e dolente nella museografia e nella coscienza europea dove permane intorno agli oggetti e ai musei il dolore della violenza coloniale e la domanda di dove gli oggetti si ‘trovino a casa’. Ferracuti propone un esempio che riguarda il complesso rimpatrio di oggetti provenienti dalla Namibia e cerca di mostrare che la restituzione non è che l’inizio di un percorso corretto perché senza di questo la museografia europea, erede del colonialismo, non farebbe che ‘sbarazzarsi’ delle cose mentre il vero processo di repatriazione chiede accompagnamento, cura e spirito critico. Chiede inoltre disponibilità a imparare dagli oggetti e dal loro complesso ritorno a casa. Ferite ancora aperte.
Figurarsi
Figurarsi. Non è certo possibile rendere compatibili le ferite aperte e il bisogno di riscatto dell’Europa con il tempo che viviamo. La mentalità neocoloniale del nostro governo e il suo piano Mattei (denominazione che l’interessato forse non avrebbe gradito), lo scenario in cui la nostra Presidente del Consiglio chiama intollerabile violenza quella degli studenti che protestano contro la politica militare di annientamento adottata dal governo israeliano è davvero paradossale. Anche per chi si occupa di aree interne e di riabitare l’Italia sono tempi difficili. Non c’è trasparenza sugli usi del PNRR, e il governo sta cercando di gettare una gigantesca rete per intrappolare il mondo culturale più attivo, accentuare pratiche autoritarie, far diventare perentorie e quasi normative opinioni di rilevante pochezza. Per la sinistra della tradizione gramsciana, l’egemonia consisteva nella capacità di creare nuova cultura e di conquistare ad essa nuovi strati sociali, basandosi sulle idee, sulle discussioni, sul pluralismo. Per la destra l’egemonia è fatta di divieti, di allarmi, di negativizzazione di ogni voce che si levi dal basso, di censure, di silenzio pubblico su tanti scenari della politica.
Alcune conquiste degli ultimi sessanta anni sono messe a dura prova e rischiano di essere spazzate via. La destra si addestra a governare in modo autoritario, tacciando di terrorismo tutti coloro che non condividono il proprio punto di vista. A criminalizzare azioni che negli anni ’60 e ’70 erano il segno della salute e della vitalità della società civile. Cerca di far diventare regola la chiusura al mondo migratorio e cerca di eliminare via via gli strumenti di integrazione, anche in modo vistosamente contrario ai bisogni di una economia che ha fame di lavoratori migranti. Attacca la legislazione sull’aborto, la magistratura, il pluralismo del voto elettorale, rilancia la scuola delle disuguaglianze, del silenzio della critica, dell’autorità che viene dall’alto del potere burocratico Che dire poi dell’indicazione che le classi scolastiche non siano in maggioranza costituite da stranieri quando in centinaia di realtà locali le scuole sono attive grazie alla loro presenza. E bisogna capire che oltre alla Quaresima c’è anche il Ramadan: bisogna accogliere la cultura religiosa dei giovani migranti come obbligo etico per ogni società aperta.
A proposito del clima politico che aleggia intorno a noi, il Ministro Valditara ha attaccato molto duramente un docente fiorentino che ha espresso su facebook – con parole forti ma radicate nella cultura toscana – un giudizio negativo sul nuovo nome del Ministero della Pubblica Istruzione e del merito, il Ministro lo ha sospeso per una settimana per dare il segnale che gli insegnanti debbono tacere o rischiano sanzioni. La critica alla nuova denominazione è stata condivisa da tutta la cultura pedagogica e didattica italiana, anche nel ricordo di Don Milani e di Tullio De Mauro. Dare sanzioni amministrative a un docente, che, riconosciuto da colleghi e studenti, fa il suo dovere con passione, per avere scritto nella sua pagina facebook un ‘porcoiddio’ come protesta contro il merito sembra un ritorno alla religione di Stato. Il Ministro ha agito con l’intenzione di mostrare che è finita “la pacchia”, pacchia che sarebbe poi la libertà di parola.
In questo scenario ho visto con inquietudine e timore un convegno alla Camera dei Deputati, Poesia a braccio. Arte e improvvisazione. Il Convegno, interamente gestito dalla destra politica, con una netta prevalenza di appartenenti ai Fratelli d’Italia, era dedicato alla poesia improvvisata. Erano presenti il Ministro Sangiuliano, il deputato Mollicone, il deputato Trancassini, il sindaco di Rieti, tutti di FdI, e l’antropologo Mario Polia, che è forse la presenza più inquietante. Alla voce di Wikipedia che lo riguarda (probabilmente fatta da lui), si vede che Polia non fa parte della comunità scientifica e si è promosso antropologo da solo, anche se è laureato in archeologia e insegna antropologia in una Università religiosa. Vale la pena di perdere un po’ di tempo per leggere il suo profilo politico di destra estrema che appare anche su You Tube.
A questo punto ci si domanda perché la poesia improvvisata viene promossa dalla destra? Mollicone, Presidente della Commissione VII della Camera: Cultura Istruzione Scienza Ricerca Editoria Sport, non ha sentito il bisogno di fare una iniziativa di profilo più ampio, di affidarsi a degli studiosi più esperti di improvvisazione poetica, ma ha inteso collocare l’improvvisazione poetica nell’area della destra (dove non è mai stata volentieri). Può darsi che tutto questo abbia a che fare con la campagna elettorale attiva in molti comuni del Lazio, può darsi che sia un tentativo di usare politicamente i temi della cultura immateriale e riproporli come parte del loro mondo politico-culturale. È quasi un atto di predazione. Penso che non sia proprio il caso di lasciare in mano alla destra l’improvvisazione poetica. I poeti giustamente vanno dove vengono invitati, ma noi che guardiamo dall’esterno non abbiamo il diritto se non il dovere di restare esterrefatti e di protestare vivacemente?
Lucano
Testimone e vittima della gestione che dell’emigrazione fece Salvini da ministro, aggredito e messo sulla strada, Mimmo Lucano, scagionato, si ricandida a Riace alla carica di sindaco. Comunque vada, Lucano entra nella categoria dei perseguitati dal potere della destra, vittima di parole d’ordine assurde e di leggi intese a massacrare e non integrare gli immigrati. È ancora la filosofia di questo governo, costruire campi per rinchiudere e poi rispedire a casa persone sofferenti, salvate dalle Ong e recluse dal governo dopo viaggi vicini alla morte. E per non farci vedere questi emigrati, si pagano anche i Paesi vicini perché gestiscano loro le strutture di reclusione. Non c’è in Europa oggi speranza che il loro destino sia diverso, ed è un grande peso per la democrazia che proclamiamo. In questo scenario Mimmo Lucano è una piccola luce di speranza. Auguri Mimmo.
Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024
_____________________________________________________________
Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale. Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014); Raccontami una storia. Fiabe, fiabisti, narratori (con A. M. Cirese, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021); Tra musei e patrimonio. Prospettive demoetnoantropologiche del nuovo millennio (a cura di Emanuela Rossi, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021); I Musei della Dea, Patron edizioni Bologna 2023). Nel 2018 ha ricevuto il Premio Cocchiara e nel 2022 il Premio Nigra alla carriera.
______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/echi-di-paesi-e-di-convegni/
Click here to print.