Nomi di piante e nomi di santi. San Giovanni nella lessicografia botanica siciliana
Posted By Comitato di Redazione On 1 gennaio 2022 @ 02:51 In Cultura,Società | No Comments
di Marina Castiglione
Si fachisti o fachisti fari incantacioni/ad erbi oy cristalli, oy ad alcunu di li elementi,/oy orbiscasti in lu jornu di la/natività di Sanctu Joanni Baptista,/et altri mali cosi chi si fannu in tali jornu.
(Confessionale del XV sec., in G. Pitrè Spettacoli e feste popolari siciliane, 1881: 298)
Ventiquattro di Giugno, San Giovanni. Era per gli Alcaresi la festa del Muzzuni,/e festeggiare soleano nei quartieri quelle piccole brocche e i germogli,/con canti e danze fino a notte alta./Si scioglievano allor le inimicizie, si intrecciavano gli amori, i comparaggi.
(Vincenzo Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio).
«Come osserva Zamboni [1] (1976: 53), il settore botanico è uno degli ambiti che più si presta a “connessioni e sviluppi di tipo latamente folclorico e, in ultima analisi, di vera ed autentica storia di cultura e di civiltà”. Il mondo naturale, nella sua articolazione di flora e fauna, è, infatti, la prima fonte del sapere popolare: rimedi terapeutici, usi delle piante per la costruzione di manufatti, storie magiche ecc.».
Così, con Roberto Sottile, cominciavamo un nostro lavoro a quattro mani [2] presentato al Convegno sul lessico e gli etnosaperi dell’Università di Cosenza svoltosi nel 2009. In quella circostanza ci occupammo di indagare alcune connessioni tra la botanica e i caratteri umani, filtrati attraverso le locuzioni idiomatiche (es.: ristari urmu), il lessico comune (ess. carduni, salacuni, ecc.), l’onomastica (ess. Piràino, Carciopolo, ecc.). In seguito non ci fu più occasione di tornare ad applicare il metodo iconimico a questo interessante campo di studio, ma di recente è tornato ad occuparsene con pregevoli risultati Alfio Lanaia, all’interno del suo volume Le parole nella storia [3]. In un capitolo integralmente dedicato alle piante [4], il dialettologo catanese affronta i seguenti concetti: i cavolicelli, i taḍḍi, le fave di Baia, le pale dei fichidindia, le pere ucciardone, il bagolaro, la senape, la vruca e la tamerice, l’acanto, gli asfodeli, i “piumini” della barba di becco e di altre piante. Basterebbe partire da quest’ultimo esempio per rendersi conto di come un referente naturale, il cui stesso nome italiano è sconosciuto ai più, possa contenere, nella lessicografia dialettale, mondi di riferimento che oggi sono scomparsi, poiché a venir meno è stato, insieme al dialetto, anche il rapporto fisico con il territorio, con il mondo vegetale e persino con quello animale (se non addomesticato e ridotto a “pet”) [5].
Nel caso specifico, non c’è chi non abbia il ricordo di un’esperienza campagnola legata all’inseguimento di uno di quei fiocchi vegetali, bianchi, che in mano hanno la consistenza di un piumino lanuginoso leggero e aereo. Si tratta dei ‘pappi’ [6], infiorescenze che trasportano al vento i semi di numerose piante, dai pioppi ad alcuni arbusti palustri come la mazzasorda. In Sicilia prendono il nome di gattareḍḍi, arrobbadinari/arrobbasordi, nannu. Il primo tipo lessicale coincide con quello di altri dialetti, come il romagnolo ‘gattini’. Tale slittamento lessicale dal mondo animale a quello vegetale non è anomalo, in quanto – nell’esempio citato – il passaggio semantico si muoverebbe lungo la somiglianza tra i ciuffi del gatto (e, in generale, del pelo animale) e l’infiorescenza pelosa della pianta [7]. Il caso di arrobbadinari/arrobbasordi recupera, invece, uno sfondo culturale connesso all’immaginata presenza di folletti dispettosi, in questo caso materializzati sotto forma di ciuffi che, al passaggio, avvolgono piccoli tesori sottraendoli ai legittimi proprietari.
L’assenza di un nome proprio testimonia di un uso presente in numerose comunità tradizionali, ossia quello della tabuizzazione del nome soprattutto relativamente a figure connesse al soprannaturale [8], indicate in maniera generica. In questo lessema composto, la motivazione è trasparente: sia che si tratti di arrobbasordi (presente nell’area ennese) o di arrobbadinari (più diffuso nella Sicilia occidentale), i pappi rientrano in una visione magica del mondo. Un passo indietro, culturalmente parlando, dobbiamo fare quando si cerchi l’iconimo di nannu, forma catanese [9]:
«La letteratura etnografica ci spiega che in passato i ragazzini, dopo avere rincorso questi nanni che giravano per aria, vi soffiavano sopra e se questi, planando, si depositavano nei loro vestiti e vi aderivano, credevano che l’anima di un loro vecchio parente defunto era venuto a visitarli. Il fatto è ancora più interessante se si considera che il nome del ‘pappo’, nannu, si può considerare un calco dal greco páppos ‘nonno, avo’ e anche ‘pappo, leggera appendice piumosa a forma di pennacchio che si stacca da certe piante’. Come si sarà ormai intuito, inoltre, da questo nome, attraverso il latino pappu(m), deriva l’it. pappo» (Lanaia cit.: 128).
La leggerezza delle anime dei defunti e la loro presenza in terra come figure protettrici risale a visioni animiste ancora oggi rivelate dalla lingua, ad esempio nella corrispondente radice di avis e di avus. La lettura di Lanaia, così come quella tentata nel lavoro del 2010 con il collega Sottile da cui si è partiti, affonda la sua matrice nella cosiddetta etimologia motivazionale che ha avuto in Mario Alinei il maestro indiscusso e che vede nel “riciclaggio” di elementi linguistici del patrimonio collettivo la chiave per interpretare la genesi di alcuni significati [10].
 Gli iconimi e il battesimo del mondo naturale
Gli iconimi e il battesimo del mondo naturale
Proprio a Mario Alinei si deve l’idea che alcune porzioni del lessico della nostra lingua siano più conservative di altre e che esse manifestino traccia, nelle circostanze più fortunate, delle diverse stratificazioni iconimiche prodottesi secolarmente. A ciascuna stratificazione corrisponderebbe uno stadio evolutivo che va dal mondo animistico-parentelare, a quello magico, sino a quello legato, infine, al cristianesimo (popolare) [11]. Un esempio classico è quello che si evince dai nomi attribuiti popolarmente a diversi animali. Secondo Alinei (2009: 360), le principali categorie zoonimiche rilevabili nei dialetti italiani, possono essere considerate tre:
1) {entità MAGICO–RELIGIOSE CRISTIANE};
2) {entità MAGICO–RELIGIOSE PRE–CRISTIANE};
3) {parenti}.
La classificazione è stata efficacemente avvalorata dai dati dell’ALE (Atlas Linguarum Europae) [12] e dell’ALiR (Atlas Linguistique Roman) [13] e da numerosi studi di zoonimia popolare, italiani e stranieri.

Tab. 1 Le tre principali categorie tipologiche di iconimi zoonimici:
cristiani, pre-cristiani, parentelari (Alinei 2009: 361, riprod. parziale)
Come si evince dallo schema, le forme lessicali zoonimiche connesse con la fase del cristianesimo popolare si manifestano prevalentemente sotto forma di agiozoonimi connessi a devozioni variegate (S. Giovanni, S. Nicola, S. Pietro, S. Lucia, S. Antonio, ecc.); la seconda fase, invece, si declina lessicalmente con forme comuni connesse a streghe, spauracchi, folletti, ossia figure legate al mondo magico; la terza, che però corrisponde alla prima considerando un ordine d’antichità, presenta forme parentali (mamma, sposa, comare, nonna, zio, ecc.). Questa fase coincide con un antico stadio di solidarietà tra uomo e natura, sicché l’animale diventa un membro della famiglia e come tale viene rispettato e persino sacralizzato, penetrando spesso nei racconti orali sotto forma di nume tutelare [14]. La sequenza, pertanto, che va dall’animismo al cristianesimo, prevede un “battesimo” della natura selvatica e degli esseri che la popolano: non più parenti da ascrivere alla stessa famiglia umana, non più esseri del mistero e della paura di un mondo popolato da streghe e spiriti funesti, ma finalmente esseri divini che condividono il progetto della creazione per servire gli uomini e proteggerli.
Se nei suoi studi sembra esserci uno spazio preferenziale per la zoonimia, Alinei, però, non esclude altri ambiti:
«[…] nella misura in cui la prospettiva iconomastica, ampliando enormemente l’orizzonte della ricerca etimologica, riesce a penetrare nel passato più remoto, si scopre anche che in quella nostra fase evolutiva l’intera realtà — animali, piante, natura, malattie, morte, strumenti di lavoro, giochi, e così via — veniva lessicalizzata in chiave magico-religiosa» (Alinei 2009: 433).
Le piante, quindi. Gli iconimi delle piante sono spesso trasparenti, quando non si ricorra alle classificazioni linneane e ci si muova sul terreno linguistico delle denominazioni popolari o usuali: ‘girasole’, ‘dente di leone’, ‘biancospino’, ‘stella alpina’, ‘barba del becco’, ecc. In tal caso siamo in presenza di forme descrittive che ricavano la propria forma dall’altitudine presso cui vegetano, dal dato cromatico, da una particolare conformazione, nulla, però, che faccia pensare all’attribuzione di poteri speciali, taumaturgici o magici o che riconduca la pianta ad una devozione peculiare.
Eppure, il mondo vegetale è gravido di sensi simbolici e di riferimenti che travalicano le culture e le sensibilità, in cui tradizione popolare e tradizione colta svolgono ruoli di pari legittimità e si rafforzano reciprocamente. Si pensi all’albero di fico [15]:
«Il fico, come albero e come frutto, ha una vastissima simbologia, cangiante se non contraddittoria come tutte le simbologie tenute prive di testualizzazione. […] In quanto albero il fico è emblema di vita, abbondanza, serenità, immortalità: pianta che mette in comunicazione la terra con il cielo. Sotto di esso sembrano siano nate alcune divinità indù e non solo, come anche Romolo e Remo. C’è un che di fondativo nell’albero di fico, come nel frutto. Allegoria frequente dell’organo genitale femminile, il frutto del fico rimanda all’eros ma anche al peccato, come a dire a una sessualità morbosa, eteroclita, esaltante come mortifera. Intere tradizioni di ermeneutica sostengono che il frutto del peccato offerto da Eva ad Adamo fosse un fico piuttosto che una mela. E, del resto, è con foglie di fico che i nostri due primi esseri umani, appena cacciati dall’Eden, coprono la loro nudità. […] E il fico diviene così, implicando un andirivieni incessante fra colpa e redenzione, nudità e rivestimento, natura e cultura, il simbolo stesso della conversione, della trasformazione ininterrotta del valore dei valori» (Marrone, 2021: 40-41).
Se nel mondo classico il bosco ha rappresentato il luogo in cui si insegnava o si cercava la pace (l’Accademia platonica nasce tra olivi e platani) e per sfrondare un bosco sacro occorreva produrre riti di espiazione, il cristianesimo desacralizza la natura, quasi la avversa, e tra i boschi costruisce narrazioni di blasfemia e stregoneria. Le stesse narrazioni orali fanno del bosco il luogo della perdita e del pericolo e degli alberi i potenziali inghiottitoi verso gli inferi [16]. Sotto gli alberi tribunalizi, però, nel Medioevo, si esercita anche la giustizia terrena: la locuzione siciliana lassari all’urmu, analizzata e spiegata nel 2009 nell’articolo che si è citato ad incipit, ne è una traccia linguistica ancora attiva, anche se dispersa nel metaplasmo da sostantivo (urmu, ‘albero dell’olmo’) ad aggettivo (urmu, ‘uomo che non ha bevuto, scusso’).
La nominazione del mondo vegetale, dunque, non può essere estranea ad una intrecciata relazione tra etimi e motivazioni, in una alternanza di demotivazioni e rimotivazioni che però sono più complesse da tracciare rispetto a quelle dei loro “fratelli” zoonimi, non foss’altro per la grande varietà di specie non sempre distinguibili nelle tassonomie popolari, tant’è che lo studio del sistema della flora è meno praticato [17].
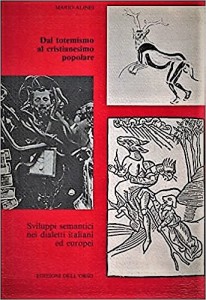 Gli agiofitonimi nella lessicografia siciliana
Gli agiofitonimi nella lessicografia siciliana
In una dimensione solidale tra uomo e ambiente naturale, la conoscenza delle piante era un presupposto innanzitutto di sopravvivenza. Dalla raccolta delle erbe e dei frutti spontanei si attingevano sostanze alimentari; dalle piante si ricavava il legno e si estraevano fibre da impiegare per la produzione di oggetti materiali: corde, ceste, tessuti; nei vegetali erano depositate anche proprietà taumaturgiche utili all’uomo e alle bestie.
Elementi vegetali penetravano anche nelle narrazioni orali: le infiorescenze [18] o altri elementi [19] costituivano spesso il primo emistichio degli stornelli e su di essi si plasmava la rima; erano l’elemento di paragone rispetto alle bellezze della donna (di volta in volta assimilata ad un giglio, un garofano o ad una rosa); apparivano nelle fiabe anche attraverso l’onomastica femminile (Majurana, Marvìzia, Bianca Cipudda, ecc.) [20]; costituivano la risposta di molti indovinelli [21]. L’individuazione delle piante nell’ecosistema circostante era, dunque, garanzia di fruizione di una materia prima accessibile e, come tale, andava trasmessa anche alle generazioni future attraverso un chiaro e inequivocabile sistema di nominazione.
Le denominazioni popolari si costruiscono generalmente con un composto endocentrico costituito dal nome generico dell’erba/albero/fiore/ortaggio seguito da un aggettivo portatore di una qualche caratteristica della pianta stessa (o del frutto) o da un etnico di provenienza. La struttura, dunque, non è dissimile da quella della classificazione scientifica che distingue il nome del genere, seguito da un termine che di norma è un aggettivo descrittivo (anche un etnico) o un aggettivo derivato dallo scopritore della varietà (ess. Homo sapiens, Euphorbia pulcherrima o Adonis cupania, dal nome di Francesco Cupani [22]). In alcuni casi, invece, si ha un’unica forma costituita o da un lessema semplice (es. sic. zarchi, bietole [23]) o da un composto univerbato (es. sic. pisciacani, per diversi tipi di piante selvatiche, tra cui la Sinapis pubescens).
Provando a individuare gli iconimi che stanno alla base del “battesimo” della vita vegetale, è facile riscontrare forme generiche come erva diàvula (Diplotaxis muralis), erva angelica (Angelica sylvestris) o erva biniritta (Geum urbanum), erva di Santa Cruci (Nicotiana tabacum), o, ancora, erva di la Trinità (Viola tricolor). Sono presenti anche tipi lessicali più descrittivi, che rimandano soltanto esteriormente all’ambito religioso, come ad esempio varva di parrini (Plantago lanceolata) o vastuni di lu patriarca (Celsia eretica).
Compulsando il più importante repertorio dialettale del siciliano, ossia il Vocabolario Siciliano (VS) ideato da Giorgio Piccitto [24] che collaziona tutte le forme registrate nei vocabolari editi e inediti, oltre che forme reperite sul campo con il metodo del questionario per corrispondenza [25], abbiamo individuato un numero non alto di agiofitonimi, nella forma semplice o derivata. Da alcune motivazioni esplicitamente riportate dalle fonti primarie, sembra che il “battesimo” della natura non sia la causa di queste denominazioni, legate piuttosto alla cadenza stagionale della loro maturazione e raccolta:
|
Nome del santo |
Festività calendariale |
Fonte |
Forma linguistica |
Varietà di pianta |
Motivazione |
| Agata | 5 febbraio | Tr., Pe. | erva sant’Àita | bugula: Aiuga reptans |
// |
| Andrea | 30 novembre | Can. | àrvulu di sant’Andrìa | loto falso: Diospyros lotus |
// |
| Anna | 26 luglio | PA 50 | santanna (pessica i s.) | var. di pesche; |
// |
| Can. | santannisi | var. di pere;var. di nocciuole | |||
| Can. | çiuri di sant’Anna | camomilla bastarda: Anthemis arvensis | |||
| Antonio | 13 giugno | Can.: CT 41 | çiuri di sant’Antòniu | giglio di sant’Antonio: Lilium candidum | maturano nella seconda metà di giugno |
| CT 12-14 | santantoni | var. di ciliegie duracine | |||
| Can., Pe. | erva di sant’Antoniu | piantaggine: Plantago maior | |||
| Apollonia | 9 febbraio | Pa., Can. | erva di sant’Apollònia | Ranunculus bullatus e asiaticus | // |
| Barbara | 4 novembre | Can. | erva di santa Bbàrbara | Barbarea vulgaris |
// |
| Benedetto | 21 marzo | Can. | erva di san Binirittu | Geum urbanum |
// |
| Caterina | 25 novembre | CT 12 | pire santa caterina | var. di pere | maturano o si raccolgono nell’ultima decade di novembre |
| CL 5 | ggigliu di Santa Caterina | giglio | |||
| Can. | fiuri di santa Caterina | fanciullaccia: Nigella damascaena | |||
| Cosimo | 27 settembre | Can., Pe. | erva di san Còsimu | calendula: Calendula arvensis |
// |
| Cristoforo | 25 luglio | Can.Can. | erva di san Cristòfalu | Althaea spicatapolmonaria: Polmonaria officinalis. |
// |
| Domenico | 8 agosto | Can., Pe. | erva di sannumiricu | vescicaria: Cardiospermum halicacabum |
// |
| Eligio | 1dicembre | Can.: TP 15 | erva di sant’Aloi | Ammi creticum |
// |
| Filippo | 3 maggio | Dr. | erva di sanfilippu | tiglio: Tilia cordata |
// |
| Can. | erva di san Fulippu | abete: Abies alta | |||
| Tr. | àrvulu di san Filippo | abete rosso: Picea excelsa | |||
| Francesco | 4 ottobre | Pe.: Etna | amureddu di san Franciscu | la pianta e il frutto del lampone: Rubus idaeus | sanfranciscanu: di legumi e frutti di cui mette in evidenza il colore violaceo del tegumento o della buccia (in riferimento al colore del saio francescano) |
| Dr. | erba di sanfranciscu | var. di borragine | |||
| Can.:AG 22/RG7 | fasola/casola sanfranciscana | var. di fagiolo | |||
| Can: AG 22 | ciciru sanfranciscanu | var. di cece | |||
| Can: CT 41 | favi sanfranciscani | var. di fava | |||
| Can: CT 41 | aliva sanfranciscana | var. di oliva | |||
| Can: AG 32 | rracina sanfranciscana | var. di uva violacea | |||
| Can : RG 6Tr., NU, CT 7 | ficu sanfrancischina | var. di fico di color scuro | |||
| Tr., Pe. | erva di san franciscu (o erva di gammi malati) | bugula: Aiuga reptans | |||
| Giacomo | 25 luglio | Can. | çiuri di san Iàbbicu o anche çiuri di san Giàcumu | Senecio Iacoboea |
// |
| Can. | erva di sagnàbbicu | Senecio Iacobea | |||
| Pe.: CT 41, Can. | varva di sagnàbbicu/sagnàpicu | narciso marino, pianta delle amarillidacee | |||
| Giorgio | 23 aprile | Can. | erva di san Giòrgiu | valeriana: Valeriana officirtalis |
// |
| Giovanni | 24 giugno | Ca. | çiuri di san Giuvanni | caglio: Galium verum |
// |
| Pe. | erva di san Giuvanni | Campanula fragilis | |||
| Can. | erva di san Giuvanni | Nepeta glechoma | |||
| Can. | erva di san Giuvanni | Sedum maximum | |||
| Pi. | varva di san Giuvanni | Campanula gracilis | |||
| Can. | vastuni/vastuneddu di sanciuvanni | Polygonum orientale | |||
| PA 1 | sanciuvanni | var. di pera selvatica | |||
| Can.: AG 19 | rracina di sangiuvanni | var. d’uva | |||
| Tri. | cacciòffulu di San Giuvanni | cardo selvatico: Dipsacus silvestri | |||
| Can.: PA 41 | prunu sangiuvanni | var. di susina | |||
| ME 12 | pira sangiuvanni | var. di pera | |||
| CT 12 | pir’i sangiuvanni | var. di pera | |||
| CT12 | pum’i sangiuvanni | var. di mela | |||
| CAN: TP 11/Le.: RG4 | ficu sanciuvannara | var. di fichi | |||
| Can.: SR 12, TP 11 | piru sanciuvannaru | var. di pera | |||
| PA 50 | prunu sanciuvannaru | var. di susina | |||
| Can.: SR 12, TP 11 | pumu sanciuvannaru | var. di mela | |||
| Can.: CT | fastuca sangiuannara | var. di pistacchio | |||
| Can.; CT 4 | nucidda sangiuvannara | var. di nocciòlo precoce | |||
| Can.: SR 5, RG 6; SR 16, RG 11 | ficu sangiuvannara | var. di fico | |||
| Can.: AG 5 | fava sangiuvannara | var. di fava | |||
| Can.: SR 12, AG 33, 35, 40; SR 16 | piru sangiuvannaru | var. di pera | |||
| Can.: SR 12, AG 33, 35, 40 | pumu sangiuvannaru | var. di mela | |||
| Giuliano | 27 gennaio | Can. | erva di san Giulianu | Satureia iuliana | |
| Giuseppe | 19 marzo | Can. | çiuri di san Giuseppi | Littoria triphylla |
// |
| Pe. | çiuri di san Giuseppi | Littoria vulgaris | |||
| Can. | çiuri di san Giuseppi | Adonis flammeus | |||
| Can. | çiuri di san Giuseppi | Adonis aestivalis | |||
| Can | çiuri di san Giuseppi | oleandro: Nerium oleander | |||
| Me | çiuri di san Giuseppi | giaggiolo: Isis germanica | |||
| ME 35 | hiùr’i sanciuseppi | narciso (pianta delle Amarillidacee) | |||
| Pe. | erva di san Giuseppi | Agapantus umbrellatus | |||
| Can. | vastuneddu di san Giuseppi | giaggiolo | |||
| Pe. | vastuni di san Giuseppi | Allium trifoliatum | |||
| Can. | vastuni di san Giuseppi | Nerium oleander | |||
| CT 38, PA 50 | vastuni di san Giuseppi | asfodelo | |||
| Can. | vastuni di sanciuseppi senza truncu
[26] |
fior bambagio: Allium Chamae- moly | |||
| Lorenzo | 10 agosto | erva di san Lorenzu | bugula: Aiuga reptans |
// |
|
| Lucia | 13 dicembre | Pe | erva di santa Lucìa | Salvia clandestina |
// |
| Can. | àrvulu di santa Lucìa | ciliegio canino: Prunus mahaleb | |||
| Marco | 25 aprile | Can. | çiuri di san Marcu | girasole: Helianthus anmius |
// |
| Tri. | erva di san Marcu | Cardamine hirsuta | |||
| Maria [27] | // | Tr. | erva santamaria | erba amara ma non disgustevole |
// |
| Can.: CL 16, AG 2, 7, 19 | santamaria | var. di fico | |||
| Tr.; Pe. | erva di la Madonna | scalderona: Salvia sclarea; vetriola: Parietaria officinalis | |||
| Can. | erva di la Maronna | spino giallo: Centaurea solstitialis | |||
| Martino | 11 novembre | Can. | çiuri di san Martinu | Meria peregrina |
// |
| Tr./Man./ SN: CL 2, 3, 8, AG 9; ME 85, CL 6, PA 43 | sammartinara | var. di frumento (di buona qualità; bianca e grossa; a spiga nera) | |||
| Tr. | sammartinaru | var. di cavolfiore | |||
| Mercurio | 25 novembre | Pe. | erva di san Mircèriu | Torilis nodosa |
// |
| Michele | 29 settembre | Can. | çiuri di san Micheli | zafferano bastardo: Colchicum autumnale |
// |
| Nicola | 6 dicembre | SR 16 | sannicola | liquirizia |
// |
| Paolo | 29 giugno | EN 5 | sampàulu / sampaula | var. di frumento |
// |
| Pietro | 29 giugno | DB | erva di sampetru | Mentha graeca | che matura nei giorni in cui si festeggia San Pietro |
| CT 9 | sampetru | senecio: Senecio vulgaris | |||
| Can. | sampetru | Senecio iacobea | |||
| Can. | sampetru | Chrysantbemum balsamita | |||
| CT 12 | prunu sampitraru | var. di susina | |||
| CT 12 | cirasa sampitrara | var. di ciliegia | |||
| CT12 | cirasa sampitrota | var. di ciliegia | |||
| Can.: CT 9; CT 37 | cirasa sampitrisa | var. di ciliegia | |||
| Rocco | 16 agosto | An. | erva di san Rrocco | Pulicaria dysenterica | |
| Simone | 28 ottobre | Can. | erva di san Simuni | Malva rotundifolia | |
| Stefano | 26 dicembre | Can.: PA 41 | erva di santu Stèfanu | Circaea lutetiana. | |
| Tommaso | 3 luglio | Pe. | erva di san Tumasi | Bauhinia scandens | |
| Venera | 26 luglio | Can.: CT 14; CT 12 | pèrsich’i santavénnira | var. di pesche |
Caso diverso è l’attribuzione a ben tre santi di una pianta erbacea perenne che cresce lungo i sentieri o nei campi incolti, la Bugula (Aiuga reptans). Anche in italiano essa è detta “erba di san Lorenzo”, ma dalle fonti indirette incamerate nel VS, essa può essere identificata con l’erva di sant’Àita, l’erva di san Franciscu e l’erva di san Lorenzu. Un geosinonimo diffuso della Bugula è erva di gammi malati, che abbina in stretta connessione la patologia e il rimedio terapeutico offerto dalla pianta: infatti, nella medicina popolare le foglie erano impiegate per trattare le emorragie, le piaghe da decubito, ma anche per combattere le intossicazioni epatiche grazie ad un effetto antinfiammatorio. Gli agiofitonimi costituiscono una spia del «legame tra mondo cerimoniale e vegetale […(caratterizzato da)] una nomenclatura simbolica semanticamente correlata all’universo botanico»[28]. La proprietà terapeutiche, quindi, possono essere la manifestazione di una potenza ultraterrena, sebbene ciò non sia particolarmente frequente nelle piante officinali in Sicilia, o quanto meno non appare tra le informazioni desumibili dai lessici editi ed inediti.
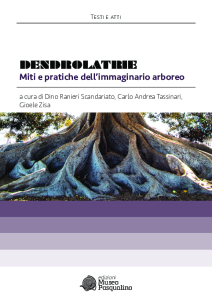 Un’analisi semasiologica a partire da un’assenza
Un’analisi semasiologica a partire da un’assenza
Tra tutti i casi che emergono dall’elenco, il più interessante ci sembra quello legato a san Giovanni, non tanto per ciò che c’è, quanto per ciò che manca. A san Giovanni Battista, la cui festività coincide con la nascita presunta del santo, il 24 giugno, vengono collegati frutti, ortaggi, fiori [29]. Tra le varie presenze di questo agionimo, nella lessicografia siciliana manca quello relativo all’iperico, sebbene sia innegabile che l’arbusto fiorisca proprio in concomitanza con la festività del Santo, a fine giugno. Comunemente, però, l’Hypericum perforatum è detto proprio “erba/fiore di san Giovanni” [30]: i boccioli e i fiori freschi raggruppati in corimbi, di color paglierino, vengono utilizzati ‒ essiccati o macerati ‒ per diversi malesseri, dalle malattie della pelle agli stati depressivi [31]. Dalle vescicole oleose delle foglie si secerne un liquido rossastro, l’ipericina. Le sue proprietà terapeutiche e magiche sono note sia in area mediterranea che continentale, tanto da essere connessa a riti druidici [32].
Nel volume dedicato alla medicina popolare, Giuseppe Pitrè registra una voce galloitalica, raccolta a Nicosia, ossia curdùn di San Giovanni (Torilis nodosa) [33], e la elenca tra le numerose erbe vulnerarie, ossia con potere cicatrizzante, in analogia con l’iperico. Se però si cerchino espressamente informazioni su questa pianta, si individuano le seguenti ricette:
-
Ogghiu d’addàuru, olio nel quale è stata infusa qualche bacca d’alloro, aggiuntovi qualche fiore di piricò, iperico (Hypericum perforatum, L.) (Montevago): 308-309
-
Ogghiu di pericò[34], olio nel quale sono infusi fiori o foglie di iperico raccolti nella notte di S. Giovanni (Trapani). Nella bollitura si riduce l’olio ad una terza parte (Mazzara): 309
-
Olio d’iperico ed olio di aricchiedda d’apa: tre foglie fritte in olio d’oliva. L’effetto è mirabile sulle piaghe dei bambini (Palazzo Adriano): 314
-
Gargarismi di infuso di piricò o erva di S. Giuvanni, iperico (Palermo), o di vino, nel quale sia stata bollita della suola nuova (Terranova), o di aceto bollito, infusevi due pietre focaie (Villalba), o di decozione di paglia od anche di franta sarvaggia (Rubus cupanianus) (Mazzara): 336.
Ricaviamo da questo breve elenco due importanti informazioni: una riguarda il fitonimo e l’altra la motivazione del nome. Nel quarto rimedio, dedicato al dolor di denti, l’iperico viene espressamente nominato con due diverse forme, piricò e erva di S. Giuvanni. Ecco, finalmente, la denominazione mancante! L’altra informazione la si deduce, invece, dalla ricetta dell’olio di iperico: affinché i benefici contenuti nella pianta si manifestino occorre che i fiori vengano raccolti durante la notte di san Giovanni, notte di solstizio, che in tutto il folklore mediterraneo è connessa alla potenza vegetale.
La testimonianza di questa pratica di raccolta notturna ‒ o svolta alle prime ore del giorno ‒ è ancora oggi rinvenibile non soltanto relativamente all’iperico, ma anche rispetto ad altri fiori di campo ed erbe officinali. Nel 2017 io stessa raccolsi a Milena (CL) un etnotesto che illustrava il modo in cui veniva prodotto domesticamente l’ògghiu di pricò, a partire dalla raccolta che si svolgeva dopo avere recitato una formula (non prodotta in quella sede) con alle spalle il campo di iperico [35].
Lo stesso Pitrè riconduce alla notte del 24 giugno la raccolta di due piante: il puleggio (Mentha pulegium) [36], poi utilizzato per esser posto nel Presepe la notte di Natale, e, appunto, l’iperico [37]. Ma nella stessa notte si mangiano fave, si gettano a terra i frutti primaticci del ficodindia per far produrre la pianta per un periodo di tempo più esteso; si pota la vite delle pergole; si sradicano alti pioppi da condurre in processione [38]; si salassano gli alberi onde riposarvi sotto. Se non si provveda a spezzarne qualche ramoscello, il viandante che dorme all’aperto resterà ligatu, ammaliato [39].
Tra divinazioni e pericoli, la notte di san Giovanni si presta anche per trasmettere le orazioni magiche, esattamente come avveniva, più comunemente, la notte di Natale. Due ulteriori dati lessicali tratti dal VS ci confermano l’abbinamento piante selvatiche-san Giovanni:
curuna di vintura (AA, Mal.) ‘biada verde che i fanciulli mietevano nel giorno di S. Giovanni Battista o dei SS. Apostoli Pietro e Paolo’ [40].
taveddu (Sic.) m. ‘corone formate dai frutti del fico selvatico, a Terranova, per la caprificazione, che debbono essere dispari e, per avere effetto debbono essere appesi il giorno di S. Giovanni, che è il giorno più miracoloso dell’anno’.
Al santo protettore del paese, che è proprio San Giovanni, si collega anche il rito del muzzuni che si svolge ad Alcara Li Fusi (ME), in segno di ringraziamento per le messi che chiudono il ciclo del grano cominciato in autunno e attraverso cui si salda un legame profondo tra divinità e umanità, vita e rinascita.
La variante muzzuni [41], con il significato che qui vedremo, non è registrata nel VS, però è presente il lessotipo principale, ossia mazzuni: può trattarsi di un fascio di legna o di canne, di un mazzo di fiori o di sarmenti, di un mannello di spighe o di una scopa vegetale. In molte accezioni esso è collegato con funzioni simboliche:
«a) mannello di spighe, spesso offerto come primizia dai mietitori alla Madonna delle Grazie, per propiziarsi un buon raccolto; b) falò che accendevano un tempo i ragazzi durante la novena di Natale, per illuminare le strade, o in occasione della festa di S. Lucia; c) mazzo di fiori artificiali dato al prelato che officia in un’altra chiesa; d) canestro ornato di spighe e di fiori e colmo di frutta o d’altro offerto a q. con cui si vuol allacciare un rapporto di amicizia (VS/II, s.v. mazzuni1)».
Ad Alcara esso, circondato da tappeti intessuti dalle donne di casa e addobbato con ori antichi, rappresenta la “testa mozzata di san Giovanni Battista” di cui si celebra il dies natalis:
«Tale oggetto cerimoniale è posto al centro di un piccolo altarino, adorno anche di piante e fiori. Le stesse donne lo realizzano rivestendo una brocca o una bottiglia, da cui fuoriesce un mazzetto di spighe di grano (tradizionalmente anche di orzo – u muzzuni poviru recentemente riproposto –) misto a garofani e lavanda, con un elegante foulard»[42].
Fondativo dell’ordine naturale, il solstizio estivo è, dunque, il momento di passaggio in cui convergono scadenze calendariali, attività produttive (su tutte la cerealicoltura) e dimensione religiosa, così come accade anche in altri momenti dell’anno [43]:
«Ecco il santo più famoso presso tutti i popoli, il santo a cui parte la fantasia de’ volghi, parte ragioni etniche e parte ragioni mitologiche han legato tanti usi, credenze e tradizioni d’ogni sorta quanti non ha nessun santo o più santi messi insieme.
La festa di S. Giovanni cade il 24 giugno, cioè nel solstizio di estate come la festa della nascita di Gesù cade nel solstizio d’inverno; questo concorso, se si guardi agli occhi della mitologia comparata, basta a spiegare perché questo e non altro giorno, S. Giovanni e non altro santo nell’estate, il 24 dicembre e i giorni ad esso più vicini abbiano avuto la fortuna di raccogliere la più copiosa messe di fatti che contribuiscono alla ormai celebre teoria solare» [44].
La peculiarità del 24 giugno, antica festa pagana, si riverbera, in alcuni centri, anche nella realizzazione di fuochi sacri, vamparigghi [45], sul modello di quelli di S. Giuseppe. Ma l’aspetto simbolicamente più rilevante sta nel collegamento tra il giorno di San Giovanni e i riti del comparatico [46], spesso rafforzati proprio dalla presenza di elementi vegetali. L’ùriu i san-Ciuvanni [lett. ‘orzo di San Giovanni’], regalo che ufficializza il rapporto tra novelli consuoceri; un canestro di fiori e frutta scambiato tra ragazze a San Marco D’Alunzio (ME) [47]; un mazzo di fiori, anch’esso detto muzzuni, a Gratteri [48]; i germogli del grano sul modello dei Sepolcri del Giovedì Santo [49]; piante di basilico a Catania; garofani intrecciati con nastri colorati a Naso: l’elemento vegetale è il contesto naturale e simbolico in cui si rafforza una parentela spirituale [50]. Il dono sancisce e rende pubblico un avvenuto cambiamento dei rapporti, tali che essi somiglino ad un “affratellamento” siglato sotto gli occhi del Santo:
«L’istituzione del comparatico al più alto grado possibile, quello di San Giovanni, si inquadra coerentemente nella ideologia del battesimo, attraverso il quale si dice che il bambino passa dalla condizione di “turcu”, di “armali”, di natura tout court, a quella culturale di “cristianu”, termine che in siciliano equivale anche a dire uomo, membro di un insieme sociale già strutturato» [51].
Tale sacralità così come si costruisce, può anche essere distrutta, facendo precipitare le relazioni nel precedente stato di frantumazione del legame sociale e, in ultima analisi, conducendo ad una disgregazione, di cui San Giovanni è altrettanto testimone:
«È significativo che questa stessa regressione sia espressa dai modi di dire che riguardano la rottura del legame di comparatico; di due compari che litighino si dice che “jéttanu u San Ciuvanni ‘nto muzzuni”, gettano il San Giovanni nell’acqua di una brocca di terracotta. Il valore salvifico che ha l’acqua nel segno battesimale si converte, in caso di rottura di un rapporto di comparatico, nel suo opposto»[52].
La potenza del santo, infatti, può produrre anche pesanti vendette, come dimostra un proverbio: Di tutti li santi riditinni,/ Ma nun pigghiari ‘mprisa cu San Giuvanni. Da ciò si evince come attorno al Santo si concentrino potenze non comuni e a dimostrarcelo è ancora una volta un proverbio che lo pone quasi sullo stesso piano di Dio: Cui nun timi a San Giuvanni,/ Mancu timi a Diu cchiù granni. A causa di questa concentrazione simbolica, tra uomo e natura, singolo e comunità, la fede in san Giovanni non può che essere totale e imperitura:
«Quando si giura sul Santo, si fa un giuramento troppo grave perché si possa spergiurare e perché non si abbia a prestar fede. Se non che, questi giuramenti, non si fanno mai sulla possibilità d’esser colti da disgrazie» [53].
In Sicilia, la centralità simbolica del Battista e l’emergere, attraverso la sua devozione, di un momento dell’anno ad alta densità di significati antropologici, dovrebbe manifestarsi in un nome che però è assente dai dizionari, salvo trovarlo nascosto ‒ come abbiamo visto ‒ tra le righe di un volume di Giuseppe Pitrè. La difficile ricerca del “vero” nome della pianta ci sembra risponda a un quadro tabuistico non difficile da ricostruire se si prenda il complessivo sistema semasiologico connesso all’iperico. Torniamo nuovamente al VS, alla ricerca dei geosinonimi dei diversi tipi di iperico nominati in Sicilia:
| Hypericum |
geosinonimo |
fonte |
| asciru/sciru | (Can.) Hypericum quadrangulum | |
| (erva di S. Giuvanni) | (Pitrè 1881) | |
| brunnulidda | (Can.) Hypericum qua- drangulum e Hypericum perforatum | |
| cacciadiavuli | (Can.) Hypericum perforatum | |
| cunucchiedda | (As., Pe., Can.: RG 11) Hypericum crispum | |
| piricò/pericò/pricò | (DB., Pa., Mo., ecc.) m. iperico, pianta erbacea delle guttifere.nome generico di quattro varietà di iperico: a) (Pe., Can.) Androsaemum officinale, b) (As., Can.) Hypericum montanum\ anche (Pe., Can.) p. a-mmàcchia, c) (Pe., Can.) Hypericum perfoliatum, d) (Pe., Can.) Hypericum quadrangolum; anche (Pa., Can.) p. fàusu. ò. seguito da un elemento di determinazione se ne indicano alcune varietà: (Pa., Can.) p. a-mmàcchia. Hypericum crispum, (Can.) p. ad arvuliddu: Hypericum ciliatum, (Can.) p. ccu-ffogghi di murtidda; (Ca., Can.) p. ccu-ffogghi piluseddi; (Can.) p. muntagnolu | |
| rizzuta | pianta delle Guttifere ‘con la quale si fanno manipoli per ricavare la seta dalle pellicole’. | |
| sciatra/sciàtala | (Tr., Pe.: SR 16, Uc.1) | |
| scuparinu | (CT 47) pianta erbacea del genere iperico | |
| tota/totasana | (Pe.; Can.) erba sana o ruta selvatica, pianta erbacea del genere Iperico: Hypericum androsaemum. |
L’assenza di contestualizzazione geografica delle forme (tranne in pochi casi) rende impossibile costruire un quadro interpretativo circa la loro distribuzione areale e, conseguentemente, formulare ipotesi di stratificazione etimologica [54].
Il lessotipo certamente presente in sincronia è pericò/ piricò /pricò, grecismo da ὑπερικόν, transitato dal lat. hypericon. La forma è vitalizzata dall’uso della polirematica ògghiu di pricò (e varr.). Ci sembra suggestiva una possibile etimologia, che però non trova riscontro sui dizionari etimologici, da ὑπό (‘sotto’) e εἰκών (‘immagine, icona’) in quanto erba protettrice con cui addobbare gli altari. Il DIR [55] rimanda, invece, ad un composto tra ὑπό (‘sotto’) e ερείκη (‘erica’) che però non sembra trovi conferma nell’habitat della pianta.
Dal punto di vista iconimico alcune forme sono descrittive: brunnulidda (lett.: ‘biondina’), cunucchiedda (lett.: ‘piccola conocchia), rizzuta [56] (lett.: ‘ricciuta’), scuparinu (lett.: ‘pennello’). Sono di etimologia incerta asciru/sciru e tota/totasana [57]. Restano le voci cacciadiavuli e sciatra. La prima ha una grande espansione e arriva sino all’italiano comune. Ritornando alle proprietà magiche della pianta, si comprende bene perché il composto abbia avuto fortuna: ogni disturbo sembrerebbe retrocedere grazie all’impiego officinale, vero toccasana per i malanni del corpo e dello spirito. San Giovanni, esorcista, manifesterebbe il suo potere nel contrastare ogni impedimento fisico e morale, grazie all’effusione del suo potere sulle diverse parti della pianta (foglie, infiorescenze e fiori), raccolta in suo onore e nel suo giorno.
Cacciadiavuli, dunque, potrebbe costituirsi come appellativo di erba di san Giuvanni, per evitare la nominazione esplicita del santo nella pianta che più di altre ne rappresenta la forza. Più complesso, quasi un azzardo, la spiegazione dell’ultimo geosinonimo. Non sappiamo nulla circa il tipo sciatra, se non quanto riportato nel VS, in una sequenza di rimandi fra tre voci:
sciàtala (Can.: SR 12) f. doronico (pianta erbacea delle Composite): Doronicum parda-lianches.
sciatareḍḍa f. pianta non meglio determinata, ritenuta dannosa per le pecore o (EN 4a) adoperata per accendere il fuoco. Cfr. sciaṭṛa
sciàṭṛa (Tr., Pe.: SR 16, Uc.1) f. iperico, erba di s. Giovanni. Anche sciàtala.
Se non parlassimo di un vegetale connesso al santo delle divinazioni, degli auspici, dei diavoli da cacciare, non verremmo attirati da un’imprecazione la cui origine etimologica è altrettanto misteriosa: sciàtara e-mmàtara! L’esclamazione esprime stupore, paura, sdegno, disprezzo e la si ritrova come primo elemento di formazioni analoghe: sciàtira e rrinchju!, sciàtiri e-ddiàvulu! sciàtiri e-mmaṭṛi e-viḍḍicu di vecchja! sciàtiri e-mmaṭṛi e-vogghju diri! sciàṭṛa maṭṛa e-ccuṭṛa! sciatulammàtula! sciataredda e-mmataredda!
Ciò che ci riconduce nell’alveo del nostro discorso è trovare il costituente sciàṭṛa a inizio di una formula per scacciare il malocchio delle fattucchiere, accompagnandosi da un segno della croce: sciàtara e-mmàtara, acqua e-ssali, zzoccu voi fari num-pozza iuvari [lett.: sciàtara e-mmàtara, acqua e sale, ciò che vuoi fare, non si possa realizzare]. San Giovanni non c’è, ma la dimensione di nominazione dell’iperico ricondurrebbe nuovamente alla straordinarietà del santo e dei suoi poteri miracolosi. Un modellamento lessicale (possibile) su una formula scaramantica che connetterebbe, ancora una volta, l’iperico alla fascinazione e alla “incantacioni ad erbi”.
Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2022
Note
[1] Zamboni A., Categorie semantiche e categorie lessicali nella terminologia botanica, in Aree lessicali, Atti del X convegno per gli Studi Dialettali Italiani (Firenze, 22-26 ottobre 1973), Pacini, Pisa 1976: 53-83.
[2] Castiglione M./ Sottile R., Fitonimia e caratteri popolari in Sicilia, fra traslati e saperi popolari, in N. Prantera/A. Mendicino/C. Citraro, a cura di, Parole. Il lessico come strumento per organizzare e trasmettere gli etnosaperi, Centro Editoriale e Librario, Università della Calabria, 2009: 187-206.
[3] Lanaia A., Le parole nella storia, Collana Lingue e Culture in Sicilia, Piccola Biblioteca per la scuola, 10, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo, 2000.
[4] Negli altri, i campi indagati sono: i tipi umani; affezioni del corpo e dell’anima; le azioni; gli animali veri o fantastici; il tempo la natura e il territorio; gli strumenti, i toponimi.
[5] Lo storico della lingua Gian Luigi Beccaria apre il suo libro I nomi del mondo affermando che «l’agonia e la morte delle cose cammini di pari passo con l’oblio del nome che le designa» (Beccaria G. L., I nomi del mondo, Einaudi, Torino 1995: 3 e ss.). In effetti, di norma le parole morenti sono tali perché scompaiono i referenti (cfr. Ruffino G., Sicilia, Laterza, Bari, 2001): oggetti artigianali, procedure di coltivazione, usi domestici, ecc.; nel caso della botanica i referenti continuano a sussistere, ma muore il rapporto con essi e, di conseguenza, la necessità di nominarli.
[6] I pappi del tarassaco “astuto” vengono citati in una poesia giovanile di Primo Levi, Voi non sapete studiare!, oggi contenuta in Mori R./Scarpa D., Album Primo Levi, Einaudi, Torino 2017.
[7] Connessione legittimata anche dal DIR (Dizionario dell’Italiano Ragionato), G. D’Anna, Firenze, 1988: 757, s.v. gatto.
[8] Cfr. Cardona G.R., Introduzione all’etnolinguistica, UTET, Torino, 2006 [1976].
[9] Nel VS (Vocabolario siciliano), a cura di Piccitto G. (vol. I), diretto da Tropea G. (voll. II-IV), a cura di Trovato S. C. (vol. V), Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Catania-Palermo, è registrata come voce di tradizione indiretta, registrata nel Dizionario del Cannarella (Cannarella P., Dizionario siculo di scienze naturali, ms. inedito della Biblioteca Braidense di Milano, di cc. 4934 + 1195 di indice italiano siciliano + 771 di indice latino siciliano + LXXXII di bibliografia. Compilato fra il 1900 e il 1930 circa. Ne furono pubblicate 3 dispense per complessive pp. 32, Girgenti 1927, Milano 1928). Cfr. VS/III: 11.
[10] Cfr. Alinei M., L’ origine delle parole, Aracne, Roma, 2009.
[11] Cfr. Alinei M., Dal totemismo al cristianesimo popolare. Sviluppi semantici nei dialetti italiani ed europei, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1984. Lo studio delle linee di continuità etimologica si fonda soprattutto sugli aspetti formali, laddove l’iconimia
[12] Si tratta di un progetto di atlante linguistico continentale lanciato nel 1970 e fondato su dati lessicografici. I volumi vennero pubblicati tra il 1975 e il 2007. Cfr. Caprini R., L’Atlas Linguarum Europæ, Actes de la Conférence annuelle du Centre d’Etudes Francoprovençales “René Willien” (Saint-Nicolas, 23 novembre 2013), “La géolinguistique dans les Alpes au XXI siècle: méthodes, défis et perspectives”, Aosta 2014: 11-17.
[13] Atlas Linguistique Roman, Grenoble, Université Stendhal / Centre de Dialectologie, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1 (1996), 3 t.; IIa (2001), 2 t.; IIb (2008), 2. Anche in questo progetto geolinguistico si utilizzano materiali lessicografici già editi nei diversi paesi con varietà linguistiche neolatine, che vengono elaborati da comitati scientifici territoriali. La lettura delle carte segue il metodo iconomastico.
[14] Di tali passaggi è testimonianza anche il patrimonio fiabistico siciliano: «Il mitologema che funge da collante ai testi, ossificati dalla tradizione orale e indeboliti a narrazioni per l’infanzia, è quello del passaggio dalla morte alla vita. La trasformazione zoomorfica è passaggio dall’uno all’altro mondo o dall’uno all’altro stato e conduce all’accettazione dell’animale nel cerchio familiare/umano.» Castiglione M., Fiabe e racconti della tradizione orale siciliana. Testi e analisi, in Collana Lingue e Culture in Sicilia, Piccola Biblioteca per la scuola, 4, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 2018: 44.
[15] Marrone G., Pensieri selvaggi. Nota introduttiva, in Scandariato D.R./ Tassinari C.A./ Zisa G., a cura di, Dendrolatrie. Miti e pratiche dell’immaginario arboreo, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021: 35-42.
[16] Gli inghiottitoi possono essere rappresentanti anche da individui ibridi e cannibalici, come le mammedraghe della narrazione orale siciliana, in Castiglione M., I re animali nelle fiabe di Giuseppe Pitrè: nomi o sostanze?, in Gianfranco Marrone (a cura di) Zoosemiotica 2.0. Forme e politiche dell’animalità, Nuovi Quaderni del Circolo Semiologico Siciliano, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2017: 479-494.
[17] Fa eccezione la scuola dialettologica torinese che già tra il 2004 e il 2007 produsse i tre tomi del I volume dell’ALEPO, così distribuiti: I/I – alberi e arbusti; I/II erbacee; I/III – funghi e licheni. Per l’Atlante Linguistico ed etnografico del Piemonte occidentale, cfr. Canobbio S./ Telmon T., a cura di, Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte occidentale – ALEPO. Presentazione e guida alla lettura, Prefazione di Corrado Grassi, Priuli & Verlucca Editori, Pavone Canavese, 2003. Inoltre, nel 2013 è stato attivato un progetto, coltivareparole.it, partito come attività di sportello presso le comunità di minoranza linguistica, ma che poi si è evoluto nella realizzazione di un atlante digitale dedicato all’etnobotanica, per cui cfr. Pons A., Coltivare parole. Lingue locali ed etnobotanica, Scuola Latina di Pomaretto, Pomaretto 2017.
[18] Cfr. Pitrè G., Canti popolari siciliani, vol. 1, Pedone Lauriel, Palermo, 1871. Es.: Ciuri di pipi,/ La testa mi la dugnu pri li strati,/ Sugnu ‘ntra l’acqua e moru di la siti (n. 135).
[19] Es: Ossu d’amarena/ Si tu nun m’ami, io moru di pena (n. 128).
[20] Nel repertorio collazionato nei quattro volumi di Giuseppe Pitrè, La bella majurana è la fiaba XIII, Marvìzia è la fiaba XVII, Bianca Cipudda la XXIV. A differenza di quanto accade con i nomi dei re animali, questi spunti onomastici non trovano particolari significazioni dentro le narrazioni: «la connotazione fitonomica di questi nomi resta un quid da cui non si dipartono elementi narrativi significativi e la fiaba sembra ‘sprecare’ possibili suggestioni folkloriche, irrecuperabili per il moderno lettore, ma senz’altro riconducibili ad un sistema di conoscenze e a una funzionalità strutturale profonda e ormai più che residuale», Castiglione, Fiabe e racconti cit.: 34.
[21] Cfr. G. Pitrè, Canti popolari siciliani, vol. 2, Pedone Lauriel, Palermo, 1871. Ess: Fora virdi, dintra russu/ e li feddi mussu mussu (853 – Il cocomero); Passavi pr’una strata e pr’una via;/ Li fimmini spiaru zuccu avia:/ Io l’hê dittu zoccu avia (858 – La susina); Don Gaspanu, don Gaspanu/ chi faciti ‘nta stu chianu?/ Nè manciti né viviti/ Siccu e longu vi faciti (860 – Lo sparagio).
[22] Padre della prima cellula dell’Orto botanico di Palermo Cupani, dell’ordine religioso dei Padri del terz’ordine regolare di San Francesco, nel 1692 aveva realizzato un orto nel suo feudo di Misilmeri e nel 1696 pubblica la sua opera più nota, ossia l’Hortus Catholicus. Cfr. Castiglione M., Ampelonimi popolari siciliani: etnici, toponimi e antroponimi in tre antichi cataloghi, «Rivista Italiana di Onomastica» RION, XIX (2013), 2: 503-532.
[23] Per la ricca onomasiologia dei nomi delle bietole in Sicilia, cfr. Ruffino G., Sicilia, Laterza, Bari 2001.
[24] VS, Vocabolario siciliano, a cura di G. Piccitto (vol. I), diretto da G. Tropea (voll. II-IV), a cura di S. C. Trovato (vol. V), Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Catania-Palermo 1977-2002. Le forme riportate nel presente articolo sono seguite dalle sigle dei dizionari collazionati dai redattori.
[25] Le schede di questa ricca messe di informazioni onomasiologiche sono oggi custodite presso l’Opera del Vocabolario, nel Monastero dei Benedettini di Catania, in cui è ospitato il Dipartimento di Scienze Umanistiche. La proprietà è del Centro di studi filologici e linguistici siciliani.
[26] Detto anche agghiu di li maghi: si coglie in questa denominazione il passaggio da una classificazione magica al cristianesimo popolare, che vuole San Giuseppe rappresentato sempre con un alto bastone fiorito.
[27] Non risulta registrata nel VS, ma esiste la forma santamarioti, relativo ai carciofi coltivati nel paese di Niscemi (CL). La denominazione è un attributo agiofitonimico, legato alla devozione per tutte le festività mariane del paese, in particolare per Maria SS. del Bosco. L’etnico popolare degli abitanti del paese è proprio santamarioti.
[28] Mannella P.L.J., Impieghi fitoterapici in Sicilia. Il Ricettario della zza Pina, in “Dialoghi Mediterranei”, n.30, marzo 2018.
[29] A san Giovanni vanno collegati anche numerosi piccoli animali, cfr. Lanaia A., Nomi siciliani di invertebrati e piccoli animali. Studio etimologico e iconimico, Tesi di dottorato (XXV ciclo), Università degli Studi di Catania, Relatore S.C. Trovato, a.a. 2011-2012. In VS /IV: 351 vi si trovano collegati: la lumaca (babbaluceḍḍu sangiuvannaru), il grillo (griḍḍu sangiuvannaru), il ramarro (sangiuanni), il martin pescatore (aceḍḍu di Sangiuvanni), la mantide (sanciuvanni/sangiuvannuzzu), la lucciola (sangiuvannuzzu). All’entrata lessicale del ramarro si dice che esso era rispettato dai bambini e per questo motivo non veniva cacciato, in quanto “accende la candela al Signore”.
[30] Si tratta di una pianta delle guttifere, sotto forma di erba o arbusto, con foglie opposte e fiori gialli. In Italia ne esistono 21 specie. Anche sul Dizionario Treccani si utilizza l’agionimo: «Alcune specie […] come l’iperico o erba di S. Giovanni o pilatro (lat. scient. Hypericum perforatum)» (https://www.treccani.it/vocabolario/iperico/, consultato il 09/11/2021). La forma pl. fiori de S. Giovàni è, ad esempio, nella parlata veneto-giuliana, laddove l’uso è sempre una infusione in olio d’oliva delle infiorescenze essiccate, cfr. Perecin C., Nomi di piante nella parlata veneto-giuliana di Buie e del territorio tra i fiumi Quieto e Dragogna, in «Atti», vol. XXXI, 2001: 479-504; èrba da/de San Giuàn, in Ferrari V., Lessico botanico popolare della provincia di Cremona dialettale, etimologico, «Monografie di pianura», 11, Provincia di Cremona, Fantigrafica, Cremona 2016; G. Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale della Calabria, Longo Editore, Ravenna 1983.
[31] Anche la moderna erboristeria medica ha riconosciuto l’importante attività terapeutica dell’iperico: in particolare l’azione antinfiammatoria viene attribuita all’ipericina e all’amentoflavone. Per quanto riguarda l’azione ansiolitica, invece, questa verrebbe esercitata attraverso l’attivazione del recettore per le benzodiazepine. Per uso interno la pianta viene impiegata nella cura di gastriti e della stomatite vescicolare. Per uso esterno, l’olio d’iperico è un coadiuvante nella cura di bruciature, ferite, pelli arrossate e favorisce una rapida riparazione del rivestimento epidermico.
[32] Come testimoniato in Arietti N., La flora economica e popolare del territorio bresciano, II, Ateneo di Brescia, Brescia 1980: 23: «In Germania e nell’Inghilterra dove fiorì il rito druidico, l’Hypericum perforatum L, […], era venerato come pianta atta agli incantesimi. Le fanciulle ne facevano segretamente un mazzo nella notte di S. Giovanni al tenue chiarore delle lucciole, lo appendevano nella loro cameretta e il pronostico si aveva il mattino seguente: se i fiori erano rimasti freschi ne traevano l’auspicio di un prossimo e felice matrimonio; se avvizziti era invece segno infausto.»
[33] Pitrè G., Medicina popolare siciliana, Edizione Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1896 [ed. anastatica, Forni Editore, Bologna, 1980]: 310.
[34] Anche ùgghju di curucucù, o curucù, forma presente in Mannella, Impieghi fitoterapici cit.. La voce non è registrata in VS e risulta estrapolata da Castelli R., Credenze e usi popolari siciliani, Palermo 1878, che non si è potuto consultare.
[35] La fine di giugno è collegata anche alla presenza delle lucciole: «l’iperico comincia a fiorire nel periodo del solstizio d’estate e […] esso veniva raccolto proprio nella notte di San Giovanni al lume delle lucciole», Trovato S.C., Valori e funzioni del sanfratellano nel pastiche linguistico consoliano del Sorriso dell’ignoto marinaio e di Lunaria, in Dialetto e letteratura, Atti del 2° Convegno di Studi sul dialetto siciliano, Pachino 28-30 aprile 1987 a cura di G. Gulino ed E. Scuderi, Pachino 1989: 113-146.
[36] La consuetudine di “battezzare” fasci d’erbe, in particolare di puleggio, manipolati a forma di bambolotti, durante la notte di san Giovanni, è documentata per gran parte dell’Italia meridionale da Spera V.M., Pupe di San Giovanni e battesimo di bambole, in “Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera. Rivista di Cultura Lucana”, v, 8, 1984, pp. 29-49. Per la Sicilia, Pitrè G., Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. 2, Edizione Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1889: 279-283, al capitolo “Battesimo di bambole”.
[37] Pitrè G., Spettacoli e feste popolari siciliane, Edizione Luigi Pedone Lauriel, Palermo 1881, in part.: 288-320.
[38] Costume registrato da Pitrè, Spettacoli e feste cit., a Monterosso, dove si gridava per le strade “Viva lu santu travu”: 317.
[39] Ivi: 311.
[40] Per vintura si intende la sorte, il destino. Nel giorno di San Giovanni, riferisce Pitrè, si praticavano sovente le divinazioni e si facevano auspici, in particolare le fanciulle in età da marito.
[41] VS/II tratta la voce muzzuni unicamente come derivato di muzzu, per cui indica qualunque scarto, pezzo, frammento di coccio, moccolo, mozzicone, del tutto sconnesso dal nostro tipo lessicale e dall’ambito di riferimento (più prossimo alla parola italiana ‘mazzo’). Però, in Pitrè si registra un’usanza che sembra rendere affini sia i lessemi che i contesti simbolici: a Caccamo (PA), la sera del 23 giugno era costume in molte famiglie riunirsi e sorteggiare il nome di un maschio e una femmina, dichiarandoli compari: l’usanza era detta “lu muzzuni” dal nome della brocca rotta in cui erano poste le sorti. Cfr. Pitré G. Spettacoli e feste cit.: 297-98). Una ulteriore accezione riportata in Pitrè, ma dallo stesso demologo considerata arcaica e non riproducibile ai suoi tempi, è quella di “canzone”: «Il giorno di S. Giovanni cantano lo muzzone» (Ivi: 297).
[42] Cfr. Giallombardo F., La festa di san Giuseppe in Sicilia. Figure dell’alternanza e liturgie alimentari, Fondazione Buttitta, Palermo, 2006:39.
[43] Per una problematizzazione del concetto di permanenza e continuità nei riti popolari, cfr. Buttitta I.E., Continuità delle forme e mutamento dei sensi. Ricerche e analisi del simbolismo festivo, Bonanno, Acireale, 2013.
[44] Pitrè G., Spettacoli e feste cit.: 288.
[45] Ne parla Pitrè per Acireale, Spettacoli e feste cit.: 308.
[46] Fari sanciuanni è, in Calabria, sintagma che indica lo stringere i rapporti di comparatico, cfr. Rohlfs 1983, cit..in VS/IV, p. 35, sangiuvanni è, oltre alla festa di San Giovanni Battista del 24 giugno, anche il comparatico. Viene riportata una locuzione fraseologica registrata nel ragusano: si non fussi pô sangiuvanni, astura ci avissi fiḍḍïatu a facci, [‘se non fosse per il comparatico, a quest’ora gli avrei sfregiato il volto].
[47] Cfr. D’Onofrio S., Amicizia ed eros nel comparatico siciliano. Prime considerazioni sull’incesto di terzo tipo e l’atomo di parentela spirituale, in «L’Uomo», Volume XI – n. 1, 1987: 93-135.
[48] Ivi: 98-99.
[49] Pitrè G., Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. 2, Edizione Luigi Pedone Lauriel, Palermo, 1889: 276-77.
[50] Per una panoramica antropologica completa, cfr. D’Onofrio S., Le parentele spirituali. Europa e orizzonte cristiano, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2017.
[51] Cfr. D’Onofrio, Amicizia ed eros cit.: 102.
[52] Ivi:134.
[53] Pitrè G., Usi e costumi cit.: 255.
[54] L’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) sinora non si è occupato di flora e fauna locali, il che rende impossibile anche attingere a dati geolinguistici in supporto di questo elenco, per valutarne la vitalità e diffusione.
[55] Il lessema non è contemplato nel DELI, mentre è presente nel DEI/III: 2024, con lo stesso etimo del DIR.
[56] È Rohlfs (Supplemento ai Vocabolari Siciliani, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Monaco 1977) a individuarne l’attribuzione ad una varietà specifica, ossia l’Hypericum crispum, in base ad una corrispondenza nel lessico botanico calabrese.
[57] Avanziamo con molte remore un collegamento con uno degli attributi mariani, “Tota pulchra es, Maria et macula originalis non est in te”.
______________________________________________________________
Marina Castiglione, professoressa ordinaria di Linguistica italiana e Coordinatrice del Dottorato di ricerca in Studi umanistici presso l’Università degli Studi di Palermo, ha svolto corsi di Filologia della letteratura italiana, Dialettologia, Storia della lingua, Pragmatica e testualità. Fa parte del Comitato scientifico del Bollettino del Centro di Studi Filologici e Siciliani e della Rivista di studi “Il nome nel testo”. Curatrice della collana editoriale Diàlektos, Piccola Biblioteca per la scuola con Luisa Amenta e Iride Valenti, che si occupa della divulgazione del patrimonio linguistico regionale per la Legge 9/2011. Direttrice del progetto DASES (Dizionario Atlante dei soprannomi etnici in Sicilia) che compone la sezione onomastica dell’Atlante linguistico della Sicilia (ALS), è impegnata nella ricerca sui lessici settoriali, sulla onomastica letteraria, sulla linguistica testuale. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra cui: L’incesto della parola. Lingua e scrittura in Silvana Grasso (2009); Parole e strumenti dei gessai in Sicilia. Lessico di un mestiere scomparso (2012); L’identità nel nome. Profili antroponimici in Sicilia (2019). Nel 2020 è uscita la curatela, insieme ad Elena Riccio, del volume Leonardo Sciascia (1821-1989). Letteratura, critica, militanza civile, CSFLS e Dipartimento di Scienze umanistiche.
___________________________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nomi-di-piante-e-nomi-di-santi-san-giovanni-nella-lessicografia-botanica-siciliana/
Click here to print.






