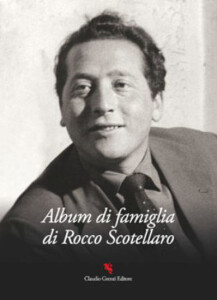Scotellaro. Una eredità incorporata
Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 02:57 In Cultura,Letture | No Comments
Quanta strada insieme
Nei primi anni 70, Scotellaro diventò per me un compagno di strada. Insegnavo Storia delle Tradizioni Popolari all’Università di Siena in un clima ancora vivo di impegno politico. Raccolsi con altri colleghi una serie di scritti e ne feci una dispensa in cui si metteva in scena l’epica delle lotte sociali del secondo dopoguerra [1] e dove si mostrava una via per studiare la storia delle tradizioni popolari non come nostalgia del passato, né come filologia o classificazione di tipologie, ma nel nesso con la storia sociale. Mi nutrivo e imparavo dagli scritti di Gramsci, di Cirese, di De Martino e in modo particolare di Scotellaro. Erano passati poco più di vent’anni dalla sua morte avvenuta quando aveva da poco superato la trentina.
Con Scotellaro ho avuto un rapporto intellettuale di natura non solo critica e storiografica ma di forte condivisione. Lo ho incontrato studiando i suoi scritti e tramite la memoria di Alberto Cirese, mio maestro di studi demo-etno-antropologici. Cirese non l’aveva conosciuto direttamente ma ne aveva capito la personalità al convegno di Matera del 1955 a lui dedicato. Cirese e Gianni Bosio, legati allora a Raniero Panzieri e a Lelio Basso, facevano parte di una sinistra radicale e socialista. Di Rocco condividevano la tradizione socialista oltre che l’importanza data alla ricerca sociale. In quegli anni l’area socialista era in competizione, a volte anche in conflitto, con lo stile e il centralismo del PCI. Con Cirese ho condiviso una parte del percorso nel PSIUP [2], per poi confluire, staccandomi da lui, nel Movimento studentesco e nella sinistra extraparlamentare.
Scotellaro era per entrambi, il mio maestro ed io, emblema di un’altra idea di sinistra. Priva di retorica, solidale, basata sull’iniziativa e l’autonomia delle classi subalterne. Al sopracitato Convegno di Matera, l’analisi di Franco Fortini (da me letta molti anni dopo) mi aveva molto colpito perché aveva analizzato Scotellaro con grande sincerità. Non aveva detto che era un grande poeta e aveva usato parole forti come ‘piccoli e tenaci roditori contadini’. La sinistra radicale di allora era severa, piena di ragioni critiche. Non era una sinistra identitaria in cui venivano esaltati i propri componenti e sminuiti [3] gli altri. La poesia non poteva essere da meno nella ricerca della verità. Infatti:
«Non siamo qui per nutrire la leggenda del piccolo sindaco-poeta. Siamo qui per continuare la nostra conversazione con lui» (Fortini 1974: 3).
«Agite perché la fraternità sia nelle cose, nelle istituzioni, nel pane che mangiate e nel vino che bevete, perché l’azione, come disse cent’anni fa un grande poeta francese, sia sorella al sogno. Quel giovane si chiamava Rocco Scotellaro» (ivi: 54/55) [4].
Credo che a queste parole Rocco avrebbe applaudito [5]. Molte poesie di Scotellaro hanno una densità spiccata tra linguaggi poetici del Novecento italiano e critica e antagonismo politico, oltre che una grande forza riflessiva e una costante ironia. Ho attinto molto dagli scritti sulla poesia di Fortini che era mio collega a Siena in quegli anni ’70 ancora carichi di lotte e di storia vicina.
Contadini del Sud [6] fu una scoperta: era un’opera che stava al centro del mio Olimpo di studi e di politica culturale del quale facevano parte Danilo Montaldi, Gianni Bosio, Franco Cagnetta e Danilo Dolci. La sua conoscenza mi fu trasmessa da Cirese che aveva compreso che l’opera conteneva in modo originale la vivace dimensione culturale dei subalterni (come si diceva allora), dava la voce alle culture altre, nasceva dall’ascolto. Mi sentivo molto in sintonia con quel modo di fare ricerca e col mondo col quale si metteva in contatto.
E poi. E poi mia madre era nata in Lucania, a Rionero in Vulture, anche se si trasferì a Portici [7] da bambina. Così la Lucania mi pareva una mia terra, anche se poco vista ma assai letta [8].
In questa dimensione, Cristo si è fermato ad Eboli di Levi [9] rappresentò per me una sorta di ricerca sul campo raccontata da un non antropologo, ma certo degna di avere un posto di primo piano in un manuale di antropologia. La sua ricerca fu particolarmente utile per la rinascita e la trasformazione degli studi italiani DEA [10] nel secondo dopoguerra. Al centro dell’opera di Levi spiccava il tema della autonomia delle culture e di quella contadina in particolare. Il pensiero di Levi era diverso dal ‘centralismo democratico’ del PCI e dall’idea che la classe rivoluzionaria fosse rappresentata solo dal proletariato mentre i contadini, pur se alleati, non avevano prospettiva di futuro. All’epoca sembrava che il futuro fosse prerogativa soltanto della classe operaia.
Tutto questo mi faceva essere ‘con’ Scotellaro, dentro il suo modo di sentire ed esprimere ansie, sentimenti, attese di un mondo contadino e paesano. Mondo che non appariva mai semplificato e acritico ma sempre rappresentato nelle varietà, nei disagi, nelle proteste senza speranza, negli anarchismi, nei millenarismi, negli individualismi.
Non posso dire di essere stato uno studioso di Scotellaro. I miei pochi scritti su di lui risentono molto del clima degli anni ’70. Clima che è difficile per ora capire interamente, ex post, e che percepisco come una frattura nella mia storia e in quella collettiva, un tempo in cui le autobiografie si spezzano, e ancora oggi i ricordi si confondono: tra le grandi assemblee liberatorie negli Ospedali Psichiatrici e il settarismo dei gruppi ultramilitanti, tra la scuola aperta ai genitori e il terrorismo. Resta per me una frattura traumatica la visione del corpo di Aldo Moro nel bagagliaio di una R4. È difficile riconnettermi col me stesso di allora. Così vado un po’ a tentoni.
Di Rocco sono stato un ammiratore, un lettore che si lasciava guidare: il mio approccio allo studio delle storie di vita è stato ispirato al suo esempio di ricerca delle diversità, alla scoperta dei racconti come chiave per capire la complessità e la ricchezza della società e della vita, rifuggendo da storie fittizie e imbellite con uno scopo politico precostituito,
Più volte ne ho riletto i racconti e le poesie, fino a che qualche frammento delle sue parole non è diventato quasi un mantra interiore per me:
Mi hai risposto tra l’altro
Che un padre che ama i figli
Può solo vederli andar via [11]
o la figura di Ramorra e quel distrarsi al bivio, o anche
‘Sempre nuova è l’alba’,
Non gridatemi più dentro,
non soffiatemi in cuore
i vostri fiati caldi, contadini.
Non mi farò più un bicchiere contento.
Versi che mi sono entrati nella memoria fino ad essere figure del mio stesso pensare e rappresentare le emozioni. Così come mi sono entrati dentro come esempi e come riferimenti negli studi sulle biografie le persone che animano il libro Contadini del Sud: il figlio del tricolore, il bufalaro, l’assessore socialista che si sposò tre volte, il De Grazia e la sua scelta religiosa come forma di cambiamento progressista.
L’Uva puttanella, testo autobiografico originalissimo anche per la scrittura, parla di un percorso da casa verso la vigna, e tutte le volte che lo rileggo ho l’impressione di compiere anche io lo stesso viaggio, tanto è significativo della dimensione sociale della riflessività e della memoria soggettiva. È un testo inquieto e privo di certezze che non segna l’immedesimazione nella prospettiva dei contadini. Scotellaro se ne distanzia ma anche per questo il suo impegno si fa più responsabile e insieme faticoso nel ricercare punti comuni e per alimentare il suo spirito di servizio verso di loro. Spesso ‘ i piccoli tenaci roditori contadini’ sono seccanti e noiosi e riescono a mettere in discussione il suo stesso equilibrio. Le pagine dedicate a coloro che con lui condividevano il carcere sono momenti riflessivi, allo stesso tempo di distanza e di vicinanza, di interpretazione mescolata ad un sentimento di pietas, di tattica della relazione e di tecnica della comprensione, di una socievolezza sempre impegnata sui confini della moralità.
Anche se da tempo non ho più scritto su Scotellaro, lui ha continuato a germogliare dentro di me. Pensare a Rocco mi chiede di ritrovare giovinezze remote di quando, almeno nei miei desideri, l’azione politica era sorella del sogno [13].
Ogni volta che sono a Matera vado a Palazzo Lanfranchi per vedere il grande murale che Carlo Levi ha realizzato per il funerale di Rocco Scotellaro. Il dipinto mi commuove e ogni volta lo fotografo. La prima volta che, quasi in pellegrinaggio, andai a Tricarico, fui deluso di trovare che la memoria di Rocco era quasi del tutto assente. Era tempo di dimenticanza. Era comunque presente un Centro Scotellaro la cui direttrice Maria Bisceglia incontrai in seguito grazie a Ferdinando Mirizzi.
Voglio ricordare che Cirese [14] ha scritto, in polemica con De Martino [15], un testo molto intenso su Scotellaro. Lo ha fatto nel suo ‘stile tardo’ [16]. In questo lavoro critica De Martino per l’atteggiamento dell’intellettuale che viene da fuori e che approfitta delle culture e delle personalità locali, le sintetizza nella ‘linea’ nazionale del partito [17], ma non le riconosce nella loro specificità, diversità, autonomia perché contrarie al verbo del centralismo democratico comunista. Il testo di Cirese è pieno di memoria di quel che Scotellaro significò per la cultura di sinistra degli anni ‘50 e ’60 [18] e di dolorosa delusione verso De Martino, non tanto e non solo per il suo ‘storicismo’ legato a Croce, ma per un ingiusto comportamento verso Scotellaro e la sua poesia.
Sono lontanissimo dal volere aprire polemiche e dare giudizi; sono un allievo di Cirese che deve molto a De Martino. Sono molto critico verso alcuni aspetti del pensiero e delle ricerche di De Martino, ma gli sono debitore di riferimenti importanti, la mia formazione intellettuale di antropologo passa attraverso le sue opere da cui ho appreso tanto e che sono in sintonia con i temi che mi hanno avvicinato a Scotellaro. Di De Martino ho fatto mia la formula che indica i caratteri morali della ricerca:
«Io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un “compagno”, come un cercatore di uomini e di umane dimenticate istorie, che al tempo stesso spia e controlla la sua propria umanità, e che vuol rendersi partecipe, insieme agli uomini incontrati, della fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo e loro che ritrovavo» [19].
È una sorta di giuramento di fondazione, che Scotellaro attualizza per la prima volta nella forma di ‘libro di etnografia’ proprio con i Contadini del Sud e L’uva puttanella. De Martino ne aveva colto i principi e il metodo. E le sue Note lucane, dentro le pagine di Furore, simbolo e valore [20] sono state per me un punto centrale di riferimento. Le incomprensioni e i conflitti tra i due grandi dei nostri studi sono un episodio a sé della storia di quegli anni, ed è giusto che siano stati trattarli a parte.
Aggiornarsi
Dopo questa topografia di memorie personali e di luoghi simbolici che nel tempo mi hanno legato a Scotellaro, mi riaffaccio su di lui in occasione del centenario della sua nascita. Lo rivedo oggi, con occhi nuovi, attraverso la lettura di studi e contributi aggiornati. Nel suo centenario, la memoria di Rocco risulta un po’ sbiadita per lontananza, se confrontata con i centenari di Lorenzo Milani, Italo Calvino, Saverio Tutino. Altri centenari che sono incastonati nella mia storia personale. La morte di Rocco, davvero prematura, è del 1953 quella di Don Milani del 1967, di Calvino del 1985 e di Tutino del 2011.
Ma forse una vita più breve contiene una carica di senso compressa, dotata di grande potenzialità espansiva, che la distanza nel tempo modifica e carica di nuove significazioni purché non venga seppellita nell’ oblio. Sul web ho trovato qualche riga sull’incuria della sua tomba, e sulla chiusura del Centro Scotellaro di Tricarico. Non sono segnali confortanti. I sindaci hanno poca memoria in generale, ed è più grave quando si confrontano con una figura forte ed esemplare di sindaco come fu Scotellaro.
Ma ho registrato una traccia in controtendenza: il 17 marzo scorso infatti l’Associazione dei Lucani di Siena ha promosso, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università, un convegno dedicato a Rocco con la presenza di due relatori antropologi (Fabio Mugnaini ed io). In quella occasione ho avuto modo di tornare sulla figura di Scotellaro, fare i conti con le tensioni intellettuali ed emotive che ancora mi suscita. Ma anche con l’abisso che mi separa dai nuovi studi. In quell’incontro, come anche in questo testo, ho scelto di raccontare la storia del mio sodalizio con Rocco e, nel narrarla, ho avuto la percezione che ancora oggi si senta attuale il nesso tra cultura e politica e che, anche negli scenari mutati, ci siano dei nodi ‘metodologici’ che sono ancora vivi. Perché anche oggi siamo interessati al nesso tra poesia, governo di un paese, militanza controcorrente, ricerca e capacità di far parlare, ascoltare, leggere le voci della gente. Fabio Mugnaini, che con e come me in quella occasione parlava di Scotellaro, ha preferito riflettere sulla Basilicata contemporanea, sconosciuta a Rocco, ma carica di nuove disuguaglianze, una sorta di aggiornamento del senso che la sua storia ci ha lasciato. Questa ricerca del senso e del valore della poetica di Rocco nel presente è la dimensione più rilevante, l’unica che non lo veda relegato soltanto al passato.
Riprendere le fila di tanti studi, di documenti nuovi, di lettere, di fotografie che negli anni ‘70 non erano stati pubblicati e quindi non erano disponibili per me, ha aperto nuovi campi e modi di vedere Scotellaro. Modi sempre più lontani dal mito leviano del poeta contadino ma tesi invece a potenziare la figura dell’intellettuale, della ricerca dei suoi contatti, dei rapporti con altre figure del panorama intellettuale di quel tempo (Levi, Rossi Doria, Fiore, Mazzarone). Il rapporto con Mazzarone non era a me noto negli anni ’70. Mi ci ha iniziato il racconto e gli scritti [21] di Ferdinando Mirizzi, collega antropologo dell’Università della Basilicata. Ma sono stati soprattutto gli scritti di Marco Gatto e, in specie il suo volume [22] uscito per il centenario, ad aiutarmi a superare il gap di memoria e di conoscenza della nuova letteratura su Rocco. La nuova raccolta di foto – prima ci si riferiva a poche immagini che ne accentuavano il carattere leggendario – aiuta a vederne la pluralità di momenti, di incontri, di orientamenti. Già in un articolo del 2022 Gatto aveva suggerito una attenta lettura del catalogo e delle sue immagini [23].
Rocco viene proposto quasi come un emblema di un inizio perduto la cui forza simbolica resta non logorata, adatta a ritrovare un percorso dentro il nodo della questione meridionale e del fallimento del Sud in una prospettiva di rinascita e di politica nuova.
Riferendosi in particolare ad uno scritto di Leogrande [24], Gatto indica Scotellaro come punto di riferimento rispetto alla domanda di nuovi percorsi e si domanda chi siano oggi i nuovi “contadini del sud”, le cui storie raccogliere perché si possa progettare la fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo e loro che ritrovavo. Per Leogrande, i nuovi contadini sono i braccianti agricoli del nuovo mondo migratorio, anche se questa scelta mette in risalto conflitti potenziali con i contadini rimasti sul territorio, per lo più ostili al nuovo bracciantato. Auspica che questa ostilità possa essere superata per conquistare una nuova alleanza tra i locali e i migranti, i marginali, gli ultimi.
Nella mia mente torna forte il nesso tra Scotellaro e la figura di un altro sindaco Mimmo Lucano, già sindaco di Riace. Come successe a Rocco Scotellaro, anche Lucano è stato aggredito dalle istituzioni e dalla politica conservatrice mentre cercava in modo creativo ed originale di trovare un nesso tra nuove migrazioni, sviluppo ed eredità della cultura locale. Lucano vive oggi da emarginato dentro l’iter del lungo processo, con una condanna a sette anni di carcere e il ricorso in appello ancora in corso. Nel quadro delle iniziative dell’Associazione Riabitare l’Italia, di cui faccio parte da qualche anno, lo ho incontrato in un’aula strapiena e solidale dell’Università della Calabria. Lucano parlava con un tono quasi visionario, quasi religioso, in modo meno riflessivo e ironico di Scotellaro, ma era simile nel sentire il peso della responsabilità, la consapevolezza di non potersi sottrarre a quella lotta e di ritenere inevitabile quel suo destino. Forse a Carlo Levi sarebbe sembrato una reincarnazione di Rocco.
Sul piano della progettualità torna in scena, nel nesso che cerco tra Scotellaro e gli studi successivi, la storia intera dalla Basilicata che negli anni del dopoguerra la resero quasi una regione laboratorio per la presenza sul suo territorio di studi antropologici internazionali e italiani, ma anche letterari ed artistici. Nella introduzione al suo volume di ricerca sul campo a Scanzano Ionico, l’antropologa Maria Minicuci [25] ricorda i nomi di tanti studiosi anglosassoni impegnati su quel territorio: a partire dalla tesi dottorale di Robert Banfield da cui scaturì la nozione di ‘familismo amorale’ (nozione che poi fu ripresa da Paul Ginsborg che la estese a tutta l’Italia e non solo ai ceti popolari) fino a John Davis critico verso la tradizione anglosassone di ricerca. Ma fu laboratorio anche per i tanti intellettuali che vi sperimentarono il domicilio coatto, da Levi a Rossi Doria e a tanti altri. Maria Minicuci, descrivendo il mondo dei contadini imprenditori del presente, sottolinea. attraverso la casistica descritta, la difficoltà di unire il loro mondo con quello delle culture estensive, del bracciantato straniero e del caporalato. Negli studi degli anni ’50 si usava erroneamente il concetto di progresso incentrato sullo sviluppo industriale, perdendo così di vista tanta parte della specificità del Sud. Il maggiore paradosso è quello dei Sassi di Matera passati da essere vergogna nazionale a patrimonio dell’Umanità Unesco.
Ed è proprio nel clima degli anni ’50 che De Martino descriveva così Tricarico [26]:
«Tuttavia il fatto reale è che in questo scenario che sembra la negazione della storia vivono alcune migliaia di persone storiche. Vivono nel groviglio di tane che si addossano alle pendici alquanto brusche del colle di Tricarico, onde ne risulta un labirinto di sconnesse viuzze precipiti, sfogo di fogne della parte alta del paese. Vivono, ma meglio si direbbe che contendono al caos le più elementari distinzioni dell’essere: la luce lotta qui ancora con le tenebre, e la forzata coabitazione di uomini e bestie suggerisce l’immagine di una specie umana ancora in lotta per distinguersi dalle specie animali».
La poesia
Anche la poesia ha una dimensione antropologica. Quella di Scotellaro continua a parlami, come se, con il trascorrere del tempo, non perdesse mai il senso anzi si rinnovasse. Più in generale sono convinto che si può definire utilmente una dimensione antropologica della poesia, perché essa, nella sua scrittura ambigua, potente ed evocativa, riesce ad aprire – indipendentemente da quando è stata scritta – immaginazioni del possibile, antropologie del domani [27]. Nel dialogo con la nostra soggettività essa non ha bisogno di contesti storici, non ci viene chiesta una filologia letteraria, quando ne siamo colpiti, Così come questi versi di Baudelaire rimbalzati da Fortini su Scotellaro e da qui su di me.
Andrò via soddisfatto da un mondo ove l’azione non è sorella del sogno
Si è in presenza di un dialogo diretto tra soggettività ed esperienza vitale e morale. Le poesie (lo diceva già Fortini nel 1955) non sono da adottare per una militanza, ma per una interrogazione di sé che quella militanza costantemente rimette in questione. Tante poesie potrebbero essere rilette oggi con un nuovo senso e una nuova libertà. Penso che per ‘ripoliticizzare Scotellaro’ potrebbe essere utile fare questo percorso per vedere il rapporto tra un mondo cambiato e un intellettuale scomparso troppo presto che ci ha lasciato però dei modi di guardare – fatti di parole – che possono rivelarsi strumenti per scoprire il presente.
Exempla: contadini, migranti, lucani
Voglio segnalare tre possibili modelli di pensabilità attuale di Rocco.
- All’inizio delle mie ricerche in Toscana mi sono occupato di contadini mezzadri che avevano lasciato la terra, sentendosi sfruttati e isolati rispetto al mondo moderno, chiusi in antiche e ormai insopportabili servitù. È stato per rappresentare la loro storia che mi sono occupato di musei. Oggi il mondo di quei contadini e dei loro musei è diventato obsoleto per le amministrazioni pubbliche. Vittime di tanti ‘nuovismi’, i sindaci sono per lo più incuranti del passato e con essi anche il loro elettorato. Da quando mi occupo di zone interne e di rinascita di paesi caratterizzati da abbandono e crollo demografico, mi rendo conto che i saperi, le pratiche, la capacità di economie self-sustaining e – necessariamente – a km zero dei contadini, costituiscono una nuova attualità. I contadini sono tornati sulla scena attraverso gli studi e le proposte politiche che arrivano dal Messico e dall’India, ma anche dalle nostre campagne dove negli anni ‘80 sono nate comuni, imprese e cooperative.
- Via via negli ultimi trenta anni si assiste a fenomeni di ritorno: ritornano i nipoti che, saltata la generazione dei padri modernisti, riprendono possesso delle terre dei nonni. È un nuovo e diverso mondo contadino rispetto a quello che conobbe Scotellaro, ma assai sensibile alle parole d’ordine ecologiste, alla solidarietà, alla sperimentazione, alla innovazione non finalizzata al solo aumento del reddito. Esiste un’ampia letteratura mondiale sul nuovo modo di abitare il territorio [28] con forte centralità contadina [29]. Si tratta di un movimento inteso a riabitare, riequilibrare, innovare tenendo in conto la grande eredità delle agricolture storiche dell’Italia rurale. Un modo di riferirsi al mondo contadino di oggi sarebbe il primo ‘exemplum’ che potrebbe trovare in Rocco una guida, un filo conduttore: il ritorno alla terra, le nuove agricolture contadine all’insegna della ‘coscienza di luogo’ prima che della coscienza di classe. I contadini di Rocco Scotellaro diventerebbero così riabitatori dei paesi e innovatori facendo rivivere e reinterpretando gli antichi modi di coltivare. Sarebbe uno dei modi perché Scotellaro riviva come ‘patrono’ in questa possibile nuova dimensione contadina.

Tricarico, al cimitero presso la tomba di Rocco Scotellaro, la madre Francesca Armento, Carlo Levi e amici. 1960
3. Nelle recenti considerazioni su Scotellaro sembra prevalere l’ipotesi di una sua presa con il mondo degli ultimi, con un progetto di civiltà che incorpori la nuova domanda di lavoro e di asilo. Una frontiera di una nuova cultura di mescolanza. È uno dei temi che emergono dal dibattito che ho più sopra riportato. Il nuovo bracciantato agricolo che è uno dei mondi di maggiore sfruttamento, di povertà e di precarietà dellavita e del futuro, può essere alla base di un ripensamento del Sud agricolo contro forme di agricoltura estensiva e per lo più anticontadina. È un secondo modo di riferirsi a Rocco e alla sua attenzione, alla sua pazienza, alla sua pietas, come modo di costruire condizioni di vita e di futuro nuove come quell’alba ‘sempre nuova’ della sua poesia più nota. Tra il primo e il secondo modello si giocano anche la coscienza di classe e la coscienza di luogo: è una difficile scommessa farle alleare.
Leggendo sul web i commenti sulla ricorrenza del centenario, mi pare che Scotellaro possa anche essere assunto a patrono della Basilicata contemporanea come regione marginale che vuole affermare la propria identità (la ‘lucanità’, la cui traccia sta già nel titolo de L’uva puttanella) [30]. Un approccio identitario che può essere del tutto positivo visto che Scotellaro non si presta a mitologie turistiche, ma può forse offuscare le grandi potenzialità sociali della memoria scotellariana, sui temi delle diseguaglianze, includendola in una prospettiva giocata sul passato e tendente a non evidenziare lo stato attuale della Basilicata e le sue innovazioni e contraddizioni.
Questi tre modelli esemplari – i nuovi contadini, i migranti, l’identità regionale – possono anche intrecciarsi e assumere così grande forza. Non ne sono sicuro ma, secondo me, il modo di ridare contemporaneità a Scotellaro è solo all’inizio.
Finisco – per non farmi illusioni – con una testimonianza recente che ho trovato sul web:
«A Tricarico, …, il ricordo di Rocco, suo figlio vero, pare più nascosto. Un dipinto murale all’entrata del paese lo raffigura, ma poi ne scompare ogni traccia. I quartieri Saraceno e della Rabata, pur abitati, e le sue strade, testimoniano di un passato che più non c’è e dell’assenza di Rocco. Il centro di documentazione a lui dedicato è stato chiuso. “Io sono uno degli altri” che, come lui, sono stati cancellati» [31].
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023
[*] È appena uscita la rivista L’ospite ingrato, numero monografico dedicato a Rocco Scotellaro col titolo 1923-2023: Rocco Scotellaro, presente e futuro per la cura di Marco Gatto e Lorenzo Pallini. Un numero davvero importante con 18 testi tra i quali alcune interviste ai principali studiosi di Rocco. Mi dispiace di non aver potuto tenerne conto in questo scritto. Ho avuto solo modo di usare qualche utile riferimento. Si precisa che questo testo esce in coedizione tra le riviste Dialoghi Mediterranei e Dalla parte del torto. Le foto sono tratte dal volume a cura di Carmela Biscaglia, Album di famiglia di Rocco Scotellaro, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2019. Si ringrazia per l’autorizzazione alla pubblicazione.
Note
[1] P. Clemente, M. L. Meoni, M. Squillacciotti (a cura), Il dibattito sul folklore in Italia, Milano, Cultura popolare ed., 1976, dove scrissi: Movimento operaio, cultura di sinistra e folklore; Sul folklore progressivo; Il caso Scotellaro. La dispensa didattica da cui nasceva il libro è del 1974/5, quando avevo 32 anni ed ero al secondo anno d’insegnamento universitario.
[2] Anche Scotellaro entrò nel partito socialista, in una fase del dopoguerra in cui esso si chiamava PSIUP, e a quel nome ci si ispirò per il partito nato nel 1964 al quale Cirese ed io aderimmo
[3] Franco Fortini, La poesia di Scotellaro, Matera, Basilicata editrice, 1974
[4] ibidem
[5] Sono grato – in memoria – a Leonardo Sacco con il quale ho dialogato in amicizia e stima negli anni ’80, per avere pubblicato questo testo e le pagine che seguono sulle poesie, senza – pare – attendere l’autorizzazione di Fortini. È un carteggio di prima mano forse ricostruito dalla registrazione, ma anche da appunti sulle poesie. Ne ho trovato riferimento in Alessandra Reccia, Al di qua della storia. Franco Fortini sulla poesia di Rocco Scotellaro in L’Ospite ingrato, n. 13, 2023, titolo generale: 1923-2023: Rocco Scotellaro, presente e futuro.
[6] Rocco Scotellaro, L’uva puttanella. Contadini del Sud, Bari, Laterza, 1955.
[7] A Portici mio padre studiò Scienze agrarie e incontrò mia madre. Proprio a Portici dove, molti anni dopo, morì Scotellaro
[8] Ora grazie alle tante collaborazioni di ricerca con l’Università della Basilicata mi è diventata familiare, come era giusto che fosse
[9] Cristo si è fermato ad Eboli, Torino, Einaudi, 1945
[10] DEA una sintesi acronima di demo-etno-antropologici, dove demo stava per demologici ovvero di tradizioni popolari
[11] Lezioni di economia, 1952, in Fortini, cit.: 29. In questi casi non c’entra solo l’antropologia ma anche il messaggio etico che fa da riferimento nella vita reale, così come nel caso di ‘uno si distrae al bivio’, si tratta di un messaggio che riguarda me stesso.
[12] Da Passaggio alla città, I primi tre versi recitano Ho perduto la schiavitù contadina, /non mi farò più un bicchiere contento/ho perduto la mia libertà. Se ne ricava una tematica della nostalgia che si avvicina a quella formulata da A. Cirese in Condizione contadina, nostalgia, partecipazione, in id. Oggetti, segni musei, Torino, Einaudi 1977
[13] Baudelaire Il rinnegamento di San Pietro è all’origine del passo di Fortini, che lo capovolge: «Per quel che mi riguarda, andrò via soddisfatto da un mondo ove l’azione non è sorella del sogno;
m’auguro di spada ferire e di spada perire!» Da I fiori del male 1857.
[14] A. M. Cirese, Per Rocco Scotellaro: letizia, malinconia e indignazione retrospettiva. – In: SM Annali di San Michele, n. 18, 2005. “Contadini del Sud, Contadini del Nord. Studi e documenti sul mondo contadino in Italia a 50 anni dalla morte di Rocco Scotellaro”, a cura di Giovanni Kezich e Emilia De Simoni. All’epoca Cirese aveva 84 anni e tornava su un tema per lui doloroso: i rapporti con De Martino, con il PCI anni 50, con Scotellaro.
[15] Per questi aspetti è un punto di riferimento il numero di Lares dedicato a Una “difficile alleanza”:il carteggio tra Alberto Mario Cirese e Ernesto De Martino, e l’articolo di Antonio Fanelli “Stiamo dalla stessa parte della barricata politica”, la difficile alleanza tra A.M. Cirese e E. De Martino, ivi: 407-442
[16] Said Edward W. Sullo stile tardo, Milano, il Saggiatore 2009, forse anche il mio ora che scrivo con una età analoga, è uno ‘stile tardo’
[17] De Martino era stato socialista ma in quegli anni era impegnato ad essere accolto nel PCI dove aveva avuto anche diversi attacchi.
[18] Ricordo che anche Leonardo Sacco era molto critico verso la rappresentazione che De Martino aveva dato della Lucania.
[19] Ernesto De Martino, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi dieci anni, in Società 1953.
[20] Id. Furore simbolo valore, Milano, Feltrinelli 1980. La prima edizione è del 1962.
[21] Ferdinando Mirizzi, Scotellaro e il popolare, Lares n.3, 2016; Ferdinando Mirizzi, Contadini del Sud tra valore documentario e dimensione letteraria, in Forum Italicum 50(2)2016.
[22] Marco Gatto, Rocco Scotellaro e la questione meridionale. Letteratura, politica, inchiesta, Roma, Carocci, 2023
[23] Marco Gatto Tra dimensione privata e impegno pubblico. Sull’Album di famiglia di Rocco Scotellaro in Archivio di etnografia, 1, 2021
[24] Alessandro Leogrande, Gli anni dello straniero. Italia 1998-2017, Roma, Edizioni dell’asino, 2021; mentre scrivevo queste pagine ho scoperto che Leogrande è morto quarantenne nel 2017, il libro che cito tramite G. Gatto è postumo, curato da Nicola Villa. La sua carriera di studioso e giornalista sulla frontiera del cambiamento e della disuguaglianza è straordinaria.
[25] M. Minicuci, Politica e politiche. Etnografia di un paese di riforma. Scanzano Jonico, Roma, CISU 2012
[26] E. De Martino. Note Lucane in Furore simbolo e valore, citato,
[27] P. Clemente, Penne di petto: antropologia, poesia, generazioni, in Il gallo silvestre», 13, 2000
[28] Alberto Magnaghi, Il principio territoriale, Torino, Bollati Boringhieri, 2020; Id. La conscience du lieu, Eterotopia France/ rhizome, Paris, 2017, A.De Rossi e altri, a cura di, Riabitare l’Italia, Roma, Donzelli, 2018 Segnalo inoltre tutti gli altri titoli della collana Donzelli su Riabitare l’Italia
[29] Jan Douwe Van Der Ploeg I nuovi contadini [29] ; Silvia Perez Victoria, Il ritorno dei contadini, Milano, Jaca Book 2015
[30] L’uva puttanella è quella che presenta un difetto di sviluppo della bacca, che però non incide sul gusto. Dolce ma più piccola, Scotellaro la assume a simbolo della condizione dei contadini del Sud
[31] Pier Giorgio Ardeni Il manifesto 23 aprile 2023.
_____________________________________________________________
Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale. Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014); Raccontami una storia. Fiabe, fiabisti, narratori (con A. M. Cirese, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021); Tra musei e patrimonio. Prospettive demoetnoantropologiche del nuovo millennio (a cura di Emanuela Rossi, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021); I Musei della Dea, Patron edizioni Bologna 2023). Nel 2018 ha ricevuto il Premio Cocchiara e nel 2022 il Premio Nigra alla carriera.
______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/scotellaro-una-eredita-incorporata/
Click here to print.