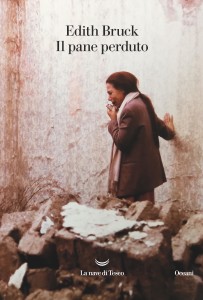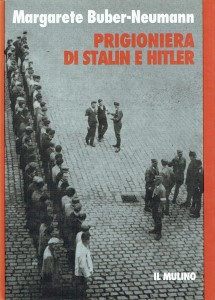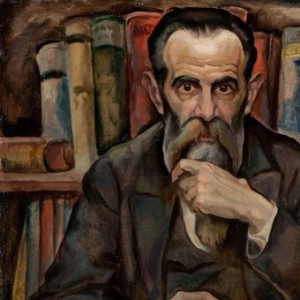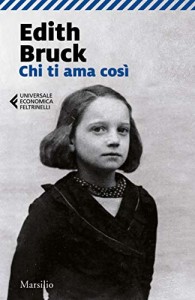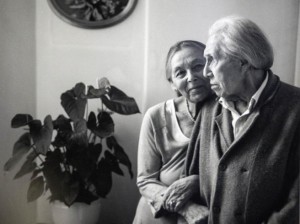Vite parallele nel dramma e nella scrittura
Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2021 @ 02:27 In Cultura,Letture | No Comments
Subito salta agli occhi, leggendo della travagliata vita di Edith Bruck (Il pane perduto, La Nave di Teseo, 2021), un punto di assonanza con Margarete Buber-Neumann [1], al di là delle evidenti differenze: due donne, una tedesca, Margarete, l’altra ungherese, Edith, finite entrambe in campi nazisti. Edith da bambina, Margarete da giovane donna. Edith in quanto ebrea, Margarete, che pure ha ascendenze ebree, in quanto compagna di Neumann. Ma quale è allora l’assonanza, se c’è?
Non si è conosciute con il proprio cognome
In primo luogo, e balza agli occhi, il fatto che entrambe non saranno conosciute con il proprio nome ma con quello di un marito (Edith Bruck) o dei mariti (Margarete Buber-Neumann). Uno strano destino, dovuto forse anche alla difficoltà del cognome originale, nel caso di Edith. Margarete, nasce Thūring; Edith, Steinschreibel. Ma questa non può essere stata l’unica ragione.
Affinità e diversità: Margarete ha sposato un Buber da giovane. Da lui nasceranno le sue due figlie; il secondo marito, amato con maggiore consapevolezza, da lei già più adulta, le verrà poi sottratto dalla volontà di Stalin. Edith adotta invece il cognome di un suo coniuge (il terzo) che è stato tale brevemente e su carta, sposato per convenienza, data la normativa israeliana, per evitare il servizio militare e presto scomparso dal suo orizzonte.
Ambedue scriveranno. Margarete però non si considera una scrittrice ma, più modestamente, una giornalista. Nel campo di Ravensbrūck ha però conosciuto Milena, la Milena Jesenská amata da Kafka, la destinataria delle sue lettere. E Milena l’ha convinta a vincere le sue esitazioni, dovute soprattutto a modestia: Scriveranno insieme del campo di Ravensbrūck, di quello che ha voluto dire per loro, dei mutamenti intercorsi – a un certo punto si verrà condotti a morte anche lì, non più solo altrove, grazie a treni che da lì partono. Milena però non potrà farlo: muore nel campo. Non ce la fa a sopravvivere. E la sua amica Margarete decide quindi che dovrà procedere lei a raccontare cosa ha voluto dire vivere per anni sotto i nazisti, costrette in una struttura coercitiva, obbligate a una vita di difficoltà e soprusi, a duri lavori, costrette alla fame se non all’inedia. Lei scriverà, una volta rientrata a casa [2], della vita nel gulag e nel campo nazista di Ravensbrūck. Scriverà anche dell’amica Milena [3]. Scriverà del periodo trascorso in Siberia [4]. Forse la scrittura aiuta il superamento dei fatti, dei traumi subiti.
Edith Bruck invece fin da bambina intende scrivere. Ha in mente tutto quello che vuole mettere su carta e non rinuncerà mai a farlo, nonostante le difficoltà della sua vita, nonostante il primo giovane marito sia duramente contrario. Scrivere per lei è una irrinunciabile priorità. Da quando starà in Italia, scriverà in italiano.
Quindi, due scrittrici: ma la più giovane appare, in questo senso, più determinata, più consapevole. L’altra lo sarà, ma non si reputa, almeno inizialmente e per quanto ne sappiamo, una vera e propria scrittrice: è giocata da una certa modestia di fondo.
Probabilmente entrambe saranno aiutate, nella vita successiva al periodo nei campi di concentramento, dalla scrittura, anche se non sempre scrivere basta: di Edith sappiamo che ha passato la vita tra forti dolori fisici, certamente legati a quanto le era occorso. Di Margarete non sappiamo abbastanza: il suo fisico era tremendamente provato ai tempi della prigionia, prima in Siberia, poi in Germania. Certamente il suo viaggio di ritorno è stato duro e faticoso, tanto che lei è giunta a casa nonostante grandi difficoltà nel muoversi, nel camminare, nel pedalare. Ma non sappiamo molto dei tempi successivi, al contrario di quanto avvenuto con Edith.
Entrambe vengono da famiglie piuttosto tradizionali, in cui ci sono entrambi i genitori e vari altri figli oltre a loro. Ci si attende dai figli che studino o che vadano a lavorare, nella famiglia di Edith: e infatti i più grandi sono nella città di Budapest, dove è più facile trovare lavoro.
Anche il padre di Margarete vorrebbe impegno nello studio o un discreto lavoro: ma le figlie sono, al riguardo, un po’ ribelli. Aiutate in questo da un maggiore benessere economico e da una madre indulgente verso i loro desideri. Diverranno socialiste: una scelta detestata dal padre.
In casa di Edith c’è invece pochissimo denaro, bisogna fare i conti con le quotidiane difficoltà economiche.
Differenze sociali
Ci sono certamente evidenti, forti differenze di ceto: la famiglia di Margarete è ascesa alla media borghesia, il padre guadagna abbastanza bene. Ha tendenze autoritarie, mitigate dalla moglie, più intesa a comprendere i figli, i loro desideri e comportamenti.
Il padre di Edith è più modesto in termini di riuscita sociale, la famiglia sopravvive con difficoltà. Il peso di una famiglia numerosa si fa sentire [5], condiziona la loro vita sia prima della cattività, sia subito dopo: almeno una delle sue sorelle è risoluta a sfuggire alla povertà, si impegnerà con durezza in questo senso e il suo atteggiamento peserà sulla giovane Edith da poco uscita dalla prigionia.
Il legame con la madre
In entrambi i casi mi sembra si possa dire che le due, Margarete e Edith, hanno un più stretto legame con la madre che non con il padre. Margarete anzi con il padre non si trova affatto bene, e lui è critico verso questa figlia scriteriata, anche se sarà pronto a soccorrerla quando si troverà in difficoltà con il marito e i suoceri Buber.
Edith porta con sé il ricordo dei genitori, ma soprattutto della mamma, dei suoi discorsi sulla terra di Palestina, terra di latte e miele. Un bacio della mamma è considerato un raro, significativo premio.
Sorelle, fratelli
Margarete ha alcune sorelle: una in particolare, Babette, le è più vicina delle altre, dei fratelli. Forse anche perché ha sposato un uomo interessante, Willi Mūnzenberg, uno dei fondatori del Comintern. Che tuttavia negli anni ’30 entrerà in conflitto con Stalin. I due sono certamente vicini ideologicamente, un punto di appoggio per Margarete. Sono presenti nei momenti di maggiore difficoltà. Alla liberazione Willi però non riuscirà a tornare a casa: probabilmente, verrà ucciso durante la fuga dalla Francia occupata dai nazisti: si ipotizza, da qualche agente di Stalin. Un destino che una volta di più sembra avvicinare le due sorelle.
Diversa la situazione di Edith, che da prigioniera sta con la propria sorella Eliz [6], che ha cinque anni più di lei e che cerca di aiutarla, di darle buoni consigli, di prendersene cura per quanto possibile. Insieme passano nel campo di Dachau; poi otto giorni di viaggio e giungono a Christianstadt. Ci stanno per cinque settimane, poi ancora in viaggio, nella neve e nel gelo, con scarso cibo. Eliz l’aiuta a camminare, ad andare avanti anche quando lei non sente più le gambe, è debolissima a causa anche di una protratta diarrea. Dopo cinque settimane – la cifra si ripete – sono a Bergen Belsen. Poi, a Celle, a 30 km. da Bergen Belsen. La ragazzina si innamora, la sorella più grande veglia su di lei, la esorta a fare attenzione: lei, di 18 anni, non ha mai baciato un uomo.
Passano i giorni, i mesi. Dopo cinque mesi dalla loro liberazione a fine 1945 le due sorelle giungono a Budapest. Vanno prima all’AJDC, dove vengono dati loro un certificato e un po’ di denaro. Poi corrono a cercare la sorella Margo. Margo è ormai vedova, con un bimbo, Tomika. Lei chiede notizie della madre: loro speravano di trovarla là o di avere notizie da Margo, anche se subito una sorvegliante aveva detto alla piccola Edith che sua madre era il fumo che vedeva andare verso l’alto, e che forse era diventata sapone. Budapest è piena di russi, su cui circolano storie tremende.
Le due vanno a Debrecen a trovare la sorella Leila: che sembra però distante e fredda. Finalmente tornano dal lavoro il fratello Peter e il marito di Leila, un commerciante che fa traffici di sale e farina con la Romania. Ma vivere lì è psicologicamente difficile, le due sorelle reduci dai campi temono di essere di peso: torneranno nel paese di origine, nella vecchia casa: Leila aveva detto che con il loro ritorno le sorelle le avevano tolto dieci anni di vita.
Peter si sposa, accoglie Edith e Eliz per qualche tempo: ma Eliz va via presto, va a Budapest e si imbarca per Israele. Il fratello vorrebbe che Edith sposasse un vecchio amico del padre, che si sistemasse; lei odia l’idea. Decide di andare da Margo in Romania: Margo si è risposata ma non sembra felice. Durante il viaggio è costretta ad attendere al confine, alloggia presso una famiglia che le porterà via i gioielli affidati a lei dal fratello. Poi giunge Tibi, cognato di Margo, e si parte per Praga.
Relazioni con uomini
Margarete vive due amori; il primo, per il giovane Rafael Buber, figlio del noto filosofo Martin Buber, rianimatore del cassidismo. Da Rafael, sposato non appena raggiunta la maggiore età, avrà due figlie, una delle quali nata prima del matrimonio. Ma Rafael, che sembrava critico verso il padre, ideologicamente vicino a Margaret, è ormai cresciuto, si lascia alle spalle le idee giovanili, rientra in famiglia: il rapporto con Margarete si esaurisce e si inasprisce, i Buber le impediranno di vedere le figlie, a lungo. Poi, il suo secondo grande amore, Neumann. Che finirà però con l’essere arrestato e portato in un ignoto carcere russo, ucciso a causa delle sue divergenze con Stalin, che all’epoca ipotizzava accordi con Hitler e non apprezzava tutto ciò che Neumann aveva fatto per contrastarne l’ascesa. Margarete rimarrà sola. Sola in un Paese che non è il suo, tra gente che poco per volta evita di avere rapporti con lei, per paura delle possibili conseguenze. Ma è una donna, non è più una ragazzina. Ha fatto le sue esperienze, vivrà con una certa consapevolezza i suoi anni in un lager russo, in Siberia prima; e poi, a Ravensbrūck. Rientrata a casa, scriverà e racconterà di Milena e di Ravensbrūck, testimonierà in merito, quando necessario.

Campo di concentramento di Ravensbrūck
Edith è invece una ragazzina, certamente rimasta molto colpita da quanto le è successo, non in grado di elaborare bene il lutto per la perdita di padre e madre. Si innamora facilmente, in genere di ragazzi che si rivelano quasi subito sbagliati. Pensa di amare Tibi, il cognato di sua sorella. Lui tiene in realtà alla propria vita, non intende affatto cambiarla per lei. Matrimonio? Non è il caso, forse più avanti. Intanto i due stanno insieme, la ragazzina resta incinta. Perde il figlio. Tibi non ha alcuna intenzione di sposarla. Le sorelle si preoccupano per Edith, la mandano per qualche mese in un kibbuz: lei studia inglese, scrive qualche poesia, legge. Poi il ritorno a casa da Margo. Una casa piccola, dove manca lo spazio: lei dovrà ancora dormire in camera con Tibi. E si arriva a un incidente: lui e un amico maneggiano una pistola. Parte un colpo, Edith è ferita. Starà 15 giorni in ospedale, ne uscirà con una prognosi di tre mesi. Tutta la città parla di questo scandalo. Eppure Milan, con cui avrebbe dovuto uscire la sera in cui era stata ferita, la va a trovare, le porta fiori e dolci, le dice di amarla. Vorrebbe sposarla. Lei ha solo 16 anni, si reputa troppo giovane. Soprattutto, non ne è innamorata. Ma poi cede alle pressioni generali. C’è stato un problema con suo cognato, accusato di traffici, ricercato dalla polizia, fuggito in Germania. Lei, Milan, Margo preparano il matrimonio e la fuga.
Edith descrive il matrimonio, il cibo, il vestito bianco avuto in prestito, il ritardo del rabbino, la difficoltà di stare in tanti sotto il baldacchino, Milan che dopo aver bevuto dovrebbe rompere il bicchiere e a lungo non ci riesce [7].
Ancora pochi giorni, poi la fuga, le difficoltà al confine, l’ingresso in Germania, l’arrivo nel campo di Gerestriet: dove ci si prepara ad andare in Palestina. Poi Margo e figli partono. Gli altri, tra cui Edith, attendono. E non si capisce perché debbano tanto attendere: due mesi. Poi, finalmente, la partenza: è ormai la fine di agosto del 1948.
Voci sulla condotta poco saggia della ragazza si sono intanto sparse un po’ ovunque, sono arrivate fino in Palestina. Il matrimonio con Milan non regge. Lei vivrà un ulteriore, negativo tentativo con un ragazzo conosciuto durante il viaggio verso la nuova terra, Gabi. Con lui c’è, stando agli scritti della Bruck, un forte accordo sessuale. Lui però è geloso, anche perché spesso la deve lasciare, visto che lavora su una nave ed è assente. A un certo punto, la picchia. Più volte. Quindi, un ulteriore divorzio e poi, per motivi pratici, ancora un matrimonio, pro forma, con quel Bruck da cui lei prenderà il cognome. Questa volta i coniugi staranno insieme una mezza giornata in tutto, seduti a chiacchierare su una panchina.
Le traumatiche vicende vissute da ragazzina hanno certamente pesato a lungo, fortemente, su di lei, sui suoi comportamenti, sulle scelte amorose sbagliate, oltre che sulla sua salute duramente compromessa [8].
Margarete è più matura quando le cose volgono al peggio, saprà adattarsi quanto basta per sopravvivere, ma senza venire meno ai suoi tratti caratteriali di fondo, di serietà e impegno verso chi è in difficoltà, alle scelte politiche che l’avevano vista in un’area comunista o socialista: comunque, di sinistra.
Il lavoro
Entrambe, la Buber-Neumann e la Bruck, sono state grandi lavoratrici. Margarete, interessata alle possibili novità pedagogiche, ha seguito dei corsi per diventare maestra di scuola materna; si accosta poi all’Istituto Lichtenberg, vicino Berlino: il direttore, Karl Wilker, è un noto riformatore, pedagogo e medico. Entra poi in contatto con l’organizzazione KiHi, intesa al soccorso di bambini bisognosi. Si dedicherà quindi al lavoro da giornalista nella redazione della ‘Internationale Pressrkorrespondenz’: lì si dà molto spazio a quel che accade a Mosca. Margarete è spinta a lavorare anche dal desiderio di affrancarsi dal sostegno economico del padre.
Edith, spinta dalle circostanze, dalla necessità e dalla sua stessa natura a fare, a tentare diverse attività, dal lavoro in un bar alla pulizia di edifici e case, dalla danza alla recitazione e poi al cinema, senza mai dimenticare la scrittura, mostra una personalità decisamente più poliedrica.
Enormi diversità, quindi, tra la storia di Margarete e quella di Edith. Eppure ci sono varie assonanze. Una è certamente quella della narrazione.
Entrambe hanno passato larga parte del proprio tempo raccontando, per scritto e a voce, quello che erano i campi, il comportamento dei tedeschi, i tentativi di sopravvivenza dei prigionieri. Il dolore e la morte di tanti. Non si tratta di testimonianze indolori. Entrambe hanno molto sofferto e soffrono durante gli anni di prigionia e poi nei lunghi, restanti anni di vita. Margarete di questo accenna soltanto. Edith, invece, è consapevole della matrice remota dei suoi malesseri fisici e non trova sbagliato parlarne. In questo caso, la narrazione suscita ricordi e quindi affanni, dolori. Ma forse anche prelude al superamento del dolore, forse aiuta la protagonista nella sopravvivenza [9]
E poi, mentre sto finendo di leggere, ecco che mi imbatto in un’altra importante, significativa vicinanza: entrambe queste donne rifiutano l’odio verso chi ha reso la loro vita così difficile.
Il libro Il pane perduto si chiude con una Lettera a Dio. Questa termina ricordando i tre più frequenti interrogativi che vengono in genere posti all’autrice: se crede in Dio, se perdona il Male e se odia i suoi aguzzini:
«Alla prima domanda arrossisco come se mi chiedessero di denudarmi, alla seconda spiego che un ebreo può perdonare solo per se stesso, ma non ne sono capace perché penso agli altri annientati che non perdonerebbero me. Solo alla terza ho una risposta certa: pietà sì, verso chiunque, odio mai, per cui sono salva, orfana, libera e per questo Ti ringrazio, nella Bibbia Hashem, nella preghiera Adonai, nel quotidiano Dio» [10].
Questo mi sembra un punto di riscontro importante: al di là di tutto quello che è loro capitato, che hanno subìto, al di là delle loro vite sconvolte, della salute compromessa, Edith Bruck così come Margarete Buber-Neumann e tante altre sono state capaci di respingere la forte tentazione dell’odio. E molti uomini hanno fatto scelte analoghe. Un tratto, questo, che mi sembra da sottolineare nella sua positività ed esemplarità. Un fatto da ricordare perché sia di esempio in una società sempre più lacerata da ingiustizie sociali, da sperequazioni, da discriminazioni e detestazioni tra coloro che hanno molto e altri che hanno molto poco.
Dialoghi Mediterranei, n. 50, Luglio 2021
Note
[1] Margarete Buber-Neumann (Potsdam21 ottobre 1901-Francoforte sul Meno, 6 novembre 1989). Si tratta di una delle protagoniste del mio libro Libertà e oppressione Storie di donne del XX secolo, Napoli, Guida Editori 2020.
[2] M. Buber-Neumann, Prigioniera di Stalin e Hitler, Il Mulino1994 (1985)
[3] Milena, l’amica di Kafka, Adelphi 1986.
[4] V. anche il suo Da Potsdam a Mosca, il Mulino, 2000.
[5] Edith racconterà di un dono prezioso che viene dato a lei bambina: due nastri rossi per i capelli, e la sua preoccupazione perché uno le viene sottratto.
[6] Diversi i nomi dei familiari in Il pane perduto, Milano, La Nave di Teseo, 2021, riconoscibili comunque i personaggi.
[7] Vicende tutte da lei poi narrate in Chi ti ama così, Marsilio Venezia 2015 (1959)
[8] Ne parla a lungo in Signora Auschwitz Il dono della parola, Marsilio Venezia 2014
[9] Il tema ha un grande spazio nel libro di cui si è accennato, Signora Auschwitz.
[10] E. Bruck, Il pane perduto cit.:123.
APPENDICE
Nota cronologica su Edith Bruck (n. 11152)
1920 21 aprile. Nasce a Milano Nelo Risi
1932 3 maggio. Nasce in Ungheria, a Tiszakarád, al confine con l’Ucraina, in una famiglia ebrea con molti figli, poverissima, Edith. Lei, la sorella Eliz e il fratello Laci dormono in una stanza, i genitori in cucina. Un’altra stanza ha un tetto di canne, ci passa l’acqua. Gli altri figli, Laila, Margo e Peter, vivono e lavorano a Budapest. Il padre è macellaio e commerciante, ma i suoi traffici non portano grandi entrate. La bambina cresce e ruba, a volte, uova e galline a vicini abbienti.
1944 il primo forzoso viaggio di Edith: verso il ghetto del capoluogo e poi, a fine maggio, verso Auschwitz (4 giorni di viaggio). All’arrivo, viene separata dalla mamma, che verrà cremata. A seguire, andranno a Kaufering, lager piccolo, dove non si lavora. C’è fame, gelo, pidocchi. Poi a Landsberg, uno dei tanti sottocampi di Dachau e poi a Bergen-Belsen. Poi cinque settimane di marcia e di nuovo a Bergen Belsen, nel campo maschile, pieno di cadaveri nudi. Gelo, fame. Poi a un certo punto i prigionieri si rendono conto che i tedeschi non ci sono più.
1945 È la liberazione: arrivano una jeep e poi un camion con americani che inondano tutti di DDT. Lei, Edith, compie lì 14 anni. Staranno lì due mesi, lei e Judit, in ospedale, si rimetteranno un po’ in sesto. Poi da Bergen Belsen vanno a un paese vicino, Celle, dove danno loro dei documenti.
E ha inizio il viaggio di ritorno: viene detto loro che saranno rimpatriate tra gli ultimi in quanto ungheresi: si avviano quindi senza attendere il turno del rimpatrio. Alla stazione di Bergen Belsen prendono un treno merci che trasporta carbone, diretto a Pilsen, in Boemia. Da lì raggiungono Bratislava. Rifocillate al centro di assistenza, poi a Budapest. Lì ricevono un aiuto in soldi al centro di assistenza, poi ritrovano la sorella Mirjam: ha con sé il figlio Tomika, suo marito, spiega, è morto dopo una marcia verso i campi. Aveva fatto a lungo lavori forzati.
La sorella dà loro abiti puliti, le ospita per poco tempo: il cibo è contato. Andranno allora verso la casa di Sara, dove c’è il fratello David. Sara le accoglie freddamente, impone loro di lavarsi. Lei, bella, elegante, bracciali d’oro ai polsi. David arriva e spiega come sia morto il loro padre: lui lavora con il cognato in una fabbrica di vernici.
Dopo un po’le due sorelle decidono di proseguire per il loro paese, di vedere cosa è successo alla casa: la trovano svuotata, la Singer rotta, qualche foto emerge dal letame che trabocca dalla vicina stalla. Judit decide di andare nella Terra Promessa, vuole portare con sé la sorella: ma Edith vuole scrivere e non vuole essere comandata.
Fine 1945 Edith inizia a scrivere, in ungherese, un racconto autobiografico. Lo perderà nella fuga in Cecoslovacchia, insieme ad alcune poesie dedicate alla madre.
Mirjam sposa un cugino rimasto vedovo, vanno in Cecoslovacchia. Judit parte per la Palestina. Lei che non ha voluto seguirla resta da Sara, una Sara sempre più gelida. Poi, un incidente con un ospite di Sara che la aggredisce e Sara la manda via: non si vedranno più per venti anni. Edith va dal fratello, dorme nella stessa stanza con lui e la moglie, divisi da un telo. Il fratello vorrebbe sistemarla, la spinge a fidanzarsi con un amico del padre: che presto parte per il Canada. Davide vende la piccola casa della moglie e organizza la fuga della sorella in Slovacchia. Le dà qualche gioiello comprato con il ricavato della vendita della casa.
1946 Capodanno. Edith è a Bratislavia. La accoglie Alex, ex compagno di lager del fratello, che ha una casa grande e semivuota, con varia gente: lei capirà poi che intendono partire per la Palestina. Dovranno presto andare in un campo di transito in Germania, alla periferia di Monaco. Si viene a sapere che la nave su cui era imbarcata la sorella era stata sequestrata dagli inglesi, i migranti sono a Cipro. Edith con altri segue un lungo addestramento. Ha a che fare con un uomo che la possiede, di cui si era innamorata, che forse le ruba i gioielli.
Poi, la notizia: è nato lo Stato di Israele. Lei, su un camion per Marsiglia: la prima volta che vede il mare. In un campo di raccolta, poi su l’Arca di Noè: siamo a fine agosto.
1948 primi di settembre. Si parte per Israele. Edith sta male, vomita tutto il tempo, il marito a sua volta non abbandona la cuccetta. Ci sono ebrei dello Yemen, del Marocco, dell’Algeria. Poi, lo sbarco: verranno portati in un campo tra Tel Aviv e Haifa.
3 settembre ’48 Fa un gran caldo, in fila per ore per i pasti, si sentono “Maledizioni e parolacce” (E. Bruck, Chi ti ama così, Marsilio Venezia 1974 [2015]: 88). Non sembra la terra di latte e miele vagheggiata dalla mamma. Nel campo le dicono che Eliz e David sono già nel paese: lui, con moglie e figlio in una cooperativa agricola. Va a trovare Margo, che spiega come Eliz sia ad Haifa con il marito sposato a Cipro e abbiano un figlio, Haim. A Tel Aviv c’è uno zio Joel. Una famiglia che in qualche modo sembra potersi ritrovare, quindi. Ma intanto i rapporti con il marito peggiorano.
Edith parte in autostop per raggiungere Eliz, felice di vederla: conosce il figlio, il marito. Ma non vuole rimanere, prende un altro passaggio per rientrare. In città re-incontra un ragazzo che era sulla nave, Gabi. Poi va da David suo fratello, scopre che lui ha problemi di cuore, la moglie di polmoni: non molto adatti a lavorare la terra.
Trova lavoro: fa le pulizie in un ospedale militare, oltre che nelle case di vari medici. Prende una stanza in una famiglia con varie persone, ci si trova bene anche se chi rientra tardi deve attraversare il locale dove lei cerca di dormire. «Piano piano riacquistavo la fiducia nella gente» (Ivi: 97). Con il marito le cose sono finite. Lei ha 17 anni.
1949 Sposerà un Gabi, un amico cuoco pensa al cibo. Una settimana di sesso, poi lui riparte in nave. Lei con una conoscente fanno le pulizie nell’ospedale militare di Haifa: cosa che non piace molto al giovane marito che parte, ritorna, riparte, non apprezza che lei scriva, non vuole figli ma solo lei. Vanno avanti così per mesi. Spinta dal marito, lei lascia l’ospedale e va a lavorare al caffè Nizza, dove vende gelati. Segue un corso di ebraico, prende un diploma di cameriera professionale: e trova lavoro in un ristorante sul lungomare di Haifa. Guadagna ormai bene, ma ha problemi con clienti avvinazzati. Poi il marito ha per due volte atti di violenza nei suoi confronti:«Cominciò a picchiarmi per delle sciocchezze e una volta fu presente anche mia sorella. Io non ragionavo più, ero incapace di lasciarlo, mi detestavo perché sposandolo avevo sbagliato ancora una volta, e non sapevo che fare» (ivi: 100). Con fatica lei lo lascia, raggiunge la sorella. Più volte, con Gabi, si riprendono e ancora si lasciano. Lei continua ad andare al lavoro: lui a casa ha distrutto tutte le sue cose. Conosce dei comunisti, e uno le regala un libro di poesie di József Attila: lei ne è beata. Il cognato le spiega presto che gli ortodossi non apprezzano affatto i comunisti. Lei divorzia, ma presto capisce che o si risposa o dovrà fare il servizio militare: si risposa ufficialmente con Tomi Bruck, da cui anche divorzierà quasi subito. Un matrimonio formale: passeranno un unico pomeriggio insieme parlandosi seduti su una panchina.
1952 Lei ha ormai venti anni. Intanto, studia e legge tutto quello che le capita. Sente intorno a sé un certo biasimo sociale. Lei cerca di spiegare, di spiegarsi: «Rispondevo che non sapevano comprenderci. In Germania avevamo perso tutto e tutti e sposavamo per non restare mai, neanche un istante, soli. Vivevamo la vita giorno per giorno ancora sotto l’incubo della morte. Eravamo rimasti orfani molto giovani, senza un appoggio morale, senza una casa, con poca salute, parecchi bruciati per sempre. In città c’erano trenta divorzi al giorno e tutti di giovani come me. È difficile trovare da soli la giusta strada…» (E. Bruck, Chi ti ama cosi, cit.: 107).
Parte per Atene con un gruppo di ballo. Passerà poi al Gruppo Max con cui andrà a stare a Zurigo. Quindi, spostamento per lavoro a Napoli: e l’Italia le piace subito, impara presto l’italiano, anche se si stupisce per certi ritardi, v. l’uso del bikini, a Napoli apparentemente sconosciuto. Poi Lilli, danzatrice del ventre, si deve sposare con Simon e va a stare a Roma: Edith va con lei. Vanno a stare in via Vaina 8. Edith è colpita dall’alto numero di mendicanti, dalle tracce evidenti nelle case, nei muri, della recente guerra. Si iscrive a un corso di inglese, cerca di imparare i verbi italiani. Poi Simon e Lilli vanno in Sicilia e lei trasloca in una stanza ammobiliata non lontano da Piazza di Spagna. Mangia con i padroni di casa o, su suggerimento della proprietaria, da Otello: dove va molta gente del cinema. Lì incontra Tonino Cervi e una signora, Nadia: tramite lei finisce col lavorare in un istituto di bellezza. Lo frequentano la principessa Torlonia e Paola Ruffo di Calabria, Valentina Cortese e Anna Magnani, che la colpisce per il viso intenso. Guadagna 80 mila lire al mese, per lei tanto. Ma le pesa la proprietaria. Le pesa l’arroganza della Martinelli, che vuol essere chiamata contessa Mancinelli Scotti. Conosce molte celebrità.
1957 Incontra in un gruppo di amici Nelo Risi. In Il pane perduto scrive: «Nelo, l’uomo eletto tra milioni di uomini, mi si dava e scompariva. Mi cercava e mi abbandonava. Mi voleva e non mi voleva» (115).
1958-’59 riesce a riscrivere in italiano quello che poi sarà Chi ti ama così.
1959 Esce il suo primo libro, Chi ti ama così, Lerici, autobiografia, v. infanzia in riva al Tibisco e la Germania dei lager.
Si sposa con Nelo Risi, in Campidoglio, celebra Francesco Fausto Nitti, uno dei fondatori di Giustizia e Libertà.
2015 17 settembre. Muore Nelo Risi.
Maria Immacolata Macioti, già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali, ha insegnato nella facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione della Sapienza di Roma. Ha diretto il master Immigrati e rifugiati e ha coordinato per vari anni il Dottorato in Teoria e ricerca sociale. È stata vicepresidente dell’Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell’Ambiente. È coordinatrice scientifica della rivista “La critica sociologica” e autrice di numerosissime pubblicazioni. Tra le più recenti si segnalano: Il fascino del carisma. Alla ricerca di una spiritualità perduta (2009); L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia (con E. Pugliese, nuova edizione 2010); L’Armenia, gli Armeni cento anni dopo (2015), Miti e magie delle erbe (2019); Libertà e oppressione Storie di donne del XX secolo ( 2020).
______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/vite-parallele-nel-dramma-e-nella-scrittura/
Click here to print.