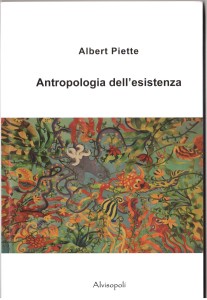Nel quotidiano susseguirsi di assunzioni di ruoli, nel correlativo intrecciarsi di relazioni intrattenute con i propri simili, con oggetti e spazi circostanti, gli individui si trovano inevitabilmente a essere soggetti – preposti – a una varietà di sollecitazioni sensoriali e percettive. Tale sottile esperienza va di pari passo con il succedersi del pensare, ordinario e comune, di tutti i giorni così come – nel fluire del tempo – con l’instaurarsi dei ricordi e, man mano, del loro eventuale archiviarsi o connettersi ad altri ricordi. Questa “tempesta interiore”, avente luogo quotidianamente, apparentemente in sordina, nella mente dei singoli, traduce in qualche modo l’estrema complessità di relazioni implicate dai livelli di agentività presi in carico dai soggetti situati nei diversi contesti sociali e culturali. Analizzare il modo in cui gli individui si fanno carico di questi diversi livelli agentivi, se ne assumono la responsabilità e talvolta li trasformano nell’agire quotidiano, significa porre al centro della lente teorica dell’antropologo l’esistenza nelle sue varie sfaccettature. Pubblicando Anthropologie existentiale, l’antropologo francese Albert Piette, professore al Dipartimento di Antropologia dell’Università Paris Ouest Nanterre, propone di ripensare l’epistemologia delle scienze umane e sociali a partire proprio dall’idea stessa di esistenza rivista con lo sguardo dell’antropologo. Nel 2016 viene pubblicata l’edizione italiana con il titolo Antropologia dell’esistenza edita a cura di Edizioni Alvisopoli con la traduzione di Murielle Drouille-Scarpa.
I capitoli del libro si avvicendano ponendo le questioni relative ai fondamenti di questa disciplina, volta a scandagliare in prima analisi l’esistenza, facendo riferimento al più ampio scenario contemporaneo riguardante le scienze umane. Scorrendo i titoli riportati nell’indice si evidenziano, fin dall’inizio, i nuclei fondanti l’impianto epistemologico del modello antropologico proposto da Piette. Nell’economia del testo, ogni capitolo pone domande e cerca risposte teoricamente date e giustificate. La domanda di partenza e di ritorno è la seguente: come si può (e si deve) impostare una disciplina, se l’oggetto di studio è l’uomo e il suo essere sociale e umano? In Antropologia dell’esistenza vengono indagate le molteplici prospettive di ricerca relative all’osservazione della dimensione esistenziale dell’uomo contemporaneo, vengono tracciati gli elementi di una descrizione critica del soggetto, le modalità del suo essere sociale e culturale in quanto individuo che agisce e pensa più nel concreto che nell’astrazione delle relazioni e strutturazioni.
Nell’antropologia esistenziale di Piette il concetto di “modo minore” ha un posto centrale poiché, nella sua prospettiva, l’esistenza umana si coniuga e si manifesta per toni, modi, gradi e sfumature varie. L’oggetto di focalizzazione è l’uomo stesso unitamente alle molteplici linee di azione pragmatica e cognitiva che tessono il fluire continuo della sua esistenza individuale. Gli iter pragmatici e cognitivi del quotidiano vivere – mai conclusi in sé in un avvicendarsi deterministico ma in concomitante svolgersi con altri individui – si sviluppano con modalità a volte imprevedibili, o non palesi, in prima istanza. Piette individua differenti strati di pensiero riassumibili in quattro livelli di intensità attentiva: il pensiero libero (puro, sconfinato e slegato), il pensiero consapevole, il pensiero attentivo (propriamente cognitivo) e il pensiero-azione. I differenti livelli emanano dalla modulazione dei quattro elementi che costituiscono il principio euristico – Piette lo chiama “riposità” – fondato sull’economia cognitiva e, il suo contrario, il lavoro di valutazione; sulla fluidità e, il suo contrario, l’irrigidimento.
Gli oggetti del pensare, se perdono un pur sottile legame con l’azione diretta, assumono la qualità di “resti” e costituiscono lo strato sedimentario sul quale si svolgono le azioni manifeste e successive. Tale strato è altro e non-è-altro rispetto alle azioni in corso che ne coniugano il rapporto di presenza-assenza. Quest’ultimo è meglio comprensibile se lo spieghiamo come assenza della presenza e presenza dell’assenza. Ne deriva una inclusione dei contrari, in una prospettata forma di continuità di base, che esprime il loro carattere complementare. Pur non essendo evidenti dei richiami, assenza e presenza – co-esistenti – si coniugano a vicenda costituendo strati di modalità di diversa densità. Piette chiama metaforicamente “tela di fondo” questo strato sedimentario costituito dai dettagli, da oggetti periferici e da tutte le forme dell’esistenza umana ascrivibili al cosiddetto “modo minore”. In Antropologia dell’esistenza troviamo in vari punti del libro la definizione di modo minore:
«è l’obiettivo dell’antropologia esistenziale fondamentalmente empirica: cogliere la realtà nelle sue variazioni e nelle sue differenze fino alle percezioni senza importanza di gesti, di pensieri, di oggetti e dei differenti esseri umani presenti. Le cose avvengono, le sfide continuano ma in un’atmosfera concretizzata da esseri e da oggetti periferici, da pensieri e da percezioni senza importanza. È proprio questo il modo minore» (Piette, 2016: 8).
La «grande quantità di dettagli» periferici e «senza rilevante importanza» che costituiscono il modo minore, strato di fondo dotato di reversibilità, è originato dalla capacità dell’uomo di trasferire le proprie azioni e la propria presenza, più o meno consapevole, da un contesto a un altro come si evince dal passo seguente:
«sono sempre colpito dalla facilità con la quale l’uomo si sposta da una situazione all’altra, una sorta di evidenza esistenziale che consiste nell’essere, nel perseverare e, come direbbe Spinoza, nel continuare semplicemente negli istanti e nelle azioni, nei momenti e nelle situazioni» (Piette, 2016: 7).
I dettagli al margine dell’azione principale, dunque, sono testimonianza della capacità dell’uomo di saper distinguere le numerose forme di esperito in base al grado di significatività rispetto all’azione in corso. Ciò solo apparentemente può dare luogo ad un paradosso poiché, nella prospettiva di Piette, il pensiero “vagabondo” corrisponde alla capacità umana di estraniarsi senza che, per questo, venga meno il controllo automatizzato della situazione. È come una zona libera di sovrapposizione, in successione, di ciò che resta dell’esperienza e delle azioni in corso, necessarie e contingenti.
In poche parole, l’uomo è “in quanto tale” proprio in virtù del suo continuo entrare, uscire e spostarsi da una situazione ad un’altra: l’esistenza empirica consta di questo continuo spostarsi di azione in azione, da contesto a contesto. Il concetto di umano che viene a delinearsi rifugge necessariamente dai processi teorici di astrazione e generalizzazione al fine di meglio focalizzare l’attenzione sull’unicità e sull’irripetibilità del fluire dell’agire del singolo in quanto ente esistente (Piette, 2016: 29). In sostanza, lo studio perseguito dall’Anthropologie existentiale prende di mira non le potenziali unità umane nel loro insieme, ma “l’essere umano in quanto esistente”, nella sua singolarità che lo rende unico rispetto a presupposti universali di un qualche tipo. Nel seguente passo tratto dal libro, Piette sintetizza così la questione relativa all’individuo e alla sua singolarità:
«ci sono degli individui, questi ciascuno, che chiunque può reperire e indicare come tali. Sono degli “esseri umani” in tutte le parti del mondo. In mezzo agli altri, ciascuno è un’unità, un’identità associata ad una continuità corporale identificabile. Diciamo che la singolarità di ciascuno non dipende dalle differenze rispetto agli altri, ma si impone da sé, è il segno stesso dell’individuo» (Piette, 2016: 31).
Poste queste coordinate di riferimento, è più semplice, per il lettore, capire come si sviluppa l’antropologia esistenziale di Piette. Tale impostazione, più che seguire il ‘cammino’ – scelto da altri antropologi – del relazionismo, fondato soprattutto sulle differenze, predilige quello della singolarità e specificità dell’essere. La singolarità dell’individuo va di pari passo, in Piette, con un altro concetto importante: il “volume dell’essere”. Esso è
«una presenza composta da diversi strati, da “potenze”, cioè da abilità diverse, da disposizioni cognitive, psicologiche e sociali innate o formate dall’abitudine, dall’esperienza, dalla vita; un peso relativamente forte di eventi passati da tanto o da poco tempo. […] il volume dell’essere contiene alcune tracce delle traiettorie sociali e culturali, dei contesti socio-culturali legati ai percorsi di vita, delle tracce dei parametri psicologici, delle tracce d’umore legate agli istanti precedenti, degli strati condivisi e differenti, che in più, si combinano tra loro, in un volume dell’essere certamente trasformato, ma con delle parti più durevoli, e più permanenti d’altre» (Piette, 2016: 32).
L’universale, se tale, si nutre di piccoli gesti e di piccoli dettagli colmando lo scarto significativo fra ciò che possiamo intendere per vissuto e il piano dell’esistenza nella sua ampiezza. Ogni azione e ogni scelta di azione, per quanto individuale e isolata, aggiunge un quid all’idea universale di uomo. In tal senso, la successione di istanti è attributo di continuità poiché essa è la risultante dei continui processi di attivazione e disattivazione dei dispositivi passati, già esperiti, e delle azioni presenti, attuate nel divenire dell’esistenza. È nelle azioni e nelle micro-azioni del quotidiano che si manifesta il rapporto di autodefinizione dell’esistenza individuale fra singolarità e generalizzazione, concretizzazione degli atti e astrazione delle azioni sociali e relazionali. Da questo punto di vista, la modalità della condivisione implica un movimento verso l’altro e un passaggio di senso e gradi di significatività verso uno spazio comune di esperienza dell’hic et nunc nel quale essa avviene. Un atto soggettivo viene astratto dalla singolarità che lo ha generato per essere rivalorizzato in una dimensione di continuo confronto. In tal modo, si approda all’individuazione di cosiddetti “atti comuni”, resi tali dal gioco sociale fra continuità, diversità e similitudine in termini quali-quantitativi.
L’aspetto dell’unità è veramente pregnante nell’impostazione di Piette poiché è manifestazione della coerenza necessaria a individuare l’uomo nel suo essere e farsi umano attraverso fasi, processi e situazioni di cambiamento e trasformazione. Si delinea, così, la necessità di una sorta di istanza di coerenza interna al sistema dell’essere. Certo, non è semplice coniugare unicità e generalità, particolare e generale, individuale e collettivo, singolarità e relazione, conservazione ed evoluzione, differenziazione e assimilazione, senza rischiare di incorrere in qualche apparente contraddizione. Di questo Piette è consapevole e questo è uno dei punti di forza del sistema teorico che costruisce e propone nelle argomentazioni dell’Anthropologie existentiale.
L’impianto epistemologico della sua Antropologia si mostra solido e incalzante nel porre e risolvere le problematiche e le questioni disciplinari propo- nendosi con chiarezza e determinazione fra i diversi riferimenti teorici attraverso la puntuale citazione di autori e testi. A tal proposito, si pone un’ultima questione: il ruolo delle relazioni. Piette prende le dovute distanze da certa antropologia sociale contemporanea che dà, a suo vedere, eccessiva centralità al “relazionismo” e all’“interazionismo”; egli procede, invece, in senso inverso, inquadrando la questione delle relazioni e delle traiettorie sociali senza rinunciare alla centralità dell’aspetto agentivo derivante dalla singolarità e dalle sequenze di micro-atti che compongono ciò che Piette riconduce al concetto di esistenza. Leggiamo, dal capitolo interamente dedicato alla questione, che le relazioni sono «modi di presenza, delle eso-azioni» cioè «espressioni che provengono dall’individuo» rivolte ad altri. Il quadro teorico concettuale si completa a più riprese con il progredire della trattazione:
«Le eso-azioni sono un’esteriorizzazione, un’espressione delle entità individuali, che possono certamente modificarle ma raramente in modo completo. (…) Diciamo che queste eso-azioni sono più o meno implicanti e fondamentali, generano dei cambiamenti che hanno diversi impatti, puntuali o durevoli, brutali o progressivi, sulla continuità dell’esistenza degli individui coinvolti. (…) La relazione è anche una non-relazione per la singolarità e l’alterità radicale di ciascuno e per la sua imperfezione. Ciò che occorre descrivere è quindi l’ombra della relazione, la sua imperfezione, la complessità millimetrica sfumata e articolata di ciascuno nelle continuità delle relazioni» (Piette, 2016: 42-43).
Dato l’oggetto di ricerca, per quanto riguarda le metodologie e le strategie di indagine utili a sostenere sul campo la prospettiva disciplinare che Piette chiama “fenomenografia”, si fa ricorso alle tecniche di shadowing combinate alle interviste e ai colloqui volti a promuovere una fase successiva di auto-riflessione e auto-espressione di sentimenti ed emozioni implicite che sostengono le azioni osservate e descritte. La fenomenografia
«punta ad un’osservazione-descrizione degli individui in determinate situazioni, seguendoli, uno alla volta, nelle loro oscillazioni, secondo il ritmo del tempo e delle giornate, centrando lo sguardo, a partire da zoom diversi, sui modi di presenza e sulla loro continuità» (Piette, 2016: 46).
Tale “grafia” dell’azione confluisce nella cosiddetta “antropografia”, intesa come scienza che studia l’individuo immerso nella singolarità della sua esistenza. Un punto è importante: l’osservazione diretta e indiretta e la descrizione densa non si focalizzano sulle interazioni in astratto ma sull’effettivo svolgersi dei particolari che rendono unico ogni atto personale e soggettivo. Quindi, dal suo posizionamento, l’antropologo non procede per focalizzazioni d’ordine esclusivamente globale né esclusivamente particolare degli eventi, ma li segue nel loro svolgersi effettivo a partire dalla presenza-continuità dell’individuo. Emerge, dunque, che l’unicità dell’esistenza umana si articola in un continuo gioco di presenza e “ritiro”, azione e passività, focalizzazioni e “resti”.
Per concludere con le parole di Piette, possiamo affermare che, in tal modo, l’individuo si costituisce – con quello che potrebbe essere inteso come un ossimoro – “attante singolare”. Dalla lettura di Antropologia dell’esistenza, si evince dunque un sicuro interesse nell’impostazione teorica di Piette deciso a riaffermare la centralità della dimensione dell’individuo nello studio critico dell’esperienza umana nel suo complesso insieme e nella sua interezza, compresa fra la nascita e la morte, nel suo gioco di manifestazione e eclissarsi di valori e tendenze, di continuità (oltre che di discontinuità) semantiche.
Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016
________________________________________________________________________________
Concetta Garofalo, laureata sia in Lettere sia in Studi storici, antropologici e geografici presso l’Università degli Studi di Palermo, studia i molteplici aspetti teorici e pragmatici della agency e i processi, a breve e lungo termine, di interazione fra soggetti, instaurati nel mondo contemporaneo in relazione ai sistemi culturali di appartenenza, in spazi e tempi configurati soprattutto dai contesti urbani e dai contesti di apprendimento. La sua prospettiva di ricerca interdisciplinare attinge agli ambiti di studio più specifici dell’etnopragmatica e della sociosemiotica.
________________________________________________________________