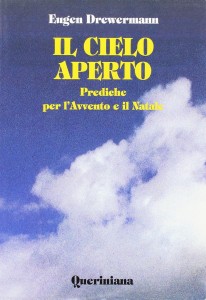Teologia e psicoanalisi. Invito al pensiero di Eugen Drewermann
Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2020 @ 03:01 In Letture,Religioni | No Comments
Proprio in questi giorni (20 giugno 2020) Eugen Drewermann ha compiuto ottant’anni. L’ho incontrato solo una volta, per alcune ore, a Palermo nel 1996, ma i suoi libri – tradotti in molte lingue – hanno segnato come pochi altri la mia vita. A mo’ di regalo di compleanno vorrei dedicargli alcune pagine sia per farlo conoscere a chi (soprattutto per ragioni anagrafiche) non abbia mai letto nulla di lui sia – proprio in omaggio al suo spirito critico – per provare a formulare alcune ragioni di dissenso. Chi volesse andare oltre questi brevi cenni introduttivi potrebbe iniziare la conoscenza della sua grandiosa opera omnia dalla lunga conversazione con Jürgen Hoeren (cfr. Drewermann 2003).
Quale ‘religione’ è necessaria all’umanità?
In un’epoca di indubbia secolarizzazione (anche se alcuni sociologi, talora modificando opinioni proprie, ritengono di individuare molte tracce di post-secolarizzazione) Drewermann sostiene con forza quasi provocatoria la legittimità, anzi l’irrinunciabilità, della “religione” per la sopravvivenza della specie umana. La tesi è per lo meno ardita: per discuterla nel merito va però liberata da possibili, anzi probabili, equivoci. Il semantema “religione”, a seconda dei contesti, viene adoperato da Drewermann in almeno due accezioni differenti. Quando egli si riferisce alle religioni ‘positive’, storiche, come sistemi gerarchici/dottrinari/etici/liturgici, si mostra di una durezza spietata:
«Ciò che noi oggi chiamiamo religione, a me pare lo sgabuzzino della società. Si suppone che lì dentro ci siano ancora un paio di attrezzi per pulire, ma essi sono più buoni per un sabba infernale che per la pulizia del sistema nel suo complesso. Il patrimonio di ciò che un tempo era la religione, oggi si presenta solo gestito in versione mediatica e folcloristica. Quando il papa, in una udienza in san Pietro, impartisce la benedizione urbi et orbi, tutte le telecamere sono puntate su questo evento e naturalmente miliardi di persone, volendo, se lo possono vedere. Ma, in quanto evento mediatico, ha lo stesso valore di quando noi qui a casa nostra guardiamo gli induisti che si immergono nel Gange. Per chi induista non è, questo fatto non è collegato a un’esperienza religiosa. Se la religione viene considerata un intrattenimento, ci si può chiedere, naturalmente, se le cose non stessero esattamente così anche prima: […] non spiritualità, non autenticità esistenziale, non il coraggio di rischiare la libertà, non individualità o esistenza profetica – il collettivo come associazione e il folclore della tradizione ‘proteggono’ la religione» (Drewermann 2003: 162).
In questa prima accezione del termine, Drewermann è in linea con quei teologi contemporanei che sostengono ormai superato il “paradigma religionale” (cfr. Fanti- Sudati 2016). Tuttavia egli usa lo stesso vocabolo “religione” come sinonimo di “fede”: e fede non in quanto accettazione di (presunte) verità che sarebbero state rivelate da Dio all’umanità mediante profeti (Mosé, Gesù, Maometto…), bensì in quanto atteggiamento di “fiducia” in Qualcuno che, nella sua potenza e nella sua bontà, regge il mondo (e, in esso, ciascun essere vivente).
«Non bisogna dire che in questo mondo ognuno è condannato alla sofferenza e all’infelicità e ciò per il semplice fatto di essere un uomo che pensa? Non è vero che, in un certo senso, tutti sono malati nel loro spirito, perché sono consapevoli di essere abbandonati a se stessi di fronte alla morte, alla caducità, alla nullità, alla non-necessarietà dell’esistenza e al fatto di essere solo in apparenza?» (Drewermann 1995: 61).
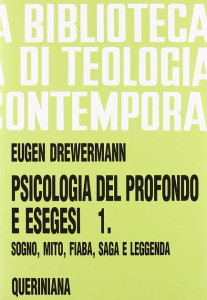 Ebbene, la “religione” (autentica) è «essenzialmente una risposta alla contingenza, a questo problema di fondo di tutto l’esserci creato e finito» (Ivi). In questa accezione, “religione” non sarebbe patrimonio esclusivo di una determinata tradizione, ma di tutte le grandi sapienze dell’umanità: la sua eclisse non risulterebbe né prevedibile né tanto meno auspicabile.
Ebbene, la “religione” (autentica) è «essenzialmente una risposta alla contingenza, a questo problema di fondo di tutto l’esserci creato e finito» (Ivi). In questa accezione, “religione” non sarebbe patrimonio esclusivo di una determinata tradizione, ma di tutte le grandi sapienze dell’umanità: la sua eclisse non risulterebbe né prevedibile né tanto meno auspicabile.
Ma analizziamo più attentamente la risposta di Drewermann, distante tanto da chi invita «ad andare oltre la religione» (Fox 2019: 226) quanto dall’insegnamento del Magistero cattolico. Egli sa bene che
«non c’è catechismo, non c’è trattazione teologica che, in sostanza, non cominci con: “In principio Dio creò il cielo e la terra”. E nella storia della teologia si è sempre inteso di poter desumere dal dato di fatto della creazione l’esistenza di Dio. Nella Chiesa cattolica, il concilio Vaticano I, verso il 1870, ha persino elevato a dogma la dottrina che è possibile dimostrare (demonstrari posse) l’esistenza di Dio. E nei testi conciliari si è addirittura aggiunta la formula: con l’ausilio della proposizione causale. Si intendeva dire che Dio è la causa suprema, e che il mondo non si spiega fino in fondo finché non desumiamo Dio come la causa che è in grado di spiegare tutto» (Drewermann 2003: 29).
Questo itinerarium mentis in Deum sarebbe, a suo parere, ormai impercorribile. Le scienze naturali (in primis, astrofisica e biologia) renderebbero impossibile continuare a partire dalla bellezza dell’universo, dalle sue leggi decifrabili, dal suo stesso esistere quali piste di decollo per risalire a un Essere creatore. A suo avviso, infatti,
«nella natura la sapienza e la bontà sono messe in discussione. Esiste una sofferenza talmente infinita, esistono talmente tante cose che non hanno ricompensa, talmente tanto caos e tanta assurdità in questo mondo, che non ci si può richiamare a un piano razionale in via di realizzazione, il quale, come una cianografia in mano a un tecnico, diventerebbe l’architettura del mondo» (Drewermann 2003: 20- 21).
La vita, individuale e collettiva, degli esseri umani come degli altri animali,
«va considerata tragica e per nessun motivo la grandiosa manifestazione di un Dio che ha organizzato tutto questo con amore e sapienza, con bontà e onnipotenza. Ciò che noi chiamiamo ‘creazione’ è, Charles Darwin ha ragione, prima di tutto un pasticcio, ben lontano da qualsiasi perfezione, che probabilmente non ci sarà mai. In un mondo in cui un animale vive solo per mangiarne un altro, in cui ogni pianta cresce facendo ombra alla pianta vicina, che fa morire, di bontà non ce n’è molta da vedere» (Drewermann 2003: 55).
 Se le cose stanno così, se nessun Lebniz può ormai arrischiare una «giustificazione di Dio» (una “teodicea”), non resta che optare per il «crescente ateismo nell’età moderna»? (Drewermann 2003: 21) Non resta che abbracciare la secolarizzazione post-religionale? Il pensatore tedesco spiazza anche questo genere di aspettative. Ammette che l’esperienza del mondo e nel mondo ci rappresenta soprattutto errori e orrori; che la condizione fisiologica non può essere se non l’angoscia intesa, heideggerianamente, come smarrimento al cospetto della morte. Aggiunge, sulla scia di Kierkegaard, che dall’angoscia deriva ogni forma di cattiveria, egoismo, avidità, prepotenza, violenza. Tuttavia si chiede: perché, sino ad oggi, in preda all’angoscia, l’umanità non si è autodistrutta? Che cosa l’ha, sinora, preservata dal suicidio nichilistico? A opera di cosa può essere ‘salvata’, oggi e nell’immediato futuro?
Se le cose stanno così, se nessun Lebniz può ormai arrischiare una «giustificazione di Dio» (una “teodicea”), non resta che optare per il «crescente ateismo nell’età moderna»? (Drewermann 2003: 21) Non resta che abbracciare la secolarizzazione post-religionale? Il pensatore tedesco spiazza anche questo genere di aspettative. Ammette che l’esperienza del mondo e nel mondo ci rappresenta soprattutto errori e orrori; che la condizione fisiologica non può essere se non l’angoscia intesa, heideggerianamente, come smarrimento al cospetto della morte. Aggiunge, sulla scia di Kierkegaard, che dall’angoscia deriva ogni forma di cattiveria, egoismo, avidità, prepotenza, violenza. Tuttavia si chiede: perché, sino ad oggi, in preda all’angoscia, l’umanità non si è autodistrutta? Che cosa l’ha, sinora, preservata dal suicidio nichilistico? A opera di cosa può essere ‘salvata’, oggi e nell’immediato futuro?
Solo dall’idea che la morte non è la fine di tutto, ma il passaggio dal tempo all’eternità. Questa idea è la fede, la religione in senso forte e vero: essa sola può risparmiare alla specie umana l’autodissoluzione collettiva. Fede non come ‘credenza’, condivisione di questa o quella ‘dottrina’, recezione di ‘opinioni’ più o meno autorevoli, ma come “fedeltà”, affidamento nelle braccia di Dio.
Tale convinzione – per essere esistenzialmente efficace nelle vite e nella storia – non può configurarsi in termini meramente concettuali: deve piuttosto manifestarsi poeticamente, nella lingua dei simboli, delle metafore, delle immagini. Non è un caso che tutti i libri ‘sacri’ (tra cui la Bibbia) si snodino su registri linguistici ‘narrativi’, raccontando sogni, miti, fiabe, saghe, leggende, visioni, storie di ‘miracoli’, ‘profezie’, parabole (cfr. Drewermann 1996). L’equivoco letale della cristianità si è consumato quando, sin dai primi secoli, questo linguaggio evocativo è stato trasposto sul piano logico-razionale ed è stato cristallizzato in dogmi e precetti da imporre sempre più violentemente quanto meno risultavano comprensibili e accettabili dal buon senso della gente e dalla riflessione degli intellettuali. Oggi la cultura ci mette a disposizione molti strumenti per riscoprire l’approccio più adeguato a questi testi, soprattutto grazie alla psicoanalisi di Freud e di Jung: i commenti al libro di Giona (cfr. Drewermann 2003) o al vangelo di Marco (cfr. Drewermann 2002), ad opera dello stesso Drewermann, ne costituiscano ammirevoli esemplificazioni.
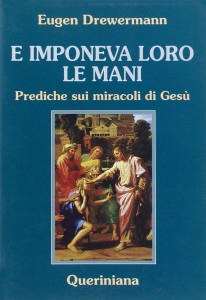 Postulare Dio anche grazie al Gesù della storia
Postulare Dio anche grazie al Gesù della storia
Possiamo concludere, dunque, che il teologo-psicoterapeuta tedesco abbia sostituito la via cosmologica (tradizionale) con una (nuova) via ‘psicologica’ che porta a Dio partendo non più dall’universo fisico quanto dal mondo interiore (e inconscio) della specie umana?
La questione non è così semplificabile. Infatti: la religione/fede, di cui abbiamo ‘disperato’ bisogno, può considerarsi il correlativo antropologico di un Dato ‘oggettivo’, assoluto, noumenico (per usare il dizionario di Kant)? È la risonanza in noi mortali di un Eterno sussistente ‘prima’, ‘senza’ e ‘oltre’ noi?
Per varie ragioni (sino a quando è stato docente universitario e prete cattolico, anche per motivi di ‘prudenza’ diplomatica: cfr. le estenuanti polemiche con il vescovo di Paderborn e altre autorità ecclesiastiche riportate in Drewermann 1994) non mi sembra che egli dia una risposta inequivoca. Dall’insieme della sua (sterminata) produzione mi pare, però che si evinca questa risposta: non lo sappiamo né lo sapremo mai, anche perché se lo sapessimo non si tratterebbe più di “fede” ma di sapere, di scienza. Se interpreto correttamente il suo pensiero, egli ritiene che, dal punto di vista del rilevamento fenomenologico, la condizione umana è esattamente quella raffigurata dall’esistenzialismo (da Kierkegaard a Sartre). Dall’incubo del Nulla si esce solo ‘postulando’ (proprio in senso kantiano) un Dio potente e amante: postulando, dunque supponendo, ammettendo, ipotizzando senza possibilità di verifica.
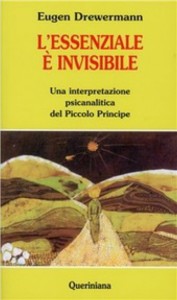 Questa fede/religione non ha dunque nessun altro appiglio che l’analisi della psiche umana, dei suoi archetipi, delle sue paure, delle sue speranze? Se così fosse, Drewermann non avrebbe motivi di dirsi cristiano. Per lui, invece, questo mondo interiore, soggettivo, individuale o personale che dir si voglia, viene come svegliato dall’impatto con uomini concreti, in carne e ossa, che si fanno messaggeri dell’annunzio salvifico: esseri storici – di cui sappiamo poco o in certi casi nulla, neppure il nome – che, come Gesù di Nazareth, hanno testimoniato, in parole e azioni, la propria fiducia nella potente benevolenza divina. Drewermann esprime in molti luoghi, e in diversi stili comunicativi, questa sua tesi cruciale che rimette in gioco la figura di Gesù (da lui, per ovvie ragioni esegetiche, ‘detronizzato’ dal ruolo assegnatoli dalla dogmatica cristiana successiva e considerato esclusivamente come persona umana e non incarnazione puntuale ed esclusiva di Dio); scelgo qui una pagina di sapore autobiografico che mi risulta suggestiva:
Questa fede/religione non ha dunque nessun altro appiglio che l’analisi della psiche umana, dei suoi archetipi, delle sue paure, delle sue speranze? Se così fosse, Drewermann non avrebbe motivi di dirsi cristiano. Per lui, invece, questo mondo interiore, soggettivo, individuale o personale che dir si voglia, viene come svegliato dall’impatto con uomini concreti, in carne e ossa, che si fanno messaggeri dell’annunzio salvifico: esseri storici – di cui sappiamo poco o in certi casi nulla, neppure il nome – che, come Gesù di Nazareth, hanno testimoniato, in parole e azioni, la propria fiducia nella potente benevolenza divina. Drewermann esprime in molti luoghi, e in diversi stili comunicativi, questa sua tesi cruciale che rimette in gioco la figura di Gesù (da lui, per ovvie ragioni esegetiche, ‘detronizzato’ dal ruolo assegnatoli dalla dogmatica cristiana successiva e considerato esclusivamente come persona umana e non incarnazione puntuale ed esclusiva di Dio); scelgo qui una pagina di sapore autobiografico che mi risulta suggestiva:
«Nella stessa misura in cui non mi convinceva la teologia della creazione insegnata dalla Chiesa, mi è apparso chiaro che il Discorso della montagna doveva essere giusto. Quando Gesù dice che le persone che soffrono, le persone che piangono, quelle che sono indifese, che sono impotenti, che sono malate, tutte queste persone devono avere necessariamente una possibilità, e che lui è venuto a fondare un mondo in cui la bontà diventi il fondamento portante delle relazioni reciproche – allora ho pensato che doveva essere proprio così, che solo così vale la pena di vivere. Il mondo così com’è non merita di esistere per più di un giorno. Ma il mondo, descritto come lo vuole e lo rende possibile Gesù, merita ogni genere di impegno e speranza. Nel linguaggio di Paolo c’è davvero un interrogativo decisivo: noi esseri umani ci continuiamo a definire secondo il vecchio modello? Anche 2000 anni dopo il discorso di Gesù di Nazareth vediamo l’essere umano sempre nell’ottica di un darwinismo sociale? Oppure osiamo credere nell’essere umano nuovo?
Mi fu chiaro che ci troviamo, di fatto, davanti a questa alternativa: da noi non vogliamo davvero nient’altro che individuare i più in forma nella lotta per la concorrenza? In tal caso, Dio abbia pietà di noi – oppure che il diavolo ci porti, sarà sempre la stessa cosa. Ma in tal caso non siamo veramente esseri umani. Oppure impariamo qualcosa di totalmente nuovo: l’essere umano nuovo, con lo sguardo rivolto all’uomo di Nazareth. E allora possiamo mobilitare delle energie, realizzare opzioni e utopie che in natura non sono previste, ma che hanno conseguenze estremamente importanti nel rapporto con gli animali e col mondo al nostro fianco.
In altri termini, ho creduto in Dio nel modo in cui Gesù ha cercato di portarlo nel mondo. Ho creduto al Dio di Gesù. Perché, nello stesso tempo, non riuscivo a capire come facesse Gesù a considerare possibile la sua bontà, se non presupponendola reale in ciò che egli chiama suo padre. E’ in forza di questa fede che egli compie cose del tutto paradossali, cose assolutamente incredibili. […]
Gesù non si stanca di portare argomenti a partire da un Dio che egli presuppone, ma che non può dimostrare. Ciò che fa è renderlo semplicemente presente nell’evidenza del suo comportamento umano. Ed è questo che mi ha convinto. In questo io credo ancora oggi, incondizionatamente. Non potrei esistere davvero un solo giorno senza avere questa sicura fiducia, vale a dire che ciò che Gesù voleva è possibile (Drewermann 2003: 55- 57).
Spero che questa lunga citazione stuzzichi nel lettore il desiderio di scoprire, autonomamente, la ricchezza delle opere di questo autore così profondo e così stimolante. E tanto prezioso anche quando, come nel mio caso, non risulta convincente in passaggi precipui della sua trattazione.
Perplessità sulle tesi di Drewermann
Limitatamente al filo sinora seguito, cosa del suo percorso, indubbiamente suggestivo, non mi convince? Drewermann dimostra non Dio, ma la necessità psicologico-esistenziale della fede in Lui. Su questo tema è un fedele discepolo di Jung che, alla domanda di un intervistatore televisivo se credesse in Dio, dichiarò:
« “È difficile rispondere. Non ho bisogno di credere, io so!”. Nella pubblica sorpresa che è seguita alla trasmissione televisiva, ha spiegato di aver fatto un’affermazione psicologica, non metafisica. “Dio è un ovvio fatto psichico e non fisico, ha detto. L’idea di un Essere divino onnipotente è presente dappertutto, inconsciamente se non consciamente, perché è un archetipo”» (Geering 2020: 99).
 Cosa pensare di questa prospettiva? Indubbiamente, la religione – nell’accezione specifica del vocabolario di Drewermann – è un conforto per i singoli e una riserva etica per i popoli. Ma questa acquisizione, interessante dal punto di vista ‘pratico’, lascia aperto, impregiudicato, l’ambito teoretico (che, per un filosofo, è irrinunziabile): è vero o falso che ciò che chiamiamo Dio – o dimensione divina della realtà – ha una consistenza ontologica indipendentemente da ciò che gli umani desideriamo o temiamo? Un agnostico riterrà superflua, se non dannosa, questa domanda; ma chi non ha rinunziato alla ricerca filosofica (o, avendola coltivata, non è pervenuto a conclusioni agnostiche) vorrà continuare a indagare se è più ragionevole una qualche affermazione teistica o una qualche affermazione ateistica.
Cosa pensare di questa prospettiva? Indubbiamente, la religione – nell’accezione specifica del vocabolario di Drewermann – è un conforto per i singoli e una riserva etica per i popoli. Ma questa acquisizione, interessante dal punto di vista ‘pratico’, lascia aperto, impregiudicato, l’ambito teoretico (che, per un filosofo, è irrinunziabile): è vero o falso che ciò che chiamiamo Dio – o dimensione divina della realtà – ha una consistenza ontologica indipendentemente da ciò che gli umani desideriamo o temiamo? Un agnostico riterrà superflua, se non dannosa, questa domanda; ma chi non ha rinunziato alla ricerca filosofica (o, avendola coltivata, non è pervenuto a conclusioni agnostiche) vorrà continuare a indagare se è più ragionevole una qualche affermazione teistica o una qualche affermazione ateistica.
E, comunque, anche se si resta ‘prima’ o ‘fuori’ dall’ambito della speculazione metafisica – trovo il ragionamento di Drewermann vulnerabile per almeno due ragioni.
La prima è che si basa su un aut-aut: Dio o il nulla. La fede o l’angoscia. La religione o il nichilismo. Ma è davvero così o tertium datur? La lista dei pensatori, dei poeti, delle guide politiche, delle persone anonime che si sono succedute di generazione in generazione senza né una fede religiosa né una resa all’assurdismo sarebbe interminabile. Propenderei piuttosto per la tesi di chi sostiene che – se intendiamo la fede come «risposta totale di fiducia verso il mondo in generale, verso le persone e verso il futuro; e ha una forte affinità con la speranza» (Geering 2020: 49) – non si possono «separare le persone in coloro che hanno fede e coloro che non ne hanno; si tratta piuttosto di avere molta o poca fede» (ivi: 48).
Il mio amico Orlando Franceschelli ha dedicato molte energie, e altrettanti scritti, a lumeggiare – soprattutto sulla scia di Karl Löwith – una via «tra Dio e nulla» (Franceschelli 2000) verso una «felicità possibile» (Franceschelli 2014) equidistante dalla beatitudine escatologica come dalla disperazione esistenzialistica. Egli evita – con molte ragioni – l’ambiguità semantica del termine ‘fede’ per esprimere la sua apertura di credito al mondo e alla vita, ma in sostanza ci si intende: anche se Dio non ci fosse, non resterebbe la disperazione, madre di tutti i crimini. «Agli increduli naturalisti moderni per i quali Dio e l’immortalità non esistono» resta la possibilità di «definire la propria visione di bene e male “appetto alla natura” (Leopardi) e facendo appello non alla volontà di potenza ma alla propria libertà, ragionevole sensibilità, capacità di solidarietà samaritana»; non certo la via obbligata di «sentirsi uomini-dio legittimati a “scavalcare a cuor leggero tutte le barriere morali” (Dostoevskij)» (Franceschelli 2018: 141).
In una sua importante opera Drewermann enuncia la tesi che solo la fede in un Dio personale può contrastare «le quattro “forme fondamentali” dell’angoscia nevrotica» (Drewermann 1996: 104): la nevrosi ossessiva, l’isterismo, la depressione e la schizoidia. Punto per punto ho provato a mostrare come queste malattie dell’anima potrebbero essere non dico curate, ma contrastate, da prospettive teoretiche diverse dalla religione/fede ritenuta insostituibile dal teologo psicanalista tedesco (cfr. Cavadi 2003: 111-119).
Una seconda ragione per cui ritengo insoddisfacente la proposta ‘terapeutica’ di Drewermann (qui uso l’aggettivo ‘terapeutico’ non in senso clinico, ma traslato, metaforico: come rimedio al male di vivere, come cura del “disorientamento ontologico”) è proprio il suo essere… terapeutica. In quanto tale, infatti, essa si espone al capovolgimento esatto: nessuna religione va accettata perché sarebbe troppo comoda, indegna di un mortale che voglia vivere di verità.
Quando Drewermann scrive
«per chi sta morendo di sete nel deserto, la sete è una prova che deve esserci l’acqua, anche se nel luogo in cui egli vive non se ne trova nel raggio di chilometri e chilometri. La sete dimostra inconfutabilmente che l’acqua esiste, poiché senza acqua non vi sarebbe sete. E così, in modo tutto analogo: il fatto che noi uomini possiamo pensare a Dio dimostra che egli esiste, poiché altrimenti un pensiero simile non potrebbe neppure passarci per la testa, e già il fatto che noi abbiamo nostalgia dell’infinito dimostra che veniamo dall’infinito e verso l’infinito siamo diretti» (Drewermann 1995: 164),
la sua argomentazione, indubbiamente suggestiva, rischia di dimostrare troppo: se vale per Dio, vale per tutto ciò che il nostro cuore desidera ardentemente (pienezza di sapienza, di virtù, di giustizia, di felicità, di pace, di salute…) e che sappiamo esistere solo come méta utopica, mai del tutto raggiungibile, del nostro faticoso e incerto cammino.
Personalmente sono convinto che il dilemma Dio sì – Dio no vada sottratto al dominio esclusivo dei sentimenti e affidato prima di tutto al rigore della lucidità intellettuale (per quanto imperfetta, specie se si tratta di dimensioni meta-empiriche), al di là della polarizzazione fra
«una fede ‘esigenziale’ (Dio c’è perché la vita senza di Lui sarebbe assurda) e un ateismo altrettanto ‘esigenziale’ (Dio non c’è perché ne abbiamo bisogno psicologico: la sua esistenza sarebbe troppo bella per essere vera). […] La fame di qualcosa non depone né a favore né a sfavore della sua oggettiva esistenza: nel deserto tutti avremmo estremo desiderio di acqua fresca, ma questo desiderio – in quanto tale – né ci assicura che ci sia un’oasi né lo esclude» (Cavadi 2020: 13-14).
 Un percorso alternativo (che valorizzi gli apporti di Drewermann)
Un percorso alternativo (che valorizzi gli apporti di Drewermann)
Solo per sommi capi abbozzo, dunque, un percorso alternativo rispetto al pensiero di Drewermann, che però ne valorizzi gli apporti.
a) Prima di decidere se Dio sia o non sia – e, nel caso sia, se ‘dimostrabile’ o ‘postulabile’ – bisognerebbe accordarsi su una ipotesi definitoria di ‘cosa’ sia in questione. È vero che, se non ci stiamo occupando di un idolo fabbricato dalla mente umana, a nostra immagine e somiglianza, Egli/Ella/Esso è una x inimmaginabile, anzi indefinibile. Tuttavia,
«non potendo sapere cos’è Dio, possiamo precisare cosa intendiamo con la parola che usiamo per designarlo. Non potendo dargli una definizione reale, come dicevano gli scolastici, possiamo e dobbiamo darne una definizione nominale. È solo un punto di partenza, ma indispensabile» (Comte-Sponville 2007: 62).
Nel porre tale definizione trovo una faciloneria sbalorditiva (equamente distribuita fra ricercatori di ogni orientamento): non sappiamo definire l’essere umano, non abbiamo né immagini né idee adeguate per il cosmo, eppure siamo molto sicuri di cosa stiamo parlando quando affermiamo, o neghiamo, Dio.
« “Professore, lei crede in Dio?” A questa domanda, postagli da un giornalista, Einstein rispose semplicemente: “Mi dica prima cosa intende lei per Dio; poi le risponderò se ci credo”» (Comte-Sponville 2007: 62- 63).
Molto orientativamente, potremmo accordarci nell’intendere, con il semantema ‘Dio’, il Fondamento assoluto dell’esistenza, dell’intelligibilità e del valore intrinseco di tutto ciò che è esistito, esiste e potrà esistere. Ma, in dialogo con Drewermann, non possiamo accontentarci di una definizione tanto generica da includere concezioni panteistiche nelle quali Dio è anonimo, totalmente privo di ‘personalità’ e del tutto identificato con la natura. Dobbiamo dunque aggiungere che, all’idea di tale Fondamento, «inerisce incondizionatamente il pensiero dell’amore e della giustizia» (Drewermann 2002: 305). Con altra formula equivalente:
«Dio è inteso l’interlocutore, il vis-à-vis assoluto, il punto di riferimento di ogni ricerca di verità e amore, il fondamento personale di una fiducia che dà a noi stessi la capacità di vivere come persone libere» (Drewermann 2002: 304)
e di non affrontare con angoscia la morte.
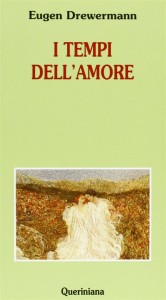 b) Abbiamo notato che per il pensatore tedesco alla certezza (o solo all’ipotesi) dell’esistenza di questo Dio non si può arrivare dall’osservazione dell’universo, ma solo (se mai) dalle strutture psiche antropologiche. Ciò, a mio avviso, soggettivizza eccessivamente i termini della questione, anche se il soggetto non è l’individuo nella sua particolarità ma il soggetto ‘trascendentale’ (nel senso di Kant e più ancora di Jung). Per ‘rassegnarsi’ a questo riduzionismo epistemologico bisognerebbe esser certi dell’inintelligibilità del cosmo, della sua assurdità intrinseca, della sua insopportabile assenza di senso. Ma possiamo ritenere chiusa la questione? Cosa impedisce di ritenere incontestabile (o almeno fortemente probabile) l’ipotesi razionale di un Dio creatore, potente e benevolo, sulla base dell’osservazione dell’universo e della storia umana in particolare? Qual è l’obiezione capitale ai ‘teisti’ di ogni genere, da Platone a Voltaire, passando per Agostino, Tommaso, Cartesio e Leibniz? Indubbiamente, come sostiene Drewermann, lo scandalo del male: «il problema della teodicea», in Occidente, «è stato, fino al momento presente, il motivo principale del crescente ateismo» (Drewermann 2003: 21). Sono d’accordo con lui e con tutta la sempre più numerosa schiera di pensatori per i quali la sofferenza dei senzienti – soprattutto dei senzienti del tutto innocenti come bimbi e animali – costituisca sino ad oggi, e forse per sempre, una pietra d’inciampo teoreticamente insormontabile.
b) Abbiamo notato che per il pensatore tedesco alla certezza (o solo all’ipotesi) dell’esistenza di questo Dio non si può arrivare dall’osservazione dell’universo, ma solo (se mai) dalle strutture psiche antropologiche. Ciò, a mio avviso, soggettivizza eccessivamente i termini della questione, anche se il soggetto non è l’individuo nella sua particolarità ma il soggetto ‘trascendentale’ (nel senso di Kant e più ancora di Jung). Per ‘rassegnarsi’ a questo riduzionismo epistemologico bisognerebbe esser certi dell’inintelligibilità del cosmo, della sua assurdità intrinseca, della sua insopportabile assenza di senso. Ma possiamo ritenere chiusa la questione? Cosa impedisce di ritenere incontestabile (o almeno fortemente probabile) l’ipotesi razionale di un Dio creatore, potente e benevolo, sulla base dell’osservazione dell’universo e della storia umana in particolare? Qual è l’obiezione capitale ai ‘teisti’ di ogni genere, da Platone a Voltaire, passando per Agostino, Tommaso, Cartesio e Leibniz? Indubbiamente, come sostiene Drewermann, lo scandalo del male: «il problema della teodicea», in Occidente, «è stato, fino al momento presente, il motivo principale del crescente ateismo» (Drewermann 2003: 21). Sono d’accordo con lui e con tutta la sempre più numerosa schiera di pensatori per i quali la sofferenza dei senzienti – soprattutto dei senzienti del tutto innocenti come bimbi e animali – costituisca sino ad oggi, e forse per sempre, una pietra d’inciampo teoreticamente insormontabile.
Lo è per chi propende ad ammettere un Principio divino, ma lo è altrettanto per chi propende a negarlo. Infatti lo smarrimento, la rivolta interiore, la protesta lancinante davanti all’eccezione dolorosa mancherebbero di presupposti se non fossimo per così dire abituati alla regolarità; il disordine non ci sorprenderebbe se non fossimo adusi all’ordine; non riusciremmo neppure a individuare come tale la patologia se non fossimo immersi nella fisiologia.
Sappiamo bene che l’ateismo contemporaneo tenta di svicolare con la teoria del ‘caso’ (e della successiva ‘necessità’): se le galassie, i pianeti all’interno delle galassie, la vita biologica all’interno del nostro pianeta, la vita cosciente all’interno della vita biologica…sono tutti effetti del caso, ciò che accade è fuori da ogni nostra reazione di ammirazione o di disapprovazione. Ma ‘caso’ è una nozione logica o solo il nome che diamo a quei dinamismi che sfuggono (forse irrimediabilmente) alla nostra conoscenza? E, ammesso che davvero qualche evento accada per ‘caso’, come e perché questa casualità diventa regolarità necessaria? Lo stupore di Einstein è ancora il mio: «la cosa più incomprensibile dell’universo è che sia comprensibile dall’intelligenza umana». Il filosofo non può concedersi tentazioni apologetiche né scorciatoie polemiche ma solo domande vere. Per esempio, se non ci voglia troppa ‘fede’ per supporre che, per ‘caso’, non solo si è prodotta una serie di eventi naturali (vita sulla terra, erbe e frutti commestibili, sensibilità animale, autocoscienza umana…), ma tali eventi si trovano in interconnessione (per cui, ad esempio, certe erbe producono effetti terapeutici su certi animali come l’essere umano e le une e gli altri non vivrebbero se la stella più vicina – il sole – ardesse a un numero di chilometri appena un po’ maggiore o un po’ minore). O se non ci voglia troppa ‘fede’ per asserire che, contro la convinzione aristotelica, qualcosa possa realizzarsi in atto senza essere in nessun modo in potenza: dunque che la creatività musicale di un Beethoveen possa darsi nell’universo come prodotto di mera casualità a partire da un grumo di quark. Non si tratta, ovviamente, di contestare l’idea centrale dell’evoluzionismo darwiniano, ma di non mitizzarlo: Henry Bergson, con la sua proposta di Evoluzione creatrice, ha provato ad aprire interessanti piste di ricerca (cfr. Bergson 2012 e Jonas 1990).
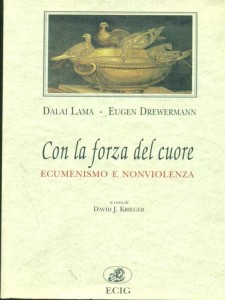 c) Se l’enigma del male, in quanto risvolto del mistero del vero/bene/bello, non cessa d’interrogare né chi ammette né chi esclude l’ipotesi di un Dio potente/benevolo, che fare? Sono arrivato alla conclusione che si debbano distinguere accuratamente i piani. Sul piano filosofico, speculativo, razionale, Pascal, all’alba della Modernità, ha asserito che quello che si manifesta nel mondo, nella natura fisica, «non indica né un’esclusione totale né una presenza manifesta della divinità, ma la presenza di un Dio che si nasconde: tutto reca impresso questo carattere» (Pascal 1984: 139). Poi sappiamo che Pascal – almeno sino ai 39 anni di vita concessigli – ha ritenuto inevitabile oltrepassare questa ambivalenza, o ambiguità, con il salto della fede cristiana (e, per i ‘libertini’, con la logica della scommessa utilitaristica). Personalmente preferisco sostare nell’osservazione disincantata di un universo che né impone necessariamente (come sostiene il Magistero cattolico ufficiale) né esclude radicalmente (come sostiene Drewermann) impronte divine. E ripromettermi di andare oltre questa zona del dubbio (in direzione dell’ateismo o del teismo) solo se mi ci dovesse condurre una discussione dialettica, tessuta con argomenti e di contro-argomenti.
c) Se l’enigma del male, in quanto risvolto del mistero del vero/bene/bello, non cessa d’interrogare né chi ammette né chi esclude l’ipotesi di un Dio potente/benevolo, che fare? Sono arrivato alla conclusione che si debbano distinguere accuratamente i piani. Sul piano filosofico, speculativo, razionale, Pascal, all’alba della Modernità, ha asserito che quello che si manifesta nel mondo, nella natura fisica, «non indica né un’esclusione totale né una presenza manifesta della divinità, ma la presenza di un Dio che si nasconde: tutto reca impresso questo carattere» (Pascal 1984: 139). Poi sappiamo che Pascal – almeno sino ai 39 anni di vita concessigli – ha ritenuto inevitabile oltrepassare questa ambivalenza, o ambiguità, con il salto della fede cristiana (e, per i ‘libertini’, con la logica della scommessa utilitaristica). Personalmente preferisco sostare nell’osservazione disincantata di un universo che né impone necessariamente (come sostiene il Magistero cattolico ufficiale) né esclude radicalmente (come sostiene Drewermann) impronte divine. E ripromettermi di andare oltre questa zona del dubbio (in direzione dell’ateismo o del teismo) solo se mi ci dovesse condurre una discussione dialettica, tessuta con argomenti e di contro-argomenti.
d) Questa apertura teoretica riguarda il piano della ricerca filosofica. Essa, pur lavorando con la logica argomentativa, non può fare a meno della dimensione intuitiva (tipica dei poeti e dunque di ogni innamorato). Un approccio che, secondo alcune intense pagine dello stesso Drewermann, può consentirci di squarciare il velo della tragicità fenomenica e di penetrare nel segreto ontologico, per così dire noumenico, dell’universo:
«Nulla di quello che ci circonda risponde a una qualsiasi delle domande fondamentali della nostra vita: perché esistiamo, perché mai noi siamo. Il freddo fuoco delle stelle tace alle nostre domande. La terra ci concede di vivere, ma le siamo indifferenti. E se la cosa finisse qui dovremmo quasi pensare che la natura si è in un certo senso permessa di scherzare con noi, generando esseri che hanno sempre in testa domande alle quali essa non solo si rifiuta di rispondere, ma a cui non può nemmeno rispondere con le sue morte leggi; proprio come se avesse voluto solo verificare per quanto tempo esseri come noi possono esistere sulla terra senza cedere alla disperazione» (Drewermann 1995: 149).
C’è soltanto un’esperienza che può liberarci dall’impasse insegnandoci che «siamo qualcosa in più di una semplice parte della natura» (Drewermann 1995: 149): l’esperienza dell’amare e dell’essere amati. Infatti è nell’amore che
«sentiamo chiarissimamente che il ’nome’ dell’altro ci viene donato come un’illuminazione del cielo. Tutta la sua esistenza ci appare come una grazia irripetibile. Mentre tutte le altre cose del mondo ci sembrano piuttosto indifferenti – potrebbero esistere come non esistere – nell’amore sentiamo con tutte le forze che l’altro deve assolutamente esistere. [...] La persona di colui che amiamo di cuore diventa per noi il luogo determinante della nostra vita, a partire dal quale scopriamo che il mondo intero non esiste se non grazie alla straripante esuberanza di un amore che sta alla base di tutto e per il quale non esiste nulla che sia in sé secondario o insignificante. Solo l’amore ci conduce al punto in cui il mondo nasce dalla mano del suo creatore; solo esso apre per noi il cielo e ci fa assistere dall’interno al processo per cui il dio Chnum modella al tornio la bellezza del corpo e la bellezza dell’anima di un uomo come un’opera d’arte perfetta; solo esso ci fa sentire il nome con cui dall’eternità Dio chiama all’esistenza un uomo» (Drewermann 1995: 122-123).
e) L’intuizione poetica e la riflessione razionale filosofica fanno quel che possono. Ma intanto la vita procede, anzi incalza. La marea della sofferenza dei viventi senzienti non cessa di montare e di tracimare. Solo la conoscenza scientifica, la solidarietà ‘corta’ nei confronti di chi ci respira in prossimità, la politica (come intreccio di sapere e di aver-cura) possono fare da argine. Chiunque, nella storia umana, ha dato e dà un contributo è ‘salvatore’, ‘redentore’: Socrate e Aristotele, Geremia e Gesù, Buddha e Lao Tze, Maometto e Bruno, Galilei e Newton, i coniugi Curie e Gandhi…Ognuno/a di loro attingerà a proprie sorgenti vitali (non necessariamente, come mostra di supporre Drewermann, un Dio potente e benevolo), reali o presunte, sperimentate o sognate. È certo, in ogni caso, che ognuno/a di noi ha bisogno della loro fiducia nella vita e della loro capacità di autodonazione e che, incoraggiati a nostra volta, possiamo offrirci reciprocamente coraggio e compassione.
Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020
Riferimenti bibliografici
Bergson H., L’evoluzione creatrice, a cura di M. Acerra, Rizzoli, Milano 2012
Cavadi A., Quando ha problemi chi è sano di mente. Un’introduzione al philosophical counseling, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003
Cavadi A., Focolai di preghiera, trasformazione del mondo in P. Squizzato (ed.), La goccia che fa traboccare il vaso. La preghiera nella grande prova, Gabrielli, San Pietro in Cariano 2020
Comte-Sponville A., Lo spirito dell’ateismo. Introduzione a una spiritualità senza Dio, Ponte alle Grazie, Milano 2007, ed.or. 2006
Drewermann E., Psicologia del profondo e esegesi, vol. 1 (Sogno, mito, fiaba, saga e leggenda) e vol. 2 (Miracolo, visione, profezia, apocalisse, storia, parabola), Queriniana, Brescia 1990, ed. or. 1996
Drewermann E., La posta in gioco. Verbale di una condanna, a cura di F. Reinders, Edizioni di Comunità, Milano 1994, ed. or. 1992
Drewermann E., I tempi dell’amore, a cura di K. Walter, Queriniana, Brescia 1995, ed. or. 1993
Drewermann E., Psicanalisi e teologia morale, Queriniana, Brescia 1996, ed. or. 1982 – 1984
Drewermann E., Il vangelo di Marco. Immagini di redenzione, Queriniana, Brescia 2002, ed. or. 1988
Drewermann E., C’è speranza per la fede? Il futuro della religione all’inizio del XXI secolo, Queriniana, Brescia 2002, ed. or. 2000
Drewermann E., Religione, perché? Trovare un senso in tempi di bramosia e di guadagno. Conversazione con Jürgen Hoeren, Queriniana, Brescia 2003, ed. or. 2001
Drewermann E., E il pesce vomitò Giona all’asciutto. Il libro di Giona interpretato alla luce della psicologia del profondo, Queriniana, Brescia 2003, ed. or. 2001
Fanti C. – Sudati F. (edd.), Oltre le religioni. Una nuova epoca per la spiritualità umana, Gabrielli, San Pietro in Cariano 2016
Fox M., Dopo la religione in Fanti C.- Vigil J. M. (edd.), Una spiritualità oltre il mito. Dal frutto alla rivoluzione della conoscenza, San Pietro in Cariano 2019
Franceschelli O., Karl Löwith. Le sfide della modernità tra Dio e nulla, Donzelli, Roma 2008
Franceschelli O., Elogio della felicità possibile. Il principio natura e la saggezza della filosofia, Donzelli, Roma 2014
Franceschelli O., In nome del bene e del male. Filosofia, laicità e ricerca di senso, Donzelli, Roma 2018
Geering L., Reimmaginare Dio. Il viaggio della fede di un moderno eretico, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2020
Jonas H., Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino 1990
Pascal B., Pensieri, edizione P. Serini, Mondadori, Milano 1984, ed. or. 1976
_____________________________________________________________
Augusto Cavadi, tra i pionieri della filosofia-in-pratica contemporanea, già docente presso il Liceo “G. Garibaldi” di Palermo, è fondatore della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”. Collabora stabilmente con La Repubblica-Palermo. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica, con particolare attenzione al fenomeno mafioso, nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018).
_______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/teologia-e-psicoanalisi-invito-al-pensiero-di-eugen-drewermann/
Click here to print.