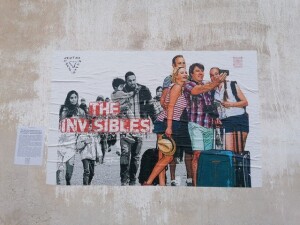Trasformazioni Mediterranee. Migrazioni, solidarietà e barriere
Posted By Comitato di Redazione On 1 marzo 2023 @ 02:23 In Cultura,Migrazioni | No Comments
di Enrico Fravega, Luca Queirolo Palmas [*]
Introduzione
La retorica nazionalista oggi più in auge costruisce il Canale di Sicilia come un territorio di battaglia, una faglia su cui si scontrano un Nord e un Sud, da un lato la difesa dei confini, italiani ed europei, dall’altro le mobilità inopportune di chi prova ad attraversare. Come per le decine di chilometri di muro che separano gli avamposti europei di Ceuta e Melilla dal Marocco (Queirolo Palmas, 2019, 2021), qui è il mare come ambiente ostile a giocare il ruolo di arma di separazione e di deterrenza. Questo tipo di narrazione rovescia tutta una lunga tradizione che da Braudel in poi ha raccontato il Mediterraneo come un luogo di scambi e ibridazioni, frizioni e conflitti, posando le fondamenta di una possibile identità transnazionale e translocale o portando in evidenza l’urgenza di pensare un black Mediterranean (Ben-Yehoyada & Pizzolato, 2019; Proglio, 2019).
Aldilà della battaglia culturale sulle rappresentazioni ufficiali, in questo articolo vorremo dare conto di alcuni processi materiali e sociali che contribuiscono a riaffermare la linea di confine, così come a innescare altre forme di relazione fra le comunità costiere e coloro che attraversano questo spazio marittimo, lo usano per l’attività lavorativa, o in esso agiscono spinti da motivazioni politico-umanitarie di diverso tipo. Nello specifico ci concentreremo su due situazioni che contribuiscono a dare una forma, una configurazione e anche un futuro, al canale: il mondo della pesca come un segmento specifico di un più ampio lavoro di mare; e le condizioni che permettono, o ostacolano, interazioni di mutuo aiuto e incontri spontanei nelle isole di questo canale che le politiche migratorie hanno voluto trasformare in nodi di confine. Lo sguardo che rivolgiamo assume come punto di osservazione principale l’operare di diverse forme di solidarietà: una solidarietà professionale, figlia della legge del mare come obbligo morale (prima ancora che giuridico) di soccorso; una solidarietà umanitaria radicata in organizzazioni della società civile, professionalizzazione e donazioni; una solidarietà spontanea, ordinaria, spesso legata a singoli individui che interpretano in questo modo il loro essere abitanti del canale.
Il metodo su cui il testo è costruito nasce da precedenti esperienze di ricerca a Lampedusa (Giliberti & Queirolo Palmas, 2021) e da una recente missione etnografica [1] svolta a bordo della barca Tanimar con la quale, a cavallo tra settembre e ottobre 2022, abbiamo attraversato il canale di Sicilia, da Pantelleria a Lampedusa, da Linosa a Malta, toccando i diversi snodi delle politiche del controllo del confine e interagendo con le autorità locali, la società civile isolana e altri attori rilevanti [2]; al tempo stesso la scrittura che organizza l’articolo è quella etnografica, che privilegia ovvero la dimensione narrativa. In queste pagine, il canale è raccontato attraverso le persone che abbiamo incontrato e i racconti, le storie e le visioni del mondo che ci hanno consegnato. In tal senso la struttura stessa del testo prova a dare forma all’idea di un dialogo che, come le acque del Mediterraneo, unisce sponde diverse – ricercatori, pescatori, solidali, funzionari pubblici, migranti ecc.
Al nostro arrivo a Malta, sulle banchine di Manoel Island, incontriamo la collega Daniela DeBono, dell’Università di Malta; le raccontiamo del nostro viaggio, alternando inglese e italiano, perché a Malta sono quasi tutti bilingue. L’inglese e il maltese sono lingue ufficiali, ma l’italiano qui è sempre stato capito e parlato, perché era appreso attraverso le trasmissioni della RAI. Daniela ci racconta che i giovani, oggi, conoscono poco la lingua italiana, perché seguono quasi esclusivamente i programmi dei canali broadcast della televisione americana. In altre parole, attraverso i consumi culturali si allenta il legame di Malta con l’Europa mediterranea – cioè con l’Italia, ma anche con il mondo arabo – e si procede alla decostruzione di una deriva plurisecolare che ha portato l’intera regione del Canale di Sicilia, con le sue isole, ad essere il baricentro del Mediterraneo.
Così, parallelamente e paradossalmente, si stringe invece il legame di Malta con l’Atlantico anglofono. Con l’America e con lo stesso Regno Unito, che qui è stato potenza coloniale. Un riposizionamento nello spazio geografico-culturale globale che ci interroga sulla stessa idea di Mediterraneo. Se il Mediterraneo è, per definizione, il mare racchiuso tra le terre – il cosiddetto “mare di mezzo” – ciò di cui ci parla Daniela DeBono sembra descrivere una sorta di condizione di spiazzamento che apre, tuttavia, uno spazio di riflessione sulle nuove geografie disegnate dal cambio di relazione tra la sponda sud e quella nord del Mediterraneo; o del mondo.
Il nostro viaggio tra Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Malta, sembra dunque configurarsi come l’esplorazione di un “nuovo mondo”; un mondo, la cui cartografia è in corso di definizione e nuove relazioni, tensioni ed opposizioni prendono forma, dispiegando effetti sia al livello macro, sia al livello micro. In questo senso, il testo che qui si presenta è anche il punto di partenza di un progetto di ricerca più ampio che mette al centro la dimensione dello scambio e della porosità fra diversi mondi del mare nel canale di Sicilia: dai pescatori ai migranti in viaggio, dagli operatori delle diverse polizie ai soccorritori della flotta civile.
La legge del mare e la globalizzazione della pesca
Avevamo incontrato Mariano durante il periodo della pandemia a Lampedusa, in fondo al molo commerciale, di fronte a due pescherecci tunisini sequestrati dalle autorità e poi abbandonati senza cura alcuna. Ci diceva allora: «il problema delle migrazioni? È questo, solo questo. Sono questi relitti che vengono lasciati in porto e fanno danni, perdono gasolio, vanno a sbattere con le barche ormeggiate. Quando viene il Libeccio è un disastro, il danno ambientale è enorme. E poi tutti i relitti sul fondo ci bucano le reti». Differentemente dallo spettacolo delle migrazioni (De Genova, 2017), il suo raccontare metteva in primo piano la questione ambientale-lavorativa, più che quella sicuritaria. E così continuava con lucidità e realismo: «Noi non dobbiamo risolvere le migrazioni, Lampedusa non può risolvere nulla. Quelle è roba degli Stati, e manco di quelli. Perché ci sono miliardi di ragazzi in viaggio e noi vogliamo fermarli?».
Per Mariano, in questo scenario, la guida resta sempre la legge del mare, intesa come obbligo morale più che giuridico: «si salva e basta. Anche i pescatori che a terra ti dicono delle cose razziste, a mare salvano. Nessuno di noi ha mai lasciato nessuno a mare. Come fai a dormire poi la notte?». Si salva e basta, appunto. Non è la legge dello Stato, è una legge sovraordinata e al tempo stesso incorporata, intima. E poi il dialogo con noi ricercatori proseguiva con i dettagli del salvataggio realizzato solo qualche settimana prima a trenta miglia da Lampedusa in acque internazionali.
«Ho incontrato un barchino con decine di persone a bordo. La Capitaneria non mi diceva nulla, se non di chiamare Malta… figurati! Alla fine, me li sono trainati sino al limite delle acque territoriali e poi li ho lasciati lì e sono arrivati i soccorsi dei militari. Ho perso la giornata di lavoro, e pure rischiato problemi di tipo legale… … ma che devi fare? Lasciarli morire a mare?».
Nella sua visione gli stessi militari e tutte le polizie dello spazio marittimo, per quanto interni a un’organizzazione gerarchica che deve rispondere alla politica di turno – e quello era il momento dei porti chiusi e di un accanimento istituzionale contro il soccorso e le ONG, simile nella sostanza per quanto diverso nella forma da quanto introdotto recentemente dal governo italiano [3] – non possono che condividere gli obblighi morali che sono propri di tutti i lavoratori del mare; e in effetti molti dei nostri interlocutori sui moli citano spesso pratiche occulte di diverso tipo che permettono agli attori istituzionali di rispettare la legge del mare, quale che sia la legge degli Stati.
In quel dicembre del 2020, le barche ferme per il maltempo ci apparivano come persone anziane, fragili, da curare, quasi da intrattenere nella loro solitudine; ad ogni ora sul molo dei pescherecci, capitani, armatori, equipaggi, familiari si riunivano lì attorno, a parlare, trafficare o controllare gli ormeggi, a prendersi il caffè alle macchinette, o semplicemente a non far nulla. Spesso i figli di queste famiglie vanno via e si costruiscono progetti di vita diversi da quelli dei padri. Con le parole di un altro pescatore: «barche ce ne sono 80, abbiamo difficoltà a tenere gli equipaggi, 3 o 4 uomini per barca. Con noi lavorano ragazzi stranieri, senegalesi, rumeni e tunisini».
Da un lato gli equipaggi divengono cosmopoliti, riflesso di una forza-lavoro internazionale, dall’altro i vicini di sempre, i tunisini – essi stessi imbarcati da decenni sui pescherecci siciliani e maltesi – rivestono il ruolo dei concorrenti agguerriti, vincenti. Prosegue Mariano:
«Se noi eravamo 80, loro erano 800. Si piazzavano sopra il banco in acque internazionali e non potevi entrare. Il pesce sta solo in certi posti, non è che si muove e tu per pescare devi andare proprio lì a prenderlo. Se gli altri arrivano prima e non ti fanno entrare sopra il banco, non riesci a far nulla. E poi qui ci siamo dati al turismo, la pesca è rimasta soprattutto a loro. Anche noi pescatori dipendiamo dal turismo ormai, perché il pesce prende più valore d’estate, per i ristoranti e per le gite in barca. Sono soldi semplici. I ragazzi di oggi lavorano nel turismo, ha portato tanta ricchezza. Li capisco, è meno fatica».
Non c’è astio nelle sue parole, solo riconoscimento di come è andata a finire la partita. Le acque internazionali sono di tutti e chi vince è perché è in condizioni migliori per vincere. Non è solo questione di confini e delimitazioni, di leggi. Qui conta il numero: e loro sono di più. Non hanno problemi a mettere su barche ed equipaggi, a tenere i figli su questo lavoro faticoso. «È dalla metà degli anni ‘90 che è così ormai». Anche perché l’isola, nella sua vita intima così come nella sua proiezione esterna, è ormai passata dall’economia (morale) della pesca a quella del turismo (Orsini, 2016).
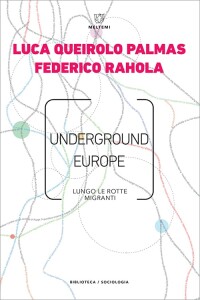 È in questa transizione che Mariano interpreta i sentimenti di ostilità nei confronti delle migrazioni: il turismo non vuole vedere i migranti e non vive come propria la legge del mare; anche se ovunque le economie turistiche dipendono dalla forza lavoro migrante (Queirolo Palmas & Rahola, 2022). E il turismo di questa isola, con un aeroporto internazionale collegato a tutta l’Europa intera, ci parla di un ulteriore processo di dislocazione che allontana i vicini tunisini e avvicina l’isola ad altre geografie. Se nella lunga stagione estiva Lampedusa vive di turisti, durante l’inverno è invece l’economia del confine quella che organizza la vita: «Vedete tutte queste camionette in giro per il paese. Ci saranno 800/1000 persone, caserme, dato che i militari stanno qui con mogli e figli. Vanno ai ristoranti, dormono affittando case o negli hotel. Campiamo di questo …». Di fatto, il suo è il racconto di una disconnessione (dall’economia della pesca) e di un riposizionamento attorno al turismo e alla migrazione, di connessioni con altre storie e traiettorie per questo pezzo di Mediterraneo: processi materiali, economici, che hanno implicazioni morali. Spesso fra gli attivisti del collettivo Askavusa che gestiscono lo spazio Porto M – uno straordinario luogo di produzione culturale – ci si riferisce a questa dislocazione riprendendo i termini dell’antropologia di Ernesto de Martino: apocalisse, crisi della presenza, fine di un mondo.
È in questa transizione che Mariano interpreta i sentimenti di ostilità nei confronti delle migrazioni: il turismo non vuole vedere i migranti e non vive come propria la legge del mare; anche se ovunque le economie turistiche dipendono dalla forza lavoro migrante (Queirolo Palmas & Rahola, 2022). E il turismo di questa isola, con un aeroporto internazionale collegato a tutta l’Europa intera, ci parla di un ulteriore processo di dislocazione che allontana i vicini tunisini e avvicina l’isola ad altre geografie. Se nella lunga stagione estiva Lampedusa vive di turisti, durante l’inverno è invece l’economia del confine quella che organizza la vita: «Vedete tutte queste camionette in giro per il paese. Ci saranno 800/1000 persone, caserme, dato che i militari stanno qui con mogli e figli. Vanno ai ristoranti, dormono affittando case o negli hotel. Campiamo di questo …». Di fatto, il suo è il racconto di una disconnessione (dall’economia della pesca) e di un riposizionamento attorno al turismo e alla migrazione, di connessioni con altre storie e traiettorie per questo pezzo di Mediterraneo: processi materiali, economici, che hanno implicazioni morali. Spesso fra gli attivisti del collettivo Askavusa che gestiscono lo spazio Porto M – uno straordinario luogo di produzione culturale – ci si riferisce a questa dislocazione riprendendo i termini dell’antropologia di Ernesto de Martino: apocalisse, crisi della presenza, fine di un mondo.
Quando torniamo su quegli stessi moli due anni dopo a bordo di Tanimar, l’idea della fine di un mondo continua ad aleggiare. Sono le cinque del mattino ed è appena attraccata una barca dei mazaresi: sta scaricando le cassette del pesce, mentre un operaio con il muletto le sposta velocemente su un camion frigo che presto si imbarcherà sul traghetto. Anche questo equipaggio è cosmopolita, con facce del Maghreb ed asiatiche. Così ci parla un altro pescatore che osserva con noi la scena:
«La pesca? che si può fare per migliorare? Nulla, è morta. Mezza Lampedusa sta aspettando la rottamazione delle barche. Pesce? Non ce n’è più. Se lo fregano i tunisini, se lo fregano i mazaresi. Il gasolio costa troppo, e non c’è più tempo buono. Prima potevi uscire per 30, 40 giorni consecutivi. Il pesce è morto, non si può fare niente per migliorare. Persino questi che vedi – i mazaresi – hanno ridotto le barche. Qui i grossisti la fanno da padroni, sono loro che fissano i prezzi. D’estate ancora ancora, vendiamo ai ristoranti, ma d’inverno? Che facciamo? Lo buttiamo il pesce che tiriamo su?».
Incontro dopo incontro, durante le nostre giornate sui moli e nei bar frequentati da questi lavoratori del mare, sembra insomma ripetersi senza sosta la stessa struttura del discorso; un frame narrativo a cui si aggancia inevitabilmente, prima o poi, la questione delle migrazioni, del soccorso, della solidarietà. A Lampedusa però, e in modo paradossale, non si vedono migranti per le strade nonostante l’isola sia al centro di uno spettacolo mediatico costruito sulla figura dell’invasione e del confine; in effetti, qui l’accoglienza istituzionale è soprattutto detenzione e confinamento, e i migranti che durante la pandemia venivano chiusi nelle navi quarantena ora lo sono nell’hotspot (Anderlini & di Meo, 2021; Giliberti & Queirolo Palmas, 2021). Così si esprime il nostro interlocutore, un seguace del neoministro Salvini che ripete con convinzione la sua adesione alla retorica che vede in questo pezzo di mare un confine da difendere: «se mi sono trovato a dover soccorrere? Milioni, milioni di volte. E che devi fare? Io salvo anche se mi mettono in galera. Almeno sono a posto con la coscienza. E poi. Io sto in mare. Chi mi salva a me, se io non salvo gli altri?».
Parole di terra e azioni di mare, discorsi e pratiche, sembrano così divergere in modo radicale, esattamente come Mariano ci aveva anticipato. Quella stessa sera lo incontriamo nuovamente a distanza di due anni; è felice di farci salire a bordo del suo peschereccio, orgoglioso di raccontarci che la sua è fra le barche più antiche di Lampedusa e risale agli anni Quaranta. Ci aggiriamo per gli interni della barca; la cuccetta è disfatta, con una madonnina sopra come buon augurio e protezione. E poi molti libri, un po’ ovunque, fra cui L’etica protestante e lo spirito del capitalismo di M. Weber e Opinioni di un clown di E. Boll; fra le pagine, un paio di occhiali da lettura, come se fosse rimasto il segno recente di un’attività smessa da poco.
Siamo stupiti di questo ritrovamento culturale, un classico della sociologia in un luogo così improbabile; è come un cortocircuito, rispetto alle chiacchiere di pochi minuti prima sopra il ponte, che ci obbliga ad associare un capitale culturale, un consumo inaspettato, a storie di mare e fatica. Un segno anche di una dislocazione, di altre connessioni che in questo spazio di lavoro si possono generare. Ritornando sul ponte del peschereccio, scampoli di nuove conversazioni che guardano al passato:
«un tempo qui era pesce azzurro, gli uomini a pescare, e le donne e bambini a inscatolare. Avevamo trenta industrie di conservazione. Era un movimento continuo. Infinite cassette di sgomberi. A volte dovevamo abbassare i prezzi, perché il rigattiere ci diceva che tutto quel pesce puzzava e non lo riuscivano a lavorare. A volte molto pesce si lasciava in mare… la barca non riusciva a contenere tutta la cala. Magari chiamavamo altri pescatori con altre barche, ma altre volte non ci stava tutto e lo ributtavamo. Ora sono i tunisini, come ti ho detto, che fanno il pesce azzurro».
Mentre Mariano parla, vediamo i moli che lui descrive; ora le barche sono rivolte ai turisti. Cerchiamo quell’ultimo stabilimento ancora esistente, e a un certo punto ne intravediamo la scritta un po’ sbiadita. Ci avviciniamo, c’è una porta aperta. Immaginiamo le maestranze, ma appare solo un uomo di spalle intento a una qualche lavorazione che non riusciamo a decifrare. Nella solitudine dei suoi gesti, ci ricorda un hobby più che un lavoro, come i molti pescatori che ci hanno raccontato dei barattoli sott’olio che si preparano durante l’inverno.
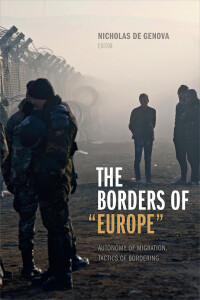 Il confine fra Sicilia, Lampedusa e Tunisia è nelle storie che raccogliamo permanentemente in movimento; molti lampedusani che si erano trasferiti in Tunisia per la pesca sono obbligati a scegliere una delle due nazionalità negli anni ’50 del post-indipendenza. Con le parole di Enzo: «o ti fai tunisino o torni in Italia». Tramite gli attivisti di Porto M., il cui posizionamento scommette sulla costruzione di una appartenenza trans-mediterranea più che europea, arriviamo sulla barca di un altro pescatore che ha smesso il mestiere dopo tre generazioni per un lavoro operaio a terra. Anche lui associa la crisi della pesca ai tunisini. «A noi fanno demolire le flotte, loro invece hanno navi nuove. Prima erano dei poveracci, peggio di noi». La pesca, che oggi pratica come hobby appunto, mantiene ai suoi occhi un lato magico, e nostalgico, al tempo stesso:
Il confine fra Sicilia, Lampedusa e Tunisia è nelle storie che raccogliamo permanentemente in movimento; molti lampedusani che si erano trasferiti in Tunisia per la pesca sono obbligati a scegliere una delle due nazionalità negli anni ’50 del post-indipendenza. Con le parole di Enzo: «o ti fai tunisino o torni in Italia». Tramite gli attivisti di Porto M., il cui posizionamento scommette sulla costruzione di una appartenenza trans-mediterranea più che europea, arriviamo sulla barca di un altro pescatore che ha smesso il mestiere dopo tre generazioni per un lavoro operaio a terra. Anche lui associa la crisi della pesca ai tunisini. «A noi fanno demolire le flotte, loro invece hanno navi nuove. Prima erano dei poveracci, peggio di noi». La pesca, che oggi pratica come hobby appunto, mantiene ai suoi occhi un lato magico, e nostalgico, al tempo stesso:
«avevamo solo la bussola e l’orologio. Partivamo a cercare gli scogli al largo e quando li trovavamo mettevamo un segnale, per poterci ritornare. Durava un mese, poi il mare se lo portava via e dovevamo trovare altri scogli. Mio nonno aveva un quaderno in cui aveva disegnato il fondo di tutta l’isola, era incredibile lui… era come se lo vedesse, sapeva dove stavano gli affossamenti, le pianure, le scarpate… lo vedeva».
Il discorso inizia lentamente a slittare. Non sono più i tunisini ad incarnare le figura dei cattivi del mare, ma le tecnologie che permettono di vedere e riconoscere tutto, sempre. Così continua: «il Gps ha distrutto la pesca. Tutte queste macchine che ti permettono di vedere i banchi di pesce e di ucciderli senza cercarli. È una mattanza». Inizia ad apparire un nuovo piano di distinzione che rimuove integralmente la figura del tunisino, del turco, dal ruolo di capro espiatorio. Nelle sue parole, che ora insistono sulla dimensione dell’estrattivismo forzato e della distruzione ambientale, l’opposizione concettuale, e materiale, è fra pesca industriale e pesca artigianale.
Se ci liberiamo dalla prima, e apparentemente egemonica, scorza di senso comune – il mare e il canale di Sicilia come confini da difendere – sotto intravediamo rapidamente un’altra narrazione, ancorata alla memoria e all’emozione, con al centro un paesaggio di incontri, di porosità, di relazioni. Quello che era confine diviene piazza liquida:
«Il mare è bello perché lì si incontra tutto il mondo. Un tempo c’erano i greci che raccoglievano le spugne con i palombari, stavano un mese e ogni volta in mare ti scambiavi delle cose. Con un equipaggio di coreani che stavano su una petroliera, abbiamo addirittura scambiato pesce con alcool e sigarette. Anche con i tunisini…noi gli davamo il vino, la birra, loro il couscous. Prima erano loro che portavano i migranti. Certo, era più sicuro. Le barche, loro, se le volevano riportare a casa perché ci lavoravano. Una volta eravamo a Lampione ed era rimasta l’ancora incagliata a un peschereccio pieno di clandestini. Li abbiamo aiutati a liberarsi. Poi ci volevano proporre un accordo… del tipo: noi ve li portiamo a Lampione e poi voi ve li portate a Lampedusa! Che dire, nel mare ci sono scambi di ogni tipo, nel mare c’è tutto il mondo».
A Malta, nel workshop di fine missione etnografica [4] Naor Ben-Yehoyada (2019), mettendo in relazione la nostra esperienza di oggi con il suo imbarco su un peschereccio mazarese, anni prima, ripropone lo scenario de martiniano della fine di un mondo, la stessa sensazione che quasi tutti i pescatori incontrati ci hanno trasmesso: «a Mazara resteranno più o meno 80 barche che fanno le campagne lunghe, giù verso la Libia e la Tunisia»; un numero simile opera oggi a Lampedusa, ma su distanze più corte. E lascia emergere così l’immagine di un’inversione, di un ordine e di una gerarchia, di un rovesciamento nella guerra del pesce: «dal 1960 al 1990, i tunisini sequestrano 600 barche; ora siamo noi che sequestriamo le barche loro. Chi ruba il pesce a chi?».
Se le barche dal lato italiano dello stretto diminuiscono, è anche perché armatori e capitani fanno fatica a garantire la riproduzione sociale degli equipaggi. Le tradizioni familiari non si trasmettono senza attriti, qualcosa si interrompe; come nel caso di Mariano di Lampedusa i cui figli sono andati altrove, o quello dei molti che hanno trasferito i capitali dalla pesca al turismo. L’orizzonte diviene per molti rottamare la barca; il capitale si concentra, la pesca artigianale viene messa nell’angolo e quella industriale sconta la diminuzione delle risorse ittiche. Le barche dei mazaresi vengono ad esempio contrattate dagli allevatori di tonni per trasportare le gabbie con le catture nelle acque della Sardegna verso Malta [5]. In questo modo, si riproduce la questione della frattura metabolica già individuata da Marx (1979); il lavoro è infatti il processo attraverso il quale l’uomo, tramite la propria azione, media, regola e controlla il metabolismo tra sé e la natura ma l’industrializzazione/globalizzazione della pesca e la trasformazione dei processi lavorativi che ne conseguono riproducono le condizioni di un iper-sfruttamento delle risorse ittiche che mette a rischio la sostenibilità di quest’attività nel tempo (Longo, 2012). E il mare, in altre parole, diviene terra.
La stessa situazione di crisi/trasformazione e globalizzazione degli equipaggi viene documentata a Malta da Gilbert Calleja (2020), anche lui protagonista di preziosi lavori etnografici sui pescherecci:
«le crew maltesi nella maggior parte dei casi sono composte da egiziani, e indonesiani che sono percepiti dai locali come soggetti subalterni. I tunisini sono invece i nostri competitori più diretti. A volte la discussione a bordo prende pieghe strane. Di fronte a una situazione difficile, i maltesi rivendicano una sorta di proprietà sul mare, come forma di un surplus di conoscenza rispetto agli altri marinai. A volte ci sono tensioni legate alla religione, che sono in realtà forme di sindacalismo obliquo: la crew molla il lavoro per pregare. Gli egiziani a Malta hanno un visto speciale, possono stare sulle barche che sono considerate come offshore, ma poi non si possono muovere dai porti».
Il mondo degli equipaggi non è solo costantemente attraversato da processi di razzializzazione (Mellino, 2012) di diverso tipo, ma anche da una specifica spazialità che ruota attorno alla intimacy, alla barca come luogo di convivenza – e anche di confinamento – in cui il corpo, le culture di genere e le forme della maschilità, contano. Anche questi processi di razzializzazione, di trasformazione della composizione sociale degli equipaggi, ci parlano di una dislocazione nella costruzione culturale di questo spazio marittimo, in cui il canale incarna nuove storie, biografie, traiettorie materiali divergenti rispetto alla retorica della difesa dei confini.
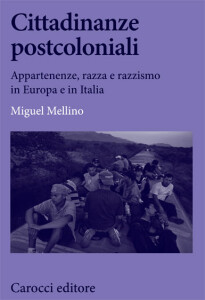 Evitare il contatto. Hotspot, celebrazioni e oblio
Evitare il contatto. Hotspot, celebrazioni e oblio
Da tempo, i governi e i vertici dell’Unione Europea stanno dando forma a politiche migratorie sempre più restrittive, operando attraverso: la proliferazione di strutture di contenimento e di concentrazione dei migranti lungo i confini; la discriminazione (fittizia) tra migranti economici e richiedenti asilo; l’impiego di apparati di controllo confinario digitali sempre più sofisticati (es.: droni, satelliti, software di riconoscimento facciale, ecc.); l’implementazione di politiche di esternalizzazione dei confini che ubicano i controlli confinari ben al di là del perimetro dell’Europa politica.
Sulle isole del Canale di Sicilia, che si collocano lungo la rotta migratoria del Mediterraneo Centrale (una delle più pericolose del mondo) l’intenzione di irreggimentare e ostacolare sempre più i flussi migratori si manifesta, principalmente, attraverso una dinamica di progressiva infrastrutturazione che contribuisce a rendere questi luoghi sempre più confine e sempre meno spazi di incontro e di relazione. Ovvero nella creazione/diffusione degli hotspot e in un continuo rafforzamento della presenza di apparati militari (es. Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Frontex) sul territorio. Un potente e costoso “apparato di cattura” che non impatta solo sui percorsi di attraversamento dello spazio marittimo Mediterraneo da parte dei migranti, ma anche, e in misura non trascurabile, sulla quotidianità degli isolani. Leggiamo questa tendenza attraverso i nostri diari di campo.
A Pantelleria, che è il frammento di territorio italiano più vicino al continente africano, il centro di accoglienza ha avuto, a lungo tempo, un carattere di provvisorietà (Cuttitta, 2015) e, solo recentemente, la presenza di uno spazio di accoglienza istituzionale ha assunto un carattere stabile. Frontex è presente dal 2020 ma il punto-crisi – dicitura che traduce in italiano il concetto di hotspot – è un’invenzione più recente.
L’inaugurazione è avvenuta il 2 agosto 2022 «alla presenza di tutti gli interlocutori istituzionali» e anche se non è (ancora) possibile l’attività di fotosegnalazione – rendendo la struttura solo parzialmente operativa – come è scritto sulla nota per la stampa della Prefettura di Trapani,
«Sono stati ultimati i lavori per l’allestimento di una struttura temporanea costituita da moduli abitativi donati dalla EUAA (Agenzia dell’Unione europea per l’asilo – ex EASO) allocati presso un’area adiacente l’ex caserma Barone che finora ha ospitato gli immigrati. La nuova struttura, finanziata dal Ministero dell’Interno, consentirà di migliorare qualitativamente l’accoglienza dei migranti ed avrà riflessi positivi anche per gli operatori di polizia che effettuano i servizi di vigilanza» [6].
Come funzionava la “accoglienza” prima dell’inaugurazione dell’hotspot ce lo racconta un’anziana volontaria della Caritas.
«Prima l’accoglienza era artigianale: ognuno faceva quello che poteva. E si stabiliva un contatto umano con le persone che arrivavano sull’isola. Chi sbarcava era preso in consegna dai Carabinieri, che trattenevano i migranti nelle celle della caserma. Però in caserma era possibile entrare, portare dei vestiti o una parola di conforto. Prima si lavorava in modo casereccio e si arrivava al “povero”, alla persona che aveva bisogno, ora è tutta burocrazia. Io sono sempre stata quella dei vestiti, se ci fosse stato qualcuno che aveva bisogno avrebbero chiesto a me e glieli facevo avere e se non ne avevo chiedevo a chi poteva darne – e gli facevo aprire le porte delle celle. Che potessero avere almeno un po’ d’aria».
Nonostante l’età avanzata la nostra interlocutrice ricorda ancora molto bene il naufragio del 13 aprile 2011, quando una barca con circa 250 persone a bordo si era incagliata sugli scogli nei pressi del porto, causando la morte di tre degli imbarcati. «Tutti si erano mobilitati sull’isola per cercare di salvare i migranti. C’erano persino i diving che si davano da fare per cercare di stabilizzare la barca. A me, mi aveva chiamato mia moglie: …ci sono dei bambini…! Cosa facciamo? E cosa facciamo… avevo una casa sfitta e l’ho messa a disposizione» ci racconta Enzo, un imprenditore locale. Girando sull’isola le foto di quel naufragio le troviamo un po’ ovunque; nella stazione dei Carabinieri, come nei bar dove facciamo colazione. Enzo ci dice che è ancora in contatto con una delle famiglie che era a bordo di quella barca e che il bambino tenuto in braccio da un carabiniere, in una delle immagini più famose che riguardano quel momento, ora gioca negli Allievi della Sampdoria.
Ora, la situazione è diversa e un “diaframma istituzionale” – fatto da procedure burocratiche, una molteplicità di divise (Carabinieri, Guardia di Finanza, Frontex), ma anche da cancelli chiusi ermeticamente e moduli abitativi “qualitativamente migliori” ma di fatto sottratti allo sguardo pubblico – si è inserito tra i migranti e le persone che “facevano l’accoglienza”. Al nuovo Punto-crisi, infatti, possono accedere esclusivamente i volontari e i dipendenti delle organizzazioni impegnate nell’accoglienza.
La “frontierizzazione” di Lampedusa avviene a partire dai primi anni Duemila e passa attraverso una molteplicità di processi che sovrapponendosi tra loro rendono l’isola un sito di cruciale importanza per comprendere le evoluzioni delle politiche europee di contrasto dell’immigrazione (Sarantaki, 2020). In questo senso, la realizzazione di un centro di accoglienza di grandi dimensioni ha reso possibile la concentrazione sull’isola di grandi numeri di persone migranti ma, allo stesso tempo, ha favorito la concentrazione in questo stesso luogo di pressoché tutti i migranti intercettati nelle acque del Canale di Sicilia; nonché l’arrivo sull’isola di un gran numero di persone come membri delle forze dell’ordine, operatori sociosanitari, operatori legali, attivisti, ecc. (Anderlini, 2020; Cuttitta, 2015; Giliberti, Queirolo Palmas, 2022).
In aggiunta, a Lampedusa, nel corso degli anni, hanno preso forma svariate esperienze di attivismo e di solidarietà diffusa, attraverso le quali si è cercato di costruire spazi di incontro tra la cittadinanza e le persone in transito. Dal punto di vista mediatico, tuttavia, l’evento che lega indissolubilmente la questione migratoria al nome di Lampedusa è il naufragio del 3 ottobre 2013, nel quale perdono la vita 368 persone. Una data che, attraverso la legge n. 45 del 2016, che istituisce la Giornata della Memoria e dell’accoglienza, assume una valenza simbolica. In altre parole, Lampedusa diviene – anche – il luogo attorno al quale prende forma una dinamica di istituzionalizzazione della memoria. E della “frontierizzazione”.
Facciamo scalo a Lampedusa dal 29 settembre al 5 ottobre, proprio nei giorni delle celebrazioni del 3 ottobre. Le strade dell’isola sono affollate da migliaia di turisti ma anche da centinaia di giovani, provenienti dalle scuole superiori di tutta Europa, che partecipano alle celebrazioni. Di migranti, invece, come abbiamo già detto, neanche l’ombra.
Una sera, mentre dal grande palco situato in fondo a Via Roma, costruito per l’occasione ed affacciato sul porto, i rappresentanti delle istituzioni e del mondo della scuola, portano i loro saluti formali, si appellano tutti ai nobili valori della solidarietà e dell’apertura allo straniero; richiamando la “responsabilità della politica” (di fatto sottraendosi alla stessa); evocando il ruolo dei giovani come la generazione che dovrà cambiare questa situazione (attribuendogli di fatto la responsabilità di aggiustare i guasti di un mondo creato dagli adulti); celebrando Lampedusa come terra dell’accoglienza e ripetendo più volte “mai più”.
Anche questo è “lo spettacolo del confine” ma, come ci ha insegnato Goffman (1969), tutto ciò che accade sulla ribalta è in relazione a quanto si colloca in un “retroscena”, ovvero in un luogo/tempo nel quale accadono fatti che pertengono alla rappresentazione ma che risultano incoerenti con l’apparenza che la ribalta cerca di dare. Nello stesso momento, in cui le istituzioni dal palco mettono in scena il dramma e l’indignazione, dalla nave Luise Michel – appena attraccata al porto di Lampedusa, e visibile dallo stesso palco – sbarcano 88 migranti salvati in mare, di cui 68 minori. Probabilmente coetanei degli stessi ragazzi che stanno assistendo alla manifestazione. Nessuno ne parla; i naufragi sembrano così relegati a un passato lontano, o forse all’oblio, e non c’è alcun contatto tra i giovani migranti e gli studenti che partecipano alla celebrazione.
Conclusioni
Provando a racchiudere il senso di questo articolo in una riflessione conclusiva ci viene in mente Iain Chambers (2012, p. 34) dove scrive che
«viaggiare servendosi di cartografie sonore, di mappe musicali, significa ascoltare e vivere un Mediterraneo che continuamente supera una sua concezione abituale dettata da frontiere nazionali e linguistiche. Sconfinati e sovrapposti, i paesaggi sonori che s’intrecciano e si intersecano favoriscono combinazioni vibranti e risonanze culturali – una poetica, che scoraggia significativamente l’idea del definitivo. Tali suoni designano i limiti di una modernità che è stata generalmente incapace e refrattaria a rispondere a traiettorie molteplici, e che ha optato invece per una narrativa univoca».
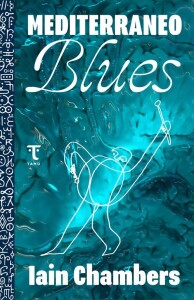 In questo senso, per comprendere le trasformazioni che stanno investendo il Mediterraneo, ci sembra necessario adottare una prospettiva che concepisca questo spazio non come una barriera, o come un’arma (Levidis, 2021), ma come uno spazio di incontro, o un crocevia (Anderlini & Fravega, 2023). Si tratta, in altre parole, di provare ad uscire dalla narrazione che descrive questo immenso spazio marittimo e culturale come un mero campo di battaglia, trovando nuove parole e nuovi modi per raccontarlo.
In questo senso, per comprendere le trasformazioni che stanno investendo il Mediterraneo, ci sembra necessario adottare una prospettiva che concepisca questo spazio non come una barriera, o come un’arma (Levidis, 2021), ma come uno spazio di incontro, o un crocevia (Anderlini & Fravega, 2023). Si tratta, in altre parole, di provare ad uscire dalla narrazione che descrive questo immenso spazio marittimo e culturale come un mero campo di battaglia, trovando nuove parole e nuovi modi per raccontarlo.
In queste pagine abbiamo voluto dare conto di come la pratica della solidarietà di base sia diffusa e, al tempo stesso, sia osteggiata. Così, senza dire della flotta civile – che svolge attività di ricerca soccorso tra la costa nordafricana e quella siciliana, nonostante una legislazione sempre più avversa – abbiamo visto come l’osservanza della legge del mare, da parte di chi va per mare è sovraordinata ad ogni altro principio giuridico; anche se chi la mette in atto rischia di essere sanzionato. E quando ci siamo trovati di fronte gli equipaggi multinazionali e globalizzati dei pescherecci dei mazaresi o dei maltesi ci è venuto spontaneo domandarci se sia mai esistito – fatti salvi gli assetti navali militari – un equipaggio realmente omogeneo dal punto di vista nazionale. E, in aggiunta, se proprio nell’incontro tra persone di varia provenienza con familiarità con una quantità di strutture sociali differenti non si produca quello scarto che è alla base di molte sperimentazioni democratiche (Graeber, 2021).
In questo quadro, l’agire delle istituzioni si caratterizza per un’estrema ambivalenza. La creazione dell’hotspot di Pantelleria, ad esempio, formalizza un’attività che precedentemente si basava sul volontariato e sulla discrezionalità degli interventi, garantendo, viceversa, la standardizzazione delle prestazioni di servizio (welfare e di sicurezza); d’altra parte, impedisce il contatto diretto tra la popolazione dell’isola e le persone migranti o, meglio, ostacola i contatti non mediati da procedure burocratiche, mezzi militari, uniformi, badge e codici identificativi.
Parallelamente, la celebrazione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, favorisce lo sviluppo di un’elaborazione collettiva sul tema dell’accoglienza, attraverso una pluralità di incontri, dibattiti e workshop, e non si può certo negare che il grande coinvolgimento del mondo studentesco sia un valore positivo dell’iniziativa. Tuttavia, la stessa manifestazione contribuisce ad una rappresentazione delle persone migranti quasi solo in termini vittimistici; ovvero come una figura passiva, priva di agency e relegata in un immaginario in cui le (necro)politiche di securitizzazione dei confini non svolgono alcun ruolo. Un migrante-spettro, insomma, che esiste solo nel discorso pubblico e, di fatto, ostacola la conoscenza e il contatto tra popolazione autoctona e persone in movimento. In questa prospettiva, la reclusione del migrante in un perimetro fisico-geografico (hotspot) o simbolico-culturale (celebrazione) sembra configurare un processo di produzione di un’alterità radicale e razzializzata (Mellino, 2011) e lentamente decostruisce l’idea del Mediterraneo come spazio-movimento o, seguendo Braudel (2017), come crocevia «dove tutto si mescola e si ricompone in una unità originale».
Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023
[*] Ai soli fini accademici si precisa che l’introduzione, il secondo paragrafo “Evitare il contatto. Hotspot, celebrazioni, oblio” e le Conclusioni sono stati scritti da Enrico Fravega, mentre il primo paragrafo “La legge del mare e la globalizzazione della pesca” è stato scritto da Luca Queirolo Palmas.
Note
[1] Il lavoro di ricerca su cui si basa questo articolo è stato finanziato dal progetto MOBS – Mobilities, solidarities and imaginaries across the borders: the mountain, the sea, the urban and the rural as spaces of transit and encounters (PRIN 2020 Prot. 2020TELSM8).
[2] Per un racconto dettagliato della ricerca, si veda Crocevia Mediterraneo, a cura di J. Anderlini ed E. Fravega (2023) e il blog Crocevia Mediterraneo de “L’equipaggio della Tanimar”: https://www.meltingpot.org/2022/09/crocevia-mediterraneo-fare-ricerca-attraverso-il-mare/
[3] Cfr. Decreto legge N. 01/2023.
[4] Titolo del workshop: “The Mediterranean Sea as a battleground and as a space of encounters. A dialogue on migrations at sea, maritime bordering practices along the “colour line”: tourism, and seafarers work practices”. Location: Institute of Mediterranean Studies dell’Università di Malta. Data: 10 ottobre 2022.
[5] Per una testimonianza di un operaio sulle condizioni di lavoro nell’allevamento dei tonni a Malta si veda: https://www.meltingpot.org/2022/10/il-mare-e-un-macello/
[6] http://www.prefettura.it/trapani/news/Comunicati_stampa:Punto_crisi_destinato_all_accoglienza_ai_fini_
del_successivo_trasferimento_dei_migranti_che_arrivano_in_modo_autonomo_sull_isola_di_pantelleria-14371820.htm
Riferimenti bibliografici
Anderlini, J., & di Meo, S. (2021), Approccio hotspot e navi quarantena, Il Mulino. https://www.rivistailmulino.it/a/approccio-hotspot-e-navi-quarantena
Anderlini, J., & Fravega, E. (Eds.) (2023), Crocevia mediterraneo, Elèuthera.
Ben-Yehoyada, Naor., & Pizzolato N. (2019), Incorporare il Mediterraneo: formazione regionale tra Sicilia e Tunisia nel secondo dopoguerra. https://www.meltemieditore.it/catalogo/incorporare-il-mediterraneo/
Braudel, F. (2017), Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Bompiani.
Calleja, G. (2020), Ethnography and experimental non-fiction storytelling: relating the experiences of Maltese Fishermen, University of Westminster.
Chambers, I. (2012), Mediterraneo Blues, Bollati Boringhieri.
Cuttitta, P. (2015), “Lampedusa tra produzione e rappresentazione del confine”, REMHU: Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana, 23(44), 31–45. https://doi.org/10.1590/1980-85852503880004403
de Genova, N. (2017), The borders of “Europe”: autonomy of migration, tactics of bordering, Duke University Press.
Giliberti, L., & Queirolo Palmas, L. (2021), The hole, the corridor and the landings: reframing Lampedusa through the COVID-19 emergency. Https://Doi.Org/10.1080/01419870.2021.1953558, 45(9), 1760–1781. https://doi.org/10.1080/01419870.2021.1953558
Goffman, E. (1969), La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino.
Graeber, D. (2021), L’utopia pirata di Libertalia, Elèuthera.
Levidis, S. (2021), BORDER NATURES. The Environment as Weapon at the Edges of Greece [Goldsmith University], https://doi.org/10.25602/GOLD.00030506
Longo, S. B. (2012), “Mediterranean Rift: Socio-Ecological Transformations in the Sicilian Bluefin Tuna Fishery”, Critical Sociology, 38(3), 417–436. https://doi.org/10.1177/0896920510382930/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_0896920510382930-FIG1.JPEG
Marx, K. (1979), Il Capitale: libro primo: il processo di produzione del capitale, Peruzzo editore.
Mellino, M. (2011), “De-provincializzare l’Italia: note su colonialità, razza e razzializzazione nel contesto italiano”, in. De-Provincializzare l’Italia: Note Su Colonialità, Razza e Razzializzazione Nel Contesto Italiano, 3, 57–90. https://doi.org/10.3280/MM2011-003004
Mellino, Miguel. (2012), Cittadinanze postcoloniali: appartenenze, razza e razzismo in Europa e in Italia,Carocci. http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843067817
Orsini, G. (2016), “Securitization as a Source of Insecurity: A Ground-Level Look at the Functioning of Europe’s External Border in Lampedusa”,. Studies in Ethnicity and Nationalism, 16(1), 135–147. https://doi.org/10.1111/SENA.12170
Proglio, G. (2019), Mediterraneo nero: archivio, memorie, corpi, Manifestolibri.
Queirolo Palmas, L. (2019),”At the Borders of the European Fortress: “Rizki”, Being a Young Migrant in Ceuta and Melilla”, Italian Journal of Sociology of Education, 11(3). https://doi.org/10.14658/pupj-ijse-2019-3-4
Queirolo Palmas, L. (2021), “Frontera Sur: Behind and beyond the fences of Ceuta and Melilla”. Ethnography, 22(4): 451–473. https://doi.org/10.1177/14661381211038252
Queirolo Palmas, L., & Rahola, F. (2022), Turismi di frontiera, Deriveapprodi.
Sarantaki, A.-M. (2020), Frontex and the evolution of European border control: a cultural approach, [Panteion University of Social and Political Sciences]. https://doi.org/10.12681/EADD/46930
______________________________________________________________
Enrico Fravega, è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova e coordinatore del progetto PRINO MOBS (PRIN 2020 Prot. 2020TELSM8). È autore di L’abitare migrante. Racconti di vita e percorsi abitativi di migranti in Italia (Editore Meltemi). Interessi di ricerca: migrazioni e pratiche di home-making, abitare informale, la costruzione del confine negli spazi marittimi.
Luca Queirolo Palmas, è Professore associato di Sociologia delle Migrazioni all’Università degli Studi di Genova e P.I. dei progetti: ERC Advanced Grant SOLROUTES e PRIN MOBS (PRIN 2020 Prot. 2020TELSM8). È fondatore del Laboratorio di Sociologia Visuale e codirettore della rivista Mondi Migranti. Ha recentemente pubblicato, con Federico Rahola, Underground Europe (Editore Meltemi).
______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/trasformazioni-mediterranee-migrazioni-solidarieta-e-barriere/
Click here to print.