Umorismo e psicoterapia. Ne possiamo parlare?
Posted By Comitato di Redazione On 1 maggio 2021 @ 02:57 In Cultura,Società | No Comments
di Alfredo Ancora
..Grande tra gli uomini e di gran terrore è la potenza del riso: contro il quale nessuno si trova difeso da ogni parte. Chi ha il coraggio di ridere è padrone del Mondo (Giacomo Leopardi, Pensieri, n.78).
Maneggiare con cura prima dell’uso
Che senso ha ritornare su questo tema [1] in tempi così drammatici? Dove vuol portare una siffatta conversazione? Un metalogo su un argomento problematico – come direbbe Gregory Bateson? Con quale obiettivo si riprendono temi come l’humor [2] o l’ironia, senza storcere troppo il naso? Senza che appaia una inutile “operazione di ripescaggio”? Queste interrogazioni – più che interrogativi – hanno semplicemente l’obiettivo di “rinfresco”, momentaneo ed autoriflessivo, per menti affaticate, a più livelli, dalle attuali condizioni di vita. Declinare tali argomenti non vuol dire certo sminuire serietà ed importanza al disagio psichico ma aggiungere modalità per letture diverse. La storia ci può dare qualche esempio. Come non ricordare Giovanni Boccaccio che in piena pestilenza di Firenze (1348) scrisse il Decamerone, un’opera narrata con leggerezza nella sua straordinaria e variegata umanità! Ad un altro livello e in un’epoca storica differente, Antonio Gramsci (1922) trovò in carcere un tempo mentale per scrivere favole [3] destinate ai suoi figli lontani ai quali immaginava di poterle raccontare! Più vicino ai nostri tempi, il magnifico film di Roberto Benigni, La vita è bella (1997), con momenti esilaranti all’interno di una storia drammatica come la Shoah, la più grande tragedia umana del Novecento (dopo quella del massacro degli Armeni da parte dei Turchi agli inizi del secolo).
Abbiamo scomodato famosi personaggi ed eventi sconvolgenti come esempi di una “sosta del pensiero”, all’interno di un filo narrativo serio per offrire un piccolo strumento agli psicoterapeuti (e non solo) che sono soggetti nel loro lavoro a continue destabilizzazioni in questa difficile fase. Infatti, chi lavora con la mente si trova a rispondere a nuovi bisogni, in contesti insoliti, con sedute virtuali e modi di comunicazione affidati ad altri canali.
È necessaria una precisazione. Chi pensa di aspettarsi idee nuove su un tema così consolidato nel tempo come l’umorismo, rimarrà probabilmente deluso. I punti di riferimento classici rimangono insuperabili. Solo qualche spunto in più da utilizzare con prudenza e in maniera opportuna senza farsi prendere la mano da eccessive e facili utilizzazioni. Maneggiare con cura quindi!
L’umorismo in psicoterapia è un fenomeno complesso, un termine polisemico che comprende aspetti relazionali, cognitivi, conversazionali che connotano un preciso contesto. Ad ogni terapeuta sono note le diverse funzioni che esso può svolgere e quanto sia talvolta difficile individuarne il quando e il se della sua utilizzazione. Si debbono creare le condizioni perché ci sia un clima empatico. Chi chiede aiuto deve poterlo “respirare”, sentirsi accolto in tutta la sua umanità [4] perché possa aprirsi a canali comunicativi inusuali. È certamente necessario che trovi di fronte a sé un terapeuta competente e capace! Battute ridanciane, frutto di grossolana giovialità rivelano dilettantismi fuori luogo in campi così delicati. È meglio forse rinunciare ed affidarsi all’uso di altri elementi usuali!
L’umorismo rappresenta un aspetto psicologico e culturale [5] fra i più importanti presenti nella nostra vita quotidiana anche al di fuori dei contesti terapeutici. Rino Cerritelli (2013) lo ritiene utile «per migliorare il carattere e la qualità del vivere. Un umorismo ingegnoso e costruttivo, che induca a ricercare un più sano rapporto con le situazioni di dolore e sofferenza». Tuttavia, nonostante il ruolo importante che esso ricopre, non si riesce ad “imbrigliarlo” in un costrutto univoco ed esaustivo per la vita comune ed ancora di più nell’incontro particolare di una seduta terapeutica! Siamo quindi consapevoli che faremo riferimento soltanto ad alcuni aspetti, tralasciandone inevitabilmente altri.
 Tornando indietro nel corso del tempo, l’uso dell’humor in terapia ha suscitato interessi presso autori con differenti pensieri. Ne citeremo solo alcuni fra i più importanti. Nel campo psicoanalitico, Sigmund Freud, autore del saggio Il motto di spirito (1905), sosteneva che l’umorismo è «il trionfo del narcisismo e del principio del piacere». Secondo Harold Searles (1974) l’umorismo serve per sublimare la disillusione. Cesare Musatti (1987) metteva in risalto soprattutto l’irrefrenabilità dell’ironia, senza dimenticare i rapporti personali fra chi esprime l’ironia e chi dell’ironia è oggetto.
Tornando indietro nel corso del tempo, l’uso dell’humor in terapia ha suscitato interessi presso autori con differenti pensieri. Ne citeremo solo alcuni fra i più importanti. Nel campo psicoanalitico, Sigmund Freud, autore del saggio Il motto di spirito (1905), sosteneva che l’umorismo è «il trionfo del narcisismo e del principio del piacere». Secondo Harold Searles (1974) l’umorismo serve per sublimare la disillusione. Cesare Musatti (1987) metteva in risalto soprattutto l’irrefrenabilità dell’ironia, senza dimenticare i rapporti personali fra chi esprime l’ironia e chi dell’ironia è oggetto.
Nell’area sistemico-relazionale, Carl Whitaker (1984) ne evidenziava gli aspetti “assurdi” e “ristrutturanti”. Nel mondo delle Terapie non comuni Milton Erikson (1983) ne descriveva le “cornici” e i “contesti”, mentre, per il costruttivismo, Paul Watzlawick (1988) ne focalizzava il suo uso nella costruzione “delle realtà terapeutiche”. L’elenco dei contributi potrebbe ovviamente continuare, per cui ci siamo limitati ai più significativi, consapevoli di non poterli menzionare tutti. Merita un particolare riferimento Bateson, autore sempre attuale (oltre le mode) e indisciplinato, nel senso al di fuori dalla disciplina e dalle strettoie di un pensiero lineare. Le incursioni mentali del suo Verso una ecologia della mente (1972) sono state fonti di ispirazione anche per me. Fondamentali le sue riflessioni: «L’humor contiene in sé aspetti paradossali, come il gioco che – alla pari dell’umorismo – è parlare di una stessa cosa a livelli diversi a cavallo fra apparenza/realtà»[6].
Concentrerò il focus delle mie osservazioni soprattutto sugli elementi comunicazionali – pur riconoscendo l’importanza degli aspetti narcisistici descritti da Freud – per sviluppare tutto quel “potenziale costruttivo” (Fasolo, 1979) che può sprigionare ogni processo terapeutico. Come nasce l’esigenza di questo particolare angolo di osservazione? Come un generico invito all’allegria? Un inarrestabile senso dell’ottimismo in una realtà di sofferenza? Tali domande nascono dalla difficoltà nel potere attivare – durante una seduta terapeutica – momenti di un altro livello, utili per una maggiore conoscenza dell’atto di cura. Quindi, chi non possiede questa particolare attitudine rischia di essere considerato solo un terapeuta serioso o addirittura troppo serio? Non si vuole sostenere la presenza di un qualcosa che sia innato! È molto importante invece l’atteggiamento mentale di chi osserva e come pensa il sistema terapeutico che si sta co-costruendo.
È necessario quindi sottolineare come l’humor non sia una capacità ereditata! Esso è un prodotto del pensiero di chi osserva una determinata realtà; non appartiene al patrimonio genetico del terapeuta. L’ottica alla quale si farà riferimento sarà costruttivista [7]. Essa, come è noto, si pone l’obiettivo di creare le condizioni perché ogni terapeuta possa sfidare il modo “vero” di vedere le cose che viene riportato in seduta. Del resto, anche il filosofo Henry Bergson (1961) ne aveva colto lo stesso significato, scrivendo a proposito del riso: «I più grandi pensatori hanno affrontato questo piccolo problema, che ha l’abilità di frustrare ogni sforzo, di scivolare via e di sfuggire solo per risorgere di nuovo come una sfida impertinente lanciata alle speculazioni filosofiche».
Non è forse quello che accade, in termini pacifici, in terapia? La possibilità di un continuo e sequenziale refraiming del problema presentato, non secondo le sue caratteristiche riportate come vere e oggettive, ma osservando nuove correlazioni. Il modo di osservare gli eventi si basa su una posizione che è limitrofa all’operazione stessa, cosicché «tu puoi percepire l’operazione di riflesso» (Lyle Hoffmann,1988).
Del resto, già 2000 anni fa il filosofo Greco Epitteto diceva che «non sono le cose in sé che ci preoccupano, ma le opinioni di quelle cose». Un atteggiamento mentale di tipo umoristico non risulta in contrasto, ovviamente, con la serietà dei problemi presentati: può offrire semmai un’ipotesi utile, soprattutto come possibile aiuto a cambiare una determinata modalità del paziente, della famiglia o della coppia, pensata come immodificabile.
Questa operazione mentale deve essere adiuvata da tutti gli arnesi contenuti in quel particolare armamentario che è il therapeutic bag di ogni “tecnico della mente”. Fra questi importante è il dia-logo – inteso in senso recursivo – come formalizzazione del pensiero fino ad allora esposto [8]. In terapia si materializza quanto diceva Heinz von Foerster (1989), fisico ed epistemologo: «se vuoi vedere, impara ad agire». Un invito a vedere un altro aspetto di una visione bloccata da una concezione della realtà preclusa ad alternative possibili.
Torniamo agli aspetti più faceti (!) dell’ironia [9], anzi sarebbe meglio parlare di arte ironica, come capacità di aprire possibili chiavi d’accesso a situazioni difficili, refrattarie ad altri tipi di aiuto. Una modalità duttile, lenta e performativa, permeata da un senso di predisposizione profonda, una sorta di “bienveillance pensive” (premurosa benevolenza) come la chiamava Formiggini (1989) nel suo famoso saggio Filosofia del ridere.
 Humor come conoscenza
Humor come conoscenza
Essa assume contemporaneamente caratteristiche di sottigliezza e raffinatezza, il cui uso è legato alla conoscenza del contesto con il quale si sta operando e con le persone con le quali si sta lavorando. Allo stesso tempo, essa rappresenta un modo complesso di conoscenza, un invito a considerare quella parte di ironia presente in ognuno di cui non si è spesso consapevoli. Una riflessione per il terapeuta a interrogarsi sul suo modo di essere ironico, spesso assente nei suoi atteggiamenti mentali assestati solo su note griglie conoscitive. Si possono così creare cornici in cui interagiscono elementi ricorsivi e autologici con continui rimandi dei termini. Questi ultimi danno luogo ad un gioco punteggiato da contorni e sfumature di livelli comunicativi di diverso ordine che possono apparire contrastanti. Infatti, alla costruzione di una realtà complessa partecipano in eguale maniera coppie di termini in apparente contraddizione: logico – illogico, senso – non senso, continuo – discontinuo, chiaro – ambiguo, etc. che sembrano rincorrersi richiamandosi continuamente l’uno all’altro. Già Kant nella sua monumentale Critica del giudizio (1790: 198) aveva scritto ben sette pagine (nella terza Critica) per occuparsi di questo argomento: «Lo humor consiste nel talento di mettersi volontariamente in una certa predisposizione d’animo, in cui tutte le cose sono giudicate in modo del tutto diverso dall’ordinario (persino al rovescio) e pure conformemente a certi princìpi razionali che sono nella disposizione stessa». Incredibile e moderna intuizione, pensando alla data in cui è stata pubblicata!
Può comunque accadere che un modo di pensare organizzato secondo canoni di logicità e congruità, non acceda facilmente a informazioni di tipo umoristico legati ad una logica altra! È possibile che all’inizio si possa andare incontro ad uno smarrimento nel momento in cui si attinge a “modi altri”, diversi da quelli abituali. Dall’esperienza clinica sappiamo quanto sia importante poter attingere alla nostra “bottega mentale” per attivare altri canali comunativi. Questi ultimi ci possono permettere di metacomunicare soprattutto in contesti in cui sia necessario dare significati diversi per nuove aggregazioni di idee o meglio menti, come le chiamava Bateson (1972). William Fry, uno dei collaboratori del Palo Alto Projet (Watzlawick, 1967), sosteneva l’importanza degli aspetti paradossali/ umoristici/de-strutturanti all’inizio e ri-strutturanti in seguito.
 Nel momento in cui viene enunciato un “motto di spirito”, si sta comunicando, anzi metacomunicando in quel preciso momento, ad un altro livello, «questo è irreale!» Se il destinatario del messaggio è capace di comprendere la cornice di riferimento “questo è un gioco” (Bateson, 1996), allora anche lui entrerà a far parte di quel processo oscillatorio reale/irreale, serio/ faceto. Naturalmente l’uso di questi strumenti comunicativi non può essere applicato in tutti i contesti. Alcuni quadri di disagio psichico non permettono infatti la possibilità di passare da un momento ad un altro con slivellamenti che risulterebbero non comprensibili se non si creano cornici adatte.
Nel momento in cui viene enunciato un “motto di spirito”, si sta comunicando, anzi metacomunicando in quel preciso momento, ad un altro livello, «questo è irreale!» Se il destinatario del messaggio è capace di comprendere la cornice di riferimento “questo è un gioco” (Bateson, 1996), allora anche lui entrerà a far parte di quel processo oscillatorio reale/irreale, serio/ faceto. Naturalmente l’uso di questi strumenti comunicativi non può essere applicato in tutti i contesti. Alcuni quadri di disagio psichico non permettono infatti la possibilità di passare da un momento ad un altro con slivellamenti che risulterebbero non comprensibili se non si creano cornici adatte.
I cambiamenti improvvisi di livello con l’uso di sequenze comunicative inaspettate, possono provocare un subitaneo disorientamento nel contesto serio di una seduta terapeutica. Esse trovano nella sua “illogicità” una spiegazione coerente e logica (Forabosco, 1980). In sintesi, si passa attraverso livelli di disordine, disorganizzazione, smarrimento verso un nuovo tipo di ordine, organizzazione, orientamento del sistema terapeutico. Bateson (1935) nel suo Humor in human comunication connota il valore di una battuta ironica all’interno di una interazione figura-sfondo!
In seguito, nel saggio Questo è un gioco (1956) presentato alla Macy Foundation [10]] espone il suo originale e complesso pensiero [11] per evidenziarne meglio il crogiuolo di intrecci e paradossi presenti nei processi comunicativi. L’antropologo e cibernetico ricorre alla teoria dei tipi logici di Russell [12], utilizzando la suggestiva immagine della “struttura a bucce di cipolle”. In questo modo raffigura la comunicazione rendendola più visibile e concreta. Precisamente, così chiosa: «Perché essa sia possibile ha bisogno di una serie di regole, di bucce, di bucce paradossali, perché se le rispettassimo fino in fondo, finiremmo per ottenere l’effetto opposto, per chiuderci in una rigidità che non ammette né umorismo, né arte, né fantasia….in altre parole che non ammette la vita stessa. Abbiamo bisogno di pasticci, di intersezioni fra le varie bucce, di un po’ di gioco fra una cornice e l ’altra» (dalla premessa di D. Zolletto in Bateson, 1956: 3).
Uno sguardo su quanto avviene nel nostro lavoro ci viene nuovamente dalle osservazioni di H. von Foerster sul sistema familiare (applicabile anche in altri contesti terapeutici). L’interazione che si crea fra il terapeuta (sfida ai valori) e la famiglia, mediante un tipo di metacomunicazione ironica ed umoristica, viene a coincidere con le ingerenze prodotte dall’incontro fra famiglia e terapeuta. Queste modalità potrebbero costituire in un membro contraente il siffatto rapporto, la famiglia, l’individuo o il terapeuta, una sorta di automodellamento dell’altro [13]. In termini più semplici, ma non semplicistici, la parte ironica della famiglia e l’ironia del terapeuta si autorimandano. Lo stesso può verificarsi in setting individuali, seguendo questa ottica (Boscolo, Bertrando, 1996).
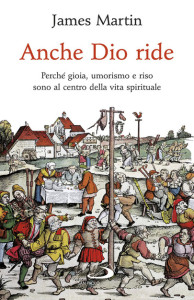 Lo humor: un altro momento di conoscenza
Lo humor: un altro momento di conoscenza
L’humor, come si diceva all’inizio, assume le vesti di un processo in fieri, ricorsivo, non un dato precostituito, una prerogativa del terapeuta. Per quanto riguarda le aspettative del paziente, oltre allo sbalordimento provocatogli da inconsuete interazioni con cui deve correlarsi, egli stesso inizia a “scoprire” – non con un certo timore – di avere una propria ironia, un proprio senso dello humor e soprattutto la capacità di poter leggere le stesse cose in un modo diverso. Il cambiamento riguarda anche il terapeuta che potrebbe accorgersi di quanto talvolta il suo modo di pensare/agire sia stato forse un po’ troppo rigido, e non gli abbia permesso di accedere alle risorse personali fino ad allora inesplorate. L’ironia come processo di conoscenza! A questo punto, sorge una domanda: qual è la modalità con cui il terapeuta si mette in rapporto con chi gli sta di fronte all’interno di un contesto fin qui definito? La Selvini Palazzoli afferma che non può esser(ci) una epistemologia del cambiamento, «non è costruito sul carattere essenzialmente asimmetrico del contesto terapeutico» (Selvini Palazzoli, 1984). Sempre su questo punto Valeria Ugazio (1985) aggiunge che a mantenere tale simmetria «non è però il tentativo del terapeuta di controllare unidirezionalmente il sistema osservato, ma la sua capacità di collegarsi alla famiglia secondo modalità che non sono coerenti con il modo di organizzare la realtà e con i patterns comportamentali del nucleo, capacità che egli deriva dal riferimento del proprio modello concettuale».
Una di queste modalità asimmetriche può essere costituita proprio dall’humor, che diventa non solo un momento altro di conoscenza, un tuffo in mondi fino allora sconosciuti, ma anche la possibilità di poter incidere sulle barriere difensive, ostacolo naturale ad ogni fase di cambiamento. Infatti, un contesto asimmetrico in cui l’osservato e l’osservatore si trovano collocati su due “postazioni” indipendenti e differenti può aiutare a conoscersi meglio. Un simile decentramento osservativo – di cui parla George Devereux (1985) – produce continui posizionamenti e ri-posizionamenti nel processo di osservazione.
Che cosa avviene quindi durante un atto di cura, luogo deputato al cambiamento? Quest’ultimo potrà avvenire solo se si creeranno le condizioni per momenti di perturbazione, necessari ad una diversa autorganizzazione mentale del sistema stesso. Il paziente non più vittima, capro espiatorio, anello debole della catena, può diventare anche stimolo, elemento di attivazione, capace di scosse verso ulteriori assestamenti di un nuovo equilibrio.
Lo humor come elemento destabilizzante
Secondo l’ottica finora descritta l’humor, come elemento perturbatore, non ha per obiettivo di far ridere introducendo qualche battuta più o meno scherzosa per sdrammatizzare l’aria che regna in seduta. L’obiettivo, se mai, è riuscire ad introdurre nel sistema elementi atti a riprodurre un vero e proprio brainstorm, un terremoto cognitivo, capace di far scricchiolare la visione compatta del paziente presentata come immodificabile e come l’unica e vera. Si possono scomporre alcune parti e ri-comporne delle altre seguendo un percorso evolutivo (non regressivo!). Il percorso difficile e faticoso di nuove strade può richiedere soste meditative utili a tutti, terapeuta compreso.
Per finire seriamente, mi piace ricorrere ad uno di quei racconti didattici di Milton Erikson, un grande terapeuta i cui libri rimangono inalterati nel corso del tempo per il loro valore. Dalla descrizione dei suoi casi clinici [14], illuminanti per l’uso di ingiunzioni umoristiche, ne riporto uno semplice.
Ad una coppia giovane che si presentò da lui con un problema di enuresi, l’illustre psicoteraupeuta prescrisse loro che quando fosse successo di nuovo, non avrebbero dovuto cambiare le lenzuola, ma dormire nel letto bagnato e li rimandò di lì a quindici giorni. Per quanto detto finora, senza lasciarsi andare a facili e semplicistiche considerazioni, si evidenzia quanto non sia utile decontestualizzare la storia! Infatti la coppia in un primo momento non era stata capace di ironizzarci su, anzi non c’era niente da ridere! Nella successiva visita, con un’altra visione e da un’altra angolazione, riuscirono a vedersi diversamente, riuscendo anche a divertirsi per una tale prescrizione!
L’umorismo con la voce di Erikson era stato capace di burlarsi degli ordinamenti e delle immagini di una situazione vissuta come immodificabile e non passibile di un qualche cambiamento. È una visione oltre la logica e il senso fino ad allora esperiti. Ogni co-costruttore di realtà terapeutiche scuote “l’ordine di quel mondo” (Watzlawick, 1980). Infatti, la destabilizzazione di parametri cognitivi può provocare in un sistema terapeutico la rottura dell’equilibro su cui era assestato precedentemente ed entrare in altre forme.
Le premesse epistemologiche attraverso le quali si opera risultano sempre molto importanti. Non c’è tecnica senza pensiero! Non bisogna infine dimenticare le contraddizioni che può procurare l’uso dello humor in coloro che sono seriamente interessati al cambiamento nei contesti terapeutici.
Dialoghi Mediterranei, n. 49, maggio 2021
Note
[1] Non si vuole far riferimento alla Psicologia positiva tanto in voga in America, dove è stata fondata da Martin Seligman nel 1975 che la considerava come «una prospettiva teorica ed applicativa della psicologia che si occupa dello studio del benessere personale, costrutto al centro della qualità della vita». Ha avuto diffusione anche in Italia dove è stata formata la Società Italiana di Psicologia Positiva ed in Francia dove ha una sua propria rivista Psychologie Positive (cfr. il num.54, Mars 2021).
[2] Fra i numerosi testi sull’argomento: Cerritelli, R. 2013, La terapia dell‘umorismo. Metodi e pratiche per il benessere personale e relazionale, Carocci, Roma; Floris, S. 2003, L’ironia ovvero la filosofia del buonumore, Marcovalerio, Torino; Scarinci, A. 2018 [a cura di], Umorismo e psicoterapia, Alpes, Roma; Morreall, J. 2011, Filosofia dell’umorismo. Origine, etica e virtù della risata, Sironi Editore, Milano; Polosa, R. 2012, Da Freud a Pirandello (passando per Berson) lo spirito e la comicità, Libellula editore, Tricase (Le).
[3] La prima pubblicazione risale al 1948, presso gli Editori Riuniti, Roma.
[4] Debbo questo spunto al collega ed amico di lunga data Alessandro Fischetti che ha anche riletto con pazienza e perizia questo elaborato. Debbo a mio figlio Ludovico la ricerca iconografica che accompagna il testo.
[5] Fra le raccolte più complete dell’humor nei vari campi del sapere, rimane a tutt’oggi fondamentale L’humour: histoire, culture et psychologie (sous la direction de G. Roux, M. Laharie), Edition Sipe, Pau 1998.
[6] Bateson, G. 1976. Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano. È utile riportare parte del metalogo “Dei giochi e della serietà” (pag. 48-49): «Padre: Allora sembra che dipenda da me chiarire che cosa intendo con l’idea di gioco. Io so di essere serio (qualunque ne sia il significato) nelle cose di cui parliamo. Noi parliamo di idee. E io so di giocare con le idee allo scopo di comprenderle e metterle insieme. È un divertimento nello stesso senso in cui un bambino si diverte coi cubi… E un bambino con i cubi per lo più si comporta in maniera molto seria col suo ‘divertimento’».
[7] Watzlawick, P. (a cura di) 1988, La realtà inventata, edizione italiana a cura di Ancora A., Fischetti A. Feltrinelli, Milano. In questo testo l’autore ha più volte suggerito l’opportunità di sostituire, per motivi epistemologici ed estetici, il termine “costruttivismo” con “ricerca della realtà”.
[8] Ancora, A. Fischetti, A. 1990, Formazione e costruttivismo, in Benvenuto, S . Nicolaus, O. [a cura di] La bottega dell’anima , Franco Angeli, Milano.
[9] Abbiamo considerato finora ironia e humor come sinonimi per il loro uso assimilabile in terapia, consapevoli dei rispettivi significati e differenze.
[10] Di grande importanza il volume (attualmente di difficile reperimento) di J. Heims Cibernetici, Editori Riuniti Roma,1994 che comprende la serie di conferenze alla Macy Foundation tra il 1946 e il 1953. Al Cybernetic Group parteciparono illustri personaggi, quali Heinz von Foerster, Norbert Wiener, Warren S. McCulloch, Claude E. Shannon, Margaret Mead. E naturalmente anche Bateson.
[11] Come è noto, furono diversi i suoi campi di ricerca: dalle osservazioni sulla comunicazione dei delfini alla teoria del doppio legame negli schizofrenici, dai processi mentali alla cibernetica. Fra le sue opere si veda Verso un’ecologia della mente, 1973 Adelphi, Milano e Mente e Natura, 1978, Adelphi, Milano; cfr. anche Ancora, A. 1996 Perché Bateson?, in “Attualità in psicologia”, anno XI, n.1.
[12] Com’è noto tale teoria dice, in termini di logica formale, che una classe non può essere elemento di se stessa, e una classe di classi non può essere una delle classi che sono suoi elementi. Essa venne originariamente formulata per risolvere alcune antinomie logiche delle quali la più antica e più nota è quella del Cretese Epimenide che dice «tutti i cretesi sono bugiardi» Cfr. A. N. Whitehead e B. Russell, 1963 Principia Mathematica, Longanesi, Milano.
[13] In Von Foerster, H. 1987, Sistemi che osservano, Astrolabio – Roma. cfr. anche Von Foerster, H. 1953 (ed) – Cybernetic:3 – Macy Foudation, New York.
[14] Haley, J. 1976, Terapie non comuni, Astrolabio, Roma. In questa raccolta l’autore descrive e commenta in una batteria di strategie terapeutiche, alcune bizzarre, alcune basate sul buon senso, alcune drammatiche, e altre ancora comiche, tutte appartenenti al vastissimo repertorio di Milton H. Erickson.
Riferimenti bibliografici
Ancora, A. 1983, A casa del maestro: colloquio con George Devereiux, seminario Centro Studi Psicoterapia Ricerca Sistemica, Roma.
Ancora, A. 1987, Crisi: un modello evolutivo nella terapia relazionale, in “Training autogeno e psicoterapie brevi” [a cura di L. Peresson] Piovan editore, Padova.
Ancora, A. Fischetti, A. 1987, Bateson ed il pensiero psichiatrico, in “Gregory Bateson, maestro dell’ecologia della mente”, Edizioni Federazione Università Verdi, Bologna.
Ancora, A. 2017, Verso una cultura dell’incontro, Franco Angeli, Milano.
Austin, J.I. 1987, Come fare cose con le parole, Marietti, Genova.
Bateson, G. 1976 (1972), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano.
Bateson, G. 1996, Questo è un gioco, [edizione italiana a cura di Davide Zolletto] Raffaello Cortina, Milano.
Bateson, G. 2016, The position of humor in human communication, in Cybernetics [The Macy conferences 1946-1953. The complete transactions] C. Pias, Diaphanes Zurich-Berlin.
Bercelli, F., Viaro, M., Rossano F. 2004, Attività in alcuni generi di psicoterapia, in Fasulo A. e Galatolo R. [a cura di], Rivista di psicolinguistica applicata, numero speciale sull’analisi della conversazione.
Berger, P. L. 1999, Homo Ridens, Il Mulino, Bologna.
Bergson, H. 1961 (1900), Il riso. Saggio sul significato del comico, [a cura di F. Stella] Rizzoli, Milano.
Bergson, H. 1 9 8 4 , Il possibile ed il reale [in AuT AuT n. 204]
Boscolo, L., Bertrando, P. 1996, Terapia sistemica individuale, Raffaello Cortina, Milano.
Cerritelli, R. 2013, La terapia dell‘umorismo. Metodi e pratiche per il benessere personale e relazionale, Carocci, Roma.
Deridda, J. 1992, L’archeologia del frivolo, Edizioni Dedalo, Bari.
Dennett, D. C. 1991, Brainstorms, Adelphi, Milano.
Devereux, G. 2013 (1985), Etnopsicoanalisi complementarista, [a cura di A. Ancora.] Franco Angeli, Milano.
Dugas, L. 1902, Psychologie du rire, Alcan, Paris.
Fasulo A., Galatolo R. [a cura di], 2004, Rivista di psicolinguistica applicata, numero speciale sull’analisi della conversazione.
Floris, S. 2003, L’ironia ovvero la filosofia del buonumore, Marcovalerio editore, Torino.
Forabosco, G. 1980, La logica dello humor, in “Le Scienze” n. 265.
Forabosco, G. 1992, Cognitive aspects of the humor process: the concept of incongruity, in International Journal of Humor Research, 5,(1): 45-68.
Formiggini, F. 1989, Filosofia del ridere, Clueb, Bologna.
Freud, S. 1976 (1905), Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, in Opere, vol.5. Bollati Boringhieri, Torino.
Goldstein, J. H., McGhee P. E. 1976, La psicologia dell’humor, FrancoAngeli, Milano.
Haley, J. 1976, Terapie non comuni, Astrolabio, Roma.
Hoffmann, L. 1988, Like a friendly editor: an interview with Lynn Hoffman, Networker Journal of strategy and systemic therapies, vol. 7 n. 2 (1988).
Kant, I. 1970 (1790), Critica del giudizio (trad. it. di Gargiulo, A.), Laterza, Roma-Bari.
Martin, J. 2020, Anche Dio ride, San Paolo, Cinisello Balsamo.
McGhee, P. E. 1979, Humor, its origin and development, Freeman, San Francisco.
Mizzau, M. 1984, L’ironia, Feltrinelli, Milano.
Morreall, J. 2011, Filosofia dell’umorismo, Sironi Editore, Milano.
Norton, H. 1983, La mia voce ti accompagnerà. I racconti didattici di Milton Erickson, Astrolabio, Roma.
Pirandello, L. 1986 (1908), L’umorismo, Garzanti, Milano.
Pizzini, F. [a cura di] 1980, Asimmetria comunicativa, FrancoAngeli, Milano.
Polosa, R. 2012, Da Freud a Pirandello (passando per Berson). Lo spirito e la comicità, Libellula editore, Tricase (Le).
Popp, V. J. 1988, Comicità e riso, Einaudi, Torino.
Scarinci, A. [a cura di] 2018, Umorismo e psicoterapia Alpes, Roma.
Selvini Palazzoli, M. 1984, Recensione di Aestetics of change di B.P. Keeney, Family Process 23.
Searles, H. F. 1974, Scritti sulla schizofrenia, Bollati Borlinghieri, Torino.
Ugazio, V. 1985, Oltre la scatola nera, in Terapia familiare n. 19.
Von Foerster, H. 1989, Costruire una realtà [in Watzlawick, P.]
Watzlawick, P. 1980, Il linguaggio del cambiamento,.Feltrinelli, Milano.
Watzlawick, P. [a cura di], La realtà inventata, [Edizione italiana a cura di Ancora, A., Fischetti, A.] 1988, Feltrinelli, Milano.
Whitaker, C. 1984, Il gioco e l’assurdo, Casa Editrice Astrolabio, Ubaldini, Roma.
______________________________________________________________
Alfredo Ancora, psichiatra e psicoterapeuta, ha insegnato Psichiatria Transculturale presso le Università di Trieste e Siena. Ha coordinato L’Unità Transculturale del Dipartimento di Salute Mentale di Roma B (III A.T). È membro dell’International Society for Academic Research on Shamanism (ISARS) e coordinateur scientifique de l’Université Populaire “Ernesto De Martino-Diego Carpitella” di Parigi.
______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM
URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/umorismo-e-psicoterapia-ne-possiamo-parlare/
Click here to print.







