Renzia d’Incà – nata a Feltre (Belluno) vive a Pisa da tempo – è voce sicura e forte di poesia. Il suo lavoro s’impone per l’ispirazione continua su temi rilevanti, che sono peculiari e costanti da anni, e hanno maturato forme espressive e retoriche sempre più asciutte, sorvegliate, che inquietano, sorprendono, intrigano. Il suo lavoro intellettuale nasce fin dagli anni novanta da un interesse per il nesso fra teatro e disagio esistenziale e umano: è stata fra i primi ad interessarsi del teatro di Armando Punzo coi detenuti di massima sicurezza al Maschio di Volterra. Poi è approdata al nesso teatro-disagio mentale, lavorando anche col gruppo Abele e don Ciotti. La sua sensibilità pronta le consente di percepire gli eventi sociali ed artistici più originali. In una sua lettera tre anni fa mi ha scritto: « ieri sera ho visto uno spettacolo teatrale molto intenso della Compagnia di Ravenna Teatro delle Albe che da qualche anno lavora a Mazara del Vallo (dove credo abbia anche un laboratorio coi ragazzi tunisini).Un monologo davvero impressionante di un dittatore sproloquiante (Gheddafi?) rispetto ai migranti. C’erano poi due fratelli che si chiamano Mancuso che hanno suonato e cantato pezzi di una straordinaria melanconia credo siculo araba».
Il suo ultimo libro di versi Bambina con draghi (prefazione di Paolo Ruffilli, Castelfranco Veneto LCE 2014), sta ricevendo l’attenzione di non pochi critici. Avendo personalmente partecipato a recenti presentazioni di questa opera, mi occorre di notare come ci siano tre possibili distinti tipi di approcci o punti di vista/lettura che alla fine risultano complementari: uno riguarda la tematica ‘femminile’, l’orgoglio e la fierezza di una donna che esplora anche con ironia la spesso drammatica condizione psicologica e umana del mondo-donna di oggi anche nella nostra società. L’altro approccio è una inesausta indagine sulla psiche, nella infinita gamma delle situazioni, condizioni, trappole, che soprattutto la famiglia d’origine (col dualismo fratello maggiore/padre) e la vita di coppia possono presentare: si deve osservare come pochi testi come i suoi scandaglino la dimensione psicanalitica del vissuto contemporaneo femminile con tanta sorprendente profondità, tante suggestioni di apprezzabile portata euristica. Il titolo di questo volume col dualismo fra bambina e draghi suggerisce o perfino rende ineludibile – proprio queste due linee di lettura, il femminile della bambina e i draghi, che – è stato detto – possono essere il fratello, il padre, il marito, l’innamorato, col loro impatto sulla psiche e sul vissuto esistenziale.
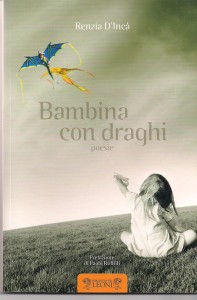 A me interesserebbe tuttavia delineare un terzo approccio, più formale e stilistico, perché illumina ogni meandro di queste tematiche profonde e complesse (talora perfino poco perspicue data la profondità soggettiva da cui misteriosamente scattano fuori): non è questione di estetismi, di disquisizioni formali. Il fatto è che il mondo vulcanico che la d’Incà lascia affiorare in linee di lava ustionanti e a volte perfino sconvolgenti non avrebbe quasi modo di resistere con efficacia sulla pagina se non grazie a risorse metriche, di rima, di figure, di consumata perizia letteraria: si raffredderebbero subito, fino forse a perdere valore, e invece la forma in quella lava si modella e diviene godibile, leggibile, quasi da mandare a memoria, tanto icastica e capace di incidersi nell’orecchio musicale del lettore. L’autrice scrisse anni fa, per esemplificare «Sei un fenomeno, un’eccezione / di solito m’annoio ma con te / fuochi d’artificio, emozione»: sembra che parli d’amore, o di altro, ma in realtà parla al tempo stesso, o preferibilmente, di poesia. E infatti «eccomi a te parola che di te / si fa carne urlo erratico / illusione poi slancio emozione». Forte è la tematica (e così facciamo un esempio della seconda possibilità di approccio di lettura, quella psicanalitica) della identità precaria, della difficoltà di definirsi (di percepirsi?): «non so chi io sia adesso / se ospite sorella o figlia / donna amante Sibilla».
A me interesserebbe tuttavia delineare un terzo approccio, più formale e stilistico, perché illumina ogni meandro di queste tematiche profonde e complesse (talora perfino poco perspicue data la profondità soggettiva da cui misteriosamente scattano fuori): non è questione di estetismi, di disquisizioni formali. Il fatto è che il mondo vulcanico che la d’Incà lascia affiorare in linee di lava ustionanti e a volte perfino sconvolgenti non avrebbe quasi modo di resistere con efficacia sulla pagina se non grazie a risorse metriche, di rima, di figure, di consumata perizia letteraria: si raffredderebbero subito, fino forse a perdere valore, e invece la forma in quella lava si modella e diviene godibile, leggibile, quasi da mandare a memoria, tanto icastica e capace di incidersi nell’orecchio musicale del lettore. L’autrice scrisse anni fa, per esemplificare «Sei un fenomeno, un’eccezione / di solito m’annoio ma con te / fuochi d’artificio, emozione»: sembra che parli d’amore, o di altro, ma in realtà parla al tempo stesso, o preferibilmente, di poesia. E infatti «eccomi a te parola che di te / si fa carne urlo erratico / illusione poi slancio emozione». Forte è la tematica (e così facciamo un esempio della seconda possibilità di approccio di lettura, quella psicanalitica) della identità precaria, della difficoltà di definirsi (di percepirsi?): «non so chi io sia adesso / se ospite sorella o figlia / donna amante Sibilla».
Nelle prime opere L’altro sguardo (1998) o Camera ottica (2001) si ritrovavano echi delle letture giovanili, perfino Quasimodo o gli ermetici, compresa Saffo o magari Garcia Lorca («ho un canto nuovo stanotte / mi abbaiano le carni»): i versi erano più lunghi nel senso musicale tradizionale (un flusso meno franto e spezzato, come invece oggi): «Ho attraversato le ripide pietraie / dei monti pisani fra fiori viola del carciofo / ti ho sorpresa distesa nel canneto / fra aghi di spine e petali di rose /erotica arsura mi prese di te / caddi prigioniero di un incanto». La sua metrica poi si è evoluta verso una sorta di terzine, una sua peculiare modalità divenuta ormai costante: facilitano la chiusa fulminea, l’eccezionale battuta, la frecciata, o il breve lamento trattenuto senza fronzoli, senza strascichi: sorta di Haiku non della natura ma della psiche.
E così nel Basilisco (2006) che già nel titolo anticipava questi recenti ‘draghi’ del 2014, la prima terzina di apertura della prima pagina era: «ho incontrato il tuo occhio / sulla soglia e sono morta / morta di paura, morta di voglia». In quel libro si trovava sviluppato il bel tema – che può ricordare i danteschi Paola e Francesca – della donna-libro: «non sgualcirmi aprimi / teneramente leggimi», ma poi la tematica non sfugge all’erotismo più diretto. «c’è una polpa generosa / dentro lo spinoso guscio / mangiami a morsi, saziami». C’è chi ha voluto sostenere nella storia della critica, con slancio utopistico e umanistico, che la poesia (più in generale ogni tipo d’arte) ci migliora. Sarà poi vero? Di consolazioni abbiamo tutti sempre bisogno, ma non in questa direzione mi pare si muova Renzia: semmai apre le serrande di un’acqua non impetuosa ma dilagante, e poi le richiude con la forma letteraria più esatta tenendo fuori la disperazione, esorcizzando il diluvio. Anche per i temi più dolorosi, più brucianti, come quello ossessivo paterno, ritornante per presenze e assenze: «padre per un’ora / padre a rate / padre a puntate / padre demonio / padre proibito / padre tradito», dove pure si esemplifica l’elemento screziato della rima, come lettura dodecafonica della vita.
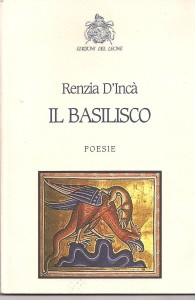 Fra i maestri che sembrano ormai più attuali per l’autrice, potrebbe esserci Caproni: questi può spiegare, ad esempio, quel suo rifarsi non alla linea dotta della poesia italiana, ma al candore (che è di Caproni) dei primitivi del nostro medioevo, quello della magia ancestrale della parola vergine da ogni adattamento letterario. E poi con l’ultimo Caproni si spella quasi la singola parola viva, se ne sezionano i piani fonici e semantici in una recondita filosofia, mettendoli in parallelo, contrapponendoli, richiamandoli: si legge ne La poesia: «forse è suono denso di suono/ ch’aggroviglia ci lacera e scuote / parola suonata dal significante / parola errante narrante / impresso reticolo di segni / fucina di eventi arcani / impalpabili eccedenti / indecodificabili reminiscenti». Spesso si toccano temi urticanti di sangue e di carne, bollenti, insondabili, come quello della madre: «preparo da mangiare alla mamma / che mi ha dato da mangiare / preparo il thè delle sei / al cappellaio matto / alla lepre marzolina che non può aspettare».
Fra i maestri che sembrano ormai più attuali per l’autrice, potrebbe esserci Caproni: questi può spiegare, ad esempio, quel suo rifarsi non alla linea dotta della poesia italiana, ma al candore (che è di Caproni) dei primitivi del nostro medioevo, quello della magia ancestrale della parola vergine da ogni adattamento letterario. E poi con l’ultimo Caproni si spella quasi la singola parola viva, se ne sezionano i piani fonici e semantici in una recondita filosofia, mettendoli in parallelo, contrapponendoli, richiamandoli: si legge ne La poesia: «forse è suono denso di suono/ ch’aggroviglia ci lacera e scuote / parola suonata dal significante / parola errante narrante / impresso reticolo di segni / fucina di eventi arcani / impalpabili eccedenti / indecodificabili reminiscenti». Spesso si toccano temi urticanti di sangue e di carne, bollenti, insondabili, come quello della madre: «preparo da mangiare alla mamma / che mi ha dato da mangiare / preparo il thè delle sei / al cappellaio matto / alla lepre marzolina che non può aspettare».
Non posso parlare della poesia di questa scrittrice (forse di nessun poeta o artista?) in forma diffusa perché non è diffusa la sua arte, ma sono schegge che partono, ritornano, non so se più acuminate all’andata o al ritorno. Spezzoni, in una circolarità che non ritrova mai lo stesso inizio-appiglio, che si perde e in questo disorientamento diviene di frequente ossessiva. Niente lirica dunque (per carità: ci si potrebbe aspettare il contrario?) ma il superamento di ogni canto abituale della tradizione, in una investigazione spesso straziata; e se il significante ci appare uno strumento docile – adatto a esprimere qualsiasi cosa l’autrice intenda – non è per slancio, non per ideologia o fede nel discorso, né fiducia nella parola rievocativa, semmai confidenza con la parola pesante, concreta, carica come un’arma ben oliata.
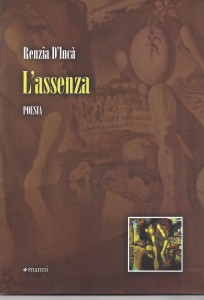 Nell’Assenza (uscito nella bella collana di Manni a Lecce, 2010) si avverte forse una maggiore leggerezza nelle consuete tematiche. Già aiuta l’ironia che viene dalla lettura di Alice e delle sue meraviglie e dei suoi imprevisti calembour, la lingua e i concetti vengono indagati con (apparente?) divertimento crescente e sorpresa continua. Da un lato tacciono sensibilmente gli accenti dolorosi e perfino drammatici, si alleggeriscono quelli erotici di conflitto, di tensione e il tono risuona più assorto e spesso stupito, come contemplativo, direi dunque mistico e non più ascetico. Forse lo si deve anche dalla percezione di un maggior distacco e controllo, se non indipendenza, dall’Altro: «ehi cocchino è a te che parlo / e non alla mia memoria alla mia desistenza / ehi, mi senti? / fin troppo chiara mi è la filigrana / della tua mesta esistenza». Un inizio di vittoria sull’altro, che è rassicurante, un augurio forse. La poesia dell’autrice conferma a ogni pagina la straordinaria (sua, di tutti) difficoltà di orientarsi nell’esistenza, ma anche la grande possibile piacevolezza che ci è data di immergersi, di perdersi. I giochi della mente si seguono a volte con sbalordimento, ma con godimento estetico, di un pensiero che si sente giocato, preso in una piccola trappola di significanti inattesi e che paiono rivelare chissà quali significati celati e inconsci: una esplorazione incessante mossa dal piacere/dolore di ascoltarsi e scrutarsi, in bilico sulla corda tesa dell’equilibrista sul baratro. Non dico del funambolo che fin troppo assomiglia all’abile incantatore, di chi sa raggirare il lettore babbeo, dico proprio dell’equilibrista che ti fa palpitare mentre avanza nell’impossibile percorso. Se poi fra i tanti c’è un protagonista-presenza esplicito da citare, questo è il gatto: per il quale si recuperano moduli compositivi di cantilene, di litanie, di laudi, di lamento, per il suo coraggio, la sua libertà e indipendenza.
Nell’Assenza (uscito nella bella collana di Manni a Lecce, 2010) si avverte forse una maggiore leggerezza nelle consuete tematiche. Già aiuta l’ironia che viene dalla lettura di Alice e delle sue meraviglie e dei suoi imprevisti calembour, la lingua e i concetti vengono indagati con (apparente?) divertimento crescente e sorpresa continua. Da un lato tacciono sensibilmente gli accenti dolorosi e perfino drammatici, si alleggeriscono quelli erotici di conflitto, di tensione e il tono risuona più assorto e spesso stupito, come contemplativo, direi dunque mistico e non più ascetico. Forse lo si deve anche dalla percezione di un maggior distacco e controllo, se non indipendenza, dall’Altro: «ehi cocchino è a te che parlo / e non alla mia memoria alla mia desistenza / ehi, mi senti? / fin troppo chiara mi è la filigrana / della tua mesta esistenza». Un inizio di vittoria sull’altro, che è rassicurante, un augurio forse. La poesia dell’autrice conferma a ogni pagina la straordinaria (sua, di tutti) difficoltà di orientarsi nell’esistenza, ma anche la grande possibile piacevolezza che ci è data di immergersi, di perdersi. I giochi della mente si seguono a volte con sbalordimento, ma con godimento estetico, di un pensiero che si sente giocato, preso in una piccola trappola di significanti inattesi e che paiono rivelare chissà quali significati celati e inconsci: una esplorazione incessante mossa dal piacere/dolore di ascoltarsi e scrutarsi, in bilico sulla corda tesa dell’equilibrista sul baratro. Non dico del funambolo che fin troppo assomiglia all’abile incantatore, di chi sa raggirare il lettore babbeo, dico proprio dell’equilibrista che ti fa palpitare mentre avanza nell’impossibile percorso. Se poi fra i tanti c’è un protagonista-presenza esplicito da citare, questo è il gatto: per il quale si recuperano moduli compositivi di cantilene, di litanie, di laudi, di lamento, per il suo coraggio, la sua libertà e indipendenza.
In genere non c’è quasi mai una poesia in sé conclusa che si possa ritagliare, a sé bastante, non dico davvero compiuta (ché questo è costante fra gli artisti moderni) ma in sé contornata: invece è un flusso, un eterno rinvio, di echi di toni incessanti, inquietanti, mai stanchi, nemmeno affannati. Con gli anni d’Incà sempre meno si racconta, sempre meno si narra o fa capire i termini della sua vicenda, eppure non ha cambiato o tradito i suoi temi. Lascia piuttosto intravedere un vissuto, benché simbolico, benché mediato con la forza dell’invenzione formale, delle rime che uniscono e disgiungono, delle strofe, delle metafore. Di Bambina con draghi, la più recente raccolta, il suo prefatore Paolo Ruffilli ha detto che si incontra il riemerso del profondo, si apre il pozzo oscuro e ritornano i draghi, i fantasmi delle esperienze di vita più celate. Certo, è così, e al tempo stesso mi è assai difficile mettere in sequenza narrativa il romanzo di se stessa che la scrittrice non cessa di tentare. Non credo possa riuscire – anche se qualche buon risultato lo si può certo ottenere: e penso alla acuta analisi che di temi, specie quelli psicanalitici e ideologico-femminili fa da tempo (anche) su Renzia una sua attenta lettrice, studiosa dell’Università di Pisa, Concetta D’Angeli – il tentativo di mettere sull’asse sintagmatico il filo di continuo interrotto e sempre ripreso dell’affabulazione, in tutti i suoi obbligati ‘a capo’. Che in questi libri non è solo artificio tradizionale della poesia. Si tratta di un universo diaristico immaginario, visionario, non si sa chi e con chi parli, varie figure si sovrappongono e si scambiano di posto. Tentazione auto-analitica, ha detto una volta Luigi Blasucci maestro di intere generazioni di letterati a Pisa. Perfetto, ben detto, tentazione: perché l’arte è solo in qualche modalità o qualche misura da valutare come auto-analisi. E quella di Renzia, è certo dedita a un vertiginoso scandaglio del profondo: ma si tratta appunto di un dono e di un lavoro letterario, mai di un condizionamento psichico, comunque da considerare sotto questi profili irrilevante. Non dico che non ci siano opere artistiche che possano rientrare fra le nevrosi creative, penso che su un altro piano possiamo godere di questo lavoro di scrittura, dei suoi eventuali progressi, del consolidarsi di un’arte difficile ma che raggiunge e premia i più raffinati giochi dell’intelligenza. Lascio la parola all’autrice, questo ultimo libro infatti si apre così: «mi hai chiamato per dirmi / che cosa sta succedendo?/niente, stavo solo morendo». Poesia e autoanalisi in una sola fulminea sintesi, ed è solo l’incipit di un libro riuscito e intenso.
Dialoghi Mediterranei, n.7, maggio 2014








