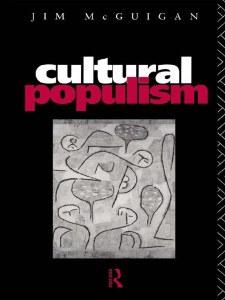In nome del popolo
La tradizione italiana di studi antropologici si è caratterizzata per molti decenni, dal dopoguerra alla fine del Novecento, per una peculiare attenzione al tema della cultura popolare. Soprattutto per l’influenza di Gramsci e di De Martino, si è consolidato un campo di ricerca focalizzato sulle differenze culturali che demarcano le classi sociali subalterne da quelle egemoniche. È un campo che ha scelto di denominarsi “demologia”: una etichetta volta soprattutto a prendere le distanze dalla vecchia disciplina del folklore, spesso attardata in approcci puramente filologici e classificatori e incline a una visione “pittoresca” (per dirla con Gramsci) delle tradizioni del popolo, specie di quello contadino. La demologia era piuttosto interessata ad affermare la centralità della questione culturale per una teoria sociale in grado di analizzare le differenze di classe – e magari di contribuire all’emancipazione dei gruppi subalterni. Oggi questo ambito di studi è invece in piena crisi: anche se ha lasciato traccia nella lettera “D” del settore scientifico disciplinare M-DEA/01 (discipline demoetnoantropologiche).
Ho analizzato in un recente volume [1] le ragioni dell’ascesa prima, e del declino poi, della demologia italiana. In sintesi, si potrebbe dire che l’idea di una “cultura popolare” separata e autonoma, descrivibile più o meno allo stesso modo in cui gli antropologi, poniamo, rappresentavano le culture dei nativi dell’Amazzonia o delle isole melanesiane, ha inizialmente affascinato sia gli studiosi sia gli appassionati di folk; ma è poi venuta meno a fronte di due processi storici. Da un lato la diffusione della cultura di massa, che sembra cancellare le differenze e omologare ogni segmento sociale a estetiche, valori e contenuti prodotti industrialmente e distribuiti commercialmente. Dall’altro, i mutamenti demografici e sociologici, che hanno reso sempre più difficile individuare in termini oggettivi un “popolo” nettamente distinto dalle classi dominanti, producendo invece un complesso continuum di segmenti di classe media se non, come sostengono alcuni, una indistinta “classe di massa”. Ho anche sostenuto, tuttavia, che la teoria gramsciana che poggia sulle nozioni di egemonico e subalterno non può fermarsi di fronte a queste trasformazioni nella cultura sociale e nelle modalità di comunicazione.
 Il problema della cultura popolare si traduce dunque nel tentativo di capire dove si pone nel contesto storico attuale, nel quadro delle rinnovate forme e tecniche della circolazione culturale, la cesura tra il piano egemonico e quello subalterno. Attorno a questo problema si gioca una possibile ripresa della tradizione demologica. Nelle brevi riflessioni che seguono, mi chiederò se questa ripresa non possa trarre linfa dal problema del populismo – cioè dal dibattito suscitato dai moderni movimenti politici populisti e dal successo che hanno raggiunto nell’ultimo decennio.
Il problema della cultura popolare si traduce dunque nel tentativo di capire dove si pone nel contesto storico attuale, nel quadro delle rinnovate forme e tecniche della circolazione culturale, la cesura tra il piano egemonico e quello subalterno. Attorno a questo problema si gioca una possibile ripresa della tradizione demologica. Nelle brevi riflessioni che seguono, mi chiederò se questa ripresa non possa trarre linfa dal problema del populismo – cioè dal dibattito suscitato dai moderni movimenti politici populisti e dal successo che hanno raggiunto nell’ultimo decennio.
La sterminata recente letteratura sul populismo [2] mette in luce prima di tutto il carattere multiforme del fenomeno, che sfugge a una definizione unitaria. Era quanto osservava già Isaiah Berlin in un convegno che sta alla base dei moderni studi sul populismo, alla fine degli anni ’60 [3]. Berlin parlava in quell’occasione di “complesso di Cenerentola”, per indicare la convinzione che esista un’essenza del populismo, e che da qualche parte debba esistere un “piede” in grado di calzare alla perfezione la “scarpetta” populista. Non era, e non è, così. E dire che il grande pensatore liberale aveva in mente solo una gamma limitata di populismi: quello russo ottocentesco, il People’s Party statunitense, e poi il peronismo e analoghi movimenti sudamericani. Oggi la gamma di versioni del populismo è molto più ampia: includendo fra l’altro i nazionalismi dell’Europa dell’Est nati dopo il crollo dell’Unione Sovietica, i “telepopulismi” dei partiti-azienda di cui Silvio Berlusconi è stato precursore, i più recenti sovranismi identitari, ma anche movimenti di sinistra come Podemos o Occupy Wall Street.
Se poi si volesse allargare la nozione di populismo a intendere un più generale stile di comunicazione politica che si afferma trasversalmente (al di là cioè di specifici e contrapposti obiettivi programmatici), ben pochi fra i partiti e i movimenti esistenti potrebbero sottrarsi a una simile diagnosi. E questo è in effetti l’esito di alcune analisi storiche o politologiche. Per l’Italia, ad esempio, un autorevole storico come Nicola Tranfaglia vede nel populismo un filo rosso ben preciso, un “carattere originale” della storia italiana, che si genera dal combinato effetto della debolezza dello Stato postunitario e dell’insolubilità della questione meridionale, trovando poi espressione nel fascismo, poi nel qualunquismo, nel leghismo, nel berlusconismo e infine nel “grillismo” e nel “renzismo” [4]. Un punto di vista interessante e fondato, certo; ma che rischia di rendere la categoria troppo ampia per avere una sua specifica utilità analitica.
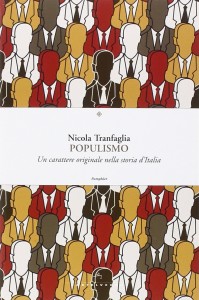 Tuttavia, già Berlin ammetteva che se non un’essenza unitaria vi sono almeno alcune somiglianze di famiglia che percorrono i populismi [5]. Su alcune di queste convergono anche molte delle analisi successive. Ad esempio, il richiamo a un senso di comunità perduta, a una autenticità esistenziale e relazionale minacciata dalla modernizzazione o da un qualche nemico esterno o interno. Ma soprattutto, il tratto caratterizzante ogni forma di populismo è la contrapposizione tra un popolo e una qualche élite.
Tuttavia, già Berlin ammetteva che se non un’essenza unitaria vi sono almeno alcune somiglianze di famiglia che percorrono i populismi [5]. Su alcune di queste convergono anche molte delle analisi successive. Ad esempio, il richiamo a un senso di comunità perduta, a una autenticità esistenziale e relazionale minacciata dalla modernizzazione o da un qualche nemico esterno o interno. Ma soprattutto, il tratto caratterizzante ogni forma di populismo è la contrapposizione tra un popolo e una qualche élite.
Il concetto di popolo può esser costruito in molti modi: su base etnica nei movimenti nazionalisti, ma più spesso in riferimento a una dicotomia alto/basso (per reddito, condizione sociale, cultura: gli strati più poveri, “quelli che lavorano”, gli esclusi dal potere). Il popolo così inteso è oppresso, abbandonato, tradito da una élite fatta di politici, banchieri, intellettuali arroccati in difesa dei propri privilegi, corrotti, spesso rappresentati come coinvolti in complotti o cospirazioni ai danni delle masse popolari. L’élite va in buona parte a comporre quei corpi intermedi dello stato che nelle forme di democrazia rappresentativa sono il principale tessuto connettivo tra il potere politico e la base sociale. Da qui l’altro elemento caratteristico dei populismi, cioè l’avversione alla mediazione e l’idea di un consenso che si forma attraverso un rapporto diretto tra i leader e il “popolo”, prescindendo da quei gruppi costruttori di egemonia (come gli intellettuali, nella classica analisi gramsciana, ma anche i corpi dello Stato) che sono visti come conniventi con l’élite.
 Popolo, élites e la questione delle classi sociali
Popolo, élites e la questione delle classi sociali
Dunque, comprendere il populismo significa entrare nella questione dei rapporti – reali e immaginati – tra gruppi sociali “alti” e “bassi”, che percepiscono ed elaborano una propria cultura specchiandosi gli uni negli altri. Ma come definire questi gruppi? Vi sono indicatori oggettivi sulla cui base stabilire chi fa parte del popolo e chi dell’élite? Nella tradizione marxista e gramsciana, le classi subalterne sono ovviamente quelle che giocano un ruolo “strumentale” in un dato contesto storico: cioè quei gruppi (quantitativamente maggioritari – le “masse” popolari) che sono utilizzati e sfruttati da altri gruppi (minoritari), i quali guadagnano a loro spese potere e ricchezza. Dunque schiavi, servi della gleba, proletariato. È la posizione all’interno del modo di produzione a definire la subalternità. Da questa discendono le condizioni di povertà e mancanza di istruzione formale. I proletari hanno da perdere solo le loro catene. Un subalterno benestante o un subalterno intellettuale sono in pratica degli ossimori: perché nel momento in cui una persona diventa benestante o intellettuale, si eleva al di sopra della condizione subalterna.
Certo, nel corso del Novecento le cose si fanno più complesse: cresce il ceto medio, le classi si frammentano in segmenti distintivi; e soprattutto il capitale economico e quello culturale non vanno più di pari passo (come sembrava invece presupporre la teoria demologica). Come scriveva Sylos Labini riflettendo, negli anni ’80, sul compimento di un processo di lungo periodo, la crescente mobilità e differenziazione sociale priva progressivamente di contenuto il concetto di “barriere di classe”:
«si può sostenere che la mobilità verticale, nell’ambito di ciascuna classe e fra una classe e l’altra, è andata crescendo negli ultimi cento anni, nonostante le interruzioni e le momentanee inversioni di tendenza: un tale fenomeno ha progressivamente attenuato le differenze propriamente economiche: oramai le differenze fra le classi sociali dipendono più da elementi culturali che da elementi obiettivi» [6].
Possiamo anche prendere come esempio di questa nuova complessità il famoso studio di Pierre Bourdieu sulle strategie della distinzione sociale basate sul consumo [7]. Qui il capitale culturale, distinto a sua volta in ereditato e acquisito, diviene criterio di classificazione importante quanto quello economico, e almeno in parte indipendente da esso. Così da dar vita a un modello quadripartito della società, con gruppi contraddistinti da variabili combinazioni di alto e basso capitale economico, alto e basso capitale culturale. La visione di Bourdieu è inoltre complicata dal fatto che i gruppi sociali (nella Francia degli anni ’60 e ’70 da lui studiata) non si trovano in posizioni statiche, che in qualche modo rispecchierebbero la loro condizione economico-culturale: al contrario, usano attivamente le strategie del consumo e del gusto per distinguersi dagli altri gruppi. Non tanto per raggiungere o imitare i più alti, quanto per tracciare linee di separazione verso i più bassi: in questo senso vanno lette ad esempio le accuse di cattivo gusto, di volgarità, di inciviltà. Non c’è dunque una oggettiva “struttura di classe”: piuttosto, sono in atto meccanismi (oggettivi nella misura in cui si incorporano negli habitus) generativi di disuguaglianza, attorno ai quali i gruppi sociali giocano la sempre mutevole partita delle identità sociali. Anche in un quadro così complesso, comunque, Bourdieu continua a identificare empiricamente i ceti sociali attraverso il loro ruolo nel modo di produzione: parla così di classe operaia, di intellettuali, di borghesia di antica tradizione e di borghesia composta da imprenditori e commercianti che si sono arricchiti di recente e così via.
 È ancora possibile oggi questa caratterizzazione delle classi? Le teorie sulla stratificazione e la disuguaglianza sociale, e i relativi dati, non potrebbero essere più dibattuti e controversi. Certo è che i mutamenti rispetto alle condizioni che hanno dominato gran parte del Novecento sono così forti che la teoria delle classi (quella fondata sulla posizione nel modo di produzione) non sembra più adeguata a descriverli. Prendiamo l’Italia. Lo stesso ISTAT, dopo aver a lungo descritto la struttura sociale italiana sulla base di uno schema classico (elaborato dal sociologo Schizzerotto)[8], composto da sei categorie (borghesia, classe media impiegatizia, piccola borghesia urbana, piccola borghesia agricola, classe operaia urbana, classe operaia agricola), ha cambiato strategia. Dal 2017 ha adottato una classificazione molto più complessa, basata sull’incrocio di parametri diversi e non riconducibili a una medesima scala: reddito e posizione lavorativa, certo (distinguendo quest’ultima fra posti stabili e precari), ma anche istruzione, età, origine etnica, collocazione geografica (Nord/Sud, ma soprattutto città/provincia), consumi culturali, partecipazione sociale e politica. Da un lato, le famiglie italiane possono esser distinte in tre grandi fasce di reddito, basso, medio e alto, ciascuna composta da 8-9 milioni di unità. Dall’altro, si distinguono 9 categorie, così definite: famiglie a basso reddito con stranieri, famiglie a basso reddito di soli italiani, famiglie tradizionali della provincia, anziane sole e giovani disoccupati, giovani blue-collar, famiglie di operai in pensione, famiglie di impiegati, pensioni d’argento, classe dirigente. Lo stesso Istituto di Statistica nota che:
È ancora possibile oggi questa caratterizzazione delle classi? Le teorie sulla stratificazione e la disuguaglianza sociale, e i relativi dati, non potrebbero essere più dibattuti e controversi. Certo è che i mutamenti rispetto alle condizioni che hanno dominato gran parte del Novecento sono così forti che la teoria delle classi (quella fondata sulla posizione nel modo di produzione) non sembra più adeguata a descriverli. Prendiamo l’Italia. Lo stesso ISTAT, dopo aver a lungo descritto la struttura sociale italiana sulla base di uno schema classico (elaborato dal sociologo Schizzerotto)[8], composto da sei categorie (borghesia, classe media impiegatizia, piccola borghesia urbana, piccola borghesia agricola, classe operaia urbana, classe operaia agricola), ha cambiato strategia. Dal 2017 ha adottato una classificazione molto più complessa, basata sull’incrocio di parametri diversi e non riconducibili a una medesima scala: reddito e posizione lavorativa, certo (distinguendo quest’ultima fra posti stabili e precari), ma anche istruzione, età, origine etnica, collocazione geografica (Nord/Sud, ma soprattutto città/provincia), consumi culturali, partecipazione sociale e politica. Da un lato, le famiglie italiane possono esser distinte in tre grandi fasce di reddito, basso, medio e alto, ciascuna composta da 8-9 milioni di unità. Dall’altro, si distinguono 9 categorie, così definite: famiglie a basso reddito con stranieri, famiglie a basso reddito di soli italiani, famiglie tradizionali della provincia, anziane sole e giovani disoccupati, giovani blue-collar, famiglie di operai in pensione, famiglie di impiegati, pensioni d’argento, classe dirigente. Lo stesso Istituto di Statistica nota che:
«in linea con la maggiore segmentazione (in termini di profili occupazionali, di reddito e adeguatezza del titolo di studio) all’interno delle stesse classi sociali ciò che sembra essersi profondamente modificato è il senso di appartenenza a una data classe sociale e ciò è particolarmente vero per la classe media e la classe operaia. Questo ha determinato la crisi della classe media, che invece di proiettarsi verso l’ascesa sociale si manifesta sia in termini di autopercezione, sia di redditi e consumi effettivi»[9].
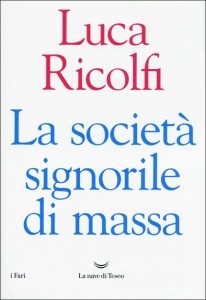 Ancora più sconcertante è il quadro che emerge dall’analisi del sociologo Luca Ricolfi, in un recente volume dal provocatorio titolo La società signorile di massa. Il ceto signorile è quello che non lavora, vivendo di un qualche tipo di rendita che consente un alto livello di consumo e di vita. Nel corso della storia, solo esigue minoranze privilegiate si sono trovate in una simile condizione – a fronte di masse di lavoratori poveri. Secondo Ricolfi, nell’Italia di oggi, il ceto signorile è invece divenuto maggioritario, come conseguenza di tre condizioni: la fine della crescita (o stagnazione economica), la radicale caduta del tasso di occupazione, il consumo opulento di massa. Ciò significa, concretamente, che la maggioranza degli italiani residenti con un’età superiore ai 15 anni non lavora – il 52,5%, esattamente – contro il 39,9 di lavoratori; un terzo segmento dei residenti è costituito da stranieri (7,9). Tra questi ultimi, uno su tre vive in condizioni di povertà assoluta; laddove la povertà assoluta fra gli italiani (lavoratori e non lavoratori, incide soltanto per il 6%). Il dato dei non lavoratori è reso ancor più vistoso dall’altissima percentuale dei NEET (not in employment, education or training), cioè di chi non lavora, non studia e non è impegnato in percorsi di formazione, che raggiungono il 30,9 % (per inciso, la percentuale più alta fra tutti i paesi europei) [10].
Ancora più sconcertante è il quadro che emerge dall’analisi del sociologo Luca Ricolfi, in un recente volume dal provocatorio titolo La società signorile di massa. Il ceto signorile è quello che non lavora, vivendo di un qualche tipo di rendita che consente un alto livello di consumo e di vita. Nel corso della storia, solo esigue minoranze privilegiate si sono trovate in una simile condizione – a fronte di masse di lavoratori poveri. Secondo Ricolfi, nell’Italia di oggi, il ceto signorile è invece divenuto maggioritario, come conseguenza di tre condizioni: la fine della crescita (o stagnazione economica), la radicale caduta del tasso di occupazione, il consumo opulento di massa. Ciò significa, concretamente, che la maggioranza degli italiani residenti con un’età superiore ai 15 anni non lavora – il 52,5%, esattamente – contro il 39,9 di lavoratori; un terzo segmento dei residenti è costituito da stranieri (7,9). Tra questi ultimi, uno su tre vive in condizioni di povertà assoluta; laddove la povertà assoluta fra gli italiani (lavoratori e non lavoratori, incide soltanto per il 6%). Il dato dei non lavoratori è reso ancor più vistoso dall’altissima percentuale dei NEET (not in employment, education or training), cioè di chi non lavora, non studia e non è impegnato in percorsi di formazione, che raggiungono il 30,9 % (per inciso, la percentuale più alta fra tutti i paesi europei) [10].
A fronte di questa situazione, resta un livello mediamente alto di reddito (che Ricolfi stima poco sotto ai 50mila euro l’anno per famiglia), e soprattutto un forte livello di risparmio, cioè di riserva di valore di cui ogni famiglia può disporre (calcolato poco sotto i 400mila euro). Riserva di valore che le famiglie italiane hanno costruito nei decenni novecenteschi di maggior sviluppo economico. In sostanza, malgrado la crisi economica, l’impoverimento relativo di alcuni settori della classe media e un’accentuazione (assai limitata, rispetto a quanto si tende a credere) delle disuguaglianze interne, la stragrande maggioranza della popolazione italiana dispone di ampia capacità di spesa, e la utilizza per mantenere un livello di consumo decisamente opulento. La società italiana è per Ridolfi opulenta nel senso che «diversi e significativi beni voluttuari, o decisamente di lusso, [sono] posseduti o fruiti da oltre la metà dei cittadini»[11]. Quali beni? Ad esempio, l’80% degli italiani ha una casa di proprietà e possiede almeno un’automobile (vi sono in realtà 1,5 auto per famiglia); il 65% si può concedere vacanze lunghe una volta all’anno, oltre a più numerose vacanze brevi.
Malgrado l’economia stagnante, l’Italia è ai primi posti in Europa e nel mondo nel possesso di smartphone, nelle spese per la cura e l’estetica del corpo, in quelle per le ripetizioni scolastiche ai figli, nel tempo dedicato al gioco e allo svago (ad esempio il tempo passato su Internet per il gioco è il triplo di quello che vi si passa per lavoro), nel consumo di sostanze illegali e così via [12]. Per contro, un settore minoritario della popolazione va a costituire quella che Ricolfi chiama una “infrastruttura paraschivistica”: occupazioni, legali o illegali, consistenti in ruoli servili o di ipersfruttamento, che interessano in buona parte i residenti stranieri. Si tratta di lavoratori stagionali, prostitute, spacciatori, persone di servizio come colf e badanti, dipendenti in nero, lavoratori della gig economy e del settore dei servizi esternalizzati: un insieme conteggiato in tre milioni e mezzo di persone, un settimo degli occupati totali [13].
Ora, in un quadro del genere, dove si colloca la subalternità? Come definire il popolo? Dovremmo pensare che solo la “infrastruttura paraschiavistica” è subalterna, in una società in cui oltre il 90% dei cittadini residenti fa parte della fascia egemonica? Oppure che la grande massa di (relativi) benestanti, che sembra principalmente preoccupata dall’incremento dei livelli di consumo, è culturalmente subalterna rispetto alla élite misteriosa e quasi invisibile che tira le fila del neoliberismo globale? O altrimenti, dove tracciare le linee di demarcazione?
Una soluzione possibile a questo complesso problema è ritenere che il popolo non esista più: che la categoria sia in sé vuota, e proprio per questo adatta ad esser strumentalizzata da ogni tipo di propaganda politica. Spesso questa è la posizione dei critici del populismo. Prendiamo il recente testo di Alessandro Dal Lago sul populismo digitale:
«Oggi, il popolo in senso stretto non esiste. Nell’auto-narrazione occidentale ha avuto una storia gloriosa…, ma con il trionfo della modernità non è diventato che un mito vuoto. Non è un oggetto sociale o politico misurabile o definibile. È una categoria del senso comune (e talvolta della filosofia giuridico-politica), un contenitore che può essere riempito di significati a seconda della specifica funzione che gli viene attribuita»[14].
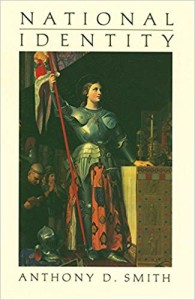 Ma il popolo è mai stato misurabile o oggettivamente definibile? Se è per questo, si può dire allora che non è mai esistito: che ogni stagione politico-culturale lo ha costruito secondo le proprie esigenze e prospettive. Ciò è vero almeno a partire da quella stagione romantica e nazionalista che lo ha “scoperto”, assumendolo inizialmente proprio nella forma culturalista del folklore. Sia Eric Hobsbawm che Anthony D. Smith hanno definito “populismo culturale” quella fase, a cavallo fra XVIII e XIX secolo, che vede emergere una valorizzazione delle tradizioni culturali dei popoli: sottolineando come essa sia stata promossa da pochi intellettuali, quasi sempre estranei a quei popoli stessi: «nella maggior parte dei casi, la scoperta della tradizione popolare e la sua trasformazione in “tradizione nazionale” di qualche popolo contadino dimenticato dalla storia, era opera di entusiastici sostenitori provenienti dalle classi dominanti o élite (straniere), come nel caso dei tedeschi per quanto riguarda i baltici e degli svedesi per quanto riguarda i finlandesi» [15].
Ma il popolo è mai stato misurabile o oggettivamente definibile? Se è per questo, si può dire allora che non è mai esistito: che ogni stagione politico-culturale lo ha costruito secondo le proprie esigenze e prospettive. Ciò è vero almeno a partire da quella stagione romantica e nazionalista che lo ha “scoperto”, assumendolo inizialmente proprio nella forma culturalista del folklore. Sia Eric Hobsbawm che Anthony D. Smith hanno definito “populismo culturale” quella fase, a cavallo fra XVIII e XIX secolo, che vede emergere una valorizzazione delle tradizioni culturali dei popoli: sottolineando come essa sia stata promossa da pochi intellettuali, quasi sempre estranei a quei popoli stessi: «nella maggior parte dei casi, la scoperta della tradizione popolare e la sua trasformazione in “tradizione nazionale” di qualche popolo contadino dimenticato dalla storia, era opera di entusiastici sostenitori provenienti dalle classi dominanti o élite (straniere), come nel caso dei tedeschi per quanto riguarda i baltici e degli svedesi per quanto riguarda i finlandesi» [15].
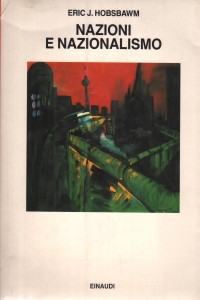 Ma se questo popolo era “costruito”, non vale forse lo stesso per quello che è stato al centro – per buona parte del Novecento – dei programmi della sinistra, sia rivoluzionaria sia riformista? Una ironica (ma non troppo) definizione del populismo è che tale concetto si riferisce al popolo nel momento in cui la sinistra non sente più di controllarlo. Ed è bene notare che l’intreccio tra populismo politico e populismo culturale si prolunga ben oltre quella fase romantica aurorale cui si riferisce Hobsbawm. Oggi, ad esempio, una caratteristica centrale dei populismi è la massiccia introduzione nella sfera politica “seria” di linguaggi e simbologie di natura decisamente pop [16]. La comunicazione politica fa largo uso ad esempio di parolacce ed espressioni dialettali; si nutre di metafore e immagini tratte dalla cultura di massa (in particolare in Italia dal calcio); si esprime all’interno di contesti, come i talk show televisivi, nei quali si mischia con lo spettacolo e con la pubblicità in modi che sarebbero risultati inimmaginabili fino a qualche decennio fa. Un tempo i leader dei partiti si legittimavano scrivendo impegnati saggi di teoria sociale; oggi lo fanno mostrandosi sui rotocalchi di gossip, impegnati a frequentare i luoghi del divertimento di massa.
Ma se questo popolo era “costruito”, non vale forse lo stesso per quello che è stato al centro – per buona parte del Novecento – dei programmi della sinistra, sia rivoluzionaria sia riformista? Una ironica (ma non troppo) definizione del populismo è che tale concetto si riferisce al popolo nel momento in cui la sinistra non sente più di controllarlo. Ed è bene notare che l’intreccio tra populismo politico e populismo culturale si prolunga ben oltre quella fase romantica aurorale cui si riferisce Hobsbawm. Oggi, ad esempio, una caratteristica centrale dei populismi è la massiccia introduzione nella sfera politica “seria” di linguaggi e simbologie di natura decisamente pop [16]. La comunicazione politica fa largo uso ad esempio di parolacce ed espressioni dialettali; si nutre di metafore e immagini tratte dalla cultura di massa (in particolare in Italia dal calcio); si esprime all’interno di contesti, come i talk show televisivi, nei quali si mischia con lo spettacolo e con la pubblicità in modi che sarebbero risultati inimmaginabili fino a qualche decennio fa. Un tempo i leader dei partiti si legittimavano scrivendo impegnati saggi di teoria sociale; oggi lo fanno mostrandosi sui rotocalchi di gossip, impegnati a frequentare i luoghi del divertimento di massa.
Il problema del populismo culturale è stato posto in modo esplicito, a partire dagli anni ‘80-’90, nel campo dei Cultural studies anglofoni. Tali studi, in particolare nel quadro della cosiddetta scuola di Birmingham, si sono caratterizzati per la presa di distanza dalle più classiche critiche alla cultura di massa: cioè da quelle teorie che, analizzando i prodotti più trash dell’industria culturale, ne denunciano il carattere alienante e la capacità di inebetire i consumatori – passivi bersagli di strategie di marketing che finirebbero per ottunderne ogni possibile senso critico. Per i cultural studies, i consumatori non sono invece mai soggetti passivi: le pratiche di consumo culturale devono essere studiate etnograficamente, per scoprire in che modo i diversi gruppi subalterni risignificano la cultura di massa, mettendo in atto a partire da essa tattiche di resistenza antiegemonica. Ecco, questo è l’atteggiamento che possiamo chiamare “populista”: prendere sul serio tutto ciò che il “popolo” fa, accettando anche i tratti culturali più banalizzanti e conservatori delle sue pratiche di consumo. Con il rischio – dicono i critici del populismo culturale – di non cogliere i macro-contesti della produzione industriale rinunciando a esercitare la critica verso palesi forme di propaganda e colonizzazione culturale [17].
 Si è detto che anche il folklorismo, fin dai suoi esordi romantici per arrivare fino alla demologia di stampo gramsciano – è in questo senso populista. Prende tratti culturali del mondo subalterno, in specie di quello contadino, e ne propone forme sofisticate di valorizzazione: mostra la presenza di una intensa vita culturale laddove in precedenza si vedeva solo ignoranza e arretratezza. Ma proprio le vicende degli studi folklorici e demologici evidenziano i rischi di ricaduta nell’approccio opposto, quello – diciamo – élitista. Infatti la demologia ha inizialmente valorizzato la “bassa” cultura del popolo in nome della storia dal basso e del progetto di emancipazione delle classi subalterne; ma ha anche finito per ingessarne i tratti (ad esempio i canti e le fiabe popolari, gli oggetti del mondo contadino, le feste tradizionali etc.) in una visione estetizzata, che ne sottolinea l’autenticità contro la natura banale e commerciale dei prodotti della cultura di massa. Quando quest’ultima si è affacciata nelle pratiche del mondo agropastorale, a partire dagli anni ’60, i demologi ne sono stati infastiditi. Negli oggetti seriali e plastificati che facevano irruzione nelle case contadine e operaie; nelle canzonette televisive che contaminavano il “vero” canto popolare; nei blue-jeans che sostituivano gli abiti tradizionali, e così via, si scorgevano gli avamposti di una colonizzazione consumistica che distruggeva le vecchie culture. Soprattutto, si scorgevamo cose “brutte”, “volgari”, “dozzinali”, che mettevamo in pericolo la bellezza, la sia pur selvaggia ricercatezza e raffinatezza degli autentici oggetti artigianali e contadini.
Si è detto che anche il folklorismo, fin dai suoi esordi romantici per arrivare fino alla demologia di stampo gramsciano – è in questo senso populista. Prende tratti culturali del mondo subalterno, in specie di quello contadino, e ne propone forme sofisticate di valorizzazione: mostra la presenza di una intensa vita culturale laddove in precedenza si vedeva solo ignoranza e arretratezza. Ma proprio le vicende degli studi folklorici e demologici evidenziano i rischi di ricaduta nell’approccio opposto, quello – diciamo – élitista. Infatti la demologia ha inizialmente valorizzato la “bassa” cultura del popolo in nome della storia dal basso e del progetto di emancipazione delle classi subalterne; ma ha anche finito per ingessarne i tratti (ad esempio i canti e le fiabe popolari, gli oggetti del mondo contadino, le feste tradizionali etc.) in una visione estetizzata, che ne sottolinea l’autenticità contro la natura banale e commerciale dei prodotti della cultura di massa. Quando quest’ultima si è affacciata nelle pratiche del mondo agropastorale, a partire dagli anni ’60, i demologi ne sono stati infastiditi. Negli oggetti seriali e plastificati che facevano irruzione nelle case contadine e operaie; nelle canzonette televisive che contaminavano il “vero” canto popolare; nei blue-jeans che sostituivano gli abiti tradizionali, e così via, si scorgevano gli avamposti di una colonizzazione consumistica che distruggeva le vecchie culture. Soprattutto, si scorgevamo cose “brutte”, “volgari”, “dozzinali”, che mettevamo in pericolo la bellezza, la sia pur selvaggia ricercatezza e raffinatezza degli autentici oggetti artigianali e contadini.
Da qui il disgusto verso le cose che in quegli anni ’60 e ’70 si chiamavano piccolo-borghesi, ma che erano in realtà prettamente popolari; tipiche cioè di ceti sociali subalterni impegnati in una ascesa sociale e in un progetto di cruciale miglioramento del livello di vita. L’ammirazione dei demologi va ai sempre più rari contadini che scelgono di restare a vivere nelle splendide case coloniche in pietra, ma prive di elettricità, riscaldamento e acqua corrente, in un loro rapporto diretto con la natura che implica il rifiuto delle tecnologie moderne, che non conoscono la televisione ma si divertono con i preziosi e antichi racconti tramandati oralmente, nelle veglie riscaldate dal tepore delle vacche. Tutto il loro disprezzo va agli inurbati nelle case popolari di periferia, che lavorano in fabbrica e hanno mobili e suppellettili di plastica, il televisore che ha sostituito il focolare e il supermercato che prende il posto dell’orto. Ma quello è il popolo, quelle sono le classi subalterne in quella precisa fase storica. Quindi, il progetto populista della demologia si volge in una nuova chiusura élitista, con lo scopo di distinguere non i più classici gruppi dirigenti, ma quei ceti intellettuali, con basso capitale economico ma alto capitale culturale, che si riconoscono nell’estetica folk.
Un simile paradosso si ripresenta sul piano politico. Il populismo è in effetti sintomo dello scollamento tra quella sinistra politica che ha preteso da sempre di rappresentarlo, riuscendo in alcune fasi storiche ad esercitare un’ampia egemonia sulle masse popolari (parallelamente all’egemonia esercitata dalla Chiesa: ed è significativo che oggi sinistra e Chiesa, una volta fieramente avverse, si trovino alleate nella lotta al “populismo”). Quella attuale è una fase di “crisi dell’egemonia”, cioè di rottura del progetto classico della sinistra – quello di tenere insieme una serie di valori progressisti e la rappresentatività delle classi subalterne in vista della loro emancipazione. Progetto parallelo a quello della demologia, azzarderei, la quale intendeva “parlare per il popolo” valorizzando al tempo stesso valori sociali e forme estetiche nelle quali gli intellettuali “folk” si riconoscevano. Ma il popolo reale si è via via allontanato dal popolo ideale che i rispettivi progetti presupponevano. Forse perché in una certa misura si è effettivamente emancipato, godendo di una qualità della vita che prima poteva soltanto agognare – ma che, in quanto puramente consumistica, suscita il disprezzo di quegli intellettuali che a loro volta appaiono come una élite priva di ogni organicità – nel senso gramsciano del termine.
L’aspetto forse più rilevante che si è spezzato nel vecchio progetto egemonico è l’alleanza fra il “proletariato” occidentale e i popoli di quello che si chiamava un tempo Terzo e Quarto mondo. La globalizzazione, contrariamente a certe convinzioni comuni, ha portato a un maggior equilibrio nella distribuzione delle risorse mondiali rispetto al passato: facendo uscire miliardi di persone, negli ultimi decenni, dallo stato di “povertà assoluta” e da condizioni di vita caratterizzate da altissima mortalità infantile, assenza di sicurezza alimentare, di servizi sanitari ed educativi e così via. Ma questo aspetto della globalizzazione, insieme agli accentuati movimenti migratori, si ripercuote sulle condizioni di esistenza dei ceti lavoratori (e di quelli “signorili”) all’interno della società occidentale. In questa situazione, di fronte all’accentuata insicurezza, alla prospettiva di perdita di diritti e privilegi, si può ricostituire un’idea di popolo come insieme di “quelli che sono rimasti fuori” (secondo l’espressione di Berlin). In questo caso, rimasti fuori dalla globalizzazione, dalle tendenze cosmopolite che, sul piano economico come su quello culturale rappresentano sempre più la linea decisiva di demarcazione fra ceti sociali. Questo popolo autopercepito si trova di conseguenza anche in tensione con le masse di migranti che raggiungono i Paesi occidentali – e non per motivi di razzismo, categoria spesso abusata, a mio parere, o evocata a sproposito con accuse che non fanno altro che accentuare il divario tra il regime morale culturalmente dominante e quello che a torto o a ragione si rappresenta come subalterno.
 L’antropologo Jonathan Friedman, in un suo recente e provocatorio libro dedicato al tema del “politicamente corretto”, ha sostenuto che una nuova relazione politica, quella tra il centro e le sue periferie, ha soppiantato la vecchia opposizione fra destra e sinistra [18]. Il ceto politico “globale” e “multiculturale” si separa sempre più dai governati. Il “politicamente corretto”, a suo parere, è l’ideologia fondamentale di un ceto politico privo ormai di ogni rapporto reale col “popolo”: ne consegue, anche se non è questo il tema del suo libro, la possibilità di una costituzione anti-politica e “sovranista” del popolo, che alimenta costantemente i movimenti populisti. Può così accadere (con la cosiddetta pop-politica, come abbiamo visto) che il populismo culturale non solo possa esser rivendicato in contrapposizione alla noiosa serietà del discorso politico, ma ne prenda direttamente il posto.
L’antropologo Jonathan Friedman, in un suo recente e provocatorio libro dedicato al tema del “politicamente corretto”, ha sostenuto che una nuova relazione politica, quella tra il centro e le sue periferie, ha soppiantato la vecchia opposizione fra destra e sinistra [18]. Il ceto politico “globale” e “multiculturale” si separa sempre più dai governati. Il “politicamente corretto”, a suo parere, è l’ideologia fondamentale di un ceto politico privo ormai di ogni rapporto reale col “popolo”: ne consegue, anche se non è questo il tema del suo libro, la possibilità di una costituzione anti-politica e “sovranista” del popolo, che alimenta costantemente i movimenti populisti. Può così accadere (con la cosiddetta pop-politica, come abbiamo visto) che il populismo culturale non solo possa esser rivendicato in contrapposizione alla noiosa serietà del discorso politico, ma ne prenda direttamente il posto.
Torniamo allora, per concludere, alla domanda iniziale: dove sta il popolo oggi? Come individuare la linea di demarcazione fra l’egemonico e il subalterno? Non sono gli indicatori oggettivi di tipo economico o culturale che possono dircelo, ma l’autopercezione dei gruppi sociali. Una sorta di “coscienza di classe”, diciamo, che si rovescia rispetto alle sue manifestazioni storiche. La fortuna dei populismi occidentali contemporanei sta proprio in una sorta di inversione delle strategie di distinzione di larga parte dei ceti medi, in particolare quelli a più basso capitale culturale. Piuttosto che tirare linee di separazione verso il basso, ci si rappresenta come “popolo” in contrapposizione a ceti più “alti” (globali, staccati dal territorio) ai quali non si riconosce tuttavia alcun ruolo egemonico, né alcuna legittimità politica.
Dovremmo dunque chiederci: è possibile ricostruire una egemonia nel vecchio senso del termine? Ovvero, è possibile ricostruire un blocco storico in cui le idee progressiste e politicamente corrette (della “sinistra”, diciamo) si connettano nuovamente con gli “interessi”, con la “concezione del mondo e della vita”, con le “interpellanze” di ampi strati sociali, recuperando magari anche una saldatura con le “interpellanze” dei migranti e con un senso di uguaglianza e giustizia globale? É una domanda che avverto come parallela a quella che riguarda la possibilità di ripristinare una demologia di taglio gramsciano, capace di studiare le differenze culturali nella loro corrispondenza con le differenze sociali. Parallela, e ovviamente altrettanto difficile.
Una cosa però almeno si può dire, alla luce del dibattito sul “populismo culturale” e della crisi della demologia. Quest’ultima dovrebbe aver capito che non si può rispondere alla diffusione omologante della cultura di massa semplicemente esprimendo disgusto verso quei ceti bassi che, invece di coltivare il vecchio autentico folklore, si lasciano catturare dalle lusinghe del consumismo. Allo stesso modo, la sinistra non può rispondere all’attuale crisi dell’egemonia con una semplice critica al “popolo”, non abbastanza sofisticato, non abbastanza intelligente da distinguere i problemi veri da quelli falsi; fondamentalmente irrazionale, prono alla propaganda sciovinista che produce paure fittizie, incline a pensare, come spesso si dice, “con la pancia”. Non può sostenere che il “popolo” non esista, né che sia solo una finzione impugnata della destra; o che, invece, va bene solo se si adegua ai valori ritenuti corretti, progressisti, politicamente corretti. In questo senso, sia la politica sia (nel suo piccolo) la demologia hanno bisogno di una scossa populista per capire qualcosa della intricata e scandalosa situazione politico-culturale nella quale ci siamo trovati immersi senza ben saper come.
Dialoghi Mediterranei, n. 42, marzo 2020
Note
[1] F. Dei, Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Bologna, Il Mulino, 2018.
[2] Si vedano fra gli altri P. A. Taguieff, L’illusione populista, trad. it. Milano, Bruno Mondadori, 2003; P. Taggart, Populism, Buckingam-Philadelphia, Open University Press, 2000; M. Anselmi, Populism. An Introduction, London-New York, Routledge, 2018; G. Fitzl, J. Mackert, B.S: Turner, eds., Populism and the crisis of democracy, 3 voll., London-New York, Routledge, 2019.
[3] G. Ionescu, E. Gellner, eds., Populism: Its Meaning and National Characteristics, London, Weidenfeld & Nicholson, 1969
[4] N. Tranfaglia, Populismo. Un carattere originale nella storia d’Italia, Bari-Roma, Laterza, 2014.
[5] I. Berlin, To define populism, in Ionescu-Gellner, cit.
(http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/bibliography/bib111bLSE.pdf)
[6] P. Sylos Labini, Le classi sociali negli anni ’80, Bari-Roma, Laterza, 1986: 10.
[7] P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, trad. it. Bologna, Il Mulino, 1983 (ed. orig. 1979).
[8] A. Schizzerotto, Classi sociali e società contemporanea. Milano, Franco Angeli, 1988.
[9] Istat 2017, Rapporto annuale 2017. La situazione del paese, Roma, Istituto nazionale di Statistica, 2017: 73
[10] L. Ricolfi, La società signorile di massa, Milano, La Nave di Teseo, 2019: 70.
[11] Ibid.: 36.
[12] Ibid.: 126-7 e passim.
[13] Ibid.: 71-86
[14] A. Dal Lago, Populismo digitale, Milano, Cortina, 2017: 23.
[15] E. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780: programma, mito, realtà, trad. it. Torino, Einaudi, 1991: 122. Cfr. A. D. Smith, National Identity, Harmondswhort, Penguin Books, 1991, e P. A. Taguieff, L’illusione populista, cit.: 95 sgg.
[16] Rimando su questo punto a F. Dei, Pop-politica. Le basi culturali del berlusconismo, in «Studi culturali», VIII (3), 2011: 471-90; e a G. Mazzoleni, A. Sfardini, Politica pop, Bologna, Il Mulino, 2009; G. Mazzoleni, R. Bracciale, La politica pop online, Bologna, Il Mulino, 2019.
[17] Si veda in particolare J. McGuigan, Cultural Populism, London, Routledge, 1992.
[18] J. Friedman, PC Worlds. Political Correctness and Rising Elites at the End of Hegemony, New York, Berghahn Books, 2019.
_____________________________________________________________
Fabio Dei, insegna Antropologia culturale presso l’Università di Pisa, si occupa prevalentemente di epistemologia delle scienze sociali e di temi della cultura popolare e di massa nell’Italia contemporanea. Nel campo degli studi sul dono ha coordinato una ricerca di AVIS Toscana sulla donazione del sangue tra i cittadini migranti Il sangue degli altri. Culture della donazione fra gli immigrati stranieri in Italia (2007) e ha curato i volumi Culture del dono (con M. Aria, Meltemi, 2008) e Il dono del sangue. Per un’antropologia dell’altruismo (con M. Aria e G. L. Mancini, Pacini, 2008). Ha pubblicato: Ragione e forme di vita. Razionalità e relativismo in antropologia (con A. Simonicca, Franco Angeli, 1990); La discesa agli inferi: J. G. Frazer nella cultura del Novecento (Argo, 1998); Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare (2003), Antropologia della violenza (2005) per Meltemi.; Introduzione all’antropologia culturale (il Mulino, 2012). Tra le sue recenti pubblicazioni: Terrore suicida. Religione, politica e violenza nelle culture del martirio (2016); Stato, violenza, libertà. La critica del potere e l’antropologia contemporanea (2017); Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco (2018).
______________________________________________________________