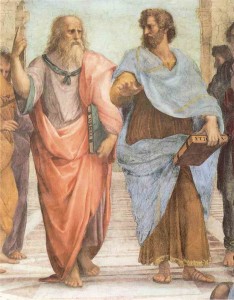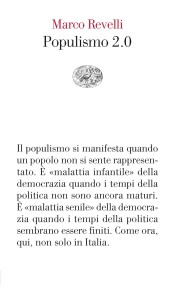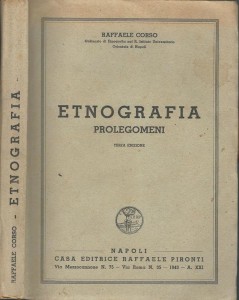populismo e demologia
di Sonia Giusti
Il tema Populismo e demologia proposto come oggetto di dibattito è questione che mi ha coinvolta subito a livello emotivo, nel senso che ho sentito qualcosa di urticante nell’accostamento di questi due fenomeni storici, essendo l’uno una prassi politica e l’altra una forma di conoscenza. Così, dopo il primo sconcerto, ho cercato di capirne le ragioni ripensando all’una e all’altra delle esperienze culturali, entrando nei nodi di ciascuna, ricostruendone i percorsi storici, impostando una comparazione antropologica che è risultata assai utile, non solo per ribadire la natura politicamente disgregatrice del populismo, ma per riconfermare come, negli accostamenti metodologici di esperienze culturali così diverse, sia possibile cogliere meglio le ragioni e la complessità storica di ciascuna, purché non si riducano a schemi classificatori e riduttivi.
Il concetto di democrazia vissuto dai Greci nella polis era fondato sulla “partecipazione” politica e sulla “pluralità” ed è rappresentato plasticamente da Norberto Bobbio con l’immagine della «piazza in cui i cittadini erano chiamati a prendere decisioni che li riguardavano». L’esperienza originaria della polis era retta dall’idea politica del cittadino greco che «non voleva comandare né essere comandato» e questo è proprio il fulcro del potere democratico, per come era inteso e praticato ad Atene nel V secolo, cioè partecipativo e relazionale. Da questo riferimento storico si può considerare la “pluralità” come criterio fondamentale su cui misurare il grado di democrazia del potere [1].
Uno degli aspetti che caratterizzano la vita democratica partecipativa, infatti, è proprio l’elemento plurale dei cittadini, concetto che si contrappone a quello di massa disindividuata, amorfa e politicamente manipolabile da un capo politico che la usa per il perseguimento della propria affermazione di potere. Per capire come si configuri questa situazione pericolosa di stallo della vita democratica di fronte ai populismi montanti e ricorrenti nel nostro Paese, è necessario ricostruirne, storicamente, le ragioni complesse che la determinano. Ma, per non trascurare l’idea che qualsiasi fenomeno storico non è eterno, e per capire meglio, in un’analisi comparativa, quale può essere la complessità del concetto di popolo se diversamente formulato, per esempio, sulla base dell’indispensabile elemento della pluralità, è utile ripensare al filone della ricerca demologica italiana fra Ottocento e Novecento e che affronteremo nella seconda parte di questo intervento.
 Dunque partiamo dall’idea che un movimento populista si afferma quando, sul disagio economico e l’insofferenza sociale, si è impastato un compatto agglomerato di gente disposta a recepire le seducenti promesse di soluzione dei problemi, confusamente avvertiti e fortemente sofferti, contenuta nell’indicazione messianica di lotta ai nemici esterni da abbattere. Sulla base di una definizione minima di appartenenza ad una classe sociale, come la possibilità di poter agire per controllarne o modificarne il destino dall’interno, Luciano Gallino ricostruisce le ragioni socio-politiche ed economiche del naufragio delle classi sociali. La conseguenza politica di questo naufragio, con il declassamento della classe media e la frantumazione del mondo del lavoro in nuove figure professionali, è stato l’emergere di un humus fertile per la crescita del germe populista: la sfiducia dei partiti visti come covi di affari personali dove i conflitti politici rivelano, spesso, non ideologiche contrapposizioni, ma incompetenza, aggressività e scorrettezza di linguaggi e comportamenti; la frantumazione dei grandi partiti politici di fronte all’avanzare di forze politicamente torbide – quelle rozzamente omofobe e xenofobe e quelle liberiste degli intellettuali conservatori –; lo svuotamento delle classi sociali.
Dunque partiamo dall’idea che un movimento populista si afferma quando, sul disagio economico e l’insofferenza sociale, si è impastato un compatto agglomerato di gente disposta a recepire le seducenti promesse di soluzione dei problemi, confusamente avvertiti e fortemente sofferti, contenuta nell’indicazione messianica di lotta ai nemici esterni da abbattere. Sulla base di una definizione minima di appartenenza ad una classe sociale, come la possibilità di poter agire per controllarne o modificarne il destino dall’interno, Luciano Gallino ricostruisce le ragioni socio-politiche ed economiche del naufragio delle classi sociali. La conseguenza politica di questo naufragio, con il declassamento della classe media e la frantumazione del mondo del lavoro in nuove figure professionali, è stato l’emergere di un humus fertile per la crescita del germe populista: la sfiducia dei partiti visti come covi di affari personali dove i conflitti politici rivelano, spesso, non ideologiche contrapposizioni, ma incompetenza, aggressività e scorrettezza di linguaggi e comportamenti; la frantumazione dei grandi partiti politici di fronte all’avanzare di forze politicamente torbide – quelle rozzamente omofobe e xenofobe e quelle liberiste degli intellettuali conservatori –; lo svuotamento delle classi sociali.
Se per definire una classe è necessario conoscere quali sono le volontà perseguite all’interno della stessa, ci sono buoni motivi per dubitare che le classi esistano ancora, visto che i motivi comuni di coloro che ne fanno parte – gli stili di vita, i tipi di alloggi, di consumi, le programmazioni educative per i propri figli – si sono frantumati. Scrive Luciano Gallino: «la classe lavoratrice è costituita dagli individui che con la loro forza lavoro, erogata alle dipendenze di qualcuno, assicurano la produzione delle merci e del capitale, mentre rientrano nella classe media, coloro che assicurano la circolazione delle une (ad esempio con il trasporto e il commercio) e dell’altro (ad esempio il credito)»[2]. Queste sono la media e piccola borghesia distinte dall’alta borghesia di imprenditori, proprietari terrieri e immobiliari, dirigenti di privata e pubblica amministrazione. Al di là di queste due classi, ormai scomposte, ci sono le migliaia di braccianti italiani e stranieri immigrati, pagati a giornata su chiamata di un caporale. Di fronte ai lavoratori che sono riusciti, grazie alle lotte sindacali, a raggiungere un minimo di diritti sociali, con la sicurezza della protezione sociale, sanitaria e scolastica, «le classi dominanti sono state così indotte a cedere una porzione dei loro privilegi, tutto sommato limitata. In ogni caso ciò ha voluto dire una riduzione del potere di cui godevano, dovuta in parte alle lotte dei lavoratori»[3].
 La tesi di Gallino è che in sostanza oggi si assiste ad una controffensiva delle classi alte che hanno perso alcuni dei loro privilegi contro coloro che hanno raggiunto un minimo di sicurezza sociale, rispetto alle condizioni miserabili in cui erano tenuti in precedenza, i salariati.
La tesi di Gallino è che in sostanza oggi si assiste ad una controffensiva delle classi alte che hanno perso alcuni dei loro privilegi contro coloro che hanno raggiunto un minimo di sicurezza sociale, rispetto alle condizioni miserabili in cui erano tenuti in precedenza, i salariati.
Con la globalizzazione, inoltre, si è costituita una nuova classe dominante transnazionale il cui collante ideologico è strumento essenziale per il funzionamento dell’economia mondiale basata su sistemi finanziari. Questo ha comportato una contrazione dei servizi pubblici e dei sistemi di protezione sociale, mentre si sono rimpinguati i patrimoni finanziari con nuove risorse, che non vengono investite in ricerca e sviluppo, che non sono produttive e che non creano quindi posti di lavoro. L’armatura mondiale di questo sistema finanziario è una ideologia liberista che si contrappone alla concezione liberale del sistema sociale e si estende su tutti gli aspetti dell’esistenza, a cominciare dalla scuola e dalla ricerca scientifica. «Secondo tale ideologia, la cultura umanistica è giudicata alla stregua di un lusso, se non di perdita di tempo» e tutt’al più è accettata come un mezzo «per creare valore attraverso la promozione del turismo». In questa situazione muore la cultura umanistica, come componente essenziale della democrazia che, invece di dare senso e contenuti all’esistenza, è piegata a produrre denaro. Nel quadro globalizzato rientrano anche le strategie delle “delocalizzazioni” che minacciano i sistemi di occupazione e protezione sociale e sembrano dire: «Se non rinunciate a una parte significativa dei vostri diritti, non vi accontentate di salari più modesti, non siete più disciplinati, noi continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora, e cioè andare a produrre dove i salari sono più bassi (e i diritti pure) e poi importare nei nostri paesi quelle merci prodotte a basso prezzo. Così voi vi troverete la concorrenza sulla porta di casa»[4].
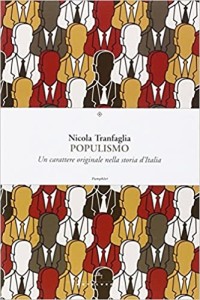 Nicola Tranfaglia, che ricerca le tracce costanti del populismo in Italia, si ferma sul tragico momento in cui, in Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, esplode il nazionalismo e la grande paura della rivoluzione bolscevica. Con l’uso della violenza contro i socialisti, «di fronte alla profondità della crisi liberale, il fascismo sembrò una soluzione semplice e realizzabile di uscita dalla crisi e di ristabilimento dell’ordine …»[5]. La seconda esplosione populistica avviene nel secondo Dopo Guerra, tra gli anni ‘50 -’70, quando l’Italia, caratterizzata da corruzione pubblica e privata, provvede, con discutibili criteri di selezione, alla costituzione della nuova classe dirigente politica. Il tracollo del sistema prosegue negli anni a venire con l’inchiesta giudiziaria di “Mani pulite”, finché negli anni ’80 -’90 si afferma il movimento della Lega Nord per l’indipendenza della Padania. Nel 2013 Matteo Salvini, segretario del partito, proseguirà a difendere il popolo (non più solo padano, ma del Paese intero) contro le istituzioni centrali italiane ed europee rivolgendo al “suo” popolo l’appello messianico e sovranista: “Prima gli Italiani”.
Nicola Tranfaglia, che ricerca le tracce costanti del populismo in Italia, si ferma sul tragico momento in cui, in Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, esplode il nazionalismo e la grande paura della rivoluzione bolscevica. Con l’uso della violenza contro i socialisti, «di fronte alla profondità della crisi liberale, il fascismo sembrò una soluzione semplice e realizzabile di uscita dalla crisi e di ristabilimento dell’ordine …»[5]. La seconda esplosione populistica avviene nel secondo Dopo Guerra, tra gli anni ‘50 -’70, quando l’Italia, caratterizzata da corruzione pubblica e privata, provvede, con discutibili criteri di selezione, alla costituzione della nuova classe dirigente politica. Il tracollo del sistema prosegue negli anni a venire con l’inchiesta giudiziaria di “Mani pulite”, finché negli anni ’80 -’90 si afferma il movimento della Lega Nord per l’indipendenza della Padania. Nel 2013 Matteo Salvini, segretario del partito, proseguirà a difendere il popolo (non più solo padano, ma del Paese intero) contro le istituzioni centrali italiane ed europee rivolgendo al “suo” popolo l’appello messianico e sovranista: “Prima gli Italiani”.
«Il populismo si manifesta quando il popolo non si sente più rappresentato», scrive Marco Revelli [6], e in questo senso di abbandono nasce il “governo della plebe” costituita dalla “polvere sociale” prodotta dallo sfaldamento del sistema di sicurezza sociale, dall’incertezza e dalla paura che provocano la fuga nelle braccia di presunti “salvatori” populisti e l’aggressione contro pericoli costruiti con la lega, o colla, razzista [7]. Si afferma sulla scena politica un nuovo protagonista, il popolo-plebe che rompe i vecchi contenitori, i partiti novecenteschi che canalizzavano la partecipazione politica dei cittadini [8].
Quello che chiamiamo populismo, sgretolamento della democrazia che comporta intolleranza, frustrazione, rancore, è una entità confusa, che trasuda disagio espresso in conati di protesta incapaci di trasformarsi in proposte di cambiamento. Il popolo, in questo senso, è una entità compatta in contrapposizione alle elités; è priva di idee che non si scontrano più, per esempio, in destra e sinistra, ma si coagulano in un agglomerato impulsivo incapace di progettare. Per “l’uomo forte” che promette di salvarlo, il popolo è l’insieme di gente onesta, e per bene, soffocata dai politici traditori. Così la sfida populista mette in ombra, anzi demonizza, i partiti politici e si concretizza in antipolitica che contagia. Tra i populisti europei fa scuola Viktor Orbàn che costruisce muri di filo spinato tra Ungheria e Serbia per fermare il nemico cioè gli immigrati e traccia sentieri antieuropei in nome dell’orgoglio sovranista contro le politiche di austerità che accusa di produrre disoccupazione e diseguaglianza.
Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo conosciuto tre varianti di populismo – il berlusconismo, il renzismo e il grillismo – caratterizzate da una forte personalizzazione, con l’uomo forte che promette meraviglie, l’imbonitore telegenico che si muove all’insegna di una rottura con il passato politico [9]. A Berlusconi, che si rivolge agli italiani dicendo loro che ama l’Italia e che la salverà da una classe politica corrotta, segue l’esperimento di Renzi che parla direttamente al popolo e promette di risolvere tutti i problemi rottamando gli avversari di partito e auspicando un “partito della nazione”, fino al quesito referendario costituzionale, con la solenne bocciatura che ne seguì, ma proseguendo, imperterrito, con l’ultima proposta del “sindaco d’Italia”. Infine l’uomo di spettacolo, con la capacità di indirizzare il rancore popolare contro l’intera classe politica, il capo del movimento grillino, trasversale alle opinioni politiche, che si rivolge al popolo della rete fatta di una moltitudine di “uno vale uno” a garanzia della democrazia diretta del popolo sovrano, coinvolgendolo nell’appello messianico ai governanti: “Arrendetevi!”.
Certamente il populismo è una strategia per la presa del potere. E comunque la fuga nel populismo è dovuta a «una crisi profonda insieme morale, economica e politica, da cui sembra ormai difficile uscire»[10]. Il pamphlet di Nicola Tranfaglia si apre con la definizione di Mario Stoppino: «Possono essere definite populiste quelle forme per le quali fonte precipua di riferimento è il popolo, considerato come aggregato sociale omogeneo e come deposito esclusivo di valori positivi, specifici e permanenti»[11]. I populismi sono interclassisti: mettono insieme braccianti, piccoli proprietari, commercianti e, per ultimo, il ceto operaio che vota Lega, deluso dalla casta dei politici corrotti e sindacalmente ostili – si pensi all’abolizione dell’articolo 18. I populisti escludono la lotta di classe e parlano di complotti contro il popolo, considerato all’ingrosso, una massa di gente che intendono difendere e alla quale dicono quello che si vuol sentir dire. Il populismo «rappresenta la corrente antiliberale più forte» che si sia affermata negli ultimi secoli e la vicinanza tra fascismo e populismo è suggerita, scrive Tranfaglia, dall’egualitarismo dei membri del popolo che si legano con il vincolo della violenza contro un nemico esterno e della fede nel capo politico a cui si affidano. La dissociazione dell’èlite sociale e intellettuale dalla classe politica fa emergere i populismi, così, la prima volta che il movimento populista si è affermato in Italia è stato con Mussolini; ai nostri giorni con Berlusconi e il suo partito-azienda – alleato con il MSI di Gianfranco Fini e con Umberto Bossi della Lega Nord [12].
 In tutti i casi la paura e il rancore sono i sentimenti che alimentano i populismi e l’astuzia politica di chi li governa sta nel saperli attrezzare contro il nemico esterno che, oggi, oltre la casta politica corrotta, è l’immigrato etichettato come «portatore di malattie e ladro di posti di lavoro», come si sente dire. Il fatto è che se c’è un capo carismatico, c’è anche una volontà di farsi guidare da lui, c’è una aspettazione che si concentra in un’entità confusa chiamata popolo con una aspirazione vaga di rigenerazione di qualcosa che gli è stato sottratto, qualcosa di armonico che rientrava nelle sue tradizioni e che ha perso. Dall’altra parte c’è la seduzione del popolo da parte di un capo imbonitore intrapresa per meglio irretirlo e strumentalizzarlo allo scopo di conquistare il potere.
In tutti i casi la paura e il rancore sono i sentimenti che alimentano i populismi e l’astuzia politica di chi li governa sta nel saperli attrezzare contro il nemico esterno che, oggi, oltre la casta politica corrotta, è l’immigrato etichettato come «portatore di malattie e ladro di posti di lavoro», come si sente dire. Il fatto è che se c’è un capo carismatico, c’è anche una volontà di farsi guidare da lui, c’è una aspettazione che si concentra in un’entità confusa chiamata popolo con una aspirazione vaga di rigenerazione di qualcosa che gli è stato sottratto, qualcosa di armonico che rientrava nelle sue tradizioni e che ha perso. Dall’altra parte c’è la seduzione del popolo da parte di un capo imbonitore intrapresa per meglio irretirlo e strumentalizzarlo allo scopo di conquistare il potere.
Ma chi l’ha detto che il popolo è un contenitore vuoto, anzi un amalgama di masse disindividuate e manipolabili? Veramente non la pensava così Jules Michelet che considerava il popolo come “geniale” protagonista del percorso di rinnovamento etico della storia. La sua concezione dello storico che «non è il tecnico dei monumenti del passato, ma il mediatore del dialogo reciproco senza il quale passato e presente non avrebbero senso», lo portarono a riversare nell’insegnamento di storia al Collège de France – dove ebbe la cattedra nel 1838 – tutta la passione politica della sua ricerca. Le sue idee liberali lo spingevano a concepire la storia come politica, anzi la storia dei popoli era da lui considerata la levatrice dei principi democratici [13]. Con Michelet siamo in pieno Romanticismo, ma già dalla metà del Settecento erano emerse tendenze che anticipavano i fermenti romantici che si addensano sulle passioni, le forze spontanee e sorgive dei popoli, le fantasie, i sentimenti. Certamente fu dopo gli eventi sanguinosi della Rivoluzione francese e della Restaurazione che si rivalutò la storia dei popoli e le loro tradizioni.
Se ora rivolgiamo l’attenzione all’importante filone di ricerca italiano delle tradizioni popolari, che si è svolto fra Ottocento e Novecento, rileviamo un concetto totalmente diverso di popolo, «che non è vuoto», che emerge ricco di varianti prospettiche, di visioni fantastiche e poetiche, di luoghi di paure e di magie, di temi musicali, di saggezze etiche e di rabbie raccolte nel buon senso dei proverbi, nella filosofia della vita e dei rapporti interpersonali che si reggono nelle regole di una convivenza di stampo antico. Il concetto di popolo, che si configura nelle riflessioni dei primi folkloristi italiani [14], non è quello di una massa informe e manipolabile, ma di una pluralità di individui che esprimono i loro sentimenti e le loro credenze legate ad esperienze storiche e territoriali differenziate che vengono espresse anche nelle forme dell’immaginario – miti, fiabe, leggende, credenze –.
Fin dalle prime ricerche demologiche si avverte l’esigenza metodologica di considerare queste manifestazioni fuori dai confini delle “curiosità” per intenderle come formazioni storiche. Così Raffaele Corso il quale, studiando il folklore giuridico italiano, la medicina e la religiosità popolare, avvertiva la necessità di una sistematicità metodologica degli studi folklorici: infatti, diceva, per quanto si raccolgano «idee e argomenti dalla vita plebea della città e della campagna dai costumi e dalle leggende delle umili classi … deve passare del tempo prima che la tenue e varia materia delle tradizioni popolari acquisti carattere di scienza ed assuma il metodo che la facciano distinguere dalle discipline sorelle o affini»[15].
Giuseppe Pitré (1841-1916), nella prolusione del 1911 all’Università di Palermo, aveva proposto il termine Demopsicologia per indicare lo studio delle tradizioni popolari e ne aveva definito lo statuto epistemologico sulla base di una monumentale raccolta di tradizioni popolari, in 25 volumi, con i quali fonda l’Archivio nel 1882, e dei due volumi di “Bibliografia delle tradizioni popolari” pubblicati nel 1894 [16]. Raffaele Pettazzoni entrò in contatto con Pitré in occasione della sua ricerca sul “rombo australiano” quando, nel 1910, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, consultò il suo Giuochi fanciulleschi siciliani, del 1883, e alcuni fascicoli dell’“Archivio per lo studio delle tradizioni popolari” fondato da Pitré e Salomone Marino nel 1882. Allora lo storico persicetano scrisse a Pitré e probabilmente allegò il suo saggio sulla “grave mora” che, tuttavia, non fu pubblicato [17]. Pettazzoni era interessato all’evoluzionismo britannico, e aveva rapporti di amicizia con James Frazer e Robert R. Marett, tanto che fu invitato al Congresso della “Folk-lore Society” di Londra nel 1929; fu lui che presentò a Marett il giovane studioso siciliano, Giuseppe Cocchiara, il quale frequentò i suoi corsi di antropologia sociale all’Exter College di Oxford dove Marett era Rettore [18]. E fu anche da quella esperienza di studi che Cocchiara maturò «la necessità di saldare la problematica folklorica a quella etnologica»; nella Premessa alla Storia del folklore, infatti, sono chiaramente individuati i due filoni di ricerca per cui «da taluni si è dato e si dà maggiore risalto alla parte letteraria delle tradizioni popolari, che è quanto dire alle tradizioni orali, e queste si studiano con i metodi comuni alla filologia, da altri si guarda alle credenze, alle superstizioni, ai costumi ecc. e questi si considerano come delle ‘sopravvivenze’, onde vengono studiati coi metodi dell’etnologia».
Le tradizioni popolari erano ancora “curiosità popolari” di cui si esaltava l’aspetto letterario oppure, secondo il metodo etnologico, se ne mettevano in risalto le credenze e i costumi. Il nodo teorico che avrebbe fatto maturare gli studi demologici in senso storicistico, secondo Giuseppe Cocchiara, sarebbe stato il convincimento di liberarsi «dalla vecchia pretesa di considerare il folklore come una scienza autonoma» per farla scorrere «dentro le arterie della storia» e per considerare finalmente il folklore etnografico come storia [19]. E non come storia parallela alla grande storia, ma come parte di un’unica storia all’interno della quale rilevare le responsabilità politiche di aver confinato le plebi rustiche all’emarginazione sociale ed economica.
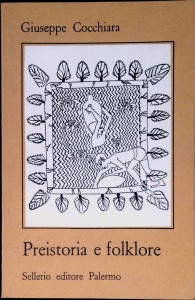 Evoluzionismo e storicismo sono i due poli entro i quali si configura la storia delle tradizioni popolari in Italia, scrive Antonino Buttitta, e l’opera di Giuseppe Cocchiara ne rappresenta il momento teorico più lucido nel quale si ricompone il metodo storico della demologia [20]. Il suo impegno di ricerca è basato sulla certezza che le tradizioni popolari non sono sopravvivenze, ma formazioni storiche, e come tali devono essere studiate per sapere come si sono formate, a quali bisogni rispondono, perché si conservano e perché si rielaborano. La sistematicità di questa prima storia del folklore in Italia, garantita teoreticamente dal Cocchiara, ne fa una pietra miliare nella storia degli studi, chiaramente inserita nel solco dello storicismo crociano [21]. Cocchiara si era avvicinato alla prospettiva storicistica della cultura popolare attraverso le idee di Benedetto Croce – Teoria e storia della storiografia e La storia come pensiero e come azione erano state due letture fondamentali – tramite le quali poteva elaborare una serie di principi che hanno dato agli studi demologici italiani una impronta scientifica, teoricamente salda e metodologicamente coerente, che possiamo sintetizzare in alcuni temi: «il problema delle origini dell’uomo va affrontato alla luce della storia e non dell’evoluzione»; il compito degli studi folklorici non è quello di studiare dei fossili, ma dei fatti che costituiscono lo svolgimento storico del travagliato mondo umano; lo studio delle tradizioni popolari si occupa di una determinata classe sociale, il popolo, che esprime una particolare visione della vita consistente in certi atteggiamenti dello spirito, del pensiero, della cultura, del costume e «delle civiltà che si presentano con caratteri propri, specifici, determinati». In questi termini, e se riusciamo a non perdere di vista le persone, Il concetto di popolo è tutt’altro che vuoto; esso è colmo di diversità di idee, di mondi fantastici e poetici, di musiche, di storie, di passioni civili.
Evoluzionismo e storicismo sono i due poli entro i quali si configura la storia delle tradizioni popolari in Italia, scrive Antonino Buttitta, e l’opera di Giuseppe Cocchiara ne rappresenta il momento teorico più lucido nel quale si ricompone il metodo storico della demologia [20]. Il suo impegno di ricerca è basato sulla certezza che le tradizioni popolari non sono sopravvivenze, ma formazioni storiche, e come tali devono essere studiate per sapere come si sono formate, a quali bisogni rispondono, perché si conservano e perché si rielaborano. La sistematicità di questa prima storia del folklore in Italia, garantita teoreticamente dal Cocchiara, ne fa una pietra miliare nella storia degli studi, chiaramente inserita nel solco dello storicismo crociano [21]. Cocchiara si era avvicinato alla prospettiva storicistica della cultura popolare attraverso le idee di Benedetto Croce – Teoria e storia della storiografia e La storia come pensiero e come azione erano state due letture fondamentali – tramite le quali poteva elaborare una serie di principi che hanno dato agli studi demologici italiani una impronta scientifica, teoricamente salda e metodologicamente coerente, che possiamo sintetizzare in alcuni temi: «il problema delle origini dell’uomo va affrontato alla luce della storia e non dell’evoluzione»; il compito degli studi folklorici non è quello di studiare dei fossili, ma dei fatti che costituiscono lo svolgimento storico del travagliato mondo umano; lo studio delle tradizioni popolari si occupa di una determinata classe sociale, il popolo, che esprime una particolare visione della vita consistente in certi atteggiamenti dello spirito, del pensiero, della cultura, del costume e «delle civiltà che si presentano con caratteri propri, specifici, determinati». In questi termini, e se riusciamo a non perdere di vista le persone, Il concetto di popolo è tutt’altro che vuoto; esso è colmo di diversità di idee, di mondi fantastici e poetici, di musiche, di storie, di passioni civili.
 È con Antonio Gramsci che, decisamente, si respinge il paradigma romantico di popolo e si realizza la rifondazione del concetto di folklore. Per Gramsci la scienza del folklore è «la storia della vita culturale degli strati ideologicamente più arretrati delle classi politicamente ed economicamente subalterne dalle origini della società borghese ad oggi»[22]. Gramsci respinge il concetto romantico di popolo, come “pittoresco”, per affermare che il folklore «è una cosa molto seria e che va presa sul serio» e perché l’insieme dei fatti folklorici esprime «una concezione del mondo e della vita». «Il moltiplicarsi di elementi progressivi» nella cultura popolare, sono elementi di presa di coscienza della condizione di subalternità, dalla quale riscattarsi e che incidono nel processo di trasformazione in senso umanistico. Nel Q. XI, Osservazioni sul ‘folklore’, Gramsci scrive: «Esiste una ‘morale’ del popolo, intesa come un insieme determinato (nel tempo e nello spazio) di massime per la condotta pratica e di costumi che ne derivano e che le hanno prodotte, morale che è strettamente legata, come le superstizioni, alle credenze religiose … occorre distinguere diversi strati: quelli fossilizzati che rispecchiano condizioni di vita passata e quindi conservativi e reazionari, e quelli che sono una serie di innovazioni, spesso creative e progressive, determinate spontaneamente da forme e condizioni di vita in un processo di sviluppo e che sono in contraddizione, o solamente diverse, dalla morale degli strati dirigenti»[23].
È con Antonio Gramsci che, decisamente, si respinge il paradigma romantico di popolo e si realizza la rifondazione del concetto di folklore. Per Gramsci la scienza del folklore è «la storia della vita culturale degli strati ideologicamente più arretrati delle classi politicamente ed economicamente subalterne dalle origini della società borghese ad oggi»[22]. Gramsci respinge il concetto romantico di popolo, come “pittoresco”, per affermare che il folklore «è una cosa molto seria e che va presa sul serio» e perché l’insieme dei fatti folklorici esprime «una concezione del mondo e della vita». «Il moltiplicarsi di elementi progressivi» nella cultura popolare, sono elementi di presa di coscienza della condizione di subalternità, dalla quale riscattarsi e che incidono nel processo di trasformazione in senso umanistico. Nel Q. XI, Osservazioni sul ‘folklore’, Gramsci scrive: «Esiste una ‘morale’ del popolo, intesa come un insieme determinato (nel tempo e nello spazio) di massime per la condotta pratica e di costumi che ne derivano e che le hanno prodotte, morale che è strettamente legata, come le superstizioni, alle credenze religiose … occorre distinguere diversi strati: quelli fossilizzati che rispecchiano condizioni di vita passata e quindi conservativi e reazionari, e quelli che sono una serie di innovazioni, spesso creative e progressive, determinate spontaneamente da forme e condizioni di vita in un processo di sviluppo e che sono in contraddizione, o solamente diverse, dalla morale degli strati dirigenti»[23].
Di fronte all’aspetto sostanzialmente negativo del folklore, presente nelle Osservazioni di Gramsci, la stizzosa domanda che si fa Cirese sulla qualifica di “concezione del mondo” assegnata da Gramsci ad «un ‘agglomerato’ tanto ‘indigesto’ di detriti e frammenti degradati, la cui sostanziale disorganicità è accresciuta anziché diminuita dalla presenza di qualche concezione effettuale e progressiva», trova la risposta nelle stesse parole di Gramsci: «perché nel folklore c’è quell’elemento di tenacia che lo rende rilevante ai fini della conoscenza e della trasformazione del reale»[24].
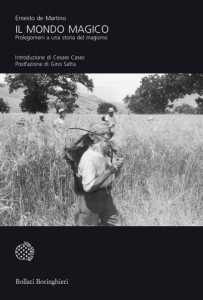 I nodi teorici della demologia italiana con lo storicismo si dipanano su più fronti. Rimangono, comunque, forti i legami e ci sembra utile ritornare sulla piega che presero quelli di De Martino con l’idealismo crociano. La lettera che egli scrisse a Benedetto Croce, senza data, ma forse del 1940, e che probabilmente non fu mai spedita, è esemplificativa del rovello teorico del giovane etnologo napoletano, perché rivela «un tassello utile della genesi del Mondo Magico» a cui stava già lavorando e che sarebbe uscito nel 1948 [25]. Nella lettera si legge: «Voi considerate la ‘magia’ come una ‘immaginazione’ o un ‘sogno’ e i poteri della natura, che essa dice di avere, come ‘supposti’. Ora a me pare che codesto concetto male si accorda con lo spirito e con la lettera della vostra filosofia dello spirito». E concludeva con una affermazione che contiene il nucleo del Mondo magico espresso in una formula fortemente icastica, che non oscilla, che contiene la soluzione del travagliato pensiero demartiniano, nutrito di storicismo che non fu mai “assoluto” [26]. La frase è questa: «La magia è La storia come pensiero e come azione dei primitivi».
I nodi teorici della demologia italiana con lo storicismo si dipanano su più fronti. Rimangono, comunque, forti i legami e ci sembra utile ritornare sulla piega che presero quelli di De Martino con l’idealismo crociano. La lettera che egli scrisse a Benedetto Croce, senza data, ma forse del 1940, e che probabilmente non fu mai spedita, è esemplificativa del rovello teorico del giovane etnologo napoletano, perché rivela «un tassello utile della genesi del Mondo Magico» a cui stava già lavorando e che sarebbe uscito nel 1948 [25]. Nella lettera si legge: «Voi considerate la ‘magia’ come una ‘immaginazione’ o un ‘sogno’ e i poteri della natura, che essa dice di avere, come ‘supposti’. Ora a me pare che codesto concetto male si accorda con lo spirito e con la lettera della vostra filosofia dello spirito». E concludeva con una affermazione che contiene il nucleo del Mondo magico espresso in una formula fortemente icastica, che non oscilla, che contiene la soluzione del travagliato pensiero demartiniano, nutrito di storicismo che non fu mai “assoluto” [26]. La frase è questa: «La magia è La storia come pensiero e come azione dei primitivi».
Anche lo scambio di idee con Remo Cantoni è utile per capire lo storicismo di De Martino. Cantoni riconosce nel Mondo magico di De Martino, «un pensiero originale, fresco, nuovo come problema e (considerava) che fosse un pericolo volerlo mortificare entro uno schema che, oggi, malamente racchiude la nostra esperienza spirituale». Cantoni si riferiva all’idealismo in cui, pur dichiarandosi un «non dispregiatore dell’idealismo crociano», avvertiva che in quello mancava «l’interesse sul problema della persona», pur riconoscendo in Croce, diceva, «il pensatore più vivo nella cultura italiana di oggi e penso che la sua saldatura tra filosofia e storia è tra le cose più intelligenti e proficue del pensiero contemporaneo», aggiungendo che «…Non vi è assolutamente eterogeneità tra mentalità primitiva e mentalità civilizzata, e che la prima è una forma o struttura della nostra vita spirituale, nella quale ci imbattiamo assai spesso, ogni qual volta l’istanza logica rallenta la sua morsa»[27]. Quest’ultima considerazione ribadiva il problema di una visione unitaria che corre tra il mondo etnologico e quello folklorico, e che era stata anticipata già da Raffaele Pettazzoni il quale, raccogliendo miti e leggende dei “primitivi”, lo faceva secondo un impianto «umanistico, nel senso ideale dell’essere uomini e dunque atti ad intendere ogni discorso umano, per quanto estraneo e remoto e non romantico», compresa «quella prima umanità magica (che) è già una umanità religiosa» cioè storica [28]. E aggiungeva: «E nemmeno è giustificato l’allarme di chi ha creduto cogliere in questa opera un segno di quel morboso irrazionalismo antistoricistico che, imperversando nella etnologia come nella storia delle religioni e nella psicologia e nella filosofia, insidierebbe oggi pericolosamente la nostra civiltà»[29].
 Quando nel 1949 esce il saggio di De Martino, Intorno ad una storia del mondo popolare subalterno la demologia si fa storia delle classi operaie e contadine inserita nel mondo della borghesia europea, una società divisa in classi, tra le quali il popolo chiaramente si contrappone alle élites borghesi. Il naturalismo della ricerca etnologica si mostra, allora, come «inerzia storiografica non casuale» di una società che riflette, a livello della ricerca scientifica, la n a t u r a l i t à della classe dei subalterni, cioè la natura delle persone intese come cose. In realtà il “circoscritto umanesimo” della civiltà occidentale esclude una porzione di mondo come astorico, plasticamente immaginato “oltre Eboli”, dove manca la “pietà storica”, mancanza tipica dei primi etnologi che hanno sistemato nei loro schemi evoluzionistici le varie comunità, dimenticando che «una civiltà è un organismo vivente ed in più un modo significativo di risolvere determinati problemi esistenziali. La ragione di questa mancanza è da ricercarsi nella ricordata connessione fra lo sfruttamento politico delle masse popolari subalterne e la considerazione naturalistica della loro cultura»[30]. Secondo le tesi di Marx, le masse popolari lottano per entrare nella storia con lo scopo di rovesciare il sistema politico che le sfrutta, e in tale lotta acquistano coscienza della situazione. «Queste masse, scrive De Martino, portano con sé le loro abitudini culturali, il loro modo di contrapporsi al mondo, la loro ingenua fede millenaristica e il loro mitologismo, e persino certi atteggiamenti magici». E di fronte a questo patrimonio culturale pericolosamente suscettibile di essere utilizzato per asservire, sceglie parole che sembrano scritte oggi:
Quando nel 1949 esce il saggio di De Martino, Intorno ad una storia del mondo popolare subalterno la demologia si fa storia delle classi operaie e contadine inserita nel mondo della borghesia europea, una società divisa in classi, tra le quali il popolo chiaramente si contrappone alle élites borghesi. Il naturalismo della ricerca etnologica si mostra, allora, come «inerzia storiografica non casuale» di una società che riflette, a livello della ricerca scientifica, la n a t u r a l i t à della classe dei subalterni, cioè la natura delle persone intese come cose. In realtà il “circoscritto umanesimo” della civiltà occidentale esclude una porzione di mondo come astorico, plasticamente immaginato “oltre Eboli”, dove manca la “pietà storica”, mancanza tipica dei primi etnologi che hanno sistemato nei loro schemi evoluzionistici le varie comunità, dimenticando che «una civiltà è un organismo vivente ed in più un modo significativo di risolvere determinati problemi esistenziali. La ragione di questa mancanza è da ricercarsi nella ricordata connessione fra lo sfruttamento politico delle masse popolari subalterne e la considerazione naturalistica della loro cultura»[30]. Secondo le tesi di Marx, le masse popolari lottano per entrare nella storia con lo scopo di rovesciare il sistema politico che le sfrutta, e in tale lotta acquistano coscienza della situazione. «Queste masse, scrive De Martino, portano con sé le loro abitudini culturali, il loro modo di contrapporsi al mondo, la loro ingenua fede millenaristica e il loro mitologismo, e persino certi atteggiamenti magici». E di fronte a questo patrimonio culturale pericolosamente suscettibile di essere utilizzato per asservire, sceglie parole che sembrano scritte oggi:
«i modi primitivi e popolareschi di contrapporsi al mondo, tutto questo rappresenta un importante potenziale di energie che può essere vantaggiosamente utilizzato i n s e n s o a p e r t a m e n t e r e a z i o n a r i o dalle classi dominanti, al fine di mantenere la sua egemonia minacciata. Nella forma più indicativa, il fenomeno si è prodotto, come è noto, nella Germania nazista, dove c’è stato un notevole tentativo di promuovere una religione dell’Ur, fondata sulla mistica tribale della razza e del sangue, sulla magica forza attribuita al condottiero alla cui demiurgia politica la massa inerte si affida. Con ciò una borghesia particolarmente aggressiva e bramosa, giovandosi di determinate tradizioni storiche della cultura nazionale, tentava di rafforzare il legame ideologico col mondo popolare subalterno, e mercé una nuova sistemazione ideologica unitaria abilmente sfruttava i modi culturali di quel mondo, utilizzandoli ai propri fini di conquista e di rapina»[31].
 “La spietata crudezza”, che De Martino riconosce al Croce quando si riferisce ai popoli coloniali descritti come “un etnos di anime morte”, è una prova di indifferenza umanistica e di pigrizia storica, visto che «in realtà a renderle ‘morte’ ha provveduto la prassi della conquista e del dominio» [32]. Non si fa storia se ci si limita alla raccolta, alla descrizione delle “curiosità” popolari, scrive De Martino; «solo più tardi, come militante della classe operaia nel Mezzogiorno d’Italia, mi resi conto che il ‘naturalismo’ dell’etnologia tradizionale si legava al carattere stesso della società borghese». Per De Martino è l’umanesimo storicistico che tiene lontano il pericolo di vedere «ritornare gli anni sinistri in cui Hitler sciamanizzava in Germania e in Europa» [33]. Non ci sono pagine più incisive di quelle che De Martino sceglie per indicare la via per contrastare il populismo e le prende dal Croce, subito dopo un altro passo dello stesso Croce, spietato, contro i Naturvölker [34]; e questa volta, invece, le parole di Croce sono colme di pietas per il «grande sogno di felicità del popolo napoletano che rifà ogni settimana con il gioco del lotto»: un sogno «dove son tutte le cose di cui esso è privato, una casa pulita, dell’aria salubre e fresca, un bel raggio di sole caldo per terra, un letto bianco e alto, un comò lucido, i maccheroni e la carne ogni giorno, e la culla per il bimbo, e la biancheria per la moglie, e il cappello nuovo per il marito»[35].
“La spietata crudezza”, che De Martino riconosce al Croce quando si riferisce ai popoli coloniali descritti come “un etnos di anime morte”, è una prova di indifferenza umanistica e di pigrizia storica, visto che «in realtà a renderle ‘morte’ ha provveduto la prassi della conquista e del dominio» [32]. Non si fa storia se ci si limita alla raccolta, alla descrizione delle “curiosità” popolari, scrive De Martino; «solo più tardi, come militante della classe operaia nel Mezzogiorno d’Italia, mi resi conto che il ‘naturalismo’ dell’etnologia tradizionale si legava al carattere stesso della società borghese». Per De Martino è l’umanesimo storicistico che tiene lontano il pericolo di vedere «ritornare gli anni sinistri in cui Hitler sciamanizzava in Germania e in Europa» [33]. Non ci sono pagine più incisive di quelle che De Martino sceglie per indicare la via per contrastare il populismo e le prende dal Croce, subito dopo un altro passo dello stesso Croce, spietato, contro i Naturvölker [34]; e questa volta, invece, le parole di Croce sono colme di pietas per il «grande sogno di felicità del popolo napoletano che rifà ogni settimana con il gioco del lotto»: un sogno «dove son tutte le cose di cui esso è privato, una casa pulita, dell’aria salubre e fresca, un bel raggio di sole caldo per terra, un letto bianco e alto, un comò lucido, i maccheroni e la carne ogni giorno, e la culla per il bimbo, e la biancheria per la moglie, e il cappello nuovo per il marito»[35].
La demologia storicista, come l’etnologia storicista, si basa sulla passione etico-politica del “trasformare” e si alimenta della passione contro la indifferenza storiografica che è basata sul rapporto di dominio sulle classi subalterne e sulla manipolazione dei cervelli. Tutto il contrario delle tesi populiste che riducono il popolo a massa informe. Commentando la notizia che «di fronte al crescere della potenza politica e sociale del proletariato e della sua ideologia» alcuni intellettuali francesi reagiscono con movimenti “verso il popolo”, De Martino coglie ancora una volta la vera natura dell’ideologia borghese che «non vuole perdere la sua egemonia sulle classi popolari», accogliendo «una parte dell’ideologia proletaria» per gestirla meglio [36]. Sulla base di queste considerazioni, si capisce come De Martino, sulla lezione di Gramsci, si sorprendesse di fronte alla poca fortuna delle tesi di Antonio Labriola relative all’impostazione del problema filosofico, specialmente in un periodo storico in cui «un gruppo subalterno diventa realmente autonomo ed egemone». L’identità di storia e filosofia è contenuta nel materialismo storico, scrive Gramsci che si chiede se Croce abbia preso l’identità di storia e filosofia dalla prassi di Labriola. Anche se riconosceva che in Croce si era persa l’identità di storia e politica. In questo modo il concetto di storia risulta anemico, “erudito”, commentava e aggiungeva: «Lo storico è un politico e in questo senso (che del resto appare anche nel Croce) la storia è sempre contemporanea, cioè politica»[37].
Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020
Note
[1] N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1984; Destra e sinistra, Donzelli, Roma, 1995.
[2] L. Gallino, La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, Bari, 2012: 7.
[3] Ivi:11.
[4] Ivi: 57.
[5] M. Revelli, Populismo 2.0, Einaudi, Torino, 2017: 45.
[6] Ivi: 1.
[7] Z. Bauman, Paura liquida, Laterza, Bari, 2006.
[8] M. Revelli, cit.: 10.
[9] N. Tranfaglia, Populismo. Un carattere originale nella storia d’Italia, Castelvecchi, Roma, 2014: 81 ss.
[10] Ivi: 86.
[11] La citazione è presa dalla voce Totalitarismo di Mario Stoppino in Dizionario di politica, Utet, Torino, 1983.
[12] Ivi: 20.
[13] J. Michelet, (1846) Il popolo, Rizzoli, Milano, 1989; di Michelet, che tradusse la Scienza nuova di Vico, cfr. anche, Discorso su Vico. Il sistema e la vita (1688-1744), Il Grano, Messina, 2013.
[14] Al termine demologia si ricorre in alternativa al termine inglese folk-lore utilizzato per la prima volta da William Thoms (1803-1885), dove folk indica il ceto contadino, cioè la popolazione rurale in contrapposizione alla élite borghese.
[15] R. Corso, Riti e pratiche contro la siccità, in “Il folklore italiano”, I, 1933; Proverbi giuridici italiani, Palermo, 1908; Patti d’amore e pegni di promessa, S. Maria Capua Vetere, 1925.
[16] Una denominazione sbagliata, quella scelta dal Pitré, commenta Cocchiara, che sarà più corretto chiamare storia delle tradizioni popolari, visto che, più che psicologia, c’è storia. Cfr. G. Cocchiara, Storia del folklore in Italia, Sellerio, Palermo, 1981: 171.
[17] Alessandro D’Amato ricostruisce questo episodio nel suo saggio intitolato Giuseppe Pitré e Raffaele Pettazzoni. Una (duplice) occasione mancata, in «Dialoghi mediterranei», 2017, riportando anche una lettera di Pettazzoni dalla quale sembra di capire che Pitré non pubblicò quel saggio, anche perché l’«Archivio» non usciva più. Il saggio di Pettazzoni era La “grave mora”. Studio su alcune forme e sopravvivenze della sacralità primitiva, che fu pubblicato nel primo fascicolo di «Storia e Materiali di Storia delle Religioni», nel 1925. D’Amato ci dice anche in cosa consisteva la seconda mancata occasione: nel fatto che il Pitré si rifiutò di partecipare al I° Congresso di Etnografia Italiana che si tenne a Roma nell’ottobre del 1911 e rifiutò di scrivere una recensione per “Lares” su La religione primitiva in Sardegna di Raffale Pettazzoni.
[18] R. R. Marett, allievo di Edward Burnett Tylor, si è occupato di antropologia religiosa ed ha contestato la tesi tyloriana dell’animismo come prima forma di religione sostituendola con il concetto di mana nel suo volume Anthropology del 1912. Nella visione evoluzionista della storia Tylor e Marett consideravano le moderne società primitive come prove viventi delle prime fasi dell’evoluzione.
[19] Ivi: 19.
[20] A. Buttitta, Introduzione a G. Cocchiara, Preistoria e foklore, Sellerio, Palermo, 1978.
[21] Cfr. A. Cusumano, Nota a G. Cocchiara, Storia del folklore in Italia, Sellerio, Palermo, 1981: 249-263.
[22] E. De Martino, Gramsci e il folklore nella cultura italiana, in “Mondo operaio” 16 giugno 1951; cfr. Tra furore e valore: Ernesto de Martino, in “Il de Martino” n. 5-6, 1996. Per Gramsci, “egemonia” è l’insieme «dei modi non esclusivamente basati sulla forza coercitiva con cui viene mantenuta l’autorità». E questo aspetto del pensiero di Gramsci è fondamentale, perché «Il problema basilare della rivoluzione è come rendere capace di egemonia una classe fino a questo momento subalterna, fare in modo che creda in se stessa come classe potenzialmente dominante e risultare credibile in quanto tale ad altre classi». E come possiamo pensare di trasformare la vita umana «quando la massa popolare è esclusa dal processo politico e potrebbe anche essere lasciata scivolare nella depoliticizzazione e nell’apatia circa le questioni pubbliche?». Cfr. anche E. J. Hobsbawm, Come cambiare il mondo. Perché riscoprire l’eredità del marxismo, Rizzoli, Milano,2012: 319, 324, 332.
[23] A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino, 1950: 215-220.
[24] A. M. Cirese, Concezioni del mondo, filosofia spontanea e istinto di classe nelle “Osservazioni sul folklore” di Antonio Gramsci (1969-70). Questa nota è stata inserita come prefazione al testo di Cirese, Intellettuali, folklore, istinto di classe. Note su Verga, Deledda, Scotellaro, Gramsci, Einaudi, Torino, 1976: 65-104.
[25] P. Angelini, Dall’epistolario di Ernesto De Martino, in “Quaderni”, a- III, n. s. n-3-4, 1989: 164.
[26] Per lo storicismo “non assoluto” di De Martino, cfr. Gennaro Sasso, Ernesto De Martino. Fra religione e filosofia, Bibliopolis, Napoli, 2001.
[27] La lettera di Remo Cantoni a De Martino è del 28 gennaio 1941, cfr. Dall’epistolario di Ernesto De Martino (a cura di P. Angelini), in «Quaderni» A. III, n. s., n.3, 1989: 173-75.
[28] R. Pettazzoni, Prefazione a Miti e Leggende, vol. I, UTET, Torino, 1948.
[29] R. Pettazzoni, Prefazione a Miti e Leggende, vol. IV, UTET, Torino, 1959.
[30] E. De Martino, Intorno ad una storia del mondo popolare subalterno, in «Società», a. V, n. 3, 1949: 411-435.
[31] Ivi: 421-422.
[32] Ivi: 317.
[33] E. De Martino, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi dieci anni, in “Società”, a. IX, n. 3, 1953: 314.
[34] Ivi: 316-319.
[35] Il passo di B. Croce, riportato da De Martino, è in Letteratura della nuova Italia, Laterza, Bari, 1929 (3°ed.). L’interesse di Croce per il popolo napoletano è attestato anche dalle 13 lettere inedite piene di proverbi napoletani da lui raccolti e mandati a Vittorio Imbriani. Quando frequentava, licealista, il Collegio della Carità a San Marcellino, aveva l’abitudine di correre all’Università per ascoltarlo e Antonio Labriola, ricevuto l’opuscolo La leggenda di Niccolò Pesce, scongiurava il giovane allievo “a non perdersi in minuzie uso Imbriani”, Cfr. Benito Iezzi, Lettere di Croce a Vittorio Imbriani, in “Nord e Sud”, a. XXVI, n. 5, 1979: 157.
[36] A. Gramsci, Q. VIII, Tendenze populiste, in Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino, 1950:131.
[37] A. Gramsci, Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, Einaudi, Torino, 1917: 80, 217. Cfr. anche A. Labriola, Marx, (a cura di D. Bondì e A. Savorelli), Edizioni della Normale, Pisa, 2019.
______________________________________________________________
Sonia Giusti, già docente di Antropologia culturale e antropologia storica presso l’Università degli Studi di Cassino e Presidente del Corso di laurea in Servizio sociale. Ha lavorato sui temi trattati da Ernesto De Martino e Raffaele Pettazzoni e sullo storicismo inglese di Robin George Collingwood, oltre alle ricerche sui Diritti Umani e sulla storicità della conoscenza. Ha svolto seminari presso le Università di Roma, Urbino, Palermo e Oxford, presso la Bodleian Libraries. È autrice di diversi studi. Tra le più recenti pubblicazioni si segnalano i seguenti titoli: Forme e significati della storia (2000); Antropologia storica (2001); Percorsi di antropologia storica (2005).
_______________________________________________________________