di Vincenzo Maria Corseri
Francesco Postorino è un filosofo e saggista che molti lettori avranno già avuto modo di conoscere sulle pagine del settimanale L’Espresso. Ha svolto una robusta attività scientifica presso diverse università italiane e francesi occupandosi prevalentemente di neoidealismo, di esistenzialismo, di socialismo liberale e di pensiero cristiano. Nelle attuali ricerche sta approfondendo alcuni aspetti nodali della riflessione filosofica contemporanea come la postmodernità e il nichilismo.
Il metodo filosofico di Postorino si incentra sulla radicale esigenza di allargare in maniera sempre più dialogica il campo di ricerca sulla nostra storia identitaria e collettiva, promuovendo anzitutto un ragionamento che non può prescindere dalla relazione con l’altro. È un orizzonte ermeneutico, quello che si prospetta nella seguente intervista, che possiamo ben inserire nel solco della celebre questione crociana su ciò che della nostra cultura resta ancora segnato dal cristianesimo e che trova un suo punto di incontro nel dialogo tra filosofia e teologia.
Atene e Gerusalemme. Iniziamo con l’indagare questi due concetti generativi, inizialmente distinti, della nostra civiltà, frutto della fusione della filosofia greca e della sapienza biblica. Da quest’intreccio, un intreccio che riflette astratta razionalità da una parte e concreta vitalità dall’altra, emerge la storia del cristianesimo, definita da un pensatore sensibile come Sergio Quinzio “prototipo e madre della storia moderna”. In che termini la consapevolezza di quest’immenso patrimonio di saperi può aiutarci ad affrontare le sfide che ci arrivano dal mondo attuale?
«Richard Tarnas, nel suo bel volume The Passion of the Western Mind, sostiene che la storia culturale dell’Occidente offre strumenti indispensabili per affrontare le sfide del presente. Io vorrei provare a dire qualcosa di diverso. Premetto che la vita è più complessa degli schemi di cui mi servo. Tuttavia, credo che oggi sia più interessante soffermarsi su alcuni elementi simbolici che continuano a parlarci nel bene e nel male. Lo spirito greco, ad esempio, è sinonimo di liberazione dal mito e una conquista della ragione; ma l’uomo greco rischia di autocelebrarsi in un cosmo fine a se stesso, ed è talmente affezionato alla dimensione della “verità” che per raggiungere lo scopo, ovvero scoprire il succo dell’epistéme, viaggia troppo in alto in compagnia solo di concetti astratti e deduzioni, e dunque può precipitare facilmente nei labirinti di un superfluo intellettualismo.
Lo spirito ebraico è già un passo avanti perché incarna la “verità” di un imprevedibile cammino che si nutre di ascolto (“Shemà Israel”), di relazione e di calde aperture verso l’Altro al maiuscolo (Dio) o l’altro orizzontale (uomo), come si evince dalle splendide sollecitazioni che ci arrivano dal pensiero neo-ebraico del secolo scorso; ma anche qui si rischia di fabbricare idoli su idoli perché questo cammino nervoso e affascinante, per quanto superiore alle imperturbabili impronte dell’uomo greco, non è sorretto dal “limite infinito”.
L’uomo contemporaneo, che abita l’orizzonte postmoderno, può tentare la vittoria sul mondo se scende dai voli dell’epistéme e cammina per l’altro, lasciandosi guidare da quel “limite infinito” che ha intonato per la prima volta l’inaudito dell’amore».
Cosa intendi per “limite infinito”?
«Il “limite infinito” è la Luce sospesa tra l’Eterno e il tempo, il Volto che ha vissuto la terra e il cielo, il fratello del confine. Cristo è il “limite infinito”, il senso che sfugge al raziocinio greco (logos) e al pur prezioso cammino ebraico (derek). Egli, infatti, corregge l’afflato teoretico dei greci e il percorso di fiducia coltivato dagli ebrei. Uso questo paradosso (“limite infinito”) perché la croce non è “tutto”, non coincide con la storia o addirittura con il mondo, ma è appunto un limite, una via, una decisione, un atto, un istante rinnovato; anzi, la croce ha vinto il mondo, ovvero una libertà misteriosa ha vinto contro altre forme di libertà, una storia delicata e personale ha vinto contro i criteri che governano da sempre il “mondo”».
Cristo, allora, inaugura una nuova libertà?
«Una libertà infinita con un confine delicato che l’anima conosce in segreto. Il confine dell’amore! Se il confine vien superato, l’amore smette di soffiare, l’inedita libertà muore e irrompe quel che noiosamente accade nel fiume caotico dell’immanenza. Il limite dell’amore non significa amare con i “dovuti limiti”. Vale il contrario! Il limite dell’amore è la possibilità di amare intensamente e senza riserve all’interno di un’angolatura che ospita il mistero del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e del profumo della Domenica. Chi ama resta dentro il perimetro di questi tre giorni, i quali sono antitetici al week-end del Nichts, cioè di quel niente totalizzante che regala pezzetti di male e di grigio a uomini e donne di ogni tempo. La libertà misteriosa dei tre giorni si nutre di un amore che l’esperienza greca non comprende e quella ebraica ancora attende; quest’ultima, in particolare, è ferma al “dover essere”».
Il “dover essere”, secondo te, non è in sintonia con lo spirito cristiano?
«Il “dover essere” ha una lunga tradizione. Mi limito a ricordare quella moderna in senso lato e quella più antica dal respiro religioso. La prima è tipica del pensiero kantiano, che ha situato in due piani paralleli l’a priori dell’uomo (Sollen) e gli eventi che accadono progressivamente nella storia (Sein). Per Kant, infatti, l’a priori custodito dalla coscienza individuale e vivificato dalla libertà interiore, può replicare al cinismo del reale; in altri termini, solo l’imperativo del tu devi, solo una legge universale che splende nel cuore dei giusti, può sconfiggere il male che galleggia nella dimensione “sensibile” e fenomenica del divenire.
L’altro “dover essere”, quello religioso, è l’impulso che accompagna la tradizione ebraica. L’uomo ebreo deve rispettare fedelmente la Legge, deve amare Dio e i suoi fratelli, deve esser giusto. In effetti, vi sono nitide affinità tra i due imperativi, solo che quello di matrice kantiana e agnostica può fare a meno di Dio e riflette la condizione antropocentrica dello spazio moderno; l’imperativo ebraico non può prescindere dall’“Io sono colui che sono” (Es, 3,14), cioè dal nome di Dio.
Ora, il dover essere in generale, cui ero legato nella sua veste moderna, è nettamente superiore al “realismo” che condiziona i cuori pigri, ma è inutile e fuorviante se si mette al centro il corpo di Cristo, il quale vince sia la notte del “realismo” sia la luce poco chiara del “dover essere”. Grazie a Cristo, infatti, non è più necessario che io faccia appello al Sollen o che io debba amare. Semplicemente amo con nuova libertà e sono felice di sperimentare questa gioia interiore che non può farsi disciplinare laicamente dagli imperativi della coscienza e neppure da un Dio esterno e padrone. Nell’universo dell’a priori, rischio di dover amare una compagna, di dover amare mio fratello, di dover amare Dio o uno sconosciuto. Se seguo Cristo non corro questo rischio, dato che il tu devi sarà immediatamente spezzato con un semplice e libero “io amo”. Certo, anche il tu devi è un limite, ma è un limite freddo e restio a un’autentica libertà. Un limite che può essere superato in due modi: attraverso una via nichilistica, oppure grazie alla via cristiana.
La via nichilistica è quella propugnata da Nietzsche, secondo cui il tu devi simboleggia proprio l’emblema del cristianesimo e della metafisica, ovvero la scelta (non-scelta) di chi obbedisce a un imperativo e quindi sarà sempre schiavo; per il filosofo tedesco bisogna schiacciare il tu devi del cammello anzitutto con l’Io voglio del leone, e quando si è davvero liberi, l’Io voglio cederà al Sì emancipato e liberissimo del fanciullo, quel Sì che viene rivolto a tutto e al contrario di tutto, al bene e al male, a Dio e agli idoli, alla menzogna e alla verità, insomma alla vita nel suo confuso e insensato accadimento.
La via cristiana, al contrario, non solo non coincide con il tu devi, ma permette che questo limite venga superato dal “limite infinito”, quel corpo e quell’essenza che inoltre trasforma ogni residuo di Io Voglio nella Volontà del Padre, oppure il Sì del fanciullo nichilista nel Sì del fanciullo che ama. Chi fa entrare Cristo nel proprio vissuto non risiede più nella prima vita, in quanto inizia a vestire una carne e uno spirito che preannunciano il Cristo fa».
Che intendi con questa espressione?
«Il Cristo fa è il mio abbandonarmi in Cristo. Un abbandono che mi consente di non abbandonare nessuno. Se il mio agire diviene l’agire di Gesù, non litigo con te, non ambisco a traguardi dal sapore egocentrico e non vinco “nel” mondo. E se lascio fare alla Sua mano, il “limite infinito” annulla in un attimo il “realismo” dei muscoli e le deboli esclamazioni del “dover essere”, così il nuovo fanciullo dell’amore può muoversi tra i respiri affannati dell’“ora nona” e i battiti della Porziuncola».
“Non avrai altri dèi di fronte a me” (Es, 20,3). Possiamo dire che l’immagine di quell’unico Dio oggi è definitivamente tramontata o si prospetta ancora la probabilità che un giorno il Dio della tradizione tornerà a splendere come prima?
«Dipende se ascolto l’urlo della morte di Dio, oppure il grido della morte di Gesù. L’urlo, com’è noto, segna la pagina confusa della contemporaneità e mi suggerisce di abbassare gli occhi dal cielo e occuparmi con un ritmo concupiscente e meccanico di quel che si svela giorno dopo giorno nelle nostre consuete catene di montaggio. Il grido, invece, mi consiglia di lottare nel mondo, solo che mi offre altri occhi (quelli di Giobbe), un’altra Parola e un’inedita narrazione che non smette di situarsi nel “tra” verticale e nel “tra” orizzontale; il primo “tra” accende la tensione tra me e Cristo, e il secondo richiama la tensione tra me e te entro il mistero dello Sguardo.
Più che il “Dio della tradizione”, preferisco usare l’espressione “Dio dell’amore”, una tautologia necessaria per rievocare quel limite: Cristo. La nostra epoca va oltre il “limite infinito”, oltre Dio, oltre l’uomo, oltre l’amore, e prova a introdurre un contatto tra il fanciullo nichilista di Nietzsche e “l’ultimo dio” invocato da Heidegger, ovvero l’ennesima esaltazione di un idolo che mi fa perder tempo, cioè mi fa perdere il tempo dell’amore».
Richiamare in seno al dibattito odierno l’assoluta singolarità del Dio cristiano, caratterizzato dall’essere persona, un Dio che incorpora e accetta in sé la sofferenza fino alla conseguenza della passione e della morte, è una condizione che sicuramente ci consente di accostare con maggiore autonomia di giudizio il complesso e delicato confronto tra verità e libertà, tra relativismo e fede. Mi piacerebbe sapere qual è il tuo punto di vista su un tema così apparentemente impalpabile quanto radicalmente presente nella nostra contemporaneità.
«Quando uso l’espressione “limite infinito” intendo fissare i segni inconfondibili dell’amore. Si tratta, tuttavia, di una “fissità dinamica”, perché l’amore non lo fermi, non lo chiudi ad esempio nelle sceneggiature mortifere del tradizionalismo. Cristo stesso non è fermo e cammina con agilità superando eternamente le categorie predilette dal vecchiume. Il suo Volto travalica i miei atti di superbia, cancella con il sorriso i miei giudizi paternalistici verso il mio tu, distrugge il mio star seduto e ironizza con amore sulle mie (umane) convinzioni. Oggi siamo chiamati, da un lato, a rimuovere le categorie che rinviano gli appuntamenti con la Verità, e dall’altro a farci “vuoto” per vincere il mondo e offrirci senza tergiversare alla prossima alterità».
 In Dopo Dio (Raffaello Cortina, Milano 2018:272-273), il filosofo tedesco Peter Sloterdijk afferma: “La deriva catastrofica del processo globale rende oggi necessario riflettere sulla creazione di un’unità di solidarietà comprensiva che sia sufficientemente forte da fungere da sistema immunitario per il tutto indifeso – questo tutto indifeso che chiamiamo natura, Terra, atmosfera, biosfera o antroposfera […] Ne deriva che, oggi, il filo conduttore dell’agire dice: agisci in modo che attraverso le conseguenze del tuo agire venga supportato o, per lo meno, non impedito il sorgere di un sistema globale di solidarietà; agisci in modo tale che la normale prassi del saccheggio e dell’esternalizzazione in uso fin qui possa essere sostituita da un ethos della protezione globale; agisci in modo tale che dalle conseguenze del tuo agire non derivino ulteriori perdite di tempo per la svolta inevitabile nell’interesse di tutti”. Vorrei chiederti un breve commento di questo brano.
In Dopo Dio (Raffaello Cortina, Milano 2018:272-273), il filosofo tedesco Peter Sloterdijk afferma: “La deriva catastrofica del processo globale rende oggi necessario riflettere sulla creazione di un’unità di solidarietà comprensiva che sia sufficientemente forte da fungere da sistema immunitario per il tutto indifeso – questo tutto indifeso che chiamiamo natura, Terra, atmosfera, biosfera o antroposfera […] Ne deriva che, oggi, il filo conduttore dell’agire dice: agisci in modo che attraverso le conseguenze del tuo agire venga supportato o, per lo meno, non impedito il sorgere di un sistema globale di solidarietà; agisci in modo tale che la normale prassi del saccheggio e dell’esternalizzazione in uso fin qui possa essere sostituita da un ethos della protezione globale; agisci in modo tale che dalle conseguenze del tuo agire non derivino ulteriori perdite di tempo per la svolta inevitabile nell’interesse di tutti”. Vorrei chiederti un breve commento di questo brano.
«L’imperativo (kantiano) “agisci”, a mio avviso, andrebbe sostituito con un “agisco”. Lo spirito cristiano, nel suo tratto autentico e drammatico, non chiede ad altri di agire per costruire un mondo migliore. In un certo senso, un cristiano non dovrebbe neppure pensare di migliorare il mondo. Ciò che conta è vincere il mondo, ma per vincerlo io non posso chiedere al mio “tu” di muoversi e sacrificarsi. Non posso chiedere a te, o alla comoda “umanità”, ciò che io posso fare per primo con vera libertà. Non solo! Se mi muovo all’interno del Suo sguardo, smetto di scrivere e parlare con registro moralistico e faccio subito quel che è già scritto, col sangue, nel foglio bianco dell’inaudito».
Simone Weil sosteneva che “il rischio è una necessità essenziale dell’anima”. Tenendo conto della precarietà della condizione umana, ritieni che l’uomo di oggi sia ancora in grado di rischiare?
«Vorrei partire da una distinzione cui tengo molto e che mi permette di avvicinarmi alla condizione di rischio. Credo che occorra distinguere in maniera netta la religione dalla fede. La religione è troppo sicura di sé, e il suo soldato dondola con ritmo autistico nella giostra profetizzata, ancora una volta, da Nietzsche. L’uomo religioso è colui che si allontana da Dio e abbraccia l’“idolo”, cioè un dio al minuscolo che soddisfa le mie mancanze e mi rende finalmente “sereno”. L’uomo religioso vuol difendere Dio contro gli atei, i “poco cristiani” e gli uomini di altre religioni, e dunque conduce una battaglia orale o digitale contro i presunti nemici di Dio. L’uomo religioso difende le categorie e non ama il “corpo”, e vede in Dio quel boss mafioso e onnipotente che può esaudire i miei capricci. L’uomo religioso è seduto, sarcastico, rumoroso, triste, infelice e “in pace” (la pace del mondo, non quella inaugurata dallo Sguardo!). L’uomo religioso non rischia!
La fede, invece, è una bellezza che spaventa. Il dono più alto, direbbe Kierkegaard, dell’insicurezza che investe chi insegue l’Eterno. Chi resta nella piccolissima cornice della croce, non ha tempo per la bugia degli idoli e vede in Cristo l’unica possibilità di sfuggire alle categorie del mondo e di amare nel disturbo. Perché l’amore è un eterno disturbo, una goccia di nervosismo che i circoli della matematica ignorano. La fede è il rischio di chi non sa ma sente. La religione è la certezza dell’avere; mentre la fede è l’insicurezza della è. Chi ama, nella fede, scende dai suoi facili postulati e rischia per rifare maldestramente l’“ora nona”.
Gesù abita nel “mondo” ma il suo cuore si posa nell’“Eden”, quel giardino offeso dalle miserie di Adam e recuperato all’ultimo istante, o al primo istante, da Maria di Màgdala, che vede per prima, e nel “giardino”, il Risorto. Cristo ha vissuto la tensione tra mondo e giardino per me e adesso mi chiede di innescare la mia personalissima tensione tra mondo e giardino per il tu e per l’Amore.
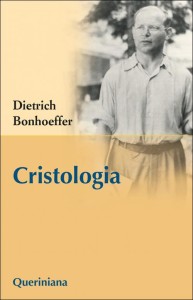 Per rispondere alla tua domanda, non so dirti se l’uomo di oggi sia in grado di rischiare. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: chi sono io? Sono un uomo religioso o un uomo di fede? Seguo Lui o le immagini effimere della contingenza? Sposo l’amore nella sua nuda concretezza (il Volto), oppure faccio l’amore con la poltrona? Mi rinchiudo nel mio “essere-nel-mondo”, per dirla con Heidegger, dove al centro si muove un Dasein imprigionato nella sua asettica situazione, oppure mi trasformo in “essere-per-gli-altri”, come direbbe Bonhoeffer? Spingo e disturbo le categorie del mondo, o faccio tutt’uno con i giuochi dialettici del suolo? Voglio il mondo o il giardino? Difendo la “città” inventata da Caino (Gen, 4, 17), oppure amo gli inquilini della città? Amo quell’uomo perché amo Cristo, oppure proteggo con cuore indurito e fondamentalista una legge, una istituzione, una consuetudine, un’idea proprio a scapito di quell’uomo?».
Per rispondere alla tua domanda, non so dirti se l’uomo di oggi sia in grado di rischiare. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi: chi sono io? Sono un uomo religioso o un uomo di fede? Seguo Lui o le immagini effimere della contingenza? Sposo l’amore nella sua nuda concretezza (il Volto), oppure faccio l’amore con la poltrona? Mi rinchiudo nel mio “essere-nel-mondo”, per dirla con Heidegger, dove al centro si muove un Dasein imprigionato nella sua asettica situazione, oppure mi trasformo in “essere-per-gli-altri”, come direbbe Bonhoeffer? Spingo e disturbo le categorie del mondo, o faccio tutt’uno con i giuochi dialettici del suolo? Voglio il mondo o il giardino? Difendo la “città” inventata da Caino (Gen, 4, 17), oppure amo gli inquilini della città? Amo quell’uomo perché amo Cristo, oppure proteggo con cuore indurito e fondamentalista una legge, una istituzione, una consuetudine, un’idea proprio a scapito di quell’uomo?».
A proposito di domande esistenziali, Buddha e Cristo, di fronte agli interrogativi che nascono dalla limitatezza umana, oppongono il silenzio come superamento di ogni risposta. Quale valore possiamo dare al silenzio?
«Il silenzio è vicino alla morte, anche per questo affascina e terrorizza. Pensiamo al silenzio che circonda le pareti del Sabato misterioso che segue la morte di Gesù e anticipa la sua resurrezione. È il Sabato delle inquietudini, dell’angoscia, dello sgomento, del vissuto mistico, di un perché che non riceve nessuna risposta umana o divina. In fondo, è il nostro Sabato! Il Sabato della mia ferita più radicale e nascosta che tu mai saprai. Il Sabato del dolore più acuto e grave, dove non vi è luogo e ragioni per metter bocca. Il Sabato che sospende ogni definizione, concetto, protezione, “fede”. Ma vi è anche il silenzio dello stupore, il silenzio che prepara una voce più attenta e responsabile, il silenzio che ti sta dicendo con pathos: “Io ti ascolto davvero!”, il silenzio che ama il due, il silenzio che colora di bianco il nostro libro, il silenzio che rende simili e deprecabili il caos e il mutismo che accompagnano i “profili” della post-modernità.
Il più importante è naturalmente il silenzio dell’amore, che ride di ogni parola, supera ogni verso, vince ogni dialettica, fotografa l’incanto con mano sudata. Bisogna educarsi presto ai suoi disorientamenti. I bambini e gli adolescenti, infatti, dovrebbero iniziare con la priorità del sentire. Perché il silenzio, incompatibile con lo “star muti”, è un barlume di chiarezza e ti permette di ascoltarti, di scoprirti, di esplorare l’uno, il due e il circostante. Il silenzio non sarà mai “post-umano” e non potrà mai assoggettarsi alla volontà di potenza di un superuomo. Il silenzio suggerisce il vero pianto. Il silenzio è “mancante” ed è propedeutico al vuoto per e con. Oggi, del resto, sia l’urlo che il mutismo vanno a braccetto e costituiscono il “pieno” e la sciocca soddisfazione che investe la natura suina e narcisistica dei protagonisti del duemila. Il silenzio distrugge le sporcizie, le sovrastrutture, l’inutile ma anche l’“utile”, e accende i desideri del gratuito, di una nuova alba, di un nuovo cammino, di una inguaribile tensione, e ti fa star sveglio di notte, ti offre l’opportunità di disegnare stelle interiori o di vedere meglio quelle che dimorano in cielo. Il silenzio è il grido più forte della verità!».
Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020
______________________________________________________________
Vincenzo Maria Corseri, dottore di ricerca in Filosofia, ha svolto attività seminariali presso la cattedra di Storia della filosofia medievale dell’Università degli Studi di Palermo e insegnato Estetica, come docente a contratto, presso l’Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani. È stato collaboratore della Facoltà Teologica di Sicilia per la redazione del Dizionario Enciclopedico dei Pensatori e Teologi di Sicilia. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Recentemente ha curato, insieme a Giuseppe L. Bonanno, il volume Cultura storica e tradizioni religiose tra Selinunte e Castelvetrano, una raccolta di studi sulla storia religiosa e culturale del territorio selinuntino (Istituto Euroarabo, Mazara del Vallo 2018). È ricercatore ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica).
_______________________________________________________________










