
Otto D’Angelo, pittore friulano popolare (1923-2018),Vigilia di festa: la preparazione delle ‘tajadéris’
speciale cirese
di Gian Paolo Gri
Anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, nel Friuli “area laterale” (etno-linguisticamente), per tanti versi analogo alla Sardegna: nelle nostre etnografie regionali di allievi in dissenso da maestri che erano discepoli di Toschi e di giovani incantati dal nuovo e buon piffero di Cultura egemonica e culture subalterne, guardavamo con invidia e cercavamo di imitare quel che accadeva nell’Isola intorno all’Atlante demologico sardo e al Brads. Nell’imitazione alcune cose funzionavano, altre meno. Funzionava poco ad esempio, il questionario su Tipi e denominazioni del pane e non era pensabile che potessimo ricavarne quel che se ne derivò invece Cagliari, a partire da Plastica effimera in Sardegna (1973 e 1976) fino ai Pani dell’editrice Ilisso (2005).
 Bene, naturalmente, la lezione sulla ‘biplanarità’ dei pani – «pane che nutre, pane che dice», con tutte le implicazioni –, ma in Friuli non potevamo certo affermare come Cirese che «i pani ci abbagliarono» per «il gioco vertiginoso» della modellazione figurativa dell’effimero. Il mondo contadino del nostro Nordest non partecipava alla civiltà mediterranea del grano e alla cultura del pane illustrate da Giulio Angioni; era segnata piuttosto da quattro secoli di polenta, prima che anch’essa, dagli anni cinquanta e sessanta del Novecento, venisse sentita come emblema di una povertà da dimenticare, messa ai margini, trasformata poi in alimento per buongustai. Non che nei secoli precedenti il grano mancasse, ma era coltivato per altri, per i padroni e per il mercato.
Bene, naturalmente, la lezione sulla ‘biplanarità’ dei pani – «pane che nutre, pane che dice», con tutte le implicazioni –, ma in Friuli non potevamo certo affermare come Cirese che «i pani ci abbagliarono» per «il gioco vertiginoso» della modellazione figurativa dell’effimero. Il mondo contadino del nostro Nordest non partecipava alla civiltà mediterranea del grano e alla cultura del pane illustrate da Giulio Angioni; era segnata piuttosto da quattro secoli di polenta, prima che anch’essa, dagli anni cinquanta e sessanta del Novecento, venisse sentita come emblema di una povertà da dimenticare, messa ai margini, trasformata poi in alimento per buongustai. Non che nei secoli precedenti il grano mancasse, ma era coltivato per altri, per i padroni e per il mercato.
Sulla tavola contadina, in pianura e in montagna, ai menudi e succedanei era subentrato il mais. La preghiera per il pane quotidiano era formula generica perché da invocare era semmai la fetta quotidiana di polenta, e «se la polente a è pìciule, ten strete la fete in man!» (se la polenta è piccola, tieni stretta la fetta in mano, falla durare più a lungo che puoi); al limite, «polente e pits», polenta e punta di dita da leccare, quando manca anche il companatico; oppure «polente e lenghe», polenta e chiacchere: una lingua impegnata a impastare parole aiuta a dimenticare la fame. In ogni contesto, anche in quello lavorativo, pane e polenta “dicevano” una obbligata e dura gerarchia: e se prima pane bianco si opponeva a pane nero (di segale, sorgo, orzo, miglio, avena, castagne e altro, e peggio ancora con le misture – fino ai gusci macinati dei legumi e alla segatura di corteccia d’abete – in tempi di carestia), dopo l’invasione del mais «Pan al paròn, polente al garšòn», e che il garzone stesse al suo posto, non coltivasse pensieri sovversivi!
 Anche i sogni di Cuccagna si erano progressivamente conformati (un mare di tòcjo intorno a montagne di polenta), anche nel mondo contadino friulano e veneto trascinato lontano dall’emigrazione a ricostruire se stesso nell’altro emisfero: «Evviva la Merica la grande cucagna / Se beve e se magna e ligeri se stà». A proposito di “leggera”: pochi anni fa (nel 2008) è stata finalmente, dopo quasi un secolo, tradotta ed edita in italiano la bella Vita e stória di Nanetto Pipetta nassùo in Italia e vegnudo in Merica per catare la cucagna, scritta nei primi anni Venti da Aquiles Bernardi (fra Paulino de Caxias) nel veneto/brasiliano del Rio Grande do Sul [1]. Già nel titolo la trasfigurazione narrativa delle avventure del Nane toso/monello è posta sotto l’ombrello mitico-alimentare della secolare Cuccagna contadina: insieme con il sorprendente incontro con l’abbondanza cuccagnesca della natura di laggiù, c’è anche il fascinoso re-incontro con i sapori di casa reinventati, segnati però e finalmente dall’abbondanza: non più fetine di polenta «con salame rostìo», ma fetone, tante e tante, a volontà, «da sbregarse la pansa».
Anche i sogni di Cuccagna si erano progressivamente conformati (un mare di tòcjo intorno a montagne di polenta), anche nel mondo contadino friulano e veneto trascinato lontano dall’emigrazione a ricostruire se stesso nell’altro emisfero: «Evviva la Merica la grande cucagna / Se beve e se magna e ligeri se stà». A proposito di “leggera”: pochi anni fa (nel 2008) è stata finalmente, dopo quasi un secolo, tradotta ed edita in italiano la bella Vita e stória di Nanetto Pipetta nassùo in Italia e vegnudo in Merica per catare la cucagna, scritta nei primi anni Venti da Aquiles Bernardi (fra Paulino de Caxias) nel veneto/brasiliano del Rio Grande do Sul [1]. Già nel titolo la trasfigurazione narrativa delle avventure del Nane toso/monello è posta sotto l’ombrello mitico-alimentare della secolare Cuccagna contadina: insieme con il sorprendente incontro con l’abbondanza cuccagnesca della natura di laggiù, c’è anche il fascinoso re-incontro con i sapori di casa reinventati, segnati però e finalmente dall’abbondanza: non più fetine di polenta «con salame rostìo», ma fetone, tante e tante, a volontà, «da sbregarse la pansa».
Questo è lo scenario che dà significati all’espressione proverbiale che anche in Friuli deplora «la cjòche dal pan», l’ubriacatura di pane, perché peggiore di quella di vino in quanto «cjòche triste», cattiva. Si tratta di una sapienza venuta da lontano (già nei Proverbi di Salomone (30, 21-23) fra «le tre cose che fanno fremere la terra, anzi le quattro che essa non può tollerare», c’è «lo stolto che si gonfia di pane»), ma in Friuli il modo di dire («A è ben triste la cjòche dal pan!») non rimanda genericamente agli stolti, ma la connotazione che la tristérie ha nella lingua friulana la imparenta con la malizia e la perfidia, la rende matrice di sventure.
La cjòche dal pan è cosa triste quando a ubriacarsi di pane è il povero: allora diventa peggiore di quella del vino perché non è figlia della festa oppure dell’infelicità, non è un’ubriacatura che matura nella condivisione della gioia o nella ricerca di smemoratezza; in questo caso si beve pane sottratto ad altri; si tratta di un’ingordigia che non è fatto personale, ma sventura comunitaria. L’ontologia del bene limitato che regge il gioco delle sorti di Ozieri [2] vale anche qui. La cultura popolare non si è mai fatta illusioni sui ricchi («Il sior al pisse tal jet e al po’ gî atòr a dî: iòi ce sudàde!»: il ricco piscia nel letto e poi può andare in giro a dire, soddisfatto e senza smentite: che bella sudata!), ma è altrettanto diffidente del povero che è diventato ricco, del servo che si fa padrone. Finisce con il rimpianto per il padrone di prima, perché «Cui ca nol’à pui dibisùgna no si ricuarda nèncja dai pedôi di so mari»: chi è uscito dalla palude del bisogno dimentica perfino i pidocchi di sua madre.

Otto D’Angelo, pittore friulano popolare ( 1923-2018), La scartocciatura serale delle pannocchie di mais
La polenta segnava la quotidianità del mondo contadino a Nordest; si direbbe un mondo di monotonia alimentare, e invece per ritrovare creatività e variazioni si legga «Polenta e…» di Giosuè Chiaradia [3]. Da mettere in conto è però la dimensione rituale, ed è su questo fronte che la documentazione restituisce pane e farina di frumento anche a livello popolare, benché la «cerimonializzazione dei pani», per dirla con Cirese, e il predominio della segnicità e del gusto del bello nella gerarchia delle funzioni resti a livelli ben inferiori a quelli sardi. Accanto alla man di pan ordinaria e al riuso del pane raffermo nella sope per la puerpera e nella panàda per piccoli e vecchi sdentati, la “messa in forma” di livello più alto si direbbe raggiunta in Friuli con la modellazione a ciambella (il colàč dei matrimoni, delle sagre e da infilare al collo del cresimando: ma l’origine slava del termine parla di un’area di cultura alimentare ampia, a scavalcare i confini linguistici ed etnici, così come per la gubàna [4]) e a treccia: ma siamo sul confine con il terreno dei dolci festivi (natalizi, pasquali, per carnevale), dei pani arricchiti, dei biscotti “calendariali”; qui si moltiplicano gli aggettivi e i complementi che hanno accompagnato alcuni pani fino a qualche decennio fa: pan dolč, pan indorât, pan zâl, pan cu lis frizzis, pan di San Valantìn, pan di San Culàu a forma di krampus sul confine nordorientale. E soprattutto il pan dai muàrts, il pan di casse. Il pane “in memoria”: un bel tema!
Nella seconda metà del Cinquecento, il notaio cividalese Marcantonio Nicoletti poteva presentare come ormai fissata nella tradizione dei friulani la pratica medievale di un lascito testamentario con il duplice scopo di «lasciare una sempiterna memoria di sé» e un suffragio per i propri peccati. Queste disposizioni erano definite pauperilia. Un’elemosina dal carattere particolare, che prevedeva la distribuzione «in specie di pane, vino, fava, carni ed altro»; soprattutto i possidenti (a rimedio «delle cose mal tolte in vita», magari inavvertitamente) disponevano un legato che obbligasse all’elemosina gli eredi, così che ogni anno «nella deposizione e, di anno in anno, nelle Quattro Tempora si portavano ai sepolcri pane e vino e dopo devoti prieghi a Dio per l’anima dei defunti, si mangiava e beveva dai presenti»[5].
Si tratta di una tradizione di lungo periodo. Sono molte le fonti documentarie nel tardo medioevo e in età moderna che contengono informazioni dirette o indirette sul fenomeno della distribuzione di alimenti “in memoria”: testamenti, obituàri, registri di spesa di confraternite e chiese, cronache, sinodi (con le ripetute proibizioni di canti, danze, consumo di cibi e bevande durante i riti funebri e manifestazioni d’allegria durante le veglie; con le condanne contro “abusi” derivanti dalla permanenza di usi legati alla doppia sepoltura e proibizioni ripetute di deporre cibo e consumarlo sopra le tombe, come nel Sinodo di Concordia del 1587, di Udine del 1610, di Capodistria del 1637, per citare soltanto alcuni casi), e altre tipologie di documenti ancora.
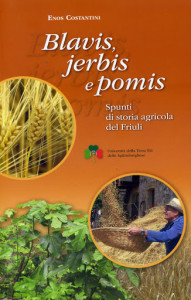 Il dono e il consumo alimentare comunitario ritmavano l’intero calendario della civiltà contadina nelle occasioni in cui più radicato appariva il legame con il culto dei morti: la benedizione delle tombe la prima domenica del mese (lis vìliis, “le vigilie”), le Dodici Notti, le rogazioni (il dono del pane e del vino a chi «andava drìo le crose», come recitavano i legati testamentari), le Quattro Tempora, il Venerdì Santo, la Vigilia del Natale (quando ancora conservava uno spiccato carattere funebre); ma, a guardare oltre la facciata, cogliendo il senso profondo della “religione cosmica” contadina, a quelle occasioni andrebbero aggiunte anche le questue dei mascherati e i doni alimentari ai questuanti di maggio [6].
Il dono e il consumo alimentare comunitario ritmavano l’intero calendario della civiltà contadina nelle occasioni in cui più radicato appariva il legame con il culto dei morti: la benedizione delle tombe la prima domenica del mese (lis vìliis, “le vigilie”), le Dodici Notti, le rogazioni (il dono del pane e del vino a chi «andava drìo le crose», come recitavano i legati testamentari), le Quattro Tempora, il Venerdì Santo, la Vigilia del Natale (quando ancora conservava uno spiccato carattere funebre); ma, a guardare oltre la facciata, cogliendo il senso profondo della “religione cosmica” contadina, a quelle occasioni andrebbero aggiunte anche le questue dei mascherati e i doni alimentari ai questuanti di maggio [6].
In Carnia resiste ancora il termine medievale per indicare la pratica antica della distribuzione di pane e vino (e di sale, in alcune località) dalla famiglia in lutto alla comunità che interviene al funerale e alle commemorazioni: limuésine, elemosina, si dice ancora, e il termine conserva integri, al proprio interno, i significati originari della misericordia e della compassione, aggiungendovi quello della condivisione e reintegrazione comunitaria attraverso l’offerta alimentare. Due poli integrati: la distribuzione verticale di alimenti ai poveri (in termini di assistenza e solidarietà; e, almeno indirettamente, con la funzione conseguente di confermare la diseguaglianza sociale) e la distribuzione e il consumo degli alimenti in orizzontale, nel segno della reciprocità, a coinvolgere la comunità intera: da tutti, verso tutti, all’interno del paese.
La scrittrice Caterina Percoto, a metà Ottocento, aveva colto perfettamente e ben descritto il senso della «questua delle anime» sul fronte comunitario, definendola «un’antica pratica in molti luoghi del Friuli» che caratterizzava la vigilia della Commemorazione dei defunti. Scrive, nel racconto Il pane dei morti: «Ogni famiglia nel dì d’Ognissanti dispensa al popolo una quantità di pane a seconda della propria agiatezza. Vengono a riceverlo tutti gli abitanti del villaggio, e prima di assaggiarle, pregano per i defunti del donatore»; tutti offrono e tutti chiedono, a turno, ricchi e poveri, «mettendo così, almeno una volta l’anno, in comunione il cibo, l’affetto e la preghiera».
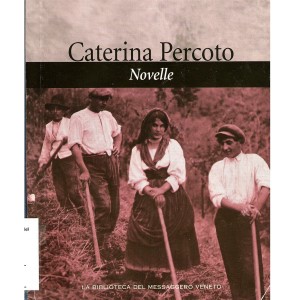 Non serve sottolineare l’ampia portata comparativa di questa tradizione del “pane dei morti”, e basterà soltanto richiamare il fatto che le coordinate etnografiche del “cibo in memoria” sono altrettanto ampie. Mi limito a ricordare il nesso fra alimentazione e dono (con il problema della reciprocità positiva e negativa che ne deriva: Dono e malocchio di Clara Gallini [7], per intenderci) e fra alimentazione e questua, con il problema delle funzioni che la questua rituale assolveva (e assolve) e del significato sostitutivo che al suo interno assumevano (e assumono) gli alimenti e le diverse categorie e figure di questuanti: poveri, koledari, coscritti, bambini, cantori, mascherati. Das Grab als Tisch ha più di un secolo: il saggio era apparso nel secondo tomo (1910) della rivista “Wörter und Sachen” di cui Mathias Murko era stato co-fondatore ad Heidelberg [8].
Non serve sottolineare l’ampia portata comparativa di questa tradizione del “pane dei morti”, e basterà soltanto richiamare il fatto che le coordinate etnografiche del “cibo in memoria” sono altrettanto ampie. Mi limito a ricordare il nesso fra alimentazione e dono (con il problema della reciprocità positiva e negativa che ne deriva: Dono e malocchio di Clara Gallini [7], per intenderci) e fra alimentazione e questua, con il problema delle funzioni che la questua rituale assolveva (e assolve) e del significato sostitutivo che al suo interno assumevano (e assumono) gli alimenti e le diverse categorie e figure di questuanti: poveri, koledari, coscritti, bambini, cantori, mascherati. Das Grab als Tisch ha più di un secolo: il saggio era apparso nel secondo tomo (1910) della rivista “Wörter und Sachen” di cui Mathias Murko era stato co-fondatore ad Heidelberg [8].
A dire quanto fosse e resti importante quell’intervento di Murko sul tema della “tomba come mensa”, basti questo: nel suo bel contributo dedicato nel 1930 sulla seconda annata delle “Annales” all’utilità dello scambio reciproco fra storici e linguisti (Les mots et les choses en histoire économique), Lucien Febvre proprio questo saggio di Murko citava come esempio di ricerca multidisciplinare, diverso dai tanti contributi linguistici che restavano ancorati al semplice dato tecnico della storia della parola e alla storia formale dell’oggetto designato. Occorreva di più, scriveva Febvre: attenzione ai contesti e al legame con la comunità e la cultura, nel loro processo di trasformazione; solo così il nesso parole/cose si sarebbe trasformato in traccia utile anche per gli storici e gli etnologi, nel loro sforzo di cogliere nelle culture subalterne, attraverso metodi indiretti e obliqui, il livello profondo, sottostante, dei significati e delle funzioni assolti da pratiche culturali radicate e diffuse, scarsamente illuminate dalla sola documentazione scritta. Il saggio di Murko appariva a Febvre esemplare anche nella sua capacità di raccordare la tradizione antica del rapporto fra culto dei morti, rituali funebri e pratiche alimentari connesse con il sacrificio (come non evocare il capitolo sesto dell’Homo necans di Walter Burkert, che verrà alcuni decenni dopo, nel 1972?), con le pratiche rituali ancora vive e attive nella documentazione dell’etnologia europea contemporanea.
Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021
Note
[1] Edizione a cura di F. Toso, Genova-Udine (Centro internazionale sul plurilinguismo) 2008. Rimando al mio Il valore simbolico del cibo. Dalle etnoscienze all’antropologia delle migrazioni, in “Oltreoceano, 4/2010 (atti del convegno L’alimentazione come patrimonio dell’emigrazione nelle Americhe, a cura di S. Serafin e C. Marcato): 27-33.
[2] La prima versione del saggio capitata (ma solo nel 1970) nelle mie mani è stata L’assegnazione collettiva delle sorti e la disponibilità limitata dei beni nel gioco di Ozieri e nelle analoghe cerimonie vicino-orientali e balcaniche, in Atti del Congresso di studi religiosi sardi, Padova 1963: 175-193; poi ho letto via via le stesure successive.
[3] G. Chiaradia, Polenta e magnar nostran, in Caneva, Udine 1997; ora anche G. e R. Chiaradia, Alimentazione tradizionale in Friuli, Udine 2018 e E. Costantini, Blavis, jerbis e pomis. Spunti di storia agricola del Friuli, Spilimbergo 2016. I testi di cucina regionale si sono moltiplicati, ma resta fondamentale l’ormai storico G. Perusini Antonini, Mangiare e bere friulano, Milano 1976.
[4] Si vedano le note sul kolač e sui dolci rituali (per il matrimonio, soprattutto) in J.W. Valvasor (1689); sua l’annotazione – comparabile forse con la tradizione dei pani cerimoniali di Sardegna – che i benestanti usavano aggiungere all’impasto di pane bianco, del kolač e della pogača nuziale anche «decorazioni fatte con la pasta stessa». Si veda il saggio di M. Bidovec, Valvasor e la buona tavola, in “Palaver” 9 (2020), n. 2: 59-93; il numero della rivista contiene gli atti, a cura di R. Dapit, del convegno internazionale “Il patrimonio alimentare nell’area di contatto fra le Alpi e l’Adriatico” (2019).
[5] G. Perusini, Notizie di folklore in uno storico friulano del ‘500, in “Lares”, 24 (1958): 55-60; G.P. Gri, Ricchi e poveri, morti e minestre, in Fagagna. Uomini e terra, a cura di C.G. Mor, Fagagna 1983: 379-407.
[6] Sul carattere funebre del maggio, G. Ferigo, I nuvìz, la fantasima, il mus. Note sull’interdizione matrimoniale di maggio. Secoli XVI-XIX , ora in “Morbida facta pecus…”. Scritti di antropologia storica della Carnia, Udine 2012: 219-276 (il saggio è del 1998).
[7] C. Gallini, Dono e malocchio, Palermo 1973 (I doni funebri alle pp. 45-50).
[8] “Wörter und Sachen”, b. II (1910): 79-160.
______________________________________________________________
Gian Paolo Gri, già ordinario di Antropologia culturale nell’Università di Udine, ha svolto ricerche nei settori dell’etnologia alpina, dedicando particolare attenzione agli aspetti simbolici dei corredi materiali, ai saperi, alle pratiche e alle rappresentazioni dell’artigianato tradizionale (Tessere tela, tessere simboli, 2000; Modi vestire, modi d’essere, 2004); dell’antropologia storica (Altri modi. Etnografia dell’agire simbolico nei processi friulani dell’Inquisizione 2002; Dare e ricambiare nel Friuli di età moderna, 2007) e dell’antropologia museale. Molte le analisi e gli interventi in tema identità, etnicità e riconfigurazione dei confini culturali nella contemporaneità e in riferimento particolare alle mutazioni in atto nel contesto nordorientale italiano ((S)confini, in nuova ed. 2015).
______________________________________________________________







