il centro in periferia
di Eugenio Imbriani
Una mostra e Bucherer
Antonio Leonardo Verri (1949-1993) è stato un importante scrittore, poeta, intellettuale che ha operato intensamente nel Salento, l’estrema propaggine della Puglia, negli ultimi decenni del secolo scorso. In una vita breve, interrotta tragicamente a causa di un incidente stradale, sono state davvero molte le iniziative a cui ha dato vita e ha partecipato, editoriali (produzione di riviste e collane, pubblicazione di testi poetici e in prosa) e organizzative (mostre, per esempio, varie occasioni di dibattito, e penso anche all’impegno nel Sindacato nazionale scrittori). Aveva la capacità di tessere relazioni, di trovare il bello in figure marginalizzate, dalle vite difficili, come il pittore Edoardo De Candia, che lo ha ritratto, il poeta Salvatore Toma, a cui era legato da una devota amicizia; era proprio questo sentimento, l’amicizia, la base preliminare delle collaborazioni che intrecciava, ci voleva poco a farla maturare.
Alto, barbuto, di statura imponente, accompagnava i suoi movimenti con una spontanea goffaggine che ne palesava il tratto gentile; aveva però un carattere solido, che gli consentiva un’attività intensa, una grande capacità di lavoro e di progettazione. Dopo la sua morte, con l’andare del tempo, Verri non è stato dimenticato, ma, al di là della cerchia di quanti gli erano più vicini, la sua produzione era poco conosciuta, perché faticosa da reperire, e anche per effetto di una scrittura difficile, sperimentale, complessa, oscura; intanto, tra i giovani studiosi e letterati che non hanno potuto conoscerlo è cresciuta la curiosità per i suoi scritti, il suo pensiero, la sua poetica.
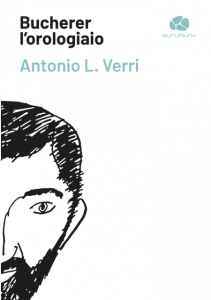 A questa esigenza risponde ora una duplice iniziativa: la riedizione delle opere, a cominciare dall’ultima, Bucherer l’orologiaio, postuma, su cui mi soffermerò dopo, e una mostra, che ha luogo nella città di Lecce, dal titolo «Verri Antonio Leonardo. Una stupenda generazione», che prevede tappe e allestimenti aggiuntivi; il primo segmento, che durerà, partendo dal 12 dicembre scorso, fino al 15 aprile prossimo, consiste nella esposizione di una serie di pannelli lungo il muro perimetrale del Museo Castromediano di Lecce, che recano disegni di artisti amati da Verri e brevi citazioni, particolarmente evocative, tratte dai suoi testi; la seconda sezione, «Documentaria», ospitata negli ampi spazi della Biblioteca Bernardini, a Lecce, è stata inaugurata il 29 dicembre 2021, è pensata come un archivio, da implementare, dei materiali prodotti da Verri (prime edizioni, riviste, dipinti, immagini, qualche manoscritto) e da testimonianze relative al contesto in cui ha operato e alle relazioni costruite con la «stupenda generazione» ricordata nel titolo. Le altre iniziative che si prefigurano (una mostra fotografica di Fernando Bevilacqua, la pubblicazione di un catalogo) faranno confluire altra documentazione nell’archivio, e speriamo che si possa costituire anche un fondo dei manoscritti.
A questa esigenza risponde ora una duplice iniziativa: la riedizione delle opere, a cominciare dall’ultima, Bucherer l’orologiaio, postuma, su cui mi soffermerò dopo, e una mostra, che ha luogo nella città di Lecce, dal titolo «Verri Antonio Leonardo. Una stupenda generazione», che prevede tappe e allestimenti aggiuntivi; il primo segmento, che durerà, partendo dal 12 dicembre scorso, fino al 15 aprile prossimo, consiste nella esposizione di una serie di pannelli lungo il muro perimetrale del Museo Castromediano di Lecce, che recano disegni di artisti amati da Verri e brevi citazioni, particolarmente evocative, tratte dai suoi testi; la seconda sezione, «Documentaria», ospitata negli ampi spazi della Biblioteca Bernardini, a Lecce, è stata inaugurata il 29 dicembre 2021, è pensata come un archivio, da implementare, dei materiali prodotti da Verri (prime edizioni, riviste, dipinti, immagini, qualche manoscritto) e da testimonianze relative al contesto in cui ha operato e alle relazioni costruite con la «stupenda generazione» ricordata nel titolo. Le altre iniziative che si prefigurano (una mostra fotografica di Fernando Bevilacqua, la pubblicazione di un catalogo) faranno confluire altra documentazione nell’archivio, e speriamo che si possa costituire anche un fondo dei manoscritti.
La mostra è curata da Mauro Marino, uno dei sodali di Antonio, che, dopo la sua morte, insieme a Piero Rapanà, istituì l’associazione denominata proprio «Fondo Verri» ed ha tenuto viva e attualizzata negli anni, con altri compagni della prima ora (Antonio Errico, Maurizio Nocera, il citato Bevilacqua…), la lezione verriana (cfr. Bevilacqua, Chiriatti, Nocera 1998). L’apertura della mostra è stata accompagnata dall’avvio, presso l’editore Kurumuny di Calimera, della collana “Declaro”, curata da Simone Giorgino, in cui verrà ripubblicata l’intera opera letteraria di Verri, a cominciare dall’ultima sua fatica, Bucherer l’orologiaio, che uscì postuma nel 1995. Il titolo della collana si riferisce al nome che egli attribuiva al progetto di una sorta di dizionario, un libro delle parole libere da convenzioni e regole, un felice universo parallelo a quello governato dalle grammatiche e dalla storia del mondo reale.
Ma veniamo a Bucherer, su cui ora desidero soffermarmi; la nuova edizione (Calimera, Kurumuny, 2021) si avvale di una introduzione di Rossano Astremo e di una nota biobibliografica di Annalucia Cudazzo. Il testo è incompiuto, ma non tanto da celare una sua unità. La trama del romanzo è molto tenue: Bucherer, il protagonista, vuol realizzare un’opera imponente, un’arca in cui ammassare cose di ogni natura, lo fa, riempie spazi, ma questo impegno esasperato si mostra da subito inconcludente, perché all’accumulazione, in prospettiva, seguiranno la disgregazione, la dissoluzione. Mi colpisce molto che il sentimento della fine risulti con evidenza nelle pagine: qui non ci sono gli allegri spiriti demolitori e costruttori di forme sconclusionate, le rane (parole) ribollenti in un uovo costantemente fecondo, che abitavano gli altri suoi lavori (La cultura dei tao, 1986; I trofei della città di Guisnes, 1988). L’arca di Bucherer si direbbe un ingombro più che un corpo in espansione, come era invece la donna grassa e debordante di creatività che Verri ha battezzato Betissa nella sua opera forse più nota (La Betissa. Storia composita dell’uomo dei curli e di una grassa signora, 1987); adesso l’accumulo diventa faticoso e assoggettato, a quanto pare, a una legge entropica. Lo stesso corpaccione dell’orologiaio intaserà la città.
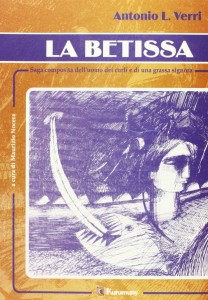 L’immaginifico innalzatore di cattedrali di riso e di castelli di cotone si trova ora a stendere una mappa del nulla, che il montare di nozioni e informazioni non ci aiuta a decifrare: «Le icone di questo fine novecento son delle storie così fugaci, così frantumabili, dei frammenti di storie e di suoni non saldi, che Bucherer, come al culmine di un comando divino, comincia a sistemare in quella che vorrebbe essere la sua Arca Immensa. Quest’oggetto, questa nidiata. Non è facile scriverne» (Verri 2021: 47). Ma, a dispetto di questa difficoltà, ugualmente Verri propina al lettore le figure iperboliche, i meravigliosi elenchi, i giochi de parole, «chimere, frasi in piena» (ivi: 87) che così sapientemente confeziona nel flusso della sua scrittura; né mancano i personaggi straordinari e mutevoli che accompagnano il narratore: Hallucigenia (nomen omen: Mauro Marino mi dice che Antonio si era informato sugli effetti dell’Lsd), Opabinia, la Mosca divoratrice, «uno spurgo di favola» (ivi: 93), il demone Zebel, Sally… Il rischio incombente è che qualcosa di indecifrato e non computato infranga il lucido disegno dell’arca che, a quel punto, inevitabilmente, sarà Imprecisa.
L’immaginifico innalzatore di cattedrali di riso e di castelli di cotone si trova ora a stendere una mappa del nulla, che il montare di nozioni e informazioni non ci aiuta a decifrare: «Le icone di questo fine novecento son delle storie così fugaci, così frantumabili, dei frammenti di storie e di suoni non saldi, che Bucherer, come al culmine di un comando divino, comincia a sistemare in quella che vorrebbe essere la sua Arca Immensa. Quest’oggetto, questa nidiata. Non è facile scriverne» (Verri 2021: 47). Ma, a dispetto di questa difficoltà, ugualmente Verri propina al lettore le figure iperboliche, i meravigliosi elenchi, i giochi de parole, «chimere, frasi in piena» (ivi: 87) che così sapientemente confeziona nel flusso della sua scrittura; né mancano i personaggi straordinari e mutevoli che accompagnano il narratore: Hallucigenia (nomen omen: Mauro Marino mi dice che Antonio si era informato sugli effetti dell’Lsd), Opabinia, la Mosca divoratrice, «uno spurgo di favola» (ivi: 93), il demone Zebel, Sally… Il rischio incombente è che qualcosa di indecifrato e non computato infranga il lucido disegno dell’arca che, a quel punto, inevitabilmente, sarà Imprecisa.
Zurigo è la città «sonora, assurda, verticale» (ivi: 87) che accoglie la grande impresa; Verri vi incontra, si direbbe, se stesso, un uomo avvolto in un cappotto, alto, «una ormai non nerissima barba, occhi che fissano senza pesare» (ivi: 88), sopra la sua testa un immenso panno bianco si illumina a tratti, vi scorrono segni, parole, avanzi di scrittura, pezzi di articoli di giornale, lingue strane, immagini: è il Declaro, o qualcosa che gli somiglia, il non-libro di tutte le parole, l’oggetto balena, o libro in cartisella, impossibile da completare. Ma a qualche conclusione si arriva: «imperfetto com’ero, ero forse io la Bellezza» (ivi: 98); e ancora: «sui polsini della mia camicia tamburellava, frenetica, solo la mia vita» (ivi: 99); infine: «sicuramente quello che riuscirò a capire sarà sempre imperfetto. E corrotto. È incredibile. Io soffiavo in una contrada di alberi di carta. E fremevo. Ero certo di essere alla fine» (ivi: 98).
Non c’è scampo, tutto andrà nel ventre della Mosca vorace, mai sazia, «preda di una forsennata allofagia» (ivi: 107); questo affannoso affastellarsi, ammucchiare oggetti, riempire vuoti, dilatarsi sarà solo materia di cieco nutrimento e devastazione. Cosa resta? La distopia è servita? Verri leggeva i segnali di fine Novecento e non erano incoraggianti; quasi trent’anni dopo la sua morte improvvisa, con il senno di poi, d’accordo, non troveremo una postura profetica nel seguente passaggio?: «si preparerà l’esca, il condor sarà preso, non riuscirà a volare e l’isola piangerà, e i vecchi se ne andranno e le montagne non avranno il colore della sabbia e la solitudine del condor si propagherà monotona, e salirà un odore di zolfo dove un tempo erano figure svanenti, dove un tempo erano solo bisbigli, e domineranno i toni bassi, la sordina di metallo che darà un tono aggressivo, metteranno la mano nella campana e tratterranno il fiato in bocca, mentre la Mosca si avvolgerà nel suo stesso fiato, col ventre gonfio di birra e di note…» (ivi: 106-107).
La pagina sui Dogon è sicuramente un frammento, arriva in modo piuttosto occasionale, ma, pure in nuce, lascia pensare a qualcosa di più impegnativo; se avesse avuto tempo, Verri l’avrebbe sviluppata sicuramente, perché la materia è molto vasta e decisamente a lui congeniale. La sua fonte principale di informazioni (non so se ha letto altro) non può che essere Dio d’acqua di Marcel Griaule; il grande antropologo aveva guidato la celeberrima Missione Dakar-Djibouti (1931-1932), finanziata dal governo francese, che aveva il fine di attraversare i territori coloniali francesi e acquisire una documentazione materiale e filmata relativa ai vari aspetti culturali dei territori (archeologia, antropologia, lingua, musica…), da destinare al progettato Musée de l’Homme di Parigi. La spedizione fu ricchissima di risultati. Il primo contatto con i Dogon, sulla falesia di Bandiagara e a Sanga (siamo nel Mali), avvenne nel settembre del 1931. Per i pochi bianchi che vi si erano imbattuti e per i vicini Peul, si trattava di una popolazione selvaggia e pericolosa; costoro li chiamavano infedeli perché non si erano convertiti alla religione islamica. Negli anni successivi, dopo la conclusione della spedizione, Griaule tornò ancora tra i Dogon; risale al 1946 l’incontro con il vecchio cacciatore cieco Ogotemmêli che, in una lunga serie di conversazioni, gli diede conto, in modo sistematico, della ricca mitologia e dell’altrettanto complesso apparato simbolico dogon. Dieu d’eau. Entretiens avec Ogotemmêli uscì nel 1948; è un libro molto bello, che ha veste letteraria quanto etnografica, ed ha affascinato un numero altissimo di lettori.
Non mi sorprende che sia successa la stessa cosa anche a Verri, così aperto alle fascinazioni e alle suggestioni letterarie e narrative: è davvero un autore molto complicato e non ha pietà per il lettore, spesso è tutt’altro che facile decifrarne le intenzioni. La sua compiaciuta ricerca di parole che risuonano, indipendenti dal significato, alimenta nello stesso tempo il suo gioco poetico e la difficoltà di chi legge ed è, tuttavia, ancorato all’ipotesi che qualcosa da capire ci sia. Può accadere, inoltre, che, in un’opera come Bucherer, incompiuta, postuma e quindi curata da altri, non dall’autore, una annotazione, un appunto, possano valere come scrittura definitiva. Prendiamo, per esempio, il seguente brano: «Digitaria, Songo Femmina, è una nuova stella, sede dei mimi, delle anime dei Dogon. Volgeva il volto verso il Nord (il paese dei Bianchi) con accanto il suo paniere e quei tanti oggetti che parevano avere le esitazioni di un arcolaio…» (Verri 2021: 49).
L’ultima immagine, le esitazioni di un arcolaio, appartiene all’esperienza dell’autore che conosce bene l’ambiente domestico e contadino in cui è vissuto nella sua Caprarica, ma teniamo conto che le prime fasi della creazione tra i dogon sono descritte come operazioni di tessitura. Digitaria exilis (fonio, nella lingua locale), la «nuova stella», veramente, ci conduce in tutt’altro settore dell’universo dogon: si tratta di una graminacea i cui chicchi rotondi cadono appena sono maturi a un semplice soffio di vento; per questo la pianta doveva essere mietuta rapidamente e altrettanto in fretta bisognava eseguire la battitura, o trebbiatura, che dir si voglia, da parte dei giovani. Ora, questi grani, considerati contaminanti, erano vietati a un gran numero di individui; soprattutto, le mogli legittime si rifiutavano di batterli; i sacerdoti non potevano nemmeno sfiorarne la polvere. Ogotemmêli spiegò al Bianco, o Nazareno, cioè Griaule, a voce bassissima, poiché toccava un argomento proibito, che fonio e mestruo sono la stessa cosa, entrambi impediscono la fecondità, e giustificava questo collegamento con un riferimento molto articolato ai miti di fondazione e alla cosmologia dogon: gli otto antenati (Nommo) che dimoravano nei cieli dovevano vivere separati, ma il primo e il terzo ruppero l’interdizione e, diventati impuri, furono allontanati dagli altri; Dio (Amma), per farli nutrire, diede loro otto grani, tra cui la Digitaria. Il primo dichiarò che non ne avrebbe mangiato, ma, dopo aver consumato gli altri sette grani, affamato, lo mangiò: aveva mancato alla sua stessa parola, così nacque la cattiva parola; essa trovò posto nel granaio che discese dal cielo: per questo motivo esiste la cattiva parola ed è legata alla Digitaria (Griaule 2002).
Ho riassunto questo passaggio tratto dalla ventitreesima giornata di Dio d’acqua per far notare da dove viene quel semplice e oscuro riferimento di Verri e renderlo in qualche misura intellegibile. Il paniere: fu dato al primo antenato, ha la base quadrata e l’apertura circolare, ai quattro lati vi sono altrettante scale, ciascuna di dieci gradini su cui trovano posto, in modo ordinato (ognuno ha la sua collocazione), gli esseri viventi, non fisicamente, ma come simboli, cioè parole; tutto questo insieme si chiama anche granaio ed è il modello che struttura le stesse costruzioni del villaggio. Quando il granaio scende dal cielo, scivolando lungo un arcobaleno, impatta violentemente al suolo e gli esseri disposti sui gradini si diffondono dappertutto. Non serve andare molto oltre, perché, sebbene la Digitaria sia diventata una stella sede dei mimi, è dimostrata chiaramente la dipendenza della pagina verriana da Griaule (o da Ogotemmêli). Ma una breve riflessione si può aggiungere.
La cosmogonia dogon è fondata sulla parola: il primo essere nato dall’unione di Dio con la terra è lo sciacallo incestuoso che violerà la madre e diviene possessore della parola esoterica, ingannevole, riservata agli indovini; il settimo degli otto geni chiamati a costruire il mondo è il Signore della parola, l’ottavo è la Parola stessa, tutto dipende dalla parola, la quale, quando si manifesta in forme materiali, conserva il suo potere: ricordate, una donna onesta non può mettere a rischio la sua fecondità battendo la Digitaria, attività che invece impegna i giovani, i quali non hanno ancora assunto responsabilità sociali. Il granaio di Ogotemmêli non è dunque un Declaro? Certo, in questo caso siamo in un contesto squisitamente orale, mentre Verri cercava la sonorità, nei suoi lavori, attraverso la mediazione della scrittura, ma ugualmente è lecito immaginare che da quella paginetta in cui cita i Dogon qualcos’altro avrebbe tirato fuori, e che, in un futuro mai arrivato, nella letteratura etnologica avrebbe trovato motivi, spunti, modelli per raccontare e inventare il mondo, come aveva fatto giocando con i temi della cultura popolare e contadina (Imbriani 2017).
Verri conosceva la Svizzera. Nato nel 1949 a Caprarica di Lecce, in una famiglia contadina alla quale rimarrà legatissimo, interruppe gli studi universitari e se ne andò oltralpe, a Schaffhausen, sede, tra l’altro, di una nota fabbrica di orologi di lusso. Aveva dimestichezza con il mondo urbano e industriale, così come aveva acquisito l’esperienza del giovane meridionale italiano all’estero, condivisa da molti suoi coetanei all’epoca, temporanea, stagionale; e aveva coltivato la conoscenza della letteratura europea del Novecento: e probabilmente ciò gli consentiva di osservare la cultura popolare dei suoi stessi genitori, del paese, della provincia con uno sguardo penetrante, capace di smontarla, individuarne i meccanismi, le pratiche, i saperi, le consuetudini; e di trovarvi i motivi che giustificavano la scelta di appartenervi, di apprezzarne i tratti costitutivi, materiali, fiabeschi, narrativi, poetici. Questa duplicità di ispirazione ha alimentato la sua idea di arte, di letteratura, di impegno culturale; decidere di vivere in una piccola località del Salento faceva parte di un progetto ampio, operativo, che stimolava le forze e le intelligenze più innovative, capaci di un respiro non localistico, anzi, e che però “facessero cose” nel territorio, oltre, magari, a studiarlo e scriverne.

Galatina, Museo Cavoti, Verri attraversa con il Quotidiano dei poeti la Porta Spazio-Tempo di Umberto Palamà (ph. Fernando Bevilacqua)
In questa impresa Verri fu capace di coinvolgere e di tessere reti con un alto numero di persone, musicisti, studiosi, pittori, poeti, editori che avevano diversa formazione e provenienza, attivi nell’area e in altre località d’Italia e del mondo. In un precedente numero di questa stessa rivista (n. 50, cfr. Imbriani 2021) ho raccontato una delle sue più complicate avventure, la pubblicazione e la distribuzione del «Quotidiano dei poeti» contemporaneamente in alcune grandi città della penisola e oltre: un paese di estrema periferia, Caprarica, teneva le fila di questa ragnatela.
La scelta di Zurigo (città industriale e commerciale) come luogo in cui ambientare la straordinaria vicenda di un insolito orologiaio risiede appunto in quella esperienza giovanile; non solo: nella introduzione (Il merlo eretico) alla prima edizione di Bucherer Aldo Bello (1995) ha ricordato un viaggio che con Verri lo condusse a Zurigo: un viaggio di ritorno, quindi, sui vecchi passi, tra memorie smussate e qualche disorientamento, ma rivitalizzate quanto è bastato per creare la scena più adatta in cui collocare il maniacale mucchio, l’arca, e far cadere l’immane corpo, smisuratamente gonfio, del personaggio.
Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022
Riferimenti bibliografici
Bello Aldo, Il merlo eretico, in A. L. Verri, Bucherer l’orologiaio, Lecce, Banca Popolare Pugliese, 1995: VII-XX
Bevilacqua Fernando, Chiriatti Luigi, Nocera Maurizio, a cura di, Antonio Verri fabbricante di armonia, Melpignano, Istituto “Diego Carpitella”, 1998
Griaule Marcel, Dio d’acqua. Incontri con Ogotemmêli, Torino, Bollati Boringhieri, 2002
Imbriani Eugenio, La strega falsa. Distinzioni e distorsioni in antropologia, Bari, Progedit, 2017
Id., Cirese. Approssimarsi al centro, in «Dialoghi Mediterranei», n. 50, 2021
Verri Antonio L., La Betissa. Storia composita dell’uomo dei curli e di una grassa signora, Lecce, Banca Popolare Sud Puglia, 1987
Id., I trofei della città di Guisnes, Parabita, Il laboratorio, 1988
Id., La cultura dei tao, Lecce, Fondo Verri Edizioni, 2014
Id., Bucherer l’orologiaio, Calimera, Kurumuny, 2021.
______________________________________________________________
Eugenio Imbriani, professore associato di Antropologia culturale e Storia delle tradizioni popolari presso l’Università del Salento (Lecce), afferisce al Dipartimento di Storia, società, studi sull’uomo. I suoi interessi sono orientati allo studio del folklore, ai temi della cultura popolare, della scrittura e dell’esperienza etnografica, ai rapporti tra memoria e oblio nella produzione dei patrimoni culturali e delle identità locali. Ha prodotto numerose pubblicazioni, monografie, saggi apparsi su riviste, in volumi collettanei, atti di convegni; è direttore della rivista “Palaver”; dirige la Sezione etnografica del Museo Civico di Giuggianello (Le). Ha conseguito l’abilitazione nazionale alla prima fascia della docenza.
______________________________________________________________









