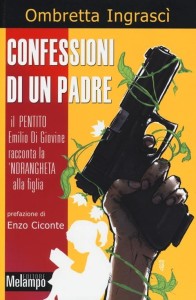Ancora recentemente una delle più attente studiose del fenomeno mafioso, anche riguardo alla presenza femminile al suo interno, notava che la “congerie” di libri dedicati a questa particolare tematica abbonda di «testi interessanti, frammentari o ideologici; spesso incapaci di darti quel necessario sguardo d’insieme, di cogliere il nocciolo della questione che ancora ci chiama in causa» [1].
Puntando su «alcuni libri importanti» [2] che tuttora fanno testo sull’argomento, vorrei provare a ipotizzare una griglia interpretativa complessiva che avvicini allo “sguardo d’insieme” di cui la Dino avverte la mancanza, pur nella consapevolezza che in questo campo – come in tutti i campi in cui si ricerca davvero – si può aspirare ad «approdi parziali e acquisizioni mai definitive» [3].
1. Premessa sul patriarcato nella società (in generale) e nella mafia (in particolare)
Il sistema di dominio mafioso è un sotto-sistema del più ampio sistema della società italiana [4]. Il primo, dunque, è inintelligibile se non si considerano le relazioni dialettiche con il secondo: relazioni di somiglianza, di continuità, ma anche di differenza, discontinuità.
 Dal punto di vista del ruolo delle donne, il sistema sociale italiano è caratterizzato da un patriarcato irriflesso ma effettivo: “irriflesso” perché scarsamente consapevole e ancor meno programmatico; “effettivo” perché vigente nelle relazioni private quotidiane e nei costumi sociali prevalenti. Esso dunque appare debole sul piano ufficiale del discorso pubblico e della stessa legislazione in divenire, ma forte sul piano ufficioso delle pratiche: anzi, proprio la sua decrescente popolarità (dovuta al fatto di essere considerato vieppiù ‘ scorretto’ politicamente) induce la maggioranza dei cittadini e delle cittadine ad abbassare la guardia, rendendone più agevoli il permanere nella psiche collettiva e l’infiltrarsi nelle trame ordinarie dei rapporti sociali.
Dal punto di vista del ruolo delle donne, il sistema sociale italiano è caratterizzato da un patriarcato irriflesso ma effettivo: “irriflesso” perché scarsamente consapevole e ancor meno programmatico; “effettivo” perché vigente nelle relazioni private quotidiane e nei costumi sociali prevalenti. Esso dunque appare debole sul piano ufficiale del discorso pubblico e della stessa legislazione in divenire, ma forte sul piano ufficioso delle pratiche: anzi, proprio la sua decrescente popolarità (dovuta al fatto di essere considerato vieppiù ‘ scorretto’ politicamente) induce la maggioranza dei cittadini e delle cittadine ad abbassare la guardia, rendendone più agevoli il permanere nella psiche collettiva e l’infiltrarsi nelle trame ordinarie dei rapporti sociali.
Se il sistema mafioso è un sotto-sistema del sistema sociale, diventa attendibile l’ipotesi che il primo sia in relazione dialettica (di affinità e di diversità) con l’impianto patriarcale-maschilista del secondo. Detto in termini più immediati: l’ipotesi che i mafiosi siano maschilisti, ma a modo proprio (dunque: per certi versi come gli altri maschi, per altri con alcune peculiarità) [5]. Nulla di nuovo, per altro, rispetto ad altre caratteristiche antropologiche dei mafiosi: capitalisti, ma a modo proprio; cattolici, ma a modo proprio; sciovinisti (sicilianisti), ma a modo proprio.
Per verificare tale ipotesi è necessario chiarire cosa intendere per patriarcato. Adotto qui la formulazione proposta da Gilligan e Sninder: un assetto culturale-sociale fondato «su una struttura binaria e gerarchica di genere» per la quale:
- “le capacità umane” sono o “mascoline” o “femminili” e le mascoline sono da privilegiare;
- “alcuni uomini” sono al di sopra di altri e “tutti gli uomini al di sopra delle donne”;
- si perpetua “una separazione tra il sé e le relazioni”, con la conseguenza (dannosa sia per gli uomini che per le donne) che gli uomini vengono obbligati ad “avere un sé senza relazioni” e le donne ad “avere relazioni senza avere un sé” [6] .
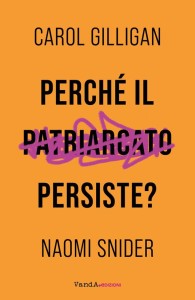 2. La condizione delle donne ‘ interne’ al sotto-sistema mafioso
2. La condizione delle donne ‘ interne’ al sotto-sistema mafioso
2.1 Aspetti di omogeneità
Dalle testimonianze dirette e indirette risulta con chiarezza che le donne ‘interne’ al sistema mafioso patiscono le stesse conseguenze del maschilismo patriarcale subite dalle donne ‘esterne’ [7].
a) In entrambi i contesti la donna vive in regime di oppressione ordinaria, anche quando non si registrano episodi eclatanti di violenza fisica. In entrambi i contesti il maschio violento – mafioso o estraneo al mondo mafioso che sia – adotta la violenza non necessariamente esercitandola, ma anche solo minacciandola: la esercita alcune volte per poterla minacciare efficacemente sempre. Da qui la necessità, per le donne ‘interne’ o ‘esterne’ al regime mafioso, di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, di non accettare la logica dell’emergenza o dell’eccezionalità [8]; di acquisire «una visione non emergenziale del fenomeno» [9] ; di «costruire una visione delle cose che consenta alle ragazze di liberarsi da gabbie che loro stesse considerano normali, anzi, necessarie» [10]).
Va subito osservato che, contrariamente a quanto suppongono coloro che non hanno ascoltato le testimonianze affidabili di donne congiunte di mafiosi, il tasso di violenza maschile in essi non né maggiore né minore rispetto alla media statistica dell’intera popolazione maschile: ci sono mafiosi che non hanno mai alzato un dito contro la moglie e non-mafiosi (o, addirittura, militanti attivi nell’anti-mafia) che la picchiano abitualmente [11]. Possono negare queste narrazioni solo osservatori «legati a un’idea lombrosiana del mafioso, brutto, sporco e cattivo. Che invece può essere spietato nel suo ambito per così dire ‘di lavoro’ e affettuoso a casa. Che può quindi voler bene e farsi voler bene» [12]. Non diversamente dagli ufficiali e dai soldati nazisti di stanza nei lager.
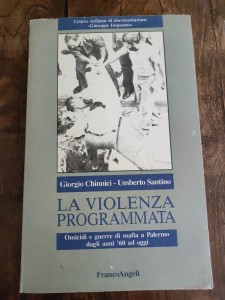 Chi ha avuto un congiunto associato a Cosa Nostra che si mostrava «allegro, affettuoso, amava la vita, gli amici e il valzer» come può non chiedersi se egli sia soltanto «un mostro dedito a esercizi di morte, sempre in lotta col diverso, a partire dalla propria parte femminile negata»? [13]. Per qualsiasi familiare, “sentire di volergli bene” non può mai considerarsi un «sentimento politicamente scorretto» [14]: i sentimenti in sé non sono né scorretti né corretti. Ne siamo ‘affetti’, toccati. L’opzione etica comincia quando ci si chiede se farli prevalere su ogni altro criterio di giudizio o relegarli alla sfera emotiva cui appartengono per essere capaci di assumere (interiormente e pubblicamente) le opportune distanze. In misura più o meno notevole, a un certo momento della vita, non siamo un po’ tutti costretti a fare i conti con i nostri genitori (o con i nostri ex-partner) conciliando la gratitudine per quanto ci hanno saputo dare di prezioso e il risentimento per quanto ci hanno voluto o negare di prezioso o imporre di sgradito?
Chi ha avuto un congiunto associato a Cosa Nostra che si mostrava «allegro, affettuoso, amava la vita, gli amici e il valzer» come può non chiedersi se egli sia soltanto «un mostro dedito a esercizi di morte, sempre in lotta col diverso, a partire dalla propria parte femminile negata»? [13]. Per qualsiasi familiare, “sentire di volergli bene” non può mai considerarsi un «sentimento politicamente scorretto» [14]: i sentimenti in sé non sono né scorretti né corretti. Ne siamo ‘affetti’, toccati. L’opzione etica comincia quando ci si chiede se farli prevalere su ogni altro criterio di giudizio o relegarli alla sfera emotiva cui appartengono per essere capaci di assumere (interiormente e pubblicamente) le opportune distanze. In misura più o meno notevole, a un certo momento della vita, non siamo un po’ tutti costretti a fare i conti con i nostri genitori (o con i nostri ex-partner) conciliando la gratitudine per quanto ci hanno saputo dare di prezioso e il risentimento per quanto ci hanno voluto o negare di prezioso o imporre di sgradito?
b) In entrambi i contesti le donne subiscono un deficit di agibilità democratica perché se, in generale, si può affermare che il patriarcato è «l’antitesi dei valori democratici» [15], altrettanto si può affermare dei sistemi di dominio mafiosi. La riprova: che la lotta delle donne per la democrazia è stata doppiamente faticosa perché contro il maschilismo e contro le maglie del potere illegale. Come attesta la storia,
«la lotta alla mafia è stata, soprattutto nel passato, lotta per la democrazia e per la tutela dei diritti dei lavoratori, da cui le donne sono state a lungo escluse. Nelle esperienze associate di lotta alla mafia, la presenza femminile, pur quando numerosa, ha incontrato enormi difficoltà nel configurarsi in forme strutturate e durevoli, accompagnate da ruoli pubblici riconosciuti» [16].
c) Le donne ‘interne’ al sistema mafioso condividono, con tutte le altre concittadine, il condizionamento culturale del patriarcato che è, prima ancora di un assetto politico-istituzionale modificabile, un a priori psicologico, un modo di vedere il mondo sociale quasi universalmente condiviso [17]. In esse però questo condizionamento mentale si abbina, rinsaldandosi, con il condizionamento (più o meno consapevole) del codice culturale mafioso, come ben si esprime la collaboratrice di giustizia Carmela Iuculano:
«La mafia è un fenomeno che controlla le menti. Per me veramente è ‘na ragnatela perché tu entri là e rimani intrappolato, più ti muovi, più vuoi uscirtene, peggio è perché più t’ intrappoli, più t’ impigli nella rete, e peggio il ragno t’immobilizza, ti succhia piano piano, fino a che ti svuota tutto…» [18] .
 d) In entrambi i contesti si nota uno iato – talora una vera contraddizione – fra ciò che viene proclamato espressamente (la dignità della donna, il suo diritto all’autodeterminazione, l’intangibilità del suo ‘onore’ …) e ciò che si vive effettivamente (la subordinazione dei bisogni e dei desideri femminili ai bisogni e ai desideri maschili). Nella tradizione culturale italiana, dalla donna-angelo dei Medievali alla donna ‘divina’ dei Romantici, sino alle canzoni di musica leggera e alla letteratura ‘rosa’, campeggia lo stereotipo della donna come figura sacra o comunque intoccabile perché preziosa: tutto ciò in pacifica compatibilità con un sistema giuridico, economico e simbolico in cui le pari opportunità fra maschi e femmine costituiscono conquiste recenti e comunque parziali e per giunta reversibili. Similmente un luogo comune, ribadito artatamente dagli ambienti mafiosi, è che il vero “uomo d’onore” rispetta la moglie propria e le mogli degli altri membri di Cosa Nostra: come se avere molte amanti non fosse una mancanza di rispetto verso la propria moglie o come se, in caso di ordini ‘superiori’ , il mafioso non dovesse essere pronto a uccidere la moglie di un altro mafioso o la propria stessa moglie.
d) In entrambi i contesti si nota uno iato – talora una vera contraddizione – fra ciò che viene proclamato espressamente (la dignità della donna, il suo diritto all’autodeterminazione, l’intangibilità del suo ‘onore’ …) e ciò che si vive effettivamente (la subordinazione dei bisogni e dei desideri femminili ai bisogni e ai desideri maschili). Nella tradizione culturale italiana, dalla donna-angelo dei Medievali alla donna ‘divina’ dei Romantici, sino alle canzoni di musica leggera e alla letteratura ‘rosa’, campeggia lo stereotipo della donna come figura sacra o comunque intoccabile perché preziosa: tutto ciò in pacifica compatibilità con un sistema giuridico, economico e simbolico in cui le pari opportunità fra maschi e femmine costituiscono conquiste recenti e comunque parziali e per giunta reversibili. Similmente un luogo comune, ribadito artatamente dagli ambienti mafiosi, è che il vero “uomo d’onore” rispetta la moglie propria e le mogli degli altri membri di Cosa Nostra: come se avere molte amanti non fosse una mancanza di rispetto verso la propria moglie o come se, in caso di ordini ‘superiori’ , il mafioso non dovesse essere pronto a uccidere la moglie di un altro mafioso o la propria stessa moglie.
e) Da quanto sinora considerato si potrebbe condividere la sintesi proposta da Nando dalla Chiesa:
«Ci si trova davanti all’universo in assoluto più maschilista della società italiana, in cui la donna serve a riprodurre forza lavoro militare e codici di violenza. Dove accade che essa possa anche ottenere scettri provvisori, a causa di ergastoli e lotte intestine. Ma sono scettri delegati da un maschio, segno mai di emancipazione bensì sempre di assoggettamento. Dove l’omertà rade al suolo ogni idea di onore e dignità. Dove l’amore è una variabile ‘dipendente’ dalle leggi del clan, e nessuna Antigone è permessa. E in cui anzi l’onore può essere difeso uccidendo le proprie figlie» [19].
Si tratta però di una delle due facce della luna. Non va dimenticata la faccia solitamente in ombra: che le donne ‘ interne’ al sistema mafioso sono ‘complici’ del sistema patriarcale (in quanto donne) e del sistema mafioso (in quanto donne di mafia). Confrontiamo quanto affermano le due studiose statunitensi Gilligan e Snider sul patriarcato e quanto afferma Renata Siebert sul ruolo ‘pedagogico’ delle donne ‘interne’ alla mafia.
Le prime:
«Non è un segreto che il patriarcato dipenda dalla complicità delle donne. Il suo perdurare si fonda in parte sul silenzio e l’ottemperanza delle donne, compresa la loro disponibilità a continuare ad accettare il sacrificio dei figli per qualunque causa o proposito superiore» [20].
La seconda:
«Nella strategia mafiosa della signoria del territorio, sono le donne che fungono da cassa di risonanza per il ricatto, per la minaccia, per l’angoscia di morte che generano l’omertà, la complicità, l’obbedienza alla legge mafiosa» [21].
 Ammettere queste responsabilità (almeno oggettive, spesso anche soggettive) a carico di donne non è certo un modo di denigrarle. Anzi, è proprio della mentalità maschilista tradizionale (non certo estranea alla formazione di tanti magistrati e avvocati) escludere per principio che a una donna possano essere imputati reati gravi (e, più in genere, errori e difetti nella gestione delle dinamiche sociali) come si trattasse di una perenne minorenne, non del tutto in grado di intendere e di volere [22]. Invece le cronache sono sempre più affollate di nomi di donne che svolgono ruoli attivi all’interno delle organizzazioni mafiose: «sono veramente tante le spacciatrici di droga, nei quartieri più degradati di Palermo, che non esitano ad utilizzare anche i loro figli!» [23]; «oltre alla spacciatrici, ci sono anche donne che possono dirsi proprio trafficanti» [24] e altre «intestatarie di quote notevoli» di imprese di mafiosi o «prestanome, nel caso che i congiunti non possano comparire» [25].
Ammettere queste responsabilità (almeno oggettive, spesso anche soggettive) a carico di donne non è certo un modo di denigrarle. Anzi, è proprio della mentalità maschilista tradizionale (non certo estranea alla formazione di tanti magistrati e avvocati) escludere per principio che a una donna possano essere imputati reati gravi (e, più in genere, errori e difetti nella gestione delle dinamiche sociali) come si trattasse di una perenne minorenne, non del tutto in grado di intendere e di volere [22]. Invece le cronache sono sempre più affollate di nomi di donne che svolgono ruoli attivi all’interno delle organizzazioni mafiose: «sono veramente tante le spacciatrici di droga, nei quartieri più degradati di Palermo, che non esitano ad utilizzare anche i loro figli!» [23]; «oltre alla spacciatrici, ci sono anche donne che possono dirsi proprio trafficanti» [24] e altre «intestatarie di quote notevoli» di imprese di mafiosi o «prestanome, nel caso che i congiunti non possano comparire» [25].
In occasione di mafiosi che decidono di collaborare con l’apparato giudiziario statale il protagonismo delle donne di mafia, abitualmente sottotraccia, emerge alla luce del sole. In qualche caso perché sono mogli o figlie che inducono il congiunto a saltare il fosso [26] o comunque restano al suo fianco per sostenerlo [27]; in altri più numerosi perché o tentano di dissuaderlo [28] o – se non riescono – prendono clamorosamente
«le distanze dai pentiti con pubbliche dichiarazioni con cui hanno accusato magistrati e forze dell’ordine, colpevoli di aver indotto al ‘tradimento’ i loro familiari, hanno definito questi ultimi ‘infami’ e li hanno rinnegati» [29].
Secondo Teresa Principato e Alessandra Dino,
«nella sorprendente quantità di dichiarazioni di ‘scomunica’ rilasciate dalle parenti dei pentiti vi sarebbe […] una nuova strategia comunicativa di Cosa Nostra, che avrebbe consegnato alle donne la funzione di difesa dell’organizzazione nei confronti del mondo esterno; interpretazione che conduce a riconsiderare il ruolo puramente familistico e marginale del passato e a parlare di una vera e propria ‘centralità sommersa’ della donna nell’organizzazione mafiosa» [30].
Dunque, nel positivo e nel negativo, la parabola della condizione femminile dentro l’orbita mafiosa si disegna in parallelo con la parabola della condizione femminile in generale.
Insieme a questi aspetti di affinità vanno però notate almeno due differenze fra la prospettiva patriarcale-maschilista, in generale, e la sua declinazione mafiosa, in particolare.
Un primo elemento di specificità potrebbe individuarsi nella legittimazione ideologica (che, come si è notato sopra, raramente si traduce nelle pratiche quotidiane) della dignità della donna: la cultura illuministico-borghese la fonda sulla natura umana comune e sui conseguenti diritti naturali; la cultura mafiosa, invece, sull’appartenenza della donna a una famiglia (anagrafica e/o criminale) in generale e a un maschio (il padre, il marito, il fratello…) in particolare [31].
Un secondo elemento di differenza fra l’ideologia patriarcale in generale e la sua versione mafiosa discende, strettamente, dal precedente: tutti i maschilisti usano, e abusano, quando e come possono, delle femmine, ma mentre il patriarcato condiviso sostiene (verbalmente) la dignità di ogni donna in quanto tale, la sua versione mafiosa sostiene (verbalmente) la dignità di quelle donne che appartengono anagraficamente a una famiglia mafiosa, a esclusione di tutte le persone (amanti, prostitute, gay, transessuali…) che abbiano con membri di Cosa Nostra legami affettivo-sessuali non legalmente riconosciuti.
3. La condizione delle donne ‘transfughe’ dal sotto-sistema mafioso
3.1 Aspetti di omogeneità
Se la ricostruzione precedente è realistica,
«l’immagine della donna siciliana, chiusa in casa e vestita di nero, non corrisponde nella quasi generalità alla situazione attuale. In Sicilia, come altrove, le donne rivendicano emancipazione e occupazione. […] Lo stereotipo di donna siciliana sottomessa, semplice trasmettitrice dei valori legati alla famiglia, non ha più ragion d’ essere. Anche all’ interno delle famiglie mafiose» [32].
 Questo mutamento presenta certamente i tratti di una emancipazione “perversa” [33], o di una “pseudoemancipazione” [34], ma in altri casi si tratta – esattamente come nel caso delle donne in generale – di una emancipazione reale. Mi riferisco a quel numero non trascurabile di donne che, insofferenti per le ragioni più varie del regime patriarcale di stampo mafioso, decidono di rompere con le famiglie (anagrafiche e/o criminali) di appartenenza. Queste ‘ribelli’ [35] affrontano i medesimi rischi delle donne che decidono di scrollarsi dalle spalle il giogo del patriarcato vigente anche negli ambienti esterni alla mafia, pagando un prezzo altrettanto alto in termini psicologici, economici, di sanzione sociale e, talora, addirittura con la vita biologica (per questo verso vivono una condizione omogenea alla condizione di tutte le donne del loro tempo).
Questo mutamento presenta certamente i tratti di una emancipazione “perversa” [33], o di una “pseudoemancipazione” [34], ma in altri casi si tratta – esattamente come nel caso delle donne in generale – di una emancipazione reale. Mi riferisco a quel numero non trascurabile di donne che, insofferenti per le ragioni più varie del regime patriarcale di stampo mafioso, decidono di rompere con le famiglie (anagrafiche e/o criminali) di appartenenza. Queste ‘ribelli’ [35] affrontano i medesimi rischi delle donne che decidono di scrollarsi dalle spalle il giogo del patriarcato vigente anche negli ambienti esterni alla mafia, pagando un prezzo altrettanto alto in termini psicologici, economici, di sanzione sociale e, talora, addirittura con la vita biologica (per questo verso vivono una condizione omogenea alla condizione di tutte le donne del loro tempo).
3.2 Aspetti di specificità
a) Se è vero che le donne che vogliono uscire dal recinto mafioso devono affrontare difficoltà del tutto simili alle donne che vogliono liberarsi dalla gabbia del patriarcato, è vero altresì che, in più, diventano delle ‘nemiche’ di un sistema criminale che non può tollerare il ‘cattivo’ esempio di schegge disobbedienti [36] (e questo costituisce un peso supplementare specifico rispetto alle donne che non gravitano nell’orbita del potere mafioso) [37].
b) Questa differenza di livello di rischio può misurarsi se si considera la differenza di ‘giustificazione’ del femminicidio nel sistema patriarcale in generale e nel sotto-sistema mafioso in particolare: nel primo orizzonte mentale lo si ritiene un gesto inaccettabile (e, infatti, non si rinunzia a ricorrere a spiegazioni varie, pur se quasi sempre infondate: “è stato un raptus”, “il pover’ uomo era ormai esasperato dopo anni di maltrattamenti subiti”, “lei lo ha prima provocato sessualmente e poi gli si è negata deridendolo”); nel secondo orizzonte mentale, invece, lo si ritiene un gesto accettabile, anzi in alcuni casi doveroso (per salvaguardare l’onore della famiglia in generale, di uno o più maschi della famiglia in particolare [38]). Mi riferisco non solo ai casi – ‘ovvi’ – di donne accusate (fondatamente o infondatamente) di aver tradito la cosca (cfr. Lea Garofalo [39]) o il marito (cfr. Lia Pipitone [40]), ma anche di donne massacrate solo perché congiunte di ‘collaboratori di giustizia’ (giornalisticamente denominati ‘pentiti’ ) in una logica di vendetta ‘trasversale’ (cfr. la madre, la sorella e la zia di Francesco Marino Mannoia o la moglie e la madre di Riccardo Messina) o, addirittura, perché involontarie possibili testimoni di giustizia (come l’appena diciassettenne Graziella Campagna [41]).
 Quando una donna viene uccisa perché familiare di un ‘traditore’ non si tratta tecnicamente di ‘femminicidio’ dal momento che la vittima non è colpita in quanto donna: ma ciò smentisce ugualmente il luogo comune secondo cui la mafia non uccide né i bambini né i preti né le donne. Nonostante la stampa ripeta in ogni occasione questo ritornello, la storia insegna che le cosche mafiose non hanno mai risparmiato la vita né di bambini né di preti né di donne tutte le volte che lo hanno ritenuto necessario per gli interessi superiori (anzi supremi) di Cosa Nostra [42].
Quando una donna viene uccisa perché familiare di un ‘traditore’ non si tratta tecnicamente di ‘femminicidio’ dal momento che la vittima non è colpita in quanto donna: ma ciò smentisce ugualmente il luogo comune secondo cui la mafia non uccide né i bambini né i preti né le donne. Nonostante la stampa ripeta in ogni occasione questo ritornello, la storia insegna che le cosche mafiose non hanno mai risparmiato la vita né di bambini né di preti né di donne tutte le volte che lo hanno ritenuto necessario per gli interessi superiori (anzi supremi) di Cosa Nostra [42].
Se ciò è vero, meritano immensa stima tutte le donne che, nate al di fuori di ambienti mafiosi e para-mafiosi, non solo se ne sono tenute lontane ma si sono impegnate, a diverso titolo e con diverse funzioni, a contrastare il sistema di dominio mafioso [43]. Si tratta in prevalenza di
«vedove e madri di magistrati, poliziotti, politici uccisi dalla mafia, che in questi anni hanno saputo trasformare il loro dolore individuale in capacità di testimonianza e di lotta contro la mafia. Sono tutte donne il cui impegno nasce anche da una elevata coscienza civile, dall’avere condiviso con i loro congiunti la volontà di contrastare la forza della mafia, anche contro la sostanziale negligenza dello Stato» [44].
Tuttavia, stima non minore meritano tutte le donne che, nate in ambienti mafiosi o para-mafiosi, hanno avuto la lucidità per diagnosticare la propria prigionia e il coraggio – talora stupefacente – di spezzare le catene e di intraprendere strade di liberazione [45]. (Talora questo transito viene formulato come passaggio dalla mafia allo Stato, ma è un modo troppo sbrigativo di esprimersi: la mafia è anche infiltrata in gangli decisivi delle istituzioni statali, dunque se ne esce per passare dalla parte della legalità costituzionale incarnata da pezzi dello Stato democratico). Le loro vicende dimostrano
«quanto sia difficile scegliere di parlare e quali conseguenze di isolamento dall’ambiente popolare può portare una tale scelta. Ma questo isolamento purtroppo è ovvio: viene rotto un codice di comportamento; c’ è una paura delle conseguenze ed è naturale che si voglia dimostrare che non si ha niente a che fare con quelli che quel codice di silenzio e di ricerca della vendetta privata hanno violato. Non è altrettanto ovvio che l’isolamento sia anche da parte della cosiddetta “società civile” che dice di volere la lotta alla mafia. Ma purtroppo questo è avvenuto […] per tutte le donne di estrazione popolare, a causa di una concezione della mafia come cancro, come antistato, e quindi della lotta antimafia come lotta di giudici e poliziotti, o in ogni caso come lotta di élite, fatta di manifestazioni, ma che esclude sostanzialmente un’attività per un cambiamento del comportamento delle masse popolari, per una liberazione dalla sudditanza alla mafia, per una crescita della coscienza civile da parte dei soggetti più deboli economicamente e quindi più esposti all’arruolamento della mafia» [46] .
c) Se si vogliono tenere nella considerazione che meritano i vissuti di molte di queste donne fuoriuscite dalla ‘caverna’ mafiosa, non si può ignorare che l’esodo non è necessariamente accompagnato da risentimento e odio verso i padri, i fratelli, i mariti (come normalmente avviene nell’animo di donne maltrattate da congiunti maschi); talora c’è proprio una tensione fra affezione privata e rottura pubblica (in modalità non necessariamente eclatanti). Questa tensione si risolve nei casi in cui la donna intuisce che, proprio perché legata da una qualche forma d’amore, spera di dare al congiunto un’estrema sollecitazione a liberarsi da quella cappa tossica da cui ella si è liberata. Nessuna contraddizione, perciò, fra la memoria grata di ciò che un soggetto è stato come padre o compagno di vita e il rifiuto dell’apparato ideologico ed etico che lo ha plasmato come mafioso inchiodandolo a un ruolo da cui è arduo decidere di evadere [47]. Per capire questo, e soprattutto per viverlo, è necessario un colpo d’ala che ci elevi al di là dell’«alternativa tra mafia e legalità, o tra mafia e antimafia» [48], all’altezza di un punto di vista che «non cancella le ingiustizie ma le pone in un quadro differente». A tale livello può condurci solo la tensione esistenziale «ad un ordine trascendente che informa le azioni della vita quotidiana, una forza d’animo che viene da una sapienza spirituale»[49]: ma qui inizia tutto un altro discorso.
Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022
Note
[1] A. Dino in Che c’entriamo noi. Conversazione tra Alessandra e Gisella in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi. Racconti di donne, mafie, contaminazioni, Mimesis, Milano – Udine 2022: 16-17.
[2] Ivi: 17.
[3] A. Dino, Frammenti di biografie plurali in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 142.
[4] Con questa formula rozza intendo dire che i mafiosi e i loro complici costituiscono una parte della società italiana, meridionale in specie (dunque non sono un ‘corpo separato’); ma una parte soltanto (che, dunque, non va confusa né con i resistenti antimafia né con gli auto-illusi equidistanti). Alcuni sociologi, opportunamente, aggiungono che si tratta di una parte attivamente contagiosa al punto che il nostro può essere definito «sistema sociale mafioso» (preferirei dire “mafiogeno”) (V. Sanfilippo, Il contributo della nonviolenza al superamento del sistema mafioso in V. Sanfilippo [ed.], Nonviolenza e mafia. Idee ed esperienze per un superamento del sistema mafioso, Di Girolamo, Trapani 2005: 13). Comunque, in seguito ad analisi più raffinate, si perviene alla conclusione che “la realtà sociale” va «vista come un organismo in cui le parti cosiddette ‘cattive’ sono intrecciate profondamente con quelle ‘sane’. Questa visione rimanda all’impossibilità di estirpare, di annientare violentemente, una parte della società umana per quanto essa possa essere a ragione giudicata ‘malata’ poiché ogni malattia lascia tracce in tutto l’organismo, pronte a ricostituirsi velocemente” (V. Sanfilippo, Nonviolenza e mafia in A. Cavadi, Quel maledetto 1992. L’inquietante eredità di Falcone e Borsellino, Di Girolamo, Trapani 2022: 50-51).
[5] Secondo Umberto Santino «il maschilismo della mafia non è una sua specificità, si limita a rispecchiare il maschilismo del contesto sociale (fino a non molti anni fa alle donne erano precluse alcune professioni e nella Chiesa cattolica è precluso il sacerdozio)» (Breve storia della mafia e dell’antimafia, Di Girolamo, Trapani 2011: 26). Se è vero che il maschilismo non è una “specificità” della mafia, tuttavia ritengo che esso nel sistema mafioso si declini in maniera “specifica”: in questo breve saggio proverò a mostrarlo a proposito della condizione sia delle donne rimaste dentro il sistema mafioso sia delle ‘ribelli’ che ne sono uscite.
[6] C. Gillican – N. Snider, Perché il patriarcato persiste?, Vanda Edizioni, Milano 2021: 32.
[7] Dovrebbe essere pleonastico precisare che diciture come “dentro” e “fuori” il sotto-sistema mafioso sono solo approssimazioni categoriali ad uso analitico: nessuna donna (come nessun cittadino) è integralmente ed esclusivamente “dentro” o “fuori” la sfera d’influenza mafiosa (soprattutto dal punto di vista della mentalità). In particolare, poi, sono individuabili nel Paese delle “zone grigie” in cui «il consenso nei confronti delle mafie» è semi-cosciente e «si può spezzare solo col dialogo, il dubbio, l’ascolto non giudicante» (C. Triolo in C. Natoli – C. Triolo, Trent’anni dopo: l’eredità di chi non c’era in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 219).
[8] Noto, en passant, che questa illusione ottica vale – anche al di là della violenza contro le donne – se confrontiamo in generale la violenza mafiosa e la violenza patriarcale. Come il sistema mafioso è oppressivo anche quando non uccide (anzi, forse soprattutto quando non ha bisogno di ricorrere alla violenza esplicita, esercitata) così il sistema patriarcale-maschilista è oppressivo anche quando non uccide (anzi, l’intensificarsi dei femminicidi è la spia di una crescente resistenza femminile alla ‘normalità’ della subordinazione di genere). Ma la maggioranza della popolazione (pur essendone essa stessa vittima quotidiana) si accorge della violenza strutturale della mafia (ai danni di cittadini di ogni ‘genere’) e del patriarcato (ai danni in primis delle donne) solo quando vede il sangue. Evidenziata questa affinità globale, va precisato che la violenza mafiosa ha un carattere “programmatico” (viene progettata con freddezza in una politica di cosca ed attuata anche senza nessun coinvolgimento emotivo) (cfr. G. Chinnici – U. Santino, La violenza programmata. Omicidi e guerre di mafia a Palermo dagli anni ’60 a oggi, Franco Angeli, Milano 1991), laddove la violenza maschilista-patriarcale, per quanto possa essere pianificata (al massimo, di solito, per un breve periodo), non rientra in una logica collettiva (non esiste il partito o il sindacato o il movimento degli uomini violenti) e non viene attuata senza che l’omicida (a meno di essere un killer prezzolato) provi soggettivamente odio verso la vittima designata.
[9] S. Pollice, Il filo che ci unisce in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 145.
[10] C. Lombardo, Raccontare, semplicemente raccontare in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 91.
[11] Qui l’occhio analitico dell’osservatore deve farsi particolarmente attento. Come ricorda Maria Livia Alga (in Pa’ suvicchiaria. L’agire mafioso della burocrazia in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 164), secondo Simone Weil «la violenza pietrifica, diversamente, e ugualmente, le anime di quelli che la subiscono e di quelli che la usano». L’asserto vale tanto se parliamo di uomini violenti in generale quanto se parliamo di mafiosi: infatti il sistema mafioso mortifica e avvilisce l’umanità non solo delle vittime ma anche dei carnefici, così come “la mentalità patriarcale” impoverisce e rattrappisce la personalità degli stessi maschi che la riproducono passivamente. A riprova si potrebbero evocare quei maschi evoluti che sono riusciti a emanciparsi, contestualmente, tanto dal sistema mafioso quanto dal maschilismo, come Peppino Impastato che «nel corso della sua breve vita» mostrò in pratica «un nuovo modo di relazionarsi tra i generi» (E. Costa, Non posso non partire da me in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 52). Tuttavia i due tipi di violenza non vanno necessariamente insieme: un medesimo soggetto violento può mortificare sé stesso perché esercita violenza sia (in quanto maschio patriarcale) contro le donne sia (in quanto mafioso) contro ogni nemico della cosca: ma, come ho accennato sopra, può esercitarla da maschilista patriarcale senza mai sfiorare con un dito un avversario o da mafioso senza mai sfiorare con un dito una donna (a meno che non gli sia ordinato dai capi della organizzazione criminale cui è legato da giuramento di obbedienza).
[12] M. Di Carlo, Rimettendo assieme i cocci in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 72
[13] G. Modica, Ritrovare la propria ombra in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 101.
[14] Ivi: 98.
[15] C. Gillican – N. Snider, Perché il patriarcato persiste?, cit.: 179.
[16] A. Dino in Che c’entriamo noi. Conversazione tra Alessandra e Gisella in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 19.
[17] «Alcune persone traggono benefici dall’organizzazione istituzionale ed economica patriarcale e hanno un interesse collettivo di mantenerli. Tuttavia ogni teoria politica o sociale poggia su una psicologia, vale a dire una serie di presupposti su ciò che le persone vogliono e cosa le motiva» (C. Gillican – N. Snider, Perché il patriarcato persiste?, cit.: 34-35). Per questo «il cambiamento politico dipende dalla trasformazione psicologica e viceversa. Se lasciamo intatta la psicologia del patriarcato, difficilmente ci libereremo della sua politica. Se lasciamo la sua politica al suo posto, facilmente la sua psicologia viene scambiata per naturale» (ivi: 184).
[18] Il brano, da un’intervista allegata alla tesi di laurea di Stella Di Vincenzo (Le donne d’onore e l’onore delle donne: Cosa Nostra al femminile tra appartenenza e opposizione), è citato da G. Modica in Che c’entriamo noi. Conversazione tra Alessandra e Gisella in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 20.
[19] N. Dalla Chiesa, Dove nessuna Antigone era permessa. Donne e mafia: venticinque anni tra Cosa Nostra e ‘ndrangheta in “L’Indice dei libri del mese”, XXXVII, 11: 5. Trovo la citazione nella dotta rassegna bibliografica di C. Bracchi, Della genealogia di Antigone in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 245-246.
[20] C. Gillican – N. Snider, Perché il patriarcato persiste?, cit.: 177.
[21] R. Siebert, Le donne, la mafia, Il Saggiatore, Milano 1994: 263.
[22] «Siebert ha anche combattuto con forza il pregiudizio in cui tanto da parte della mafia, quanto per un certo tempo anche da parte dell’antimafia, sono state rinchiuse le donne: l’idea che non potessero essere considerate responsabili delle loro azioni. […] Nelle sentenze si legge chiaramente come le donne, non avendo il sufficiente grado di autonomia per essere riconosciute responsabili del reato di associazione mafiosa, se hanno commesso reati lo hanno fatto “per seguire i loro uomini”. L’antimafia faceva così da specchio a quello che la mafia esprimeva a proposito delle donne» (S. Pollice, Il filo che ci unisce in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 20). Sulla scia della Siebert, anche Ombretta Ingrascì denunzia in proposito un certo «paternalismo giudiziario» (Donne d’onore. Storie di mafia al femminile, Bruno Mondadori, Milano 2007: 97).
[23] A. Puglisi, Donne, Mafia e Antimafia, Di Girolamo, Trapani 2012: 13. Cfr. Anche O. Ingrascì, Donne d’onore, cit.: 51-57.
[24] Ivi: 14. Cfr. anche, O. Ingrascì, Donne d’onore, cit.: 57-61.
[25] Ivi: 14. Cfr. anche O. Ingrascì, Donne d’onore, cit.: 63-74.
[26] Per esempio Margherita Gangemi, moglie di Antonino Calderone o Maria Cristina De Almeida Guimaraes, terza e ultima moglie di Tommaso Buscetta (sulle quali cfr. O. Ingrascì, Donne d’onore, cit.: 139-141) o anche Rita Simoncini, che accompagna il marito Francesco Marino Mannoia nel percorso di collaborazione inducendolo a preferire «l’amore ai tradizionali valori famigliari conformi al codice mafioso» (così Giovanni Falcone in L. Madeo, Donne di mafia. Vittime. Complici. Protagoniste, Mondadori, Milano 1994: 25).
[27] Per esempio le mogli di Totuccio Contorno, Gaspare Mutolo, Leonardo Messina.
[28] «La strategia anti-pentitismo» adottata dalla ‘ndrangheta sembra «basata non tanto su azioni vendicative, quanto piuttosto sulla persuasione dei delatori»: «le ‘pecorelle smarrite’ non vengono uccise ma ricontattate una per una, promettendo opportunità migliori di quelle proposte dallo Stato. Pedine di questa tecnica di riconquista sono state le donne che hanno svolto un ruolo molto prezioso nel far tornare nei binari i propri uomini devianti» (O. Ingrascì, Confessioni di un padre. Il pentito Emilio Di Giovine racconta la ‘ndrangheta alla figlia, Melampo Editore, Milano 2013: 139. L’autrice rimanda in nota sia al saggio di R. Sciarrone, Passaggio di frontiera: la difficile via d’uscita dalla mafia calabrese in A. Dino, Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica, Donzelli Editore, Roma 2006: 129-162, sia al saggio di R. Siebert, Donne di mafia: affermazione di uno pseudo-soggetto femminile. Il caso della ‘Ndrangheta in Aa.Vv., Donne e mafie, Università degli Studi di Palermo, Palermo 2002).
[29] A. Puglisi – U. Santino, Donne e pentitismo in A. Puglisi, Donne, cit.: 49. Alla radice di queste sceneggiate «c’è la paura e la volontà di prevenire la ritorsione, ma c’è pure, e in alcuni casi soprattutto, la volontà di persistenza nel ruolo, che non è sempre un ruolo passivo, ma può essere un ruolo attivo, legato ai vantaggi che offre l’universo mafioso» (ivi: 73). Per il riferimento circostanziato a vari casi concreti cfr. anche O. Ingrascì, Donne d’onore, cit.: 141-148).
[30] L. Violante, Introduzione a T. Principato – A. Dino, Mafia Donna. Le vestali del sacro e dell’onore, Flaccovio, Palermo 1997: 5-6.
[31] Come tutte le legittimazioni ideologiche, anche questa si rivela falsificata dall’esperienza storica effettiva. Come si esprime una collaboratrice di giustizia, convinta di essere stata “tradita” dai suoi stessi fratelli di sangue, a proposito dell’“attaccamento alla famiglia” da parte loro: «Non è che gli danno il valore della famiglia, è per convenienza; cioè come la sigaretta si usa e si getta. Ti uso quando mi fai quella determinata cosa, ti butto a terra quando non la fai» (A. Dino, Frammenti di biografie plurali, cit.: 139).
[32] Ivi: 11.
[33] Definirei tale ogni (apparente) emancipazione, ‘dentro’ e ‘fuori’ il sistema mafioso, in cui la donna – invece di ‘femminilizzare’ il sistema in cui è inserita – si traveste da maschio scimmiottandone i tratti più duri, aggressivi, violenti (So benissimo che anche il termine ‘femminilizzazione’ comporta una sua ambiguità: in linea di principio, infatti, alcune qualità tradizionalmente attribuite alle donne – pazienza, mitezza, cura dei deboli… – appartengono all’umanità in quanto tale).
[34] Cfr. O. Ingrascì, Donne d’onore, cit.: 84-91. In questo paragrafo, significativamente intitolato La teoria della pseudoemancipazione, l’autrice scrive tra l’altro: «Anche la situazione in cui una donna si pone alla guida di un clan risponde, infatti, alla logica secondo cui l’uomo utilizza le donne nel mercato criminale quando gli servono, continuando in tal modo a esercitare la propria autorità. È una delle ragioni per cui la trasformazione della condizione delle donne nella mafia va interpretata non tanto come espressione di un progresso del loro status, quanto come la riproduzione di un modello tradizionale, quello patriarcale, che non si è modificato nel tempo» (ivi: 89-90).
[35] Il termine evoca il titolo di un libro di N. Dalla Chiesa (Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore, Melampo Editore, Milano 2006) che però racconta le storie anche di donne (la madre di Salvatore Carnevale, la madre di Roberto Antiochia e la sorella di Paolo Borsellino) che si sono schierate contro la ragnatela mafiosa senza esserne mai state impigliate.
[36] Nel capitolo dedicato a Le collaboratrici di giustizia Ombretta Ingascì distingue «il modello vendicativo» (ivi: 149) e «il modello emancipativo» (ivi: 152-159) nel quale ultimo rientra, a suo avviso, la vicenda da lei stessa raccolta della “pentita” Rosa N. (ivi: 160-176).
[37] Alessandra Dino sintetizza «la specificità della violenza di genere nei confronti delle donne di mafia» (ovviamente se si tratta di donne non prone ai voleri dei maschi-boss) in 5 caratteristiche: «nella crudeltà, con livelli di particolare ‘ferocia’, quando le due forme (di genere e mafiosa) si ‘mischiano’, quando occorre far rispettare le regole; nella difficoltà nel sanzionare la violenza di genere nei processi per mafia, laddove prevale il reato più grave; negli aspetti simbolici della violenza e nella loro differenza tra le varie organizzazioni (donne suicidate con l’acido, costrette a defenestrarsi); nel doppio isolamento delle donne nei contesti mafiosi e nella difficoltà nel prender atto della violenza, considerata normale o come sanzione meritata; nella difficoltà di fuoriuscita» (A. Dino in Che c’entriamo noi. Conversazione tra Alessandra e Gisella in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 36).
[38] Un’ efficace sintesi di maschilismo patriarcale (generico), salvaguardia dell’“onore” familiare e omofobia la si ritrova nel caso del ‘ndranghetista Emilio Di Giovine: «avrebbe voluto uccidere una sorella solo perché, dice lui, era una ‘lesbica’. Lo ammette: “Ero maschilista, peggio dei razzisti. Avevo i paraocchi”. E la sua cultura mafiosa prevede che solo il sangue possa lavare un’offesa all’onore della famiglia» (E. Ciconte, Prefazione in O. Ingrascì, Confessioni di un padre, cit.: 13).
[39] Cfr. P. De Chiara, Il coraggio di dire noi. Lea Garofalo, la donna che sfidò la ‘ndrangheta, Falco Editore, Cosenza 2012 e M. Demaria, La scelta di Lea. Lea Garofalo, la ribellione di una donna alla ‘ndrangheta, Melampo, Milano 2013.
[40] Cfr. A. Cordaro – S. Palazzolo, Se muoio, sopravvivimi. La storia di mia madre che non voleva essere più la figlia di un mafioso, Melampo Editore, Milano 2012 (Alessio Cordaro, co-autore insieme al giornalista Salvo Palazzolo, è il figlio di Lia Pipitone e aveva solo 4 anni quando la madre è stata assassinata in circostanze tuttora non chiarite).
[41] Cfr. R. Brancato, Con i tuoi occhi. Storia di Graziella Campagna uccisa dalla mafia, La Zisa, Palermo 2010.
[42] Nel lungo elenco di vittime di mafia ‘innocenti’ (cioè non aderenti a cosche mafiose) stilato da U. Santino (L’altra Sicilia. Caduti nella lotta contro la mafia e per la democrazia dai Fasci siciliani ai nostri giorni, Di Girolamo, Trapani 2010) si possono rintracciare nomi di minori, di preti e di donne. Per i piccoli, in particolare, cfr. anche il paragrafo La mafia uccide anche i bambini del volume di U. Santino, Breve storia della mafia e dell’antimafia, cit.: 152-154.
[43] Anna Puglisi ha raccolto le sue conversazioni con le compagne di Francesco Renda, Cesare Terranova e Paolo Giaccone in Storie di donne. Antonietta Renda, Giovanna Terranova, Camilla Giaccone raccontano la loro vita, Di Girolamo, Trapani 2007. Rita Bartoli Costa, vedova del Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa, si è raccontata autobiograficamente nel suo Una storia vera a Palermo, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2002; altrettanto Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo, nel suo Nata il 19 luglio. Lo sguardo dolce dell’antimafia, Editore Melampo, Milano 2006. Già nell’Ottocento abbiamo figure di donne che – nate e cresciute fuori da logiche mafiose e para-mafiose – non hanno esitato a denunziare i mafiosi del loro territorio: Giuseppa Di Sano, Agata Mazzola, Margherita Lo Verde (cfr. U. Santino, La mafia dimenticata. La criminalità organizzata in Sicilia dall’Unità d’Italia ai primi del Novecento. Le inchieste, i processi. Un documento storico, Melampo Editore, Milano 2017: 302 -307) e Giovanna Cirillo che pubblica una denunzia contro il sindaco di Marineo e altri mafiosi, da lei ritenuti responsabili morali del suicidio del marito – integerrimo delegato di Pubblica Sicurezza – Stanislao Rampolla del Tindaro (cfr. A. Puglisi in Donne, Mafia e Antimafia, cit.: 13 che rimanda a G. Cirillo Rampolla, Suicidio per mafia, La Luna, Palermo 1986). Nel Novecento forse la pioniera e l’emblema di tutte le donne che si sono scagliate pubblicamente contro gli assassini mafiosi è stata Francesca Serio, madre del sindacalista Salvatore Carnevale (1955).
[44] A. Puglisi, Donne, Mafia e Antimafia, cit.: 16.
[45] Anna Puglisi ha rievocato le vicende di alcune di queste donne (Maria Benigno, Vita Rugnetta e altre) nel suo Donne, Mafia e Antimafia, cit.:15-17) e ha pubblicato, dopo averle raccolto personalmente, le storie di vita di Michela Buscemi e Piera Lo Verso in Sole contro la mafia, La Luna, Palermo 1990. Celebre, anche per il legame filiale con il giudice Paolo Borsellino e per la tragicità dell’esito, la vicenda di Rita Atria (cui – dopo il testo di Sandra Rizza, Una ragazza contro la mafia, La Luna, Palermo 1993 – sono dedicati ormai molti titoli). Ma la figura-simbolo delle donne che rompono radicalmente con l’ambiente mafioso di origine e si schierano nettamente sul fronte opposto resta Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, di cui leggere l’intervista a cura di A. Puglisi e U. Santino, La mafia in casa mia, Di Girolamo, Trapani 2018. Gli stessi studiosi hanno pubblicato, dopo la morte della protagonista, il dossier Cara Felicia. A Felicia Bartolotta Impastato, Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, Palermo 2005.
[46] A. Puglisi, Donne, Mafia e Antimafia, cit.: 13.
[47] Sia pure su un registro meno drammatico, tutte le persone che abbiamo frequentazioni con ex-mafiosi, ad esempio per progetti di volontariato nelle carceri, siamo alla costante ricerca di un precario equilibrio fra la dimensione affettiva della relazione («Però avevano una tenerezza…Una tenerezza che per pregiudizio non conferiresti mai a…a un mafioso o ex mafioso» confida una studentessa universitaria a proposito di detenuti incontrati nel corso di un laboratorio nel carcere di Milano Bollate: cfr. A. Dino in Che c’entriamo noi. Conversazione tra Alessandra e Gisella in A. Dino – G. Modica, Che c’entriamo noi, cit.: 34) e «il rispetto delle centinaia di persone le cui vite sono state distrutte, fisicamente o psicologicamente», da questi “assassini”» (ivi: 33).
[48] L. Alga, Pa’ suvicchiaria, cit.:169-170.
[49] Ivi: 169.
_____________________________________________________________
Augusto Cavadi, già docente presso vari Licei siciliani, co-dirige insieme alla moglie Adriana Saieva la “Casa dell’equità e della bellezza” di Palermo. Collabora stabilmente con il sito http://www.zerozeronews.it/. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica (con particolare attenzione al fenomeno mafioso), nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); La mafia desnuda – L’esperienza della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone” (Di Girolamo, 2017); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018), Dio visto da Sud. La Sicilia crocevia di religioni e agnosticismi (SCe, 2020); O religione o ateismo? La spiritualità “laica” come fondamento comune (Algra 2021).
______________________________________________________________