Una mia amica antropologa svedese, Eva Carlestal, che ha svolto qualche anno fa una ricerca etnografica in Sicilia su una comunità di pesca, ha osservato che «i siciliani si riuniscono spesso per condividere un pasto, ma godono anche soltanto nel discutere del cibo e condividerne le ricette. Di solito hanno opinioni molto solide su come i vari piatti dovrebbero essere preparati, e amano parlarne e confrontare il loro modo di cucinare una certa pietanza con quello degli altri, anche se le differenze sono generalmente minime» (Carlestål, 2012: 116). Che l’alimentazione sia “fatto sociale totale” che pervade ogni aspetto della vita individuale e collettiva è dato antropologico largamente acquisito e documentato. Che nella cultura mediterranea dei popoli il cibo sia di per sé marcato da un elevato tasso di socialità e solennità, oggetto particolarmente “denso” di significati e di investimenti simbolici, è qualcosa che trova nell’esperienza quotidiana e nella letteratura ampia attestazione.
Esiste un’evidente correlazione tra il mangiare e il parlare, tra il cibo che si consuma e le parole che usiamo per prepararlo, accompagnarlo, servirlo, condividerlo, definirlo, gustarlo. Nella comunicazione mangiare è verbo e sostantivo insieme e i pasti – come abbiamo imparato da Barthes – sono organizzati come in un sistema linguistico, avendo una grammatica con una specifica morfologia, una precisa sintassi e un lessico tecnico. E come la lingua, appresa in modo irriflesso fin dalla nascita, l’alimentazione è fatto eminentemente identitario, segnato da tradizioni, storie, memorie, domesticità e riconoscibilità. La narrazione di un pasto è la sua naturale appendice, destinata a costituirne la memoria e a nutrirne l’immaginario. Mangiamo e parliamo di ciò che mangiamo per cui – alla fin fine – siamo ciò che mangiamo e mangiamo quello che siamo in un pervasivo e totalizzante cortocircuito che può dare vita a quel fenomeno coniato come “gastromania”.
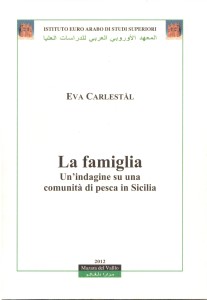 Non c’è probabilmente nulla oggi di più mediatico della cucina, nulla di più sviscerato, raccontato, rappresentato del cibo che si fa icona, feticcio, metafora, compendio e palinsesto dei nostri desideri, delle nostre emozioni, delle nostre passioni. Non basta più farne oggetto e soggetto di storytelling, di storie e narrazioni, di parole e discorsi intorno alla tavola, nei riti usuali della conversazione e dei dialoghi familiari di cui ha scritto Eva Carlestål. Il cibo da quando ha fatto irruzione nei social è fotografato prima di essere consumato, esibito nell’immancabile scambio dei selfie prima di essere apprezzato nel palato. Questo potente dispositivo semiotico che nella convivialità insegna a conoscere gli uomini e il mondo attraverso la formazione del gusto e l’esperienza dei sapori, rischia oggi, nella società dell’abbondanza, di diventare sempre più segno di se stesso, immagine prima di essere sostanza, simulacro del piacere del vedere e del comunicare che precede e oltrepassa il piacere dell’assaggiare e del mangiare. Un’orgia di piatti curati nella loro bellezza cromatica, nella loro raffinatezza estetica, nella loro invidiata rarità, fin all’esercizio estremo di un compulsivo collezionismo enogastronomico. Una saturazione di figure e di parvenze che si sovrappone all’ipertrofia delle parole, delle retoriche e delle pratiche discorsive contemporanee.
Non c’è probabilmente nulla oggi di più mediatico della cucina, nulla di più sviscerato, raccontato, rappresentato del cibo che si fa icona, feticcio, metafora, compendio e palinsesto dei nostri desideri, delle nostre emozioni, delle nostre passioni. Non basta più farne oggetto e soggetto di storytelling, di storie e narrazioni, di parole e discorsi intorno alla tavola, nei riti usuali della conversazione e dei dialoghi familiari di cui ha scritto Eva Carlestål. Il cibo da quando ha fatto irruzione nei social è fotografato prima di essere consumato, esibito nell’immancabile scambio dei selfie prima di essere apprezzato nel palato. Questo potente dispositivo semiotico che nella convivialità insegna a conoscere gli uomini e il mondo attraverso la formazione del gusto e l’esperienza dei sapori, rischia oggi, nella società dell’abbondanza, di diventare sempre più segno di se stesso, immagine prima di essere sostanza, simulacro del piacere del vedere e del comunicare che precede e oltrepassa il piacere dell’assaggiare e del mangiare. Un’orgia di piatti curati nella loro bellezza cromatica, nella loro raffinatezza estetica, nella loro invidiata rarità, fin all’esercizio estremo di un compulsivo collezionismo enogastronomico. Una saturazione di figure e di parvenze che si sovrappone all’ipertrofia delle parole, delle retoriche e delle pratiche discorsive contemporanee.
La verità è che il cibo in quanto luogo paradigmatico di transizione dalla natura alla cultura, formidabile vettore delle azioni e delle relazioni tra gli uomini, fulcro gravitazionale di una moltitudine di simboli, è sempre stato al centro di un sistema mobile di segni che attraversano le frontiere più diverse, interessando le sfere della biologia e dell’economia, dell’etica e dell’estetica, della mitologia e della geografia, della tecnologia e dell’ecologia, della sociologia e della politica. Contro l’infondata tesi dell’autoctonia delle cucine è ormai prevalente lo studio critico delle cosiddette ‘tipicità’ culinarie, invenzioni della tradizione come ci hanno insegnato Hobsbawn e Ranger. Nella migrazione si generano e si plasmano le identità alimentari, che non sono realtà endogene e metafisiche ma paesaggi nomadi, confini che si spostano, orizzonti permeabili alle sperimentazioni, alle contaminazioni, allo scambio. Il cibo ha sempre viaggiato con gli uomini e le cucine, per quanto evidenti marcatori culturali, sono storicamente e antropologicamente meticce, esiti di contatti e ibridismi, di associazioni composite e feconde commistioni. «Un’arte combinatoria – ha scritto Camporesi (1998: 123) – d’interpolazione più che di invenzione, i cui processi avvengono sotto il segno della variazione più che della creazione pura»
 Il Mediterraneo è il mare per eccellenza snodo plurisecolare di circolazione degli uomini e dei beni, avendo formato con le terre che lo circondano un sistema indivisibile, una trama connettiva di interazioni e prestiti, di mescolanze e scambi. Così è stato per le tecniche, le religioni e le lingue. Così è stato ed è per i cibi, le abitudini alimentari, le materie prime e i saperi legati alla loro trasformazione, le cucine migrate con i traffici e le diaspore degli uomini. Dialoghi nati intorno ad una delle esperienze del vissuto quotidiano più naturali e apparentemente meno intellettuali, certamente più accessibili e condivisibili, essendo i confini tra le culture gastronomiche meno rigidi e vischiosi rispetto ai complessi sistemi linguistici e religiosi. Nell’ospitalità mediterranea i piatti delle diverse cucine sconfinano e trovano tolleranza e accoglienza, pur rappresentando ognuno di essi indubbia e orgogliosa espressione di appartenenza e distinzione identitaria. La loro preparazione, infatti, è sintesi di influenze e confluenze, di innesti e adattamenti di prodotti eterogenei, in un gioco di rifrazioni di costumi, usi, pratiche e modelli.
Il Mediterraneo è il mare per eccellenza snodo plurisecolare di circolazione degli uomini e dei beni, avendo formato con le terre che lo circondano un sistema indivisibile, una trama connettiva di interazioni e prestiti, di mescolanze e scambi. Così è stato per le tecniche, le religioni e le lingue. Così è stato ed è per i cibi, le abitudini alimentari, le materie prime e i saperi legati alla loro trasformazione, le cucine migrate con i traffici e le diaspore degli uomini. Dialoghi nati intorno ad una delle esperienze del vissuto quotidiano più naturali e apparentemente meno intellettuali, certamente più accessibili e condivisibili, essendo i confini tra le culture gastronomiche meno rigidi e vischiosi rispetto ai complessi sistemi linguistici e religiosi. Nell’ospitalità mediterranea i piatti delle diverse cucine sconfinano e trovano tolleranza e accoglienza, pur rappresentando ognuno di essi indubbia e orgogliosa espressione di appartenenza e distinzione identitaria. La loro preparazione, infatti, è sintesi di influenze e confluenze, di innesti e adattamenti di prodotti eterogenei, in un gioco di rifrazioni di costumi, usi, pratiche e modelli.
Nel segno della frugalità le società che il mare ha messo in relazione in un circuito di economia transnazionale hanno costruito un fitto reticolo di specificità alimentari che si differenziano ma si somigliano, essendo l’ibridazione – non l’addizione né la sovrapposizione – il carattere fondante della loro storia culturale, secondata da un ambiente naturale pressoché omogeneo. Come ha documentato Braudel per ampia parte del mondo mediterraneo, farinate e cereali costituiscono i tratti costitutivi dei patrimoni gastronomici, sostrato unitario delle varietà dei regimi e degli stili alimentari basati sulle stesse sostanze. Se il prodotto è frutto di un territorio, di una pianta coltivata, di una risorsa agricola originaria, la cucina è per se stessa laboratorio di elaborazioni e mediazioni, alchimia di cotture e vapori, ordito di espedienti e sperimentazioni, concordia discors di processi sincretici per effetto di contaminazioni, selezioni, fusioni e trasformazioni. Gli studi sulla genesi della pasta come della pizza hanno dimostrato che le “invenzioni” dei due totem della gastronomia all’italiana, sono in verità operazioni la cui complessità dipende dalla lenta costruzione e integrazione di saperi, di manualità, di gusti lievitati e migrati da una sponda all’altra, da una tavola all’altra.
Di questa straordinaria vicenda di modulazione e acculturazione alimentare nello spazio mediterraneo è esemplare la storia del couscous di cui scrive in uno appassionante volume il sociologo delle religioni Enzo Pace: Couscous. Una storia mediterranea (Cleup Padova 2022). Un saggio che, nel ripercorrere il periplo descritto da questo piatto, ricostruisce aspetti, segreti e suggestioni dell’universo materiale e immateriale racchiuso tra i suoi granelli di semola. Il racconto del viaggio nel tempo e nello spazio geografico attraversando i confini di culture e religioni diverse si richiama allo stile e al genere di scrittura inaugurati e privilegiati tra l’VIII e il IX secolo dalla letteratura araba, una narrazione diaristica che in qualche modo anticipava i resoconti etnografici diffusi secoli dopo, ad opera di missionari, esploratori, mercanti e soldati. L’autore ne recupera la leggerezza nella prosa e la curiosità nell’approccio intellettuale, una postura che senza nulla togliere allo spessore scientifico dei contenuti esposti ne accresce la leggibilità e l’intelligibilità. Così dà conto di incontri e di esperienze autobiografiche, di visite a luoghi e città, di memorie di manoscritti e libri antichi, di divagazioni politiche e incursioni nell’attualità. Un libro che, per una qualche affinità nel metodo alieno ad una facile catalogazione di genere, può accostarsi agli scritti di Piero Camporesi, raffinatissimo filologo attento alle più singolari evoluzioni gastronomiche.
Del viaggio e del viaggiare – chiave e guida interpretativa che ispira la sintassi di tutte le pagine – il couscous è davvero la metafora più compiuta, incarnando al massimo grado il nomadismo e il vagabondaggio dei cibi, la loro circolazione e penetrazione nella vasta area del Mediterraneo, la capacità di espansione dei sapori, dei gusti, delle percezioni sensoriali legate a determinati alimenti e alla loro produzione e consumo.
«Il couscous – scrive Enzo Pace – parla molte lingue, si sposa felicemente con religioni diverse, viaggia nel tempo e si sposta nello spazio adattandosi al gusto diversificato di popoli e comunità religiose differenti, conquista territori insospettati e scala posizioni di rango nella classifica dei cibi raffinati, pur partendo storicamente da un gradino inferiore, da cibo umile e popolare».
 Lo studioso cerca le tracce di questo piatto negli antichi libri di ricette, numerosi già nel IX secolo, quando a Baghdad la corte dei primi califfi abbasidi ereditarono e diffusero l’esperienza dell’alta cucina della precedente dinastia omayyade. Il couscous figura nei testi di dietetica, nei trattati di medicina araba, è attestato in documenti e in opere che risalgono ai secoli XII e XIII stampati in Oriente ma anche in Occidente, a testimoniare la complessa storia di sguardi incrociati, di assorbimenti, adattamenti ed evoluzioni di questo cibo che, nato nomade e povero in ambienti berberi dell’Ifriqiyya indispensabile alla mera sopravvivenza, «evolve in sofisticati piatti che entrano a far parte dei menu di corte, mentre continua ad accompagnare riti di passaggio, eventi religiosi festivi, momenti di elaborazione del lutto e celebrazioni comunitarie nella vita di famiglie di diversa estrazione sociale». Nelle pagine del suo famoso manuale, La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, del 1891, Pellegrino Artusi scrive del cuscussù come di un “grande intruglio” che «i discendenti di Mosè e di Giacobbe hanno, nelle loro peregrinazioni, portato in giro per il mondo, ma chi sa quante e quali modificazioni avrà subite dal tempo e dal lungo cammino percorso. Ora è usato in Italia per minestra dagli israeliti» (1994: 32).
Lo studioso cerca le tracce di questo piatto negli antichi libri di ricette, numerosi già nel IX secolo, quando a Baghdad la corte dei primi califfi abbasidi ereditarono e diffusero l’esperienza dell’alta cucina della precedente dinastia omayyade. Il couscous figura nei testi di dietetica, nei trattati di medicina araba, è attestato in documenti e in opere che risalgono ai secoli XII e XIII stampati in Oriente ma anche in Occidente, a testimoniare la complessa storia di sguardi incrociati, di assorbimenti, adattamenti ed evoluzioni di questo cibo che, nato nomade e povero in ambienti berberi dell’Ifriqiyya indispensabile alla mera sopravvivenza, «evolve in sofisticati piatti che entrano a far parte dei menu di corte, mentre continua ad accompagnare riti di passaggio, eventi religiosi festivi, momenti di elaborazione del lutto e celebrazioni comunitarie nella vita di famiglie di diversa estrazione sociale». Nelle pagine del suo famoso manuale, La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, del 1891, Pellegrino Artusi scrive del cuscussù come di un “grande intruglio” che «i discendenti di Mosè e di Giacobbe hanno, nelle loro peregrinazioni, portato in giro per il mondo, ma chi sa quante e quali modificazioni avrà subite dal tempo e dal lungo cammino percorso. Ora è usato in Italia per minestra dagli israeliti» (1994: 32).
Alle vicende connesse ai berberi Pace dedica un denso capitolo. A loro si deve il nome del couscous: da keskesu, che significativamente rinvia al gesto creativo della mano impegnata a dare forma rotonda e perfetto calibro ai piccoli granuli della semola. Nel racconto su questo popolo del Nordafrica, appartato e orgoglioso della sua autonomia etnica che ha cercato di difendere contro l’islamizzazione forzata e la colonizzazione europea, si comprendono i significati originari e culturali di questo alimento basico inventato ai margini della falesia storica della riva sud del Mediterraneo e destinato ad attraversare il mare e le vie più diverse dei continenti. Una ingegnosa creazione che plasmata dalla cultura della povertà e della fame conosce una sorprendente circolazione fino a diventare canone e referente gastronomico, piatto prelibato, cucina identitaria, mediterranea e nello stesso tempo transnazionale. Sul mare il couscous ha viaggiato, migrando con gli uomini tra le rive, con i pescatori e i naviganti, con i commercianti e i missionari e perfino con i pirati barbareschi delle guerre da corsa che ne apprezzavano le qualità.
“Buono da mangiare” ma anche “buono da pensare”, essendo particolarmente stratificato e denso di segni e di sensi, di contesti e di memorie, un palinsesto di risorse simboliche in grado parlarci della cultura e degli uomini che l’hanno prodotta, di chiarire i rapporti che legano l’alimentazione al sistema di quei valori etici ed estetici che travalicano e governano la mera commestibilità dei cibi. Come da etnico o territorialmente “tipico” il couscous sia diventato un piatto senza frontiere, dal locale al globale, si spiega grazie alla sua stessa storia diasporica, alla sua plastica e versatile composizione, alla sedimentazione e incorporazione di mondi gastronomici diversi, alla notevole screziatura degli ingredienti combinati. Come nel frutto del melograno si tengono insieme i chicchi dolci e succulenti nel mito augurale di unità, ricchezza e fertilità, così nel piatto unico del couscous si associano cereali, carne, pesce o verdure alla molteplicità dei granuli tutti eguali la cui messa in forma – scrive Enzo Pace –
«è come la messa in scena della genesi dell’universo. Mani sapienti sanno trasformare una materia umida e amorfa (farina, semola, altri cereali), con un movimento rotatorio e d’attrito, in una costellazione di granuli che si moltiplicano a vista d’occhio, nascendo per separazione continua dalla massa informe iniziale».
Sono le donne a lavorare e a dare forma all’impasto, protagoniste, a guardar bene – come in tutte le culture popolari mediterranee – dei processi di produzione e riproduzione della vita, delle tecniche di trasformazione delle materie prime alimentari: forze cosmogoniche responsabili della transizione dal disordine all’ordine, dal caos al cosmos. Sono gli uomini, invece, le figure in primo piano nel consumo tradizionalmente condiviso sul tappeto o su una stuoia attorno ad un grande piatto circolare, quando i grani di semola si portano con le dita alla bocca a piccoli pugni, come a rinnovare la memoria dell’origine nomade del pasto e a rafforzarne nella tattilità del contatto la dimensione comunitaria e conviviale, i legami che uniscono i commensali in un gesto formalizzato che non è solo finalizzato al nutrirsi.
L’autore descrive mappe e rotte intercontinentali del couscous, passa in rassegna le varianti locali con le diverse denominazioni, ne sottolinea affinità e differenze nella comparazione con i “nobili contendenti” (bulgur, tabbouleh, kubbah, trahanas) in Medio Oriente, in Turchia e in Grecia, narra fatti minuti e aneddoti personali, intreccia le vicende culinarie con la storia politica e soprattutto con le esperienze di acculturazione in Italia. In Sicilia, che ha conosciuto la prima dominazione arabo-berbera, il piatto prevalentemente a base di pesce si diffonde nelle famiglie dei pescatori, non è più un prodotto d’importazione, si indigenizza e diventa nei monasteri “dolce”, con l’aggiunta del pistacchio, la zuccata, le mandorle, la cannella e il cioccolato. In Sardegna col nome di cascà si incrocia con la pesca del corallo e si sposa con il tonno. A Livorno approda nel ‘500 con le comunità di ebrei provenienti dal Nord Africa, fondendo gusti e sapori arabo-ebraici-andalusi con quelli ebraico-maghrebino-siculi e lasciando tracce durevoli nella cucina penetrata nelle regioni dell’Italia centrale e migrata anche a Genova e Venezia.
Da eminente sociologo delle religioni Enzo Pace non può non dedicare la sua attenzione agli ineludibili legami tra l’alimentazione e la dimensione del sacro, tra i cibi e i riti, tra l’arte di trasformazione delle materie prime e le rappresentazioni simboliche. L’atto umano apparentemente più naturale e materiale rinvia, infatti, ad un articolato sistema di norme e protocolli che istituiscono le frontiere tra lecito e illecito, tra puro e impuro, tra Eros e Thanatos, tra immanenza e trascendenza. Nelle pratiche tradizionali del suo consumo il couscous ribadisce quel patto sociale e rituale consustanziale al pasto in comune, quella fratellanza spirituale sottesa alla condivisione comunitaria. «Mangiando assieme condividiamo non solo il gusto, ma anche i significati che il gusto veicola». Se è vero – contro ogni stereotipo – che le sue origini berbere precedono l’Islam e le sue vicende si mescolano con la storia del cristianesimo e dell’ebraismo nordafricano, nel mondo musulmano che prevede uno scrupoloso e rigoroso codice di condotta alimentare mangiare il couscous è «una forma di sentire per credere, per memorizzare una comune identità religiosa», accompagna le grandi feste del calendario religioso, dalla fine del digiuno del mese di Ramadhan alla ricorrenza del sacrificio; scandisce i riti di passaggio nel ciclo della vita, dalla nascita alla morte, dal parto alla circoncisione dei ragazzi, ai costumi funerari; disciplina gli scambi cerimoniali dei doni e contro-doni, dei culti domestici e delle forme di solidarietà nel dolore individuale e nella esultanza collettiva, rinsaldando i vincoli tra gli uomini e la divinità, tra i vivi e i morti.
Il libro offre un quadro conoscitivo degli usi alimentari, delle esperienze devozionali connesse alle regole del diritto islamico presso le popolazioni del Maghreb e le comunità minoritarie, ne sottolinea le ibridazioni e le variazioni nella prassi e nelle consuetudini delle diverse tradizioni locali o areali. Pur nella sua stretta correlazione alle prescrizioni e interdizioni religiose, il couscous si conferma un piatto cumulativo e accogliente, nelle sue rocambolesche avventure di adattamento, in grado di rendere compatibili gusti e palati diversi, convocando sapori e ingredienti lontani, ospitando il dolce e il salato, il pesce e la carne, le verdure e i legumi in una sintesi che è metafora di convivenza e tolleranza.
«Un cibo – conclude Enzo Pace – che attraversa storie locali senza divenire ostaggio d’identità culturali chiuse e definite una volta per tutte. Un classico cibo che ha bisogno di vari trattini per parlare delle proprie origini e delle variazioni conosciute nel corso del tempo: berbero-arabo-siculo-tabarqino-ebraico e via dicendo, a mano a mano che i confini territoriali di questo piatto si sono allargati, sovrapposti, intrecciati, come la vicenda di quello livornese o trapanese ci hanno insegnato».
Il couscous oggi è entrato nelle cucine dei ristoranti europei, nelle ricette degli chef più rinomati, negli eventi gastronomici che ne celebrano le prelibatezze. A San Vito lo Capo in provincia di Trapani, si tiene dal 1997 un Festival internazionale dedicato a questo piatto, a cui partecipano cuochi e cuoche provenienti da vari Paesi mediterranei e africani: maghrebini, francesi, israeliani, palestinesi, senegalesi, mauritani, ivoriani e italiani si sfidano in una gara che nell’ultima edizione è stata condotta nel nome della pace e più in generale nel segno dell’integrazione culturale. Attorno a questo grande simposio, pur nella retorica dell’evento turistico e della performance di carattere spettacolare, si esalta la funzione di privilegiato vettore di comunicazione e di socializzazione affidata alla alimentazione, si dispiega il mondo di varia umanità e civiltà espresso nelle diverse modalità di preparazione del medesimo cibo, si aprono percorsi di conoscenza reciproca, di convivialità culturale, di ibridazione interetnica. La tavola unisce, si sa, non solo chi consuma la pietanza ma anche chi la prepara. L’immagine dei granelli di semola da aggregare, la versatilità dei condimenti da associare quali frutti stagionali della terra e del mare, la screziatura cromatica dell’insieme in corrispondenza della commistione di gusti di norma tenuti separati, di odori, di spezie e di aromi perfettamente agglomerati fanno del couscous un modello transnazionale di bricolage alimentare, l’icona semantica e simbolica della contaminazione, della condivisione, della coesistenza.
Accade così che una famiglia tunisina oggi immigrata nella provincia di Trapani scopra che il suo piatto preferito è conosciuto e consumato da tempo sulle tavole dei siciliani, impari a modificarne o innovarne la ricetta, a scambiarne i segreti di preparazione, a cimentarsi in nuove esperienze gastronomiche. La cucina diventa spazio e laboratorio di contatti, incontri, dialoghi e il cibo linguaggio di un comune alfabeto, di una socialità ritrovata, di affinità di gesti e tecniche, di familiarità di pratiche e saperi. «Lo scambio di pietanze e conoscenze culinarie – ha scritto Fatima Giallombardo (2003: 14) – è uno dei percorsi ideologici e simbolici attraverso cui gli uomini possono affermare la loro riconoscibilità e, nello stesso tempo, la legittimità delle loro differenze». Quanto può rappresentare l’evidenza più immediata della identità etnica e occasione di rivendicazione e di nostalgica chiusura comunitaria si rivela soglia permeabile, frontiera porosa, formidabile trait d’union, ponte di conoscenza e di reciproca riconoscibilità. Nella conversazione e nel confronto di usi e competenze, parlando di come si prepara ciò che si mangia e di come e quando si mangia ciò che si prepara, nelle parole del cibo e nelle alchimie della cucina, gli uomini e le donne mescolano le lingue, sconfinano oltre le appartenenze, apprezzano le piccole differenze, come aveva osservato Eva Carlestål.
Quando mia madre portava a tavola nei giorni di festa il couscous rigorosamente a base di pesce, preparato dopo lunghe cotture a vapore nella cuscusera forata di terracotta smaltata verde sovrapposta ad una pentola di metallo contenente l’acqua in ebollizione, non l’ho mai percepito come un piatto etnico o esotico giunto a noi dagli sperduti villaggi del Maghreb. Era il prodotto di una cucina domestica, familiare, che mia madre aveva ereditato in casa da sua madre, avendo appreso da giovane l’arte laboriosa di “incocciare” i chicchi di semola di grano duro appena inumiditi, di manipolarli con i polpastrelli per calibrarne perfettamente il diametro, di ungerli con olio e di condirli con spezie e aromi diversi. Perché non si disperdessero i sapori del brodo curava di sigillare bene i bordi dell’uno e dell’altro recipiente con un cordone di farina impastata (cudduriuni) e copriva, a volte, la cuscusera con un panno bagnato e strizzato. Di pesce povero era prevalentemente formata la zuppa destinata al condimento, significativamente denominata gghiotta come quel poco di scorfani o gallinelle che spettava al pescatore alla fine della “bordata”. All’attenzione ai tempi lenti della cottura e della preparazione della zuppa era affidata la compiuta combinazione della semola e del suo condimento, restando il couscous, almeno dalle mie parti, pur con tutte le sue varianti, la più felice sintesi del secco e dell’umido ovvero della terra e del mare. Del resto, che cos’è la cucina della tradizione se non quella plasmata dalla pazienza e dalla cura esercitate nelle lunghe attese davanti al fuoco che trasforma il crudo in cotto, la natura in cultura?
L’antropologo Marco Aime (2004: 136) racconta che in una scuola materna di Torino frequentata da molti alunni maghrebini le maestre hanno deciso un giorno di preparare il couscous, secondo la ricetta “originale” della “tradizione”. Alla fine della giornata, ad un piccolo marocchino la maestra chiese se gli era piaciuto e se era come quello che preparava la sua mamma. «Quello di mia manna è più buono – rispose il bambino – perché mette uno strato di couscous e uno di tortellini, uno di couscous …». Una risposta che nella sua elementare semplicità ci insegna che di tradizionale nell’alimentazione c’è forse solo la cucina materna, che l’ingenua ricerca dell’originale ovvero del punto zero di un cibo o di una ricetta appartiene al piano del mito e dell’immaginario, che il couscous come tutti i piatti e ogni fatto di cultura viaggia nella storia, circola tra gli uomini, dialoga e si ibrida, e di queste dinamiche di persistenza e mutamento nel tempo e nello spazio porta i segni materiali e immateriali. Come ha dimostrato Enzo Pace nel racconto sapientemente tessuto in questo prezioso libro che ha il fascino e il ritmo di un periplo, attraverso il quale scopriamo come nella storia del couscous sia possibile leggere e riepilogare le pagine più significative della millenaria storia del Mediterraneo.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
Riferimenti bibliografici
Aime M., 2004, Eccessi di culture, Einaudi Torino
Artusi P., 1994, La Scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, Einaudi Torino (ed. or. 1891)
Barthes R., 1988, L’alimentazione contemporanea, in Id, Scritti, Einaudi Torino: 31-41
Braudel F., 1996, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Einaudi Torino, vol. 1.
Camporesi P., 1989, La terra e la luna. Alimentazione, folklore e società, Garzanti Milano
Carlestål E., 2012, La famiglia. Un’indagine su una comunità di pesca in Sicilia, Istituto Euroarabo Mazara del Vallo
Giallombardo F., 2003, La tavola, l’altare, la strada. Scenari del cibo in Sicilia, Sellerio Palermo
Hobsbawn E., Ranger T., 2002, L’invenzione della tradizione, Einaudi Torino
Pace E., 2022, Couscous. Una storia mediterranea, Cleup Padova.
______________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020).
______________________________________________________________











