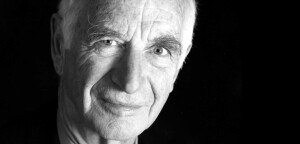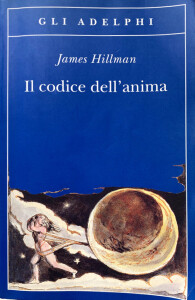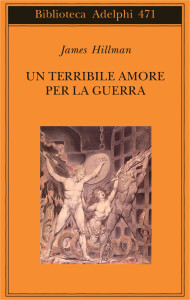di Alberto Giovanni Biuso
Il mito
La salute non può che partire dal recupero dell’elemento divino della malattia. Questo il significato della proposta che James Hillman formula in tutti i suoi testi: passare «da una sistematizzazione ottocentesca, positivistica, della mente e dei suoi disturbi a una psicopatologia degli archetipi, non-agnostica e mitopoietica» [1].
Il significato, la funzione, le strutture del mito affondano nella vita quotidiana degli umani, nelle loro speranze più intime, nelle angosce più fonde, nei pensieri del corpo. E dato che il corpo è sempre sino a che siamo vivi, il mito è consustanziale all’esserci, diventa un archetipo la cui fecondità è perenne. La mitologia non coincide con il mito neoclassicamente inteso poiché non si tratta, qui, di una bella forma o dell’armoniosa architettura della psiche ma delle sue espressioni più radicali e quindi patologiche fino all’orrendo. Il mito greco è il luogo in cui l’immaginale costruisce la propria tela di significati, dove la caverna è sempre aperta, dove dell’orrore si dà conto.
 Soltanto a questa condizione – alla condizione di una sincerità assoluta che guardi in faccia Medusa – il mito può svolgere la sua funzione sia conoscitiva sia terapeutica dei mali che ci affliggono. Paura, incubi e angosce sono infatti parte della natura corporea che ci costituisce. Pan è il Dio che produce e governa questi fenomeni. Ecco perché Pan siamo noi, è la rivelazione «della fondamentale natura dell’uomo che in quanto essere sessuale è tutt’uno con l’essere animale, con l’istinto, e perciò tutt’uno con la natura» [2]. Come il corpomente, Pan è generazione e distruzione, è metabolismo e furia, è passione, è angoscia e desiderio del tutto inseparabili, è immersione nella gioia senza coscienza dell’orgasmo. Una delle forme caratteristiche di Pan è la masturbazione, la quale sessualizza la fantasia e coniuga in modo inseparabile il desiderio e la colpa, l’Io e il Doppio, l’Identità e la Differenza, l’unità e la molteplicità.
Soltanto a questa condizione – alla condizione di una sincerità assoluta che guardi in faccia Medusa – il mito può svolgere la sua funzione sia conoscitiva sia terapeutica dei mali che ci affliggono. Paura, incubi e angosce sono infatti parte della natura corporea che ci costituisce. Pan è il Dio che produce e governa questi fenomeni. Ecco perché Pan siamo noi, è la rivelazione «della fondamentale natura dell’uomo che in quanto essere sessuale è tutt’uno con l’essere animale, con l’istinto, e perciò tutt’uno con la natura» [2]. Come il corpomente, Pan è generazione e distruzione, è metabolismo e furia, è passione, è angoscia e desiderio del tutto inseparabili, è immersione nella gioia senza coscienza dell’orgasmo. Una delle forme caratteristiche di Pan è la masturbazione, la quale sessualizza la fantasia e coniuga in modo inseparabile il desiderio e la colpa, l’Io e il Doppio, l’Identità e la Differenza, l’unità e la molteplicità.
Pan è tutti (pan) gli dèi, Pan è le ninfe, è la malattia e il suo significato, è paura di fronte a uno stimolo, è angoscia rispetto al nulla dell’esserci. È la vita nella sua pienezza tragica e cioè nel suo essere qui, ora, senza senso alcuno al di là di se stessa, un essere oggettivo e impersonale, finalmente libero dall’asservimento agli scopi.
Pan è l’identità animale di un umano che è occidentale e civilizzato ma è anche primitivo e arcaico, è un dionisiaco che pulsa nella struttura corporale poiché Pan è sempre attivo, fremente, è fisicità pura. Pan è l’unione dell’essere e dell’agire, del pensare e del fare, del comportamento e del suo significato, poiché la coscienza non costituisce l’alter del corpo ma è piuttosto il modo nel quale il corpo danza la vita. Pan è l’immediata consapevolezza che il corpo ha di esserci e dunque – nei termini neurobiologici di Antonio Damasio – è il Sé nucleare che fonda le architetture coscienzialistiche del Sé autobiografico.
La forma, la struttura delimitata degli enti, fa sì che ogni essere umano costituisca una singolarità irriducibile a qualsiasi altra; fa sì che mediocrità ed eccezioni siano soltanto un’espressione statistica ed esteriore della unicità di qualsiasi persona. Ignara di tutto questo, la psicologia inventa tipologie universali dentro le quali inserisce la varietà delle menti e delle vite. Ma la forma è bellezza, ignorarla vuol dire impedirsi di capire anche la psiche e la sua forza.
Contro tale indifferenza, al di là della catalogazione delle vite e dei destini, Hillman attinge al mito come all’humus dal quale continuano a scaturire sia gli enigmi che i significati poiché le teorie non sarebbero soltanto deduzioni formulate da un insieme di dati e nemmeno invenzioni dei cervelli degli studiosi ma costituiscono delle traduzioni concettuali del mito. Gli dèi e i loro nomi sono diventati, secondo un’intuizione junghiana spesso ripresa da Hillman, le malattie della psiche. Guarire implica il ricordare questo legame tra il corpo e gli dèi.
Un modo per rammentare il divino e nello stesso tempo comprendere l’umano consiste nell’indagare la parabola delle vite ponendosi oltre le reciproche ed escludenti assolutizzazioni dell’ereditarietà e dell’ambiente poiché deve esserci dell’altro, al di là sia dell’educazione sia dell’ereditarietà, sia dell’appreso sia dell’innato. Tale elemento è chiamato da Hillman «ghianda». Una parola, questa, dalle risonanze ancestrali, immersa nella potenza dell’albero antico e più forte (la quercia), intrisa di fecondità (il glande), significante un nucleo originario e potente che nessun ostacolo né scelta né condizionamento esterno possono intaccare: «noi nasciamo con un carattere; che è dato; che è un dono» [3], questo daimon non ci abbandona mai, esso consiste non in ciò che facciamo ma nel modo con cui agiamo in ogni circostanza, incontro, situazione, decisione, angoscia e gaudio della nostra esistenza.
Tale, per Hillman, il significato dell’affermazione di Eraclito per la quale «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων». E dunque l’eudaimonia, il ben-essere, la felicità, consiste nel dare al nostro demone ciò che gli spetta, nel riconoscere la sua natura, nel non ribellarsi inutilmente alla sua potenza. La quale si esprime in ogni attimo della vita ma lo fa con una forza del tutto peculiare nell’innamoramento. L’innamorarsi è infatti una delle esperienze umane dentro cui si fa più evidente un altro degli enigmi interiori della psiche, quel senso di esilio e di nostalgia per un qualche luogo conosciuto e insieme ignoto che costituisce il basso continuo di molte esistenze e dal quale sono scaturite anche le religioni e le filosofie, la conoscenza stessa e il suo bisogno: «poiché [il daimon] non può dimenticare la sua propria vocazione divina, si sente insieme esule sulla terra e partecipe dell’armonia del cosmo» [4].
È infatti vero che «solo nelle teorie psicologiche dell’Occidente troviamo che è la coda ad agitare il cane» [5], la coda dei fattori ambientali, familiari, educativi, rispetto al cane della potenza incomprimibile del carattere che la natura e gli dèi ci hanno dato.
L’angoscia
Opposta alla salute ma sua costante compagna è l’angoscia, la quale non costituisce una semplice tonalità emotiva o uno stato temporaneo di alterazione. L’angoscia è ciò che intesse la vita degli umani poiché essa è l’espressione psicologica della Necessità e del Tempo.
«Nel pensiero cosiddetto pitagorico e orfico Ananke era accoppiata con un grande serpente, Chronos, formando una sorta di spira che stringeva tutt’attorno l’universo. Tempo e Necessità impongono un limite a tutte le nostre possibilità di espansione all’esterno, al nostro raggio d’azione nel mondo. Insieme formano una sizigia, una coppia archetipica, il cui nesso è intrinseco, sicché dove è l’uno è anche l’altra» [6].
 Angoscia e Ananke hanno la medesima radice. Il nostro più profondo malessere nasce da quella peculiare unione di Caos e Costrizione che è la Necessità, nasce dal sentire – ancor più e prima che dal capire – che gli eventi innumerevoli e diversi della vita non provengono da alcun ordine, non vanno da nessuna parte, non hanno senso e tuttavia sono inevitabili nella loro ferrea struttura intrisa di Tύχη e di Ἀνάγκη, di una orrida e casuale necessità.
Angoscia e Ananke hanno la medesima radice. Il nostro più profondo malessere nasce da quella peculiare unione di Caos e Costrizione che è la Necessità, nasce dal sentire – ancor più e prima che dal capire – che gli eventi innumerevoli e diversi della vita non provengono da alcun ordine, non vanno da nessuna parte, non hanno senso e tuttavia sono inevitabili nella loro ferrea struttura intrisa di Tύχη e di Ἀνάγκη, di una orrida e casuale necessità.
È quello che avviene nel più potente degli avvenimenti e dei sentimenti umani, al quale ho accennato più sopra. L’innamorarsi, infatti, non può essere spiegato elencando le ragioni del nostro amore; una teoria razionale dell’innamoramento sarebbe del tutto inadeguata a descrivere il fenomeno. Anche Afrodite è espressione di Ἀνάγκη. La necessità non proviene dall’esterno, non è la costrizione di un ordine ricevuto da altri umani. Ἀνάγκη è la necessità che nasce da noi stessi, dal carattere, dalla natura, dall’insieme sottile e potente dei pensieri del corpo. Aristotele [7] ne parla come di una causa interna che produce molti fastidi; Platone la descrive come l’errante, instabile, variabile, e quindi irrazionale ma vera causa di quanto accade, assai più dell’insieme dei quattro elementi [8]; i neoplatonici e molti altri ritengono «che la necessità esercita il suo dominio dalle “più intime profondità”, e che più si scende nel profondo più si scopre come siamo rigidamente condizionati, come siamo schiavi dentro l’armatura del corpo» [9]; Spinoza invita a distinguere con chiarezza la costrizione esterna dalla necessità della propria natura e Nietzsche formula l’ironico e tragico invito a capire che Ἀνάγκη siamo noi: «Tu stesso, povero uomo pauroso, sei la Moira incoercibile, che troneggia anche sugli dèi, per tutto ciò che accade; tu sei la benedizione o la maledizione e in ogni caso la catena in cui il più forte giace legato; in te è predeterminato tutto il futuro del mondo umano, non ti serve a nulla che tu provi orrore di te stesso» [10].
Come fare, quindi, ad almeno controllare questa potenza che gli eventi e noi stessi siamo, la Necessità che il nostro corpo temporale è? Il mito formula il nome di Atena, l’unica a essere riuscita a persuadere le impersuadibili Moire a lasciar vivere Oreste. A tale esito la dea è pervenuta tramite il potere della parola. Il linguaggio ha convinto la necessità. Ma la parola, come bene seppero i Sofisti, è duplice. Di tale natura è segno supremo l’ambiguità della stessa Atena, la quale
«porta sul petto la Gorgone, terrificante immagine dell’irrazionalità; e il suo animale, la civetta, è sì la sua “saggezza”, ma è anche un uccello di malaugurio, una stridente creatura della notte […]. Il pensiero è aggiogato e imbrigliato dalla logica della ragione. Atena attua l’unione di Zeus e Ananke perché nella sua stessa persona ragione e necessità sono unite» [11].
Accettare attraverso il νοῦς, la parola-pensiero, il terribile delle nostre nature per non attribuirne le dinamiche interiori e collettive alla sola malattia; sottrarre l’umano alla patologizzazione delle morali monoteistiche per cogliere il tratto di gentilezza e di misericordia – e non soltanto di ferocia e di indifferenza – che intesse la vita del mito greco. Ecco un possibile modo per non fuggire dagli dèi, per averli accanto.
Mito, angoscia, salute si coniugano in due figure ambivalenti e ambigue, opposte ma penetranti l’una nell’altra: il Senex e il Puer. Un dio primigenio e potentissimo, Saturno, è «allo stesso tempo l’immagine del Senex positivo e del Senex negativo» [12]. Questa divinità è la forza del carattere/destino ed è soprattutto l’inestricabile nesso tra l’Io e la sua Ombra, tema principe della psicologia junghiana: «fuori dal proprio cerchio di luce, l’Io produce ombra; l’Io è la sua stessa Ombra; forse, chissà, l’Io è ombra. Dunque, il Senex rappresenta appunto questa forza di morte di cui è carica la scintillante graniticità della nostra egoica certezza» [13]. L’Ombra non soltanto segue costantemente l’Io nei passi che esso compie ma uno dei drammi psichici meno analizzati è la solitudine che i caratteri forti costruiscono intorno a sé, proprio perché un Io forte possiede un’ombra altrettanto potente, un eccesso di luce genera intorno a sé il buio.
Queste dinamiche contribuiscono a meglio comprendere e a spiegare un fatto, una catastrofe, una potenza antica dentro la quale l’umano abita e si perde: la guerra. Il tentativo di Hillman è consistito anche nel coniugare guerra, mito e psiche; di penetrare dentro la guerra, la sua disumanità così umana, il suo fascino costante e sinistro, il suo dominio nella storia. Pensare la guerra per capirla e quindi in qualche modo fronteggiarla. Una vera scienza della guerra non può limitarsi alla storia, alla sociologia, alla psicologia, alla tattica e alla strategia, non può limitarsi all’apparente razionalità delle sue cause, delle forme e degli scopi ma deve cogliere la natura inumana del massacro, le forze profonde che spingono l’essere vivente e razionale a intraprendere la distruzione di ogni cosa e di se stesso. Perché se «le guerre continueranno; non cesseranno e non cambieranno», se «i morti cadranno come sempre», almeno «saremo in grado di immaginare e dunque di capire […] non tutto, ma abbastanza da non cadere nelle illusioni deliranti della speranza, dell’amore, della pace e della ragione» [14]. Va dunque compreso perché, invece che costituire un freno alla guerra, i valori diano a essa sprone, potenza, senso.
Per capire è necessaria una psicologia qualitativa capace di cogliere l’intensità del presente e il fondo delle sue radici, la grandezza delle speranze e non la semplice salvaguardia dell’esserci; è necessaria una prospettiva che sia in grado di sollevare dai fenomeni la patina dell’ovvio e del dato, riportando invece «alla luce i temi mitici che attraversano i tempi e sono senza tempo. E la guerra è una di tali forze» (Hillman 2005: 20). Nasciamo nel limite, fatti di bisogni e dunque intrisi di violenza, ben presto avvertiti del muro del tempo oltre il quale a nessuno è possibile andare, alla ricerca costante di un senso o almeno di uno scopo per il quale valga la pena attraversare sino in fondo il deserto dell’illusione. Tra le forze che consentono all’umano di riempire il vuoto del significato, la mitologia ne ha individuate due apparentemente opposte ma convergenti fino a diventare amanti: Ares e Afrodite. «Comprendere la fusione tra bellezza e violenza, tra terrore e amore – il terribile amore per la guerra» (ivi: 133) significa riconoscere la ferocia della guerra riuscendo tuttavia a spiegare perché essa sia così costante e così coinvolgente.
La brutalità della guerra si esprime nella crudeltà intenzionale, nella coercizione, nella impersonalizzazione, nella infinita serie di atrocità, pianti, lutti dei quali la guerra è impastata. E però la sua forza, e al fondo la sua seduzione, consistono nell’essere la guerra causa e scopo a se stessa; corso costante della storia; condizione dell’anima; fondamento del cosmo dai batteri alle stelle (Eraclito); un disperato e lucido rito per tenere a bada il morire; una potenza autonoma con leggi sue proprie delle quali le forme e gli obiettivi umani, dei singoli come dei popoli, sono soltanto strumenti e aggiunte. Puntare lo sguardo sugli dèi della guerra, coinvolgere l’alterità del mito, è necessario per dar conto del fatto che le guerre sono «incongruenti nonostante tutta la loro iperrazionalità, illogiche nonostante ogni riduzione a opposizioni strutturali, inumane nonostante tutte le analisi che rivengono le loro cause in pulsioni ed errori umani» (ivi: 98).
Caratterizzare la guerra in questo modo significa collocarla sul piano del simbolico e dell’archetipico. Hillman lo dichiara, lo rivendica anzi. Perché «i miti sono la normazione dell’irragionevole. L’averlo riconosciuto è la più grande di tutte le conquiste della mente greca, ciò che distingue la cultura greca fra tutte le altre» (ivi: 21).
La guerra è la forma più universale, più distruttiva e più naturale della ὕβρις, della tracotanza che spinge gli umani a varcare i confini del limite e del tempo per cogliere la potenza smisurata del sempre e dell’immobile, in un sogno di dominio senza contrasti e senza scadenze. A fondo delle guerre contemporanee – proprio delle nostre, della miriade di guerre conosciute e di quelle ignorate – sta la convergenza fra Marte e il Cristo. La guerra si svela, in tal modo, come uno dei fenomeni più autenticamente religiosi «ed è per questo che essa è così terribile, così amata e così difficile da comprendere» (ivi: 105).
 La consonanza, il reciproco costituirsi, di religione e guerra ha una serie innumerevole di prove archeologiche, letterarie, psicologiche, scritturali. Se nel politeismo essa viene temperata dalla natura molteplice delle divinità – poiché ogni dio esiste solo in relazione a un altro –, la civiltà cristiana dà invece «corpo a una psicologia monoteistica bellicosa e aggressiva» (ivi: 225), a una visione monoculare che trasforma le religioni del Libro in una formidabile macchina di aggressione reciproca, di conflitto al proprio interno, di espansione verso terre e divinità lontane. Capire la guerra è quindi impossibile se non si comprende il monoteismo. Il binomio di «massacri e cultura» [15] non germina dal suolo greco e neppure da quello della romanità ma nasce dall’esclusione mosaica, dall’unicità del dio. Nelle varianti cristiana dell’amore e islamica di misericordia e clemenza, quel dio bellicoso non ha convertito il dio pagano della guerra e anzi «la cultura cristiana ha ispirato la più grande e duratura macchina bellica mai conosciuta nelle altre culture in ogni altra parte del mondo» (ivi: 256).
La consonanza, il reciproco costituirsi, di religione e guerra ha una serie innumerevole di prove archeologiche, letterarie, psicologiche, scritturali. Se nel politeismo essa viene temperata dalla natura molteplice delle divinità – poiché ogni dio esiste solo in relazione a un altro –, la civiltà cristiana dà invece «corpo a una psicologia monoteistica bellicosa e aggressiva» (ivi: 225), a una visione monoculare che trasforma le religioni del Libro in una formidabile macchina di aggressione reciproca, di conflitto al proprio interno, di espansione verso terre e divinità lontane. Capire la guerra è quindi impossibile se non si comprende il monoteismo. Il binomio di «massacri e cultura» [15] non germina dal suolo greco e neppure da quello della romanità ma nasce dall’esclusione mosaica, dall’unicità del dio. Nelle varianti cristiana dell’amore e islamica di misericordia e clemenza, quel dio bellicoso non ha convertito il dio pagano della guerra e anzi «la cultura cristiana ha ispirato la più grande e duratura macchina bellica mai conosciuta nelle altre culture in ogni altra parte del mondo» (ivi: 256).
Per quanto sgradevole, questa verità va ricordata non solo perché è così in effetti che le cose sono andate ma anche perché uno dei motivi che rendono potente e pervasiva la guerra è la grande e costante contraddizione per la quale nel nome di un dio amoroso sono stati massacrati nei secoli milioni di individui. Se non si opera tale svelamento critico, «la profonda ipocrisia annodata al fondo del cristianesimo manterrà i suoi credenti ignari dell’ira dell’Agnello in cui ripongono la loro fiducia» (ivi: 262).
Con la catastrofe della Prima guerra mondiale, dopo quell’esperienza indicibile e inspiegabile, l’umanesimo ha mostrato la sua natura allucinatoria e astratta rivelando invece la sua tendenza distopica, poiché «il primo conflitto mondiale è una guerra d’annientamento condotta in nome dei valori più aulici ed elevati della cultura occidentale in grado di svelare, però, che la loro sensatezza nasconde una violenza strutturale e barbarica» [16]. La Grande guerra è pertanto il culmine dell’umanesimo, lo sterminio vi è praticato nelle forme della società industriale e di massa, l’orrore è generato «in nome della pace, della cultura, di valori universali. La prima guerra mondiale, in questo senso, potrebbe essere considerata una carneficina umanista; un disastro culturale che si sprigiona grazie alla sedimentazione culturale della modernità oggettivata nella potenza distruttiva delle macchine» [17].
 Anche per Hannah Arendt la continuità tra i valori e la distruzione è tra le radici principali di ogni violenza [18], una continuità che consente alla Casa Bianca di bombardare incessantemente i popoli – a cominciare dal proprio – «con le tossine dell’ipocrisia, la vera arma di distruzione di massa in mano alla televisione […] perché l’ipocrisia televisiva evoca una risposta subliminale di disgusto e di rabbia impotente e provoca la disaffezione per la partecipazione alla vita della polis, una crisi generale di senso, il degrado dell’innata intelligenza e dignità dei cittadini e della loro percezione della verità, accendendo la miccia di una rabbia terribile» (Hillman 2005: 171-172), l’ipocrisia che compatta gli Stati Uniti affinché possano «continuare a predicare bene e a razzolare male» (ivi: 239).
Anche per Hannah Arendt la continuità tra i valori e la distruzione è tra le radici principali di ogni violenza [18], una continuità che consente alla Casa Bianca di bombardare incessantemente i popoli – a cominciare dal proprio – «con le tossine dell’ipocrisia, la vera arma di distruzione di massa in mano alla televisione […] perché l’ipocrisia televisiva evoca una risposta subliminale di disgusto e di rabbia impotente e provoca la disaffezione per la partecipazione alla vita della polis, una crisi generale di senso, il degrado dell’innata intelligenza e dignità dei cittadini e della loro percezione della verità, accendendo la miccia di una rabbia terribile» (Hillman 2005: 171-172), l’ipocrisia che compatta gli Stati Uniti affinché possano «continuare a predicare bene e a razzolare male» (ivi: 239).
Hillman è molto severo e netto nei confronti del proprio Paese, al quale addebita in gran parte la violenza mondiale «perché gli Stati Uniti sono gli armaioli del mondo» (ivi: 159), ai quali «è facile scimmiottare il flagrante imperialismo di Luigi XIV e di Federico di Prussia e di tutti gli altri Grandi di quel periodo; ma è evidente che ad essi manca del tutto la straordinaria potenza della cultura estetica che quei sovrani promossero, al punto che, sotto questo profilo, gli Stati Uniti sembrano oggi dei minorati, se non dei poveri ritardati. Neppure per difendere se stessi sanno trovare le intelligenze linguistiche capaci di leggere i messaggi del nemico» (ivi: 208-209).
Hillman distingue nettamente la religione dal mito, le cui divinità sono «stili di esistenza» (Kerényi) e non individui reali ai quali sacrificare la mente; sono degli archetipi che esprimono la complessità e la varietà della condizione umana e non degli oggetti di fede ai quali ciecamente aderire; sono favole dense di significato con le quali convivere e non entità alle quali obbedire senza ragionare. Il riferimento al mito diventa una difesa del valore salvifico del sapere, un’apologia della conoscenza come via d’uscita atta a comprendere e quindi a misurare le forze della distruzione contrapponendo a esse la misura di una cultura libera dalle menzogne dell’autorità.
Una via d’uscita dalla catastrofe è dunque per Hillman il mito politeistico, con le sue figure. In particolare Pan, il quale tiene ancora unita l’identità molteplice del politeismo mentre l’imporsi dei tre grandi monoteismi ha impoverito il mondo della sua strepitosa e costitutiva varietà, ha fatto vincere la coscienza egoica di un soggetto monocorde e senza (apparenti) contraddizioni. Ma il riemergere inevitabile della differenza produce schizofrenie, isterismi, paranoie ben più gravi di quelle che pure il corpo panico di per sé possiede, delle quali è fatto.
Pan è la coesione psicosomatica e panico/cosmica della materia con se stessa e con la pluralità senza confini che la intesse. Tanto che «quando Pan è vivo allora anche la natura lo è, ed è colma di Dei, talché lo strido della civetta è Atena e il mollusco sulla riva è Afrodite. Questi pezzi di natura non sono semplicemente attributi o proprietà. Sono gli Dei nelle loro forme biologiche» [19]. La natura mentale del mito e la struttura mitologica del corpo emergono, ora, nella loro pienezza inscindibile:
«Pan e le ninfe tengono insieme natura e psiche. Essi dicono che gli eventi istintuali sono riflessi nell’anima: dicono che l’anima è istintuale. Ogni istruzione, ogni religione, ogni terapia che non riconosca l’identità di anima e istinto quale è presentata da Pan, preferendo un lato all’altro, insulta Pan e non guarisce. Non possiamo far nulla per l’anima senza riconoscerla come natura “dentro di noi” […]. Ciò che facciamo al nostro istinto, lo facciamo anche alle nostre anime» [20].
La natura più fonda di Pan è costituita dall’al di là dell’Eros, poiché il panico – il terrore della fuga e del polemos – precede l’Eros in ogni sua forma: greca, cristiana, romantica. Con estrema chiarezza, Hillman mormora che «la lotta tra Eros e Pan, e la vittoria di Eros, continuano ad umiliare Pan ogni volta che diciamo che lo stupro è inferiore al rapporto, la masturbazione inferiore alla copula, l’amore migliore della paura, il capro più brutto della lepre» [21].
E poiché il corpo è l’intrascendibile – nonostante ogni sforzo di negazione attuato dalle religioni ascetiche e dai progetti di un’Intelligenza Artificiale disincarnata –, alla fine esso vince. Vince nella morte, in quell’impercettibile ma definitivo fermarsi del respiro umano sul mondo nel quale il mondo cessa. È in questo trionfo inevitabile del corpo che – nonostante il grido riferito da Plutarco che pose fine al mondo antico – «Pan è tuttora vivo» [22] e sempre lo rimarrà. Sempre, fino a quando un corpo umano e animale pulserà del desiderio di vita e del suo terrore.
Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023
Note
[1] J. Hillman, La vana fuga dagli dei (Due saggi apparsi su «Eranos Jahrbuch» LIV 1985 e XLIII 1974: On Paranoia; On the Necessity of Abnormal Psychology: Ananke and Atena), trad. di A. Bottini, Adelphi, Milano 2005: 94.
[2] Id., Saggio su Pan (An Essay on Pan, 1972), trad. di A. Giuliani, Adelphi, Milano 2005: 132.
[3] Id., Il codice dell’anima. Carattere, vocazione, destino (The Soul’s Code. In Search of Character and Calling, 1996), trad. di A. Bottini, Adelphi, Milano 2006: 22.
[4] Ivi: 61.
[5] Ivi: 298
[6] Id., La vana fuga dagli dei, cit.: 101.
[7] Aristotele, Metafisica: 1015a, sgg.
[8] Platone, Timeo: 47e, sgg.
[9] J. Hillman, La vana fuga dagli dei, cit.: 119-120
[10] F.W. Nietzsche, Umano, troppo umano II. Il viandante e la sua ombra, trad. di S. Giametta, in «Opere», a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1964 sgg.: vol. IV/3, af. 61, p. 168.
[11] J. Hillman, La vana fuga dagli dei, cit.: 137-138
[12] Id., Puer Aeternus (Betrayal. Senex and Puer. An Aspect of the Historical and Psychological Present, 1964 e 1967), trad. di A. Bottini, Adelphi, Milano 2008: 81.
[13] Ivi: 87.
[14] Id., Un terribile amore per la guerra (A Terrible Love of War, 2004), trad. di A. Bottini, Adelphi, Milano 2005: 263. I numeri di pagina delle successive citazioni da questo libro saranno indicati nel testo, tra parentesi.
[15] V.D. Hanson, Massacri e cultura. Le battaglie che hanno portato la civiltà occidentale a dominare il mondo (Carnace and Culture. Landmark Battles in the Rise of Western Power, 2001), trad. di S. Minacci, Garzanti, Milano 2002.
[16] P. Amato, Trincee della filosofia. Heidegger e la Grande Guerra, Mimesis, Milano-Udine 2022: 24.
[17] Ivi: 52
[18] H. Arendt, Sulla violenza (On Violence, 1970), trad. di A. Chiaruttini, Mondadori, Milano 1971: 65
[19] J. Hillman, Saggio su Pan, cit.: 58.
[20] Ivi: 128-129.
[21] Ivi: 118.
[22] Ivi: 47.
______________________________________________________________
Alberto Giovanni Biuso, professore ordinario di Filosofia teoretica nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove insegna Filosofia teoretica, Filosofia delle menti artificiali e Epistemologia. È collaboratore, redattore e membro del Comitato scientifico di numerose riviste italiane ed europee. È direttore scientifico della rivista Vita pensata. Tema privilegiato della sua ricerca è il tempo, in particolare la relazione tra temporalità e metafisica. Si occupa inoltre della mente come dispositivo semantico; della vitalità delle filosofie e delle religioni pagane; delle strutture ontologiche e dei fondamenti politici di Internet; della questione animale come luogo di superamento del paradigma umanistico. Il suo libro più recente è Disvelamento. Nella luce di un virus (Algra Editore, 2022).
______________________________________________________________