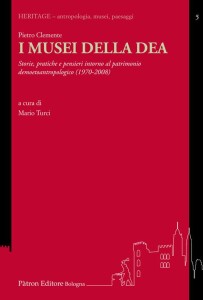I libri – si sa – servono per pensare ma più spesso per ripensare, per ricordare, per ritrovare. Quando leggiamo leghiamo quelle pagine alla vita, a quel frammento di esperienze che precedono e accompagnano il gesto di aprire il libro. «Il significato di un libro non è mai in ciò che è ma in ciò che siamo noi dopo averlo letto. Il libro vive perché ci modifica» ha scritto Giuseppe Pontiggia (2002: 69). Leggere e vivere sono, infatti, nel loro farsi due momenti consustanziali, pratiche strettamente simbiotiche poiché i libri sono quello che sono quando li leggi e perfino dove li leggi. Leggere che ha la stessa radice di legare stabilisce un legame tra l’assenza dell’autore e la presenza del lettore, tra la realtà che sta dentro le pagine e quella che ne sta fuori. Le parole e le voci sono destinate a tracimare dal mondo fatto di righe orizzontali al mondo che abitiamo fatto di tre dimensioni. La verità è che «leggiamo il libro ma, più profondamente forse, è il libro a leggere noi», come ci ha insegnato il grande studioso di letterature, George Steiner (2013: 17).
Considerazioni che trovano un fondamento ancor più persuasivo quando ci capita di rileggere a distanza di tempo pagine sulle quali abbiamo a lungo studiato, riflettuto, progettato, e ogni volta restituiscono come in forma di risacca accenti e risonanze del passato dentro nuove sonorità, visioni e suggestioni. La rilettura è sempre una nuova lettura, un’epifanica esperienza, essendo il testo struttura mai chiusa e compiuta, aperta piuttosto alle diverse provocazioni di quanti lo interrogano. Ce lo ha spiegato Umberto Eco, ma ce lo ricorda anche Leonardo Sciascia: «Un libro è come riscritto in ogni epoca in cui lo si legge e ogni volta che lo si legge. E sarebbe allora il rileggere un leggere: ma un leggere inconsapevolmente carico di tutto ciò che tra una lettura e l’altra è passato su quel libro e attraverso quel libro, nella storia umana e dentro di noi» (1998: 291). Se leggere è parte costitutiva di una pedagogia sentimentale, civile e intellettuale, rileggere segna un complesso percorso di memoria autobiografica, di verifica ermeneutica, di reinvenzione interpretativa, di riesame critico di quanto si è appreso, capito, approfondito.
Nel prendere in mano un libro sui musei etnoantropologici mi sono recentemente ritrovato ad attraversare l’esperienza di una rilettura densa di echi, di rimandi, di connessioni alle stagioni di una vita, a passioni e occasioni di incontri, scambi, scoperte, ricerche. Mi sono occupato di musei negli anni settanta e ottanta del secolo scorso. Ho contribuito a costituirne uno all’interno di una intensa attività didattica e ne ho diretto un altro su committenza di un comune ma per conto dell’Università di Palermo. Dell’uno e dell’altro oggi non c’è più traccia, disgregati, disfatti, dissolti nel nulla. Restano cataloghi di mostre, schede di censimenti e qualche libro a certificare il patrimonio di raccolte etnografiche, collezioni e documenti andati in gran parte disseminati o dispersi. Restano amicizie e relazioni, il ricordo di felici collaborazioni e di sinergie di intenti nel mezzo di un collettivo e reciproco apprendistato, di un’empatica umana corrispondenza. Sembrava in quegli anni di partecipare ad una sorta di età aurorale, ad una fase degli studi antropologici versati ad una rinnovata attenzione per la cultura materiale delle classi subalterne (come allora si chiamavano), immersi in un clima intellettuale fervido di progetti, di iniziative, di libere associazioni cooperative, di allestimenti spontanei di piccoli musei contadini.
A quegli anni di fattivo impegno e di generosi entusiasmi, a quelle esperienze di costruzione di comunità e di crescita e maturazione di tutta una generazione di studiosi, a quella mobilitazione di risorse umane investite in un’impresa scientifica di significativo rilievo, ho ripensato rileggendo le pagine di saggi di Pietro Clemente raccolti e ristampati nel volume I Musei della Dea. Storie, pratiche e pensieri intorno al patrimonio demoetnoantropologico (1982-2008), edito da Pàtron (2023). Un libro che è un’antologia di scritti simbolicamente rappresentativi della cospicua letteratura e dell’ampio dibattito generati in questi trent’anni. La rilettura di questi testi contribuisce a ricostruire, ricordare, ripensare storie di vita culturale che si intrecciano con le storie di vita individuale, idee, passioni, proposte e riflessioni intorno alla museografia destinata a trasformare i musei “scalzi”, “selvaggi”, “inquieti” “evergetici” (come furono variamente definiti quelli nati fuori dagli ambienti accademici) in musei scientifici, razionali, specialistici, territorialisti, sperimentali, performativi, o più semplicemente antropologici. Passaggi e paesaggi teorici travagliati e controversi con una straordinaria densità di implicazioni ideologiche e metodologiche.
Nel frattempo insipienze e negligenze amministrative, fragilità e precarietà gestionali, crisi degli investimenti locali e regionali, debolezze congiunturali e strutturali hanno piano piano tradito e spento le passioni che hanno originate le raccolte impegnate nella difficile transizione dall’estemporaneità delle collezioni alla maturità e organica sistematicità degli allestimenti. Dei piccoli musei nati e proliferati soprattutto nell’ultimo scorcio del ‘900 molti sono chiusi, altri stentano o vivono occasionalmente in funzione delle visite degli scolari. Pochissimi sono riusciti a superare problemi economici, pandemia, oblio e indifferenza locale restando in connessione con le comunità ed esercitando un ruolo sociale e culturale dinamico e attivo. Paradossalmente alla stagione particolarmente ricca di esperienze museali e povera di elaborazioni museografiche sembra essere seguita quella in cui si sono evoluti e moltiplicati i modelli ideologici e concettuali e contemporaneamente si sono rarefatte le spinte propulsive, le pratiche di ricerca sul campo, le concrete realizzazioni materiali.
La vicenda un po’ grottesca e un po’ malinconica richiama alla mente un certo affannarsi del dibattito antropologico attardato su specialismi, confini e arroccamenti disciplinari, a proposito dei rapporti tra la tradizione demologica e i nuovi studi di cultura materiale che cominciarono ad imporsi nel nostro Paese. Così, Lombardi Satriani, in occasione del II Congresso internazionale di antropologia tenutosi a Palermo nel marzo 1980, invitava a confrontarsi dialetticamente senza suicidarsi nell’angustia di vacui patriottismi accademici. «Altrimenti – affermò a conclusione del suo intervento – l’oggetto folklorico conteso, nuova secchia tra opposte bande, sbiadirà sempre più, precipitando nell’opacità del dato inerte. Dopo il visconte, avremmo così l’oggetto dimezzato, sino a che, anche per l’intervento dello studioso rampante, avremmo l’oggetto inesistente» (1984: 590). Un monito che nella ironica metafora calviniana dissimulava una critica alla rovinosa tendenza alla frammentazione che ha accompagnato il processo di progressiva dissipazione del patrimonio di studi demologici. Così oggi, per amara analogia, rischia forse di scomparire assieme all’oggetto folklorico anche il museo demoetnoantropologico, travolto dall’assenza di politiche sensibili e attente e dall’apatia di comunità locali distratte o disinteressate.
 Da qui la nuova luce che le pagine del libro di Pietro Clemente gettano su questioni che il tempo – con il suo viatico di mutamenti e permanenze – ci consegna in forme e prospettive nuove. Non una semplice riproposizione di testi già editi, dunque, ma una loro implicita attualizzazione rispetto a temi, contesti e fenomeni prodotti dalle contingenze storiche. Tanto più che questo volume segue la stampa di un’altra pubblicazione dello stesso autore, Tra musei e patrimonio. Prospettive demoetnoantropologiche nel nuovo millennio (edizioni Museo Pasqualino 2021) che sul medesimo argomento raccoglie gli scritti più recenti, dal 2002 al 2019. Mettendo insieme l’uno e l’altro libro si può pertanto tracciare attraverso la storia del pensiero e della capillare produzione di Clemente anche la storia – di riflesso – della museografia d’ispirazione etnografica nel nostro Paese, l’eco delle letture e dei dibattiti, i “graffiti” e le mappe dei progetti e delle buone pratiche, il racconto dei successi e dei fallimenti, l’evoluzione dei linguaggi e degli approcci legislativi nelle problematiche relazioni pubblico-privato, le criticità, le potenzialità e le sfide del futuro. Un articolato e complesso quadro conoscitivo per capire radici, ragioni, identità e indirizzi di un’antropologia che ha messo al centro delle sue ricerche l’istituzione museale occidentale «di alta cultura usata a favore dei subalterni e dei dominati per affermare una diversa cultura, una cultura altra».
Da qui la nuova luce che le pagine del libro di Pietro Clemente gettano su questioni che il tempo – con il suo viatico di mutamenti e permanenze – ci consegna in forme e prospettive nuove. Non una semplice riproposizione di testi già editi, dunque, ma una loro implicita attualizzazione rispetto a temi, contesti e fenomeni prodotti dalle contingenze storiche. Tanto più che questo volume segue la stampa di un’altra pubblicazione dello stesso autore, Tra musei e patrimonio. Prospettive demoetnoantropologiche nel nuovo millennio (edizioni Museo Pasqualino 2021) che sul medesimo argomento raccoglie gli scritti più recenti, dal 2002 al 2019. Mettendo insieme l’uno e l’altro libro si può pertanto tracciare attraverso la storia del pensiero e della capillare produzione di Clemente anche la storia – di riflesso – della museografia d’ispirazione etnografica nel nostro Paese, l’eco delle letture e dei dibattiti, i “graffiti” e le mappe dei progetti e delle buone pratiche, il racconto dei successi e dei fallimenti, l’evoluzione dei linguaggi e degli approcci legislativi nelle problematiche relazioni pubblico-privato, le criticità, le potenzialità e le sfide del futuro. Un articolato e complesso quadro conoscitivo per capire radici, ragioni, identità e indirizzi di un’antropologia che ha messo al centro delle sue ricerche l’istituzione museale occidentale «di alta cultura usata a favore dei subalterni e dei dominati per affermare una diversa cultura, una cultura altra».
Così annota Pietro Clemente che si dichiara “museologo senza museo”, un “museografo non allestitore”, in realtà, un antropologo che senza aver mai fondato né diretto musei ne ha scritto per quattro decenni non solo con la competenza e l’autorità dello studioso ma anche con la passione e la partecipazione umana che finiscono con l’investire e coinvolgere nelle imprese scientifiche l’onere del vissuto personale, della soggettività più intima, di un pezzo della sua stessa biografia. Se non ha promosso musei li ha certamente ispirati, se non li ha organizzati li ha progettati, pensati, coordinati, valorizzati. Ne offre in queste pagine uno straordinario ventaglio di definizioni e denominazioni: “Il museo come centro di comunicazione di esperienze visive e informative”; “luogo di un nuovo sodalizio tra conoscenza analitico-concettuale e conoscenza estetica”; “spazio di percezione non-scritturale”; “un grande oggetto d’uso artigiano”; “spazio essenzialmente visivo ed esperienziale”; “scatola teatrale che comunica mondi attraverso un suo ordine”; “un iperluogo aperto, comunicativo, dinamico”; “strumento di autoconoscenza popolare, di progettazione comunitaria, di sviluppo locale”; “luogo di ospitalità di memorie”; “sensore diretto della società e delle istituzioni”. Sono alcune delle tante descrizioni lessicali in cui si insiste soprattutto sulle funzioni comunicativa, esperienziale e percettiva del museo.
Attraverso le pagine che segnano e dispiegano nel tempo lo svilupparsi del pensiero di Pietro Clemente si chiarisce via via e si approfondisce sempre più il distacco dell’allievo rispetto al suo maestro, Alberto M. Cirese, la sua idea di museo come «luogo di arte applicata per la comunicazione di massa» in cui gli oggetti esposti sono da considerare «fatti visivi al pari di altri, tutti subordinati all’impegno di rappresentare forme di vita» rispetto al modello razionalista ciresiano del museo-discorso, essenzialmente fondato sulle costruzioni logiche della scienza che ci aiutano a capire la logica costruttiva delle cose o dei simboli che le rappresentano. Due concezioni museografiche diverse, non necessariamente alternative, ma che discretizzano e privilegiano aspetti ed elementi differenti: più attenta ad una pedagogia illuministica, ad un paradigma metalinguistico, concettuale e scientifico quella di Cirese, più vicina alle strategie della rappresentazione, alle virtualità scenografiche e ai linguaggi dell’estetica quella di Clemente. Per capire il significato di lealtà, fedeltà, eredità nel rapporto tra maestro e allievo valgono le parole esemplari di George Steiner (2012: 59-60): «Sono i progressi dell’allievo e le capacità di ampliamento dello studente a determinare la fama di un pedagogo e a costituirne l’obiettivo dichiarato. Più visibile è il passaggio di competenze, più grandi sono i meriti di chi istruisce (…). La massima gratificazione per un insegnante è aver istruito, individuato e ispirato coloro che da lì a poco lo sopravanzeranno, che sono destinati a travalicare la sua sfera d’azione e la sua fama».
 Clemente non rinnega nulla dell’insegnamento di Cirese ma nel solco del suo magistero apre nuove strade, dà spazio ad altri codici simbolici, al dialogo con altre arti, ai temi della soggettività e della «autobiografia implicita negli oggetti», delle storie di vita connesse alla fenomenologia delle raccolte, alle questioni della dimensione plurale dell’espressività e dell’autorialità museale. Nel ripercorrere circostanze ed esperienze dei numerosi incontri fatti in occasione di seminari, convegni e mostre, l’antropologo ricorda il nome di un museologo siciliano, Pino Aiello, un caro amico purtroppo scomparso prematuramente, che indicando uno strumento spiegò che quella era la vanga del padre, con il manico adattato alla sua altezza, alla sua mano, alle sue esigenze di mancino. Una testimonianza che chiariva la individualità irriducibile delle cose che solo apparentemente sembrano eguali repliche di infinite altre. A guardar bene, infatti, ogni oggetto nella sua datità fisica e simbolica è un unicum e porta i segni identificativi di chi l’ha costruito e di chi l’ha adoperato, così come alcuni musei portano in qualche modo la firma dei loro demiurghi fondatori.
Clemente non rinnega nulla dell’insegnamento di Cirese ma nel solco del suo magistero apre nuove strade, dà spazio ad altri codici simbolici, al dialogo con altre arti, ai temi della soggettività e della «autobiografia implicita negli oggetti», delle storie di vita connesse alla fenomenologia delle raccolte, alle questioni della dimensione plurale dell’espressività e dell’autorialità museale. Nel ripercorrere circostanze ed esperienze dei numerosi incontri fatti in occasione di seminari, convegni e mostre, l’antropologo ricorda il nome di un museologo siciliano, Pino Aiello, un caro amico purtroppo scomparso prematuramente, che indicando uno strumento spiegò che quella era la vanga del padre, con il manico adattato alla sua altezza, alla sua mano, alle sue esigenze di mancino. Una testimonianza che chiariva la individualità irriducibile delle cose che solo apparentemente sembrano eguali repliche di infinite altre. A guardar bene, infatti, ogni oggetto nella sua datità fisica e simbolica è un unicum e porta i segni identificativi di chi l’ha costruito e di chi l’ha adoperato, così come alcuni musei portano in qualche modo la firma dei loro demiurghi fondatori.
Nella scoperta del museo Guatelli di Ozzano Taro che tanta parte ha avuto nella sua vicenda umana e professionale e ha, di conseguenza, un ragguardevole spazio nelle pagine di questo libro, Pietro Clemente attraversa una nuova soglia, sposta la prospettiva sugli outsider, su collezioni museali che sfuggono alle tipologie tradizionali e introducono al concetto di “opere” non ingenue né artificiose, fortemente connotate dal carisma dei loro allestitori, «un luogo dove la notte gli oggetti parlano tra loro e si raccontano storie di gloria, di dolore e di abbandono. È la qualità visionaria dell’impresa». La narrazione più che la documentazione è la cifra distintiva di questi musei, la creatività più che la scientificità. Guatelli è un costruttore di estetiche, disegna con gli “oggetti di affezione” della cultura contadina grafismi e scritture parietali, «il romanzo epico del mondo dal quale viene», un caleidoscopio di vite e di storie collettive. «La cosa straordinaria del suo museo sta nell’essere un gigantesco deposito della memoria fisica dei ceti sociali del territorio e insieme un’opera che richiama la sensibilità artistica contemporanea». Da qui alla assimilazione alla categoria dei musei performance il passo è breve, irrompe la nuova stagione dell’evergetismo povero, del “terzo principio della museografia”, come Clemente intitolò un suo libro del 1999, connettendo l’antropologia alla letteratura, all’arte, al teatro, alla poesia.
L’attenzione per queste originali forme di allestimento museografico s’intreccia con l’interesse crescente per le storie di vita, per il racconto come documento, per la biografia come monumento, per le scritture popolari conservate nel prezioso Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, per quel modo di fare antropologia in dialogo con la storia contemporanea, mischiando la propria vita con quella dei narratori, sperimentando su se stesso gli incanti e gli inganni del ricordare e del narrare non solo con le parole ma anche attraverso gli oggetti, la loro sintassi articolata in spazi, percorsi e immagini, la loro forza emozionale e testimoniale. D’altra parte, Clemente non ha mai guardato ai musei in chiave retrospettiva, come a santuari della memoria destinati a conservare, illustrare o rimpiangere il passato ma a luoghi che nella cifra teatrale promuovono un colloquio tra generazioni, accolgono i nuovi linguaggi dei media, valorizzano l’uso delle tecnologie e progettano le sfide del futuro. «Non c’è nulla di più attuale, postmoderno, neotecnologico del museo, se lo si intende come mezzo di comunicazione di massa legato alla scolarizzazione diffusa, alla educazione collettiva, alla crescita del turismo di cultura e alla domanda sociale di radici e identità territoriali da costruire e rappresentare».
Quando nel nuovo millennio entrano nel discorso sui musei i concetti di patrimonio e patrimonializzazione, di mappe e di cooperative di comunità, di heritage, di paesaggi, di convenzioni internazionali e di liste dell’Unesco, di poetiche e politiche di un’antropologia destinata ad operare nella sfera pubblica, diversa da quella insegnata all’università, e di una museografia riflessiva e postmoderna che non riconosce confini tra personale e museale e ricongiunge etnologia e culture locali, Clemente volge lo sguardo alla complessità dei nessi nevralgici con il territorio, all’arcipelago dei piccoli centri in via di spopolamento, alle diaspore delle aree interne del nostro Paese, alle realtà periferiche che in alternativa ai guasti dell’urbanesimo resistono all’ineluttabile destino di marginalità. In questi contesti i musei possono giocare un ruolo determinante, sono agenti della prossimità, della resilienza, del possibile sviluppo locale in corrispondenza della prospettiva territorialista e della maturazione e diffusione della “coscienza di luogo”.
Il museo diffuso, l’ecomuseo ovvero il museo fuori dal museo è il modello a cui sarebbe affidato il compito di ricomporre le fratture dei territori, di colmare le faglie tra locale e globale, di presidiare la vita delle collettività, di surrogare i deficit della democrazia e di «legare alterità e familiarità», ha scritto Fredi Drugman (1999: 58). Un modo di usare il museo «come casa e come luogo di rappresentanza, come soffitta e come salotto, come luogo del simbolico e luogo dell’immaginario, come album dei ricordi e come proiezione nel futuro, come caposaldo della comunità e come rifugio individuale». È appena il caso di precisare che nella ridotta dimensione locale tutto questo assume un valore eminentemente politico oltre che culturale, un peso economico che valorizza le esperienze collettive e i saperi tradizionali incorporati nella memoria del territorio. Percorsi condivisi in preesistenze storiche, reti di relazioni e mutualità con altre infrastrutture come la scuola, la farmacia o la parrocchia, il museo in queste realtà – «vocato all’incontro e non solo allo sguardo» direbbe Claudio Rosati (2016: 312) – può aggregare e coagulare sensibilità, sentimenti e movimenti, può esercitare una funzione di alfabetizzazione, di emancipazione e di autoapprendimento, può educare all’accoglienza e alla cittadinanza attiva, alla “civicità” per usare ancora le parole di Rosati, insegnando a non separare il pubblico e il privato, le collezioni conservate all’interno e il patrimonio disseminato all’esterno, le falci e l’aratro e la sapiente trama dei campi coltivati e del paesaggio.
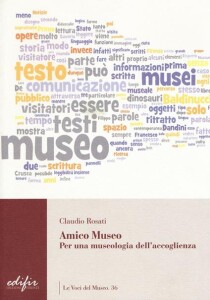 Sarebbe questo lo scenario che si apre per l’istituto culturale più antico e più universale, l’ultima strategia in applicazione del “quarto principio della museografia”, una nuova missione e una nuova frontiera per l’antropologia che deve fare i conti con la crisi del paradigma museale novecentesco e del concetto eurocentrico di patrimonio, con il pluralismo etnico delle comunità dei migranti, con gli squilibri territoriali, il declino demografico, i processi di rarefazione sociale dell’Italia dei margini, dei piccoli paesi, delle terre alte, l’erosione delle culture locali, le sconnessioni sempre più profonde tra città e campagne, tra centro e periferie. Su tutto questo – come è noto – ragiona da anni Pietro Clemente anche sulle pagine di Dialoghi Mediterranei, su come invertire lo sguardo, dal centro alla periferia, dalla “polpa” all’“osso”, dalla fuga e dall’abbandono delle aree interne e montane alla “restanza” e al ritorno, al progetto nazionale di “riabitare l’Italia”, «in cui l’unità è raggiunta davvero – ha scritto in un lontano saggio – quando, senza scandalo, si può dire che essere italiani è appartenere a un Paese fatto essenzialmente di paesi» (1997: 39).
Sarebbe questo lo scenario che si apre per l’istituto culturale più antico e più universale, l’ultima strategia in applicazione del “quarto principio della museografia”, una nuova missione e una nuova frontiera per l’antropologia che deve fare i conti con la crisi del paradigma museale novecentesco e del concetto eurocentrico di patrimonio, con il pluralismo etnico delle comunità dei migranti, con gli squilibri territoriali, il declino demografico, i processi di rarefazione sociale dell’Italia dei margini, dei piccoli paesi, delle terre alte, l’erosione delle culture locali, le sconnessioni sempre più profonde tra città e campagne, tra centro e periferie. Su tutto questo – come è noto – ragiona da anni Pietro Clemente anche sulle pagine di Dialoghi Mediterranei, su come invertire lo sguardo, dal centro alla periferia, dalla “polpa” all’“osso”, dalla fuga e dall’abbandono delle aree interne e montane alla “restanza” e al ritorno, al progetto nazionale di “riabitare l’Italia”, «in cui l’unità è raggiunta davvero – ha scritto in un lontano saggio – quando, senza scandalo, si può dire che essere italiani è appartenere a un Paese fatto essenzialmente di paesi» (1997: 39).
Non sappiamo se, nella vita delle piccole comunità che rischiano per denatalità e esodi incessanti di essere cancellate dalla geografia e dalla storia, i musei, da appigli, argini, ripari, palinsesti di memorie e di risorse, possano trasformarsi in laboratori di possibili progetti di rigenerazione della socialità perduta e di recupero della qualità dell’abitare. Non sappiamo se siano illusorie le speranze di uno sviluppo che, al di là della retorica della patrimonializzazione sovente finalizzata ad alimentare immaginari urbani, effimeri turismi ed esigenze di marketing territoriale, promuova concreti reinsediamenti, pratiche virtuose, nuovo welfare e politiche di imprenditorialità e sostenibilità ambientale. Sappiamo con certezza che migrazioni e neoabitanti, rinnovamento museografico e rilancio demografico, riattivazione delle preesistenze infrastrutturali e delle microeconomie locali sono fenomeni e processi che si tengono insieme, sono interconnessi, interdipendenti. Da qui la necessità di decostruire e denunciare quel paradosso che assicura i diritti di cittadinanza e rappresentanza all’italiano che non abita né lavora in quel territorio, mentre li nega all’immigrato che vi abita, risiede, lavora e ne sostiene i servizi. Una bizzarria che impedisce la maturazione di quel sentimento di appartenenza che fa di una popolazione una comunità, di un sistema di convivenza una democrazia partecipata. E perfino di un piccolo museo etnoantropologico può fare un «gramsciano organizzatore di cultura radicato nella società civile», per richiamare una delle tante definizioni coniate da Pietro Clemente.
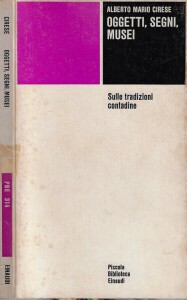 «I margini – ha scritto Giovanni Carrosio (2019: 148) – ci pongono di fronte all’urgenza di un pensiero nuovo, alto e radicale, capace di tenere insieme lo sguardo sul mondo e l’attenzione ai luoghi». Di questo pensiero che si fa parola, progetto, utopia o profezia, della riappropriazione critica della coscienza dei luoghi nella prospettiva universalistica, Pietro Clemente è senz’altro un interprete convinto e appassionato, avendo da sempre consapevolezza delle potenzialità creative e delle progettualità innovative dal punto di vista etico, culturale e politico che nei margini possono trovare incubazione, elaborazione ed attuazione. A questo modello di sviluppo alternativo non può non corrispondere e concorrere un modello di museo altro in cui “spaesarsi” per tornare ad “appaesarsi”, una museografia accogliente e inclusiva in cui possano riconoscersi soggetti di culture diverse e possano trovare spazio anche le esperienze, i saperi, le arti e l’immaginario dei migranti. Un riposizionamento museografico in coerenza ad un paradigma antropologico che in fondo può ispirarsi a quanto Lévi-Strauss ha scritto più di cinquant’anni fa, quando parlava di nuove missioni per i musei, dal momento che «gli uomini viaggiano in tutti i sensi (…) e quei rappresentanti di culture periferiche, affatto o male integrate, hanno molto da dare all’etnografo: linguaggio, tradizioni orali, credenze, concezioni del mondo, atteggiamenti davanti agli esseri e alle cose. Ma sono anche il più delle volte alle prese con problemi reali e angosciosi: isolamento, spaesamento, disoccupazione, incomprensione dell’ambiente al quale sono stati provvisoriamente o durevolmente aggregati» (Lévi-Strauss 1966: 413-4).
«I margini – ha scritto Giovanni Carrosio (2019: 148) – ci pongono di fronte all’urgenza di un pensiero nuovo, alto e radicale, capace di tenere insieme lo sguardo sul mondo e l’attenzione ai luoghi». Di questo pensiero che si fa parola, progetto, utopia o profezia, della riappropriazione critica della coscienza dei luoghi nella prospettiva universalistica, Pietro Clemente è senz’altro un interprete convinto e appassionato, avendo da sempre consapevolezza delle potenzialità creative e delle progettualità innovative dal punto di vista etico, culturale e politico che nei margini possono trovare incubazione, elaborazione ed attuazione. A questo modello di sviluppo alternativo non può non corrispondere e concorrere un modello di museo altro in cui “spaesarsi” per tornare ad “appaesarsi”, una museografia accogliente e inclusiva in cui possano riconoscersi soggetti di culture diverse e possano trovare spazio anche le esperienze, i saperi, le arti e l’immaginario dei migranti. Un riposizionamento museografico in coerenza ad un paradigma antropologico che in fondo può ispirarsi a quanto Lévi-Strauss ha scritto più di cinquant’anni fa, quando parlava di nuove missioni per i musei, dal momento che «gli uomini viaggiano in tutti i sensi (…) e quei rappresentanti di culture periferiche, affatto o male integrate, hanno molto da dare all’etnografo: linguaggio, tradizioni orali, credenze, concezioni del mondo, atteggiamenti davanti agli esseri e alle cose. Ma sono anche il più delle volte alle prese con problemi reali e angosciosi: isolamento, spaesamento, disoccupazione, incomprensione dell’ambiente al quale sono stati provvisoriamente o durevolmente aggregati» (Lévi-Strauss 1966: 413-4).
 Il profilo dei musei del futuro che può complessivamente delinearsi dalle pagine del libro di Pietro Clemente muove dunque da questo lungo percorso intellettuale di ricerca e riflessione, fatto di accelerazioni e di arretramenti, riprese, deviazioni e tornanti, in cui è tuttavia riconoscibile una direzione di marcia, una strada maestra. Se è vero che rileggere è un po’ come tradurre implicando le operazioni del comparare e dell’attraversare, del mettere in dialogo le differenze tra il passato e il presente, tra ciò è stato e ciò che è, la rilettura di questi scritti a distanza di più di trent’anni restituisce nella sua vivezza il denso dibattito generato e sviluppato ai margini di questa antropologia museale che ha lentamente preso forma e vita. È possibile – confessa l’autore nell’introduzione – che la lettura attuale sia «fuori contesto e magari non conforme a quanto pensava chi ha scritto. È il modo che hanno gli scritti di restare attivi anche fuori tempo». La verità è che il testo ne sa sempre più dell’autore e vive indipendentemente da lui. Nello scarto temporale e intenzionale si misurano intuizioni e provocazioni, interrogazioni e illuminazioni, ciò che è cambiato intorno a noi e come questi cambiamenti ci abbiano cambiato. Si chiariscono come in una sorta di bilancio retrospettivo approcci teorici e transizioni metodologiche: dall’orientamento ergologico dei cicli produttivi alla rappresentazione museografica come scenografia, da Oggetti segni e musei di Cirese al Il terzo principio della museografia, per conoscere e capire gli esiti delle ultime letture ed esperienze di antropologia museale del nostro millennio.
Il profilo dei musei del futuro che può complessivamente delinearsi dalle pagine del libro di Pietro Clemente muove dunque da questo lungo percorso intellettuale di ricerca e riflessione, fatto di accelerazioni e di arretramenti, riprese, deviazioni e tornanti, in cui è tuttavia riconoscibile una direzione di marcia, una strada maestra. Se è vero che rileggere è un po’ come tradurre implicando le operazioni del comparare e dell’attraversare, del mettere in dialogo le differenze tra il passato e il presente, tra ciò è stato e ciò che è, la rilettura di questi scritti a distanza di più di trent’anni restituisce nella sua vivezza il denso dibattito generato e sviluppato ai margini di questa antropologia museale che ha lentamente preso forma e vita. È possibile – confessa l’autore nell’introduzione – che la lettura attuale sia «fuori contesto e magari non conforme a quanto pensava chi ha scritto. È il modo che hanno gli scritti di restare attivi anche fuori tempo». La verità è che il testo ne sa sempre più dell’autore e vive indipendentemente da lui. Nello scarto temporale e intenzionale si misurano intuizioni e provocazioni, interrogazioni e illuminazioni, ciò che è cambiato intorno a noi e come questi cambiamenti ci abbiano cambiato. Si chiariscono come in una sorta di bilancio retrospettivo approcci teorici e transizioni metodologiche: dall’orientamento ergologico dei cicli produttivi alla rappresentazione museografica come scenografia, da Oggetti segni e musei di Cirese al Il terzo principio della museografia, per conoscere e capire gli esiti delle ultime letture ed esperienze di antropologia museale del nostro millennio.
Ecco perché le pagine di Clemente, che in filigrana declinano e riassumono un lungo tratto della sua incessante attività di studio e di ricerca sui musei, continuano a dialogare con le questioni culturali e le dinamiche sociali della contemporaneità, con quanti si interrogano sui linguaggi e sulle pratiche, sui rapporti tra i patrimoni materiali e immateriali e i soggetti e le forme di democrazia, sulle sfide che oggi chiamano l’antropologia a ripensare se stessa per rispondere ai nuovi problemi di produzione e fruizione museografica rispetto alla crisi d’identità delle comunità e dei territori, estenuati nel difficile equilibrio tra centri congestionati e periferie desertificate, tra modernità e marginalità, tra storie locali e immaginari globali.
Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023
Riferimenti bibliografici
Calvino I., Mondo scritto e mondo non scritto, Mondadori, Milano 2002.
Carrosio G., I margini al centro. L’Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione, Donzelli, Roma 2019.
Clemente P., Graffiti di museografia antropologica italiana, Protagon editori toscani, Siena 1996.
Clemente P., Paese/Paesi, in I luoghi della memoria, Struttura ed eventi dell’Italia unita, a cura di M. Isnenghi, Laterza, Roma-Bari 1997.
Clemente P. – Rossi E., Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, Carocci, Roma 1999.
Clemente P., Tra musei e patrimonio. Prospettive demoetnoantropologiche nel nuovo millennio, Quaderni di Antropologia museale, Museo Pasqualino edizioni, Palermo 2021
Clemente P., I Musei della Dea. Storie, pratiche e pensieri intorno al patrimonio demoetnoantropologico (1982-2008), Pàtron, Bologna 2023.
Drugman F., Imparare dalle cose, in Di Valerio F., a cura, Contesto e identità. Gli oggetti fuori e dentro i musei, Clueb, Bologna 1999: 51-59.
Lévi-Strauss C., Antropologia strutturale, Il Saggiatore Milano 1966.
Lombardi Satriani L., Lo sbiadimento dell’oggetto folklorico tra problematica demologica e cultura materiale, in I mestieri. Organizzazione, tecniche linguaggi, Atti del II Congresso internazionale di studi antropologici siciliani (26-29 marzo 1980), Quaderni del Circolo Semiologico Siciliano, n.17-18, Palermo 1984: 577-590.
Pontiggia G., L’isola volante, Mondadori, Milano 2002.
Rosati C., Amico Museo. Per una museologia dell’accoglienza, Edifir Firenze 2016.
Sciascia L., Cruciverba, Adelphi, Milano 1998.
Steiner G., I libri che non ho scritto, Garzanti, Milano 2012.
Steiner G., I libri hanno bisogno di noi, Garzanti, Milano 2013.
_____________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020). Per la stessa casa editrice ha curato il volume Per Luigi. Scritti in memoria di Luigi M. Lombardi Satriani (2022).
______________________________________________________________