Mabruk è il primo tunisino che ho incontrato quando nel 1970 ho cominciato la mia ricerca sull’immigrazione in Sicilia per la tesi di laurea. Originario di Mahdia, Mabruk vive e abita a Mazara del Vallo dal 1970. Ha lavorato per più di trent’anni a bordo dei pescherecci. Oggi è pensionato, frequenta la piazza e il bar della marina, parla perfettamente quello stesso italiano con il quale si esprimono i pescatori mazaresi, mimetizzando nelle parole del dialetto siciliano gli accenti della lingua araba. I suoi figli hanno frequentato la scuola tunisina che ha sede a Mazara e hanno poi continuato gli studi in Francia, dove si sono trasferiti. Mabruk è invece rimasto e, pur non avendo ottenuto la cittadinanza italiana, si definisce “italiano di Mahdia”.
Agli inizi degli anni settanta i tunisini immigrati in Sicilia come Mabruk erano poche migliaia. I primi arrivarono nel trapanese perfino senza passaporto, trasbordando da un peschereccio ad un altro al largo delle acque del Canale. Sbarcavano ed entravano nel giro di un racket, organizzato e foraggiato dal patronato. La maggior parte degli immigrati arrivava comunque da “turista” a Trapani con la motonave Campania felix e lavorava in clandestinità nei settori della pesca e dell’agricoltura. Il loro numero cresceva puntualmente nella stagione della vendemmia e della raccolta delle olive. Scaduto il visto, i “turisti” non tornavano al Paese d’origine, scomparivano, si mimetizzavano, inghiottiti dai mille meandri dell’economia sommersa e dalle ombre delle medine e dei quartieri degradati che ospitavano i loro poveri alloggi.
In Tunisia, Bourghiba era ancora il capo di Stato, il Padre della patria, il leader del partito neo Destour, interprete e responsabile di una politica filoccidentale e, per alcuni aspetti, antitradizionalista. Il fallimento del piano triennale coordinato dal consigliere di Stato, Ben Salah, che prevedeva la nazionalizzazione delle società private e l’esperienza di sviluppo pianificato della collettivizzazione cooperativa, aveva prodotto la crisi monetaria del 1965 e la svalutazione del dinar. Da qui disoccupazione ed emigrazione. «Ci sono nel 1970 quasi 600 mila giovani dai 15 ai 20 anni – scriveva con intelligente lungimiranza in quegli anni lo studioso francese J. Poncet (1971: 110) –, ce ne saranno un milione nel 1975 e un milione e mezzo verso il 1980 che chiederanno di vivere come si è loro insegnato, come si è loro promesso, molto meglio dei loro padri poveri fellah e disoccupati».
Le dinamiche demografiche contribuiscono a spiegare le congiunture dell’economia e la mobilità delle popolazioni. L’arrivo dei Tunisini in Sicilia era anche l’effetto di una rifrazione ovvero della speculare e storica presenza dei Siciliani in Tunisia almeno fino agli anni sessanta, quando a seguito dell’indipendenza nazionale furono in maggioranza costretti a rimpatriare. Ma nella dimensione transfrontaliera del Mediterraneo le migrazioni hanno una strutturale ciclicità e circolarità tra le due sponde, anche se le politiche dei sovranismi occidentali hanno oggi prodotto fratture, muri, respingimenti, tragedie. Tra Sicilia e Tunisia c’è una storia plurisecolare di relazioni e di transazioni, c’è un mare che è sempre stato un sistema reticolare complesso, uno spazio itinerante di orizzonti incrociati, di frontiere mobili. I fili spinati innalzati non sembrano fermare i giovani che cercano una via di fuga, una speranza, la sopravvivenza.
Dei giovani tunisini dopo la Primavera, della loro condizione inquieta e liminale scrive Giovanni Cordova in un libro attento e intenso, Karim e gli altri (Rosenberg@Sellier, 2022), una ricognizione antropologica a tutto tondo e di grande spessore, con al centro un contesto e un tempo di grave incertezza politica e di trepidante transizione culturale. Per quanto la Tunisia sia realtà geografica assai vicina e protagonista delle cronache che hanno incidenza e diretta influenza sulle nostre coste, resta scarsa e opaca la conoscenza di quanto accade e di quel che si muove dentro questo Paese, piccolo ma strategicamente centrale nell’area del Mediterraneo. Contraddizioni che appartengono al nostro sguardo eurocentrico, ritardi riconducibili al nostro pigro secondare stereotipi e luoghi comuni, distorte rappresentazioni di un mondo ritenuto immobile e incompatibile con la modernità.
Ieri, la Primavera araba ci ha colto impreparati e impacciati di fronte all’irruzione nella storia di sommovimenti popolari che portarono alla ribalta nuovi soggetti e nuove soggettività, le voci dei giovani e delle donne. Oggi rischiamo di non capire gli sviluppi e gli esiti di quella stagione insurrezionale che dalla Tunisia aveva investito tutto il Maghreb. Ieri corruzione e repressione avevano alimentato le proteste contro il regime autocratico di Ben Ali, oggi la democrazia conquistata mostra tutta la sua fragile ed effimera istituzione formale. Il libro di Giovanni Cordova scavando dentro questa faglia temporale della difficile e irrisolta transizione indaga i recessi e i risvolti della vita quotidiana, gli immaginari dei giovani delle classi medie urbane, le narrative che plasmano le loro relazioni sociali, gli aneliti di emancipazione e i vincoli di fedeltà ai codici familiari e religiosi.
Cadute le illusioni e le promesse della Primavera, la classe media si è disgregata e impoverita, le nuove generazioni che si sono liberate del sistema liberal-poliziesco di Ben Ali si ritrovano sequestrate e incanaglite nel vuoto esistenziale prodotto dall’instabilità politica del governo del presidente Kaïs Saïed tentato da torsioni autoritarie e dispotiche. Lo “stato di emergenza” si è perpetuato a tempo indeterminato e sono tornati a rendersi visibili nello spazio pubblico i simboli identitari della religione islamica, una reviviscenza di forme e pratiche di devozione che erano state abbandonate, mimetizzate, secolarizzate. I giovani cresciuti davanti alle tv satellitari del Qatar e di al-Jazeera vivono una dolorosa esperienza di subalternità e di estraniamento. Costituiscono il 43% della popolazione in età attiva ma più del 32% dei diplomati è disoccupato. La crescente disconnessione tra sistema educativo e mercato del lavoro ha aperto un buco nero nell’economia e una spaccatura nella società del Paese, divaricando ancor più la distanza sentimentale e culturale tra le generazioni.
«I giovani hanno fatto la rivoluzione, ma i vecchi l’hanno rubata. I giovani oggi non hanno sogni, perché i vecchi li hanno rubati» afferma Mounir, un trentaquattrenne originario del Sahel, figlio di una famiglia piccolo borghese che ha interrotto gli studi universitari avendo assunto consapevolezza dell’inutilità pratica del diploma di laurea. Fa il tassista, convive a Tunisi con Emma, trasgredendo la volontà dei genitori che avevano progettato un matrimonio tradizionale all’interno della rete parentale. Mounir condivide questa condizione con molti coetanei della medesima estrazione sociale, stretti tra il desiderio di indipendenza e i condizionamenti morali, in bilico tra i consumi e i costumi dettati dalla modernità e le restrizioni imposte dagli stili di vita delle comunità di appartenenza. Una dicotomia sofferta e insoluta assimilabile per certi aspetti all’ambivalenza in cui si trovano molti dei figli degli immigrati tunisini nati e scolarizzati in Sicilia, con le differenze non irrilevanti relative ai contesti di riferimento. Comune è tuttavia la soggettività generazionale, la prospettiva transnazionale, la preziosa variabile costituita dalla risorsa del capitale umano che si avvale di un livello di istruzione sicuramente superiore rispetto a quello dei padri, di un orizzonte simbolico ben più ampio e articolato di quello esperito dai genitori. Comune è in fondo l’aspirazione alla cittadinanza, all’esercizio dei diritti di libertà individuale, al riconoscimento della identità culturale e della dignità umana della persona.
Osservare l’immagine che i giovani offrono di se stessi e degli altri attraverso le loro azioni e le loro rappresentazioni, individuare le loro possibili traiettorie di vita nei processi di socializzazione e di acculturazione è la chiave di lettura della comunità tunisina oggi dopo la Primavera che Giovanni Cordova propone in questo libro, esito di un puntuale lavoro di ricerca sul terreno della durata di tre anni, dal 2016 al 2018. Un’etnografia che ha attraversato una vasta area geografica, ha esplorato una significativa pluralità di fonti, ha partecipato alla quotidianità esistenziale degli interlocutori. Una impeccabile e scientificamente avvertita metodologia di indagine condotta mediante l’immersione prolungata nelle situazioni e nelle esperienze di tutti i giorni. Distinguendo generi e generazioni, la ricerca ha approfondito la conoscenza di quella fascia di giovani compresi tra i 19 e i 23 anni riconducibili alle classi medie sempre più contigue a quelle popolari, insieme coinvolte in un medesimo processo di rapido e progressivo impoverimento.
L’autore è consapevole dell’uso ambiguo e distorto che del concetto di “gioventù”, di questa categoria anagrafica quanto mai vaga e indeterminata, è stato sovente fatto dai media. Ma è anche pienamente convinto della necessità antropologica di stabilire «un rapporto intersoggettivo fra attori sociali miranti a comprendersi reciprocamente» perché l’etnografia abbia qualche possibilità di entrare in dialogo con il mondo investigato. «Fare etnografia in Tunisia e nello spazio mediterraneo comporta inevitabilmente muoversi in uno scenario tutt’altro che isolato e privo di rapporti con “noi”». La verità e che quando parliamo e scriviamo di loro, quando raccontiamo le loro storie e le loro vite, parliamo e scriviamo di noi, raccontiamo le nostre storie, le nostre vite. Nel paesaggio giovanile descritto in questo libro potremo forse riconoscere e comprendere quanto esso sia già parte della nostra realtà, abiti le nostre città, viva in mezzo a noi. Ecco perché non sono intellegibili le speranze e le disperazioni di questi giovani che cercano l’Europa in Sicilia se non abbiamo memoria dei tenaci legami che tra la Sicilia e la Tunisia la storia di lunga durata ha tessuto lungo le antiche rotte del Mediterraneo.

“Mai fidarsi della polizia”, scritta su un muro di Tunisi firmata dal gruppo ultrà dei Dodgers Clubistes, 2007, tifosi della squadra del Club Africaine (ph. Giovanni Cordova)
Lo studio di Giovanni Cordova ha il merito di mettere a fuoco e connettere le questioni di questo piccolo Paese nordafricano, il ruolo delle nuove generazioni e il quadro drammatico e conflittuale delle tensioni politiche ed economiche di tutta l’area investita dal complesso fenomeno delle migrazioni di massa. La cosiddetta “eccezione tunisina” che fino a ieri abbiamo ammirato come alleata delle democrazie occidentali nella lotta contro il terrorismo islamista nascondeva in realtà sotto il regime di Bel Ali la sistematica violazione dei diritti umani e oggi nella transizione guidata da Kaïs Saïed svela il suo volto non meno autoritario e repressivo. L’autore ripercorre avvenimenti e cambiamenti che hanno visto, in una prima fase, protagoniste le organizzazioni della società civile e al loro interno i giovani prepotentemente attivi nella sfera pubblica, e successivamente il lento esaurirsi di queste spinte ribellistiche, l’apatia e l’anomia collettiva, il confuso smarrimento durante la pandemia fino a un largo e massiccio astensionismo dal voto, l’adesione a pratiche religiose, le varie forme di resistenza, la logorante condizione di attesa e l’ossessiva e pervasiva ricerca di un altrove da raggiungere al di là del Mediterraneo.
Di economia morale scrive Cordova – e questo paradigma concettuale attraversa tutte le sue pagine – con l’obiettivo di meglio circoscrivere il profilo culturale di questa gioventù istruita e digitalizzata che si muove in una dimensione virtuale globale e cosmopolita e in un contesto locale sorvegliato da una censura poliziesca e travagliato da una profonda crisi economica. Tra frustrazioni e depressioni per la permanente precarietà e l’assoluta mancanza di prospettive, anche il matrimonio considerato sbocco naturale dell’affermazione sociale si allontana per via dell’impossibilità di sostenerne le spese. Sul piano delle norme e dei valori il rispetto delle tradizionali nozze endogamiche tra cugini incrociati patrilineari è senza dubbio incrinato soprattutto dalla crescita del potere negoziale delle donne e dal rinnovamento dei costumi sessuali, almeno nell’ambito delle famiglie urbane di ceto medio. Da qui la diffusione delle esperienze di convivenza, come nel caso di Mounir, nonostante permanga una certa stigmatizzazione sociale dei rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Convivono, a guardar bene, registri morali contraddittori, anche in corrispondenza dell’evoluzione dell’emancipazione femminile.
Cuore della socialità maschile e crocevia elettivo dei disoccupati sono in Tunisia come in tutto il Maghreb i caffè, «incubatori di confronto, dibattito, critica politica», dove si coltiva la speranza nel progettare le partenze, nel rafforzare amicizie e complicità, nel garantire mutualità di prestazioni e solidarietà intra-generazionali. Un piccolo welfare informale che nella vita associata di questi spazi intreccia vicinato e reti familiari, sistemi di scambio e condivisione di informazioni e donazioni in un tempo terribilmente vuoto e sospeso. In passato, all’epoca di Ben Ali, i caffè erano luoghi di occhiuto controllo politico, di schedatura dei dissidenti, di spionaggio ad opera delle forze dell’ordine. Ancora oggi la percezione di insicurezza non è del tutto rimossa dal momento che non sono affatto rare le prassi arbitrarie della polizia, la violenza esercitata sui giovani sfiorati dal sospetto, i fermi e le perquisizioni soprattutto nelle municipalità ai margini di Tunisi.

Le madri dei giovani migranti dispersi supportate dalla associazione “La Terre pour tous” (ph. Giovanni Cordova)
Partire è il verbo reiterato nelle voci, nei pensieri e nell’immaginario dei giovani tunisini, lo sguardo volto al mare, la migrazione intesa come un rito di passaggio, di iniziazione alla maturità, percepita come un destino, come «un’esperienza trasformativa che consente di accedere a una piena sicurezza sociale e, soprattutto, di acquisire statuto di piena virilità». Sta nel non-detto di tanti che aspirano a guadagnare libertà e autonomia, mobilitano legami e risorse familiari, sfidano le resistenze, i divieti, le regole dell’ordine costituito, i rischi della traversata. Non è senza significato che la migrazione in lingua araba è definita harga, un’avventura destinata ad abbattere impedimenti e costrizioni, a saltare tutti gli ostacoli legali della frontiera, a “bruciare” le identità originarie, a lasciarsi alle spalle subalternità e stigmatizzazioni. Un gesto di opposizione e di contestazione, «possibile atto fondativo di soggettivazione politica». Ma anche l’antico e legittimo desiderio di dare soluzione alle difficoltà economiche, di sperimentare nuove opportunità di realizzazione personale, una via di fuga dalla povertà materiale e dal nulla esistenziale.
L’ultima cospicua parte del libro di Giovanni Cordova è dedicata alle questioni connesse alla sfera religiosa, al recupero e alla riscoperta dell’islam, all’ingombrante presenza dei salafiti, all’interferenza di agenzie straniere come i telepredicatori egiziani o sauditi, alla diffusione della pratica del velo da parte di giovani donne, alla trasformazione delle moschee in luoghi di transazioni economiche, di opere assistenziali e di ricerca di lavoro, fino all’inquietante fenomeno dei comitati di sostegno del jihad in Siria. I giovani musulmani conoscono dopo la Primavera un processo di fascinazione per il salafismo, un’attrazione per una certa escatologia messianica destinata a surrogare le delusioni e le amarezze per il mancato rinnovamento sociale promesso dalla rivoluzione. Bilel, trentunenne, tecnico informatico che veste in jeans e maglietta ma mostra in fronte la zabība, la macchia scura che si viene a creare sulla fronte di chi prega prostrandosi a terra, afferma che «incentrare la vita sulla religione come facciamo noi è una scelta ideale in vista della fine dei tempi e del giudizio universale, che sia tra un giorno o tra cinquemila anni». Anche l’amico Talel, trentenne, che porta la barba lunga, evidente segno di riconoscimento, e indossa il qamīs bianco, introdotto nella comunità salafita ha smesso di suonare la chitarra per dedicarsi alla preghiera, e così dichiara: «Guarda com’è oggi la Tunisia, a quale punto basso siamo arrivati. Forse se ci impegniamo di più nella religione le cose possono migliorare, se recuperiamo i nostri primi valori!».
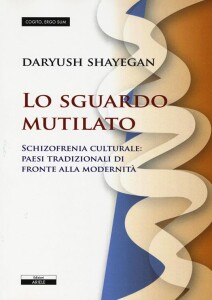 Ad un tempo mitico, fuori della storia sembrano ispirarsi i giovani musulmani come Bilel e Talel che dal salafismo traggono l’idea di un’utopia, in verità di una retrotopia, la reviviscenza di un mondo primigenio e di un’età dell’oro, il tempo celebrato dalle gesta del Profeta e dei suoi primi compagni, una nostalgia di un passato favoloso, della gloriosa civiltà islamica, di un primato culturale perduto. In questo orizzonte la religione assume un valore ponderale eminentemente politico, un indubbio ruolo di interdizione nello spazio pubblico e nelle retoriche mediatiche. «Essere e agire da buoni musulmani – scrive Cordova – rileva di un processo di soggettivazione cui è immanente una critica, talvolta grossolana, dell’esistente; sia in termini storico-geopolitici, sia come critica “ordinaria” rivolta allo Stato, ai suoi rappresentati e alle sue istituzioni». La critica declinata nel paradigma identitario può essere di segno progressivo o regressivo, può indirizzarsi contro il potere per condannare corruzioni e malaffare ma può essere a sostegno di progetti reazionari e di pulsioni autoritarie.
Ad un tempo mitico, fuori della storia sembrano ispirarsi i giovani musulmani come Bilel e Talel che dal salafismo traggono l’idea di un’utopia, in verità di una retrotopia, la reviviscenza di un mondo primigenio e di un’età dell’oro, il tempo celebrato dalle gesta del Profeta e dei suoi primi compagni, una nostalgia di un passato favoloso, della gloriosa civiltà islamica, di un primato culturale perduto. In questo orizzonte la religione assume un valore ponderale eminentemente politico, un indubbio ruolo di interdizione nello spazio pubblico e nelle retoriche mediatiche. «Essere e agire da buoni musulmani – scrive Cordova – rileva di un processo di soggettivazione cui è immanente una critica, talvolta grossolana, dell’esistente; sia in termini storico-geopolitici, sia come critica “ordinaria” rivolta allo Stato, ai suoi rappresentati e alle sue istituzioni». La critica declinata nel paradigma identitario può essere di segno progressivo o regressivo, può indirizzarsi contro il potere per condannare corruzioni e malaffare ma può essere a sostegno di progetti reazionari e di pulsioni autoritarie.
Di questa ambiguità che mette insieme conservazione e rivoluzione, umanitarismo solidale e settarismo ideologico, secolarismo e dogmatismo, partecipa in fondo la storia stessa della giovane Tunisia post-coloniale, oggi sempre più pericolosamente in bilico tra democrazia e democratura, tra libertà e dispotismo, precipitata nella schizofrenia culturale che affligge molti dei Paesi arabi, sedotti dall’Occidente e dalla modernità e tuttavia nello stesso tempo diffidenti di quella libertà individuale e di quei diritti civili che ne caratterizzano le società. A questo proposito lo studioso iraniano Daryush Shayegan ha parlato di “sguardo mutilato”, di presunti mondi incompatibili che si attraggono, si respingono e si deformano reciprocamente come in uno specchio rotto o difettoso. La religione islamica – tutte le religioni, in verità – curva il tempo lineare della storia nel tempo ciclico del mito e può sovrapporre alla realtà la sua immagine retrospettiva. Da qui, a fronte del rimpianto della grandezza perduta e ineguagliabile, il sentimento disincantato e il risentimento critico verso l’umiliazione del presente, le tesi cospirazioniste e paranoiche elaborate per evocare le macchinazioni orchestrate dalle potenze straniere, il tema ricorrente della “svendita” all’Occidente dei patrimoni e delle ricchezze ad opera delle classi dirigenti tunisine.
 A guardar bene, vittimismo e frustrazione sono sindromi di quella “infelicità araba” di cui ha scritto l’intellettuale libanese Samir Kassir, vittima delle truppe di occupazione siriane, in un prezioso libretto tradotto in Italia nel 2006. Vi descrive una condizione di impotenza, il paradosso di una paralisi, il senso fallimentare di una sconfitta, il cordoglio di un lutto non elaborato per quel che si è stati e non si è più. L’islam politico, che può spingersi agli estremi del panislamismo e del jihadismo che insegna il martirio e coltiva la cultura della morte, si offrirebbe come via di uscita alternativa all’infelicità. Soprattutto per i giovani che più nevroticamente avvertono questa schizofrenia tra il richiamo dei media e dei consumi e il sogno della rinascenza musulmana, tra i social e le sure. Una contraddizione identitaria apparentemente insanabile, un perenne inquieto stato di alienazione e sospensione.
A guardar bene, vittimismo e frustrazione sono sindromi di quella “infelicità araba” di cui ha scritto l’intellettuale libanese Samir Kassir, vittima delle truppe di occupazione siriane, in un prezioso libretto tradotto in Italia nel 2006. Vi descrive una condizione di impotenza, il paradosso di una paralisi, il senso fallimentare di una sconfitta, il cordoglio di un lutto non elaborato per quel che si è stati e non si è più. L’islam politico, che può spingersi agli estremi del panislamismo e del jihadismo che insegna il martirio e coltiva la cultura della morte, si offrirebbe come via di uscita alternativa all’infelicità. Soprattutto per i giovani che più nevroticamente avvertono questa schizofrenia tra il richiamo dei media e dei consumi e il sogno della rinascenza musulmana, tra i social e le sure. Una contraddizione identitaria apparentemente insanabile, un perenne inquieto stato di alienazione e sospensione.
In qualche modo anche in Tunisia i giovani incontrati da Giovanni Cordova soffrono di questa tensione irrisolta, della cronica indeterminatezza dell’essere e sentirsi musulmano nel quadro delle compatibilità con la modernità, con la contemporaneità. Tanto più che spinti in uno spazio liminale di invisibilità strutturale, dalla precarietà economica, dall’impossibilità di trovare lavoro e contrarre matrimonio, Bilel, Talel, Karim e gli altri condividono una generale dimensione di disagio generazionale, di malessere esistenziale, di umana fragilità e vulnerabilità. Una crisi che l’esperienza pandemica ha violentemente disvelato, evidenziato ed esacerbato, a livello transnazionale, al di qua e al di là della frontiera mediterranea, interessando i giovani in quanto giovani, i più esposti a ripercussioni e alterazioni degli equilibri psicologici e neurologici. In Tunisia la minaccia del coronavirus si è però intrecciata e ibridata con la paura del nuovo ordine poliziesco instaurato dal presidente Kaïs Saïed che assieme al coprifuoco ha imposto discriminazioni razziali e dure repressioni.
Nel restituire le voci dall’interno di questo universo umano e culturale travagliato e lacerato, il libro di Giovanni Cordova è un denso ed emozionante spaccato di biografie, di storie di vita, di testimonianze spontaneamente maturate nella quotidianità delle relazioni stabilite, delle confidenze condivise, delle amicizie consolidate. Se l’etnografia non è un’arida raccolta di dati e di osservazioni scientifiche, come è ormai definitivamente chiarito, la ricerca condotta da Cordova a Tunisi e dintorni è un modello metodologico che si avvicina allo stile narrativo e dialogico, alla scrittura interattiva che mette in gioco la soggettività dell’autore e quella del cosiddetto informatore, in una trasparente e polifonica dialettica che, pur nel rispetto e nell’asimmetria dei ruoli, ribadisce la convinzione che nell’osservazione partecipante l’osservatore è parte costitutiva dell’osservazione, con le sue ineludibili categorie interpretative e le legittime pratiche di “riflessività” che postulano nella reciprocità delle posture il costante e onesto interrogarsi sul proprio stesso sguardo.

Un frame del documentario “La vita della gioventù tunisina a dieci anni dalla rivoluzione” di International Alert
Attraversando le pagine di questo libro la “descrizione densa”, che è interpretazione dei significati di quanto è rappresentato, appare l’esito felice della pluralità degli incontri, della lettura attenta e puntuale dei contesti, della osservazione mai neutrale e tuttavia mai estranea al rigore del codice scientifico. Lontano dalla ingenua idea di un paradigma olistico che tutto presume di comprendere e di connettere in un’unica fiduciosa visione totalizzante, il quadro antropologico che emerge coglie e coinvolge più fonti e più ipotesi investigative, in un’articolazione molecolare e frastagliata che segue il flusso dei dati conoscitivi e si immerge nell’evoluzione degli eventi, così come sono elaborati e tradotti nel vissuto privato e familiare dei protagonisti. Le storie di vita, i sentimenti, le inquietudini e i progetti dei testimoni oculari dei fatti narrati sono infatti documenti preziosi non solo per la loro conoscenza ma anche per la comprensione delle modalità in cui gli stessi attori sociali percepiscono e rappresentano quanto raccontano.
Giovanni Cordova non si nasconde dietro le parole di Karim e dei suoi compagni ma a queste parole attribuisce credito, dignità e autorevolezza, queste parole mescola alle sue, non perché in assoluto “vere” dal punto di vista storico e fattuale ma perché rilevanti e significative dal punto di vista eminentemente antropologico. Accanto alle fonti orali, trapiantate e intessute nel corpo della narrazione, sono numerosissime quelle scritte, le citazioni della complessa letteratura scientifica che danno fondamento teorico ai ragionamenti, alle affermazioni e alle interpretazioni. È appena il caso di precisare infatti che non basta “essere stato sul campo”, occorre coniugare la osservazione con la partecipazione e questa con lo studio di quanto è stato pubblicato sul tema oggetto della ricerca. L’intellegibilità di questa sintesi passa attraverso la consapevolezza e l’adozione di un approccio intellettuale aperto alla dimensione relazionale del sapere antropologico, sensibile alla problematica della restituzione, attento alla legittimazione politica della ricerca. «La scrittura di un libro, l’atto col quale si diviene autori – chiarisce Cordova fin nella prima pagina del volume – non è un’impresa individuale: non può che affiorare da una trama di relazioni, studi, ricerche e sentimenti che istituiscono connessioni – legami – tra storie e persone». Connessioni e legami – di passioni e ragioni – che la scrittura di questo bel libro ha saputo sapientemente costruire tra l’autore e i lettori.
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023
Riferimenti bibliografici
Cordova G., Karim e gli altri. La gioventù tunisina dopo la Primavera, Rosenberg&Sellier Torino 2022.
Cusumano A., Il ritorno infelice. I Tunisini in Sicilia, Sellerio Palermo 1976
Kassir S., L’infelicità araba, Einaudi Torino 2006
Poncet J, “L’economie Tunisienne depouis l’Indipendence”, in Les economics maghrebines, Paris 1971
Shayegan D., Lo sguardo mutilato, Ariele, Milano 2015.
___________________________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020). Per la stessa casa editrice ha curato il volume Per Luigi. Scritti in memoria di Luigi M. Lombardi Satriani (2022).
______________________________________________________________










