di Giovanni Isgrò
Da alcuni decenni scrivo che la mancanza di una tradizione attorale in Sicilia al di qua della soglia ottocentesca sia in larga parte dovuta alla dominante del cosiddetto teatro festivo urbano che, secondo il progetto della monarchia ispanica, animò piazze e assi di parata delle città di rappresentanza dell’Isola in occasione di celebrazioni civili e religiose a partire dal Cinquecento.
Al di fuori di questo steccato, all’interno del quale si misurarono artigiani geniali costruttori di macchine e apparati, rimasero personaggi fuori canone ad orientamento attorale, tuttavia non omologabili a settori specifici del teatro “riconosciuto”, anche se alcuni di essi ebbero modo di vivere all’interno delle dinamiche teatrali dominanti, rivelando originali stranezze, proprio per difetto di appartenenza, come nel caso di Vincenzo Belando.
Profugo dalla Sicilia, iniziò il, suo peregrinare negli anni settanta del ‘500 in Italia e fuori, fino all’approdo a Parigi, dove rimase fino al 1609, data di pubblicazione della sua commedia Gli inganni d’amore. A metà fra commedia dell’arte, con le sue maschere canoniche fino all’elogio della sua «singolarissima ed antica padrona» Isabella Andreini, della cui compagnia Belando verisimilmente fece parte, è testimonianza autobiografica dell’attore emigrante che nella veste del servo Catonzu si abbandona a ricordi nostalgici della sua Sicilia.
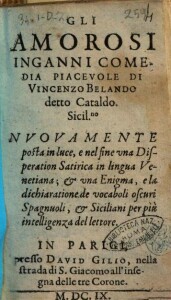 L’opera ripropone a suo modo l’originalità delle varianti del teatro quali potevano essere pensate da un siciliano. Nonostante il mestiere del comico e l’acculturazione di chi giunge alla soglia dello scrittore di commedia, rimane sottesa l’inibizione di chi mantiene nella scena, e poi di seguito nella vita, la configurazione di servo. Un servo però sui generis, in quanto determinato a raggiungere una posizione onorata al servizio di signori di alto lignaggio, che lo porterà a conquistare lo status di bourgeois de ville. Come dire un servo-attore che riuscì a diventare servo di professione.
L’opera ripropone a suo modo l’originalità delle varianti del teatro quali potevano essere pensate da un siciliano. Nonostante il mestiere del comico e l’acculturazione di chi giunge alla soglia dello scrittore di commedia, rimane sottesa l’inibizione di chi mantiene nella scena, e poi di seguito nella vita, la configurazione di servo. Un servo però sui generis, in quanto determinato a raggiungere una posizione onorata al servizio di signori di alto lignaggio, che lo porterà a conquistare lo status di bourgeois de ville. Come dire un servo-attore che riuscì a diventare servo di professione.
Tutto questo spiega come mai la stessa configurazione dell’attore-servo ne Gli inganni d’amore, come scrive Meldolesi, non abbia alcunché dello Zanni dai bisogni primordiali. Al contrario, «è il servo curioso che conosce i traffici dei suoi signori, che sa farsi passare anche da dotto, che usa e scambia le diverse lingue chiribizzose e che pretende sempre riportare il mondo alla misura del suo essere e delle sue conoscenze» [1].
“Esule integrato” è stato per questa ragione definito Vincenzo Belando, ma anche autore orientato su percorsi di regolarizzazione della commedia dell’arte; e che, secondo gli attributi scenici della sicilianità codificati da Andrea Perrucci, propone i tratti tipici della maschera sicilianizzante «garrula e contenziosa».
In definitiva Belando testimonia, da un lato la distanza dell’humus antropologico siciliano dai meccanismi della macchina “zannesca” della commedia dell’arte, dall’altro, l‘attitudine siciliana alle varianti anomale progettate da una psicologia un po’ servile, un po’ ribelle, ma anche virtualmente predisposta ad un conservatorismo regolarizzatore. E proprio in vista di questa condizione che, a fronte del gesto estremo dell’esule, non c’è contraddizione con la configurazione del nuovo percorso siciliano del teatro di quella metà degli anni ’60 con la sua armoniosa complementarietà fra l’avvento del teatro gesuitico e il progetto scenico della monarchia dominante.
Fatta esclusione di Isabella del Campo che lasciò la Sicilia per seguire Tiberio Fiorilli (in arte Scaramouche) che la sposò e la introdusse direttamente nelle dinamiche della commedia dell’arte, un altro commediante siciliano anomalo che lasciò l’Isola operando nel resto d’Italia ed oltralpe fu Giuseppe Tortoriti .
Accolto nella seconda metà del ‘600 presso la corte di Modena e poi a Parigi insieme a grandi comici come Antonio Riccoboni e Domenico Costantini, prima del rientro a Modena, e ricoprendo ruoli diversi (da servo acrobata a Pascariello a Scaramouche), Tortoriti cercò di supplire con l’esteriore versatilità del suo talento alla mancanza di un tessuto siciliano orientato verso il lavoro del comico al quale potere proficuamente attingere. Al tempo stesso dalla Sicilia ereditò, insieme alle energie espressive, la caparbietà al mantenimento di un genere, quale fu quello della “improvvisa”, proprio nel momento in cui esso entrava in crisi con la fine dei grandi comici del passato; condizione paradossale, questa, in nome di un conservatorismo che finì per ricongiungerlo idealmente con l’esprit della sua terra artigiana.
 E non è un caso che a sua volta il palermitano Andrea Perrucci, trapiantato a Napoli, noto letterato dai molteplici interessi, all’esperienza di attore teatrale associò, come ha già notato Meldolesi [2], quello di teorico della commedia dell’arte nel tempo in cui essa era ormai giunta al suo culmine, e comunque al di fuori della sua genesi storica. A metà fra compendio e opera critica, il suo trattato Dell’Arte rappresentativa, premeditata e all’improvviso pubblicato nel 1699 confermò in effetti l’orientamento dell’uomo di teatro anche quando si naturalizzò all’estero.
E non è un caso che a sua volta il palermitano Andrea Perrucci, trapiantato a Napoli, noto letterato dai molteplici interessi, all’esperienza di attore teatrale associò, come ha già notato Meldolesi [2], quello di teorico della commedia dell’arte nel tempo in cui essa era ormai giunta al suo culmine, e comunque al di fuori della sua genesi storica. A metà fra compendio e opera critica, il suo trattato Dell’Arte rappresentativa, premeditata e all’improvviso pubblicato nel 1699 confermò in effetti l’orientamento dell’uomo di teatro anche quando si naturalizzò all’estero.
Regolarizzatore e conservatore di un genere che non poté vivere direttamente da interprete, Perrucci segnò nei confronti del teatro delle maschere una distanza doppia rispetto a quella di Tortoriti, geniale nell’invenzione e apprezzato nella tecnica, ma privo di una identità culturalmente predisposta all’arte dell’improvvisa. Da qui, la meticolosa precisione con la quale l’arte recitativa e gestuale, insieme alla costante presenza creativa dell’attore, vennero illustrate tenendo conto della tradizione migliore della commedia dell’arte con il lungo studio, i tempi e i ritmi che la caratterizzarono. Come dire: un trattato conclusivo e conservativo di una forma d’arte destinata a consegnare al futuro la conoscenza del fenomeno più significativo del teatro dell’età moderna. E mentre l’evoluzione settecentesca portava all’affermazione della riforma goldoniana, in Sicilia si assistette ad un altro genere di cambiamento, che pose le premesse per la riconquista del teatro d’attore.
Proprio in questa stagione di sovvertimento del plurisecolare progetto dell’Hispanidad emerse quanto era andato maturando nella sfera popolare “occulta” nei due secoli della dominazione di Madrid. Stante che la politica della monarchia dominante fu causa primaria della marginalità della Sicilia dai circuiti del continente europeo, negli ambienti delle classi subalterne nelle realtà non esposte all’ufficialità, si andò consolidando un humus culturale nel quale l’esperienza festiva favorì un rapporto forte con le sorgenti e le forme preteatrali. Da qui, il ridefinirsi di una pratica siciliana che paradossalmente approdò ad una modernità scenica fino all’avvento dell’Opera dei pupi che tanto appassionò Meyerhold e del grande attore anomalo, da Giovanni Grasso ad Angelo Musco che affascinò Marinetti e il pubblico europeo.
In effetti i grandi serbatoi siciliani del preteatro si alimentarono di memorie medievali e di costanti aggiornamenti determinati dalla continuità delle feste popolari, nelle quali la ricchezza delle invenzioni fu foriera di varianti e di libere stranezze non inquadrabili tuttavia nella forma del professionismo, e per questa ragione destinate a rimanere anonime e sconosciute a di fuori di ristretti ambiti territoriali.
 In questo senso la pratica più ricca di testimonianze fu l’arte carnevalesca fondata sul gioco e sul divertimento animati da danze, pantomime, ma anche da prove di abilità, da gesti acrobatici, oltre che da buffonerie e provocazioni estreme; un vero e proprio laboratorio preteatrale nel quale mutuarono e maturarono forme potenzialmente predisposte alla clownery, all’esercizio circense ma anche al teatro d’avanguardia. E non è un caso che il marchese di Villabianca nel descrivere i giochi soliti farsi nel carnevale palermitano del ‘700 adoperò termini teatrali. “Attori” furono da lui chiamati i personaggi del “gioco dell’oca e della papera”, cui veniva assegnato un ruolo destinato a diventare una sorta di specializzazione a tipologia fissa: «chi fa da militare, chi da cittadino, chi da attore, chi da pulcinella, chi da bandito, chi da barriggello, chi da marte armato d’arco» [3] ecc.. e non mancavano spettacolari azioni di gruppo come la “guerra di lazzari”, una sorta di combattimento ispirato al gioco cavalleresco della quadriglia, o le pantomime mascherate.
In questo senso la pratica più ricca di testimonianze fu l’arte carnevalesca fondata sul gioco e sul divertimento animati da danze, pantomime, ma anche da prove di abilità, da gesti acrobatici, oltre che da buffonerie e provocazioni estreme; un vero e proprio laboratorio preteatrale nel quale mutuarono e maturarono forme potenzialmente predisposte alla clownery, all’esercizio circense ma anche al teatro d’avanguardia. E non è un caso che il marchese di Villabianca nel descrivere i giochi soliti farsi nel carnevale palermitano del ‘700 adoperò termini teatrali. “Attori” furono da lui chiamati i personaggi del “gioco dell’oca e della papera”, cui veniva assegnato un ruolo destinato a diventare una sorta di specializzazione a tipologia fissa: «chi fa da militare, chi da cittadino, chi da attore, chi da pulcinella, chi da bandito, chi da barriggello, chi da marte armato d’arco» [3] ecc.. e non mancavano spettacolari azioni di gruppo come la “guerra di lazzari”, una sorta di combattimento ispirato al gioco cavalleresco della quadriglia, o le pantomime mascherate.
Il personaggio che maggiormente emerge nella carrellata del Villabianca è il protagonista della pantomima “Mastro di Campo” di Mezzojuso. “Folle attore” era da lui chiamato per i convulsi gesti cadenzati nei quali si lasciava andare con la spada in mano accompagnato dal suono del tamburo, prima di iniziare l’assalto al castello della regina Bianca della quale era follemente innamorato. Respinto dalle guardie della regina, si lasciava cadere all’indietro rimanendo arrampicato su una scala in legno. Acrobazia, uso del corpo quasi come una danza, relazione convulsa con il pubblico, esternazione della passione amorosa verso la regina, erano tante componenti di un approccio preteatrale, carico di energia e di abilità espressiva, provata con cura prima della effettuazione dell’azione scenica offerta al godimento del pubblico di Mezzojuso. La festa, dunque, si trasformava in spettacolo vero e proprio nel quale si proiettavano diavolerie, figurazioni anomale, contrasti fra realismo e fantasia, conflitti tra morte e godimento, ma anche intrattenimenti farseschi in un assetto di relazione fra scena e pubblico, in un contesto di ritualità festiva che sarebbe stata la base della rivoluzione dei padri fondatori del teatro europeo del ‘900.
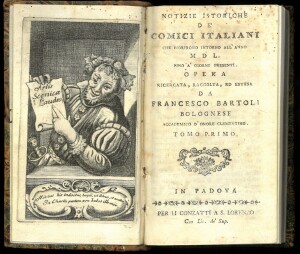 Nel caso di Palermo, alla fine del Settecento si collegò al tempo del carnevale l’affermazione di un genere di farsa popolare destinata a diventare la prima forma di teatro comico regolare, ossia la “vastasata” [4]; e fu il primo importante approdo ad un genere in qualche modo accostabile alla commedia dell’arte mediata dall’esempio delle“ pulcinellate” napoletane, anomalo, tuttavia, rispetto alla pratica dei comici professionisti, in quanto interpretato da artigiani ed esponenti del ceto medio basso della stessa città.
Nel caso di Palermo, alla fine del Settecento si collegò al tempo del carnevale l’affermazione di un genere di farsa popolare destinata a diventare la prima forma di teatro comico regolare, ossia la “vastasata” [4]; e fu il primo importante approdo ad un genere in qualche modo accostabile alla commedia dell’arte mediata dall’esempio delle“ pulcinellate” napoletane, anomalo, tuttavia, rispetto alla pratica dei comici professionisti, in quanto interpretato da artigiani ed esponenti del ceto medio basso della stessa città.
Anche in questo caso perdurò l’idea del teatro/festa caratterizzato da una platea sempre uguale, legata alle tematiche dei personaggi in scena dall’appartenenza ad uno stesso stato sociale, in un’atmosfera di rito collettivo, proprio come sarebbe successo pochi anni dopo con la nascita di un’altra forma di teatro, questa volta di figura, anomalo, ossia l’Opera dei pupi. Non a caso il fenomeno della vastasata fu preceduto dalla comparsa di un inedita figura di attore solista, Nardu da Ferrazzano.
Così ce lo descrive Daniele Bartoli:
«vestiva un abito tutto bianco e pressoché alla foggia dei pagliacci o dei Pierò de’ giocolatori. Grazioso nelle parole e nei gesti, con le arguzie della lingua e co’ movimenti del corpo divertiva moltissimo il suo auditorio. Quando il padrone lo sgridava, egli si faceva tutto pallido, che sembrava un infermo spirante, e se lo stesso placavasi poco dopo, e lo accarezzava, tutto infiammavasi in volto, diventando rosso in sì notabile guisa che cagionava meraviglia nell’anima degli spettatori. Talvolta faceva la bocca e ingrandiva il mento con sì fatto sberleffo che muoveva le risa anche dei più svogliati, e malinconici. Se la serva di cui mostravasi innamorato era seco in collera e lo rimproverava, tu lo vedevi nascondersi la testa in fra le spalle, tal che senza collo appariva, ed allora, quando [ella] faceva seco la pace e lo blandiva, tutto il collo nascosto per sì fatto modo allungava, che pareva quello d’una gru, o d’altro simile augello. Toltosi poi Nardo alla professione del comico, andava per le pubbliche vie di Palermo chiedendo ad alta voce perdono dello scandalo dato col suo parlar libero sul teatro, ma facevalo in un modo capriccioso e bizzarro. Vi chiedo scusa (egli diceva) del cattivo esempio che v’ho dato e m’accuso d’esser stato un furfante; ma più furfanti siete stati voi altri portandovi così vogliosi ad ascoltarmi. Il popolo rideva a tali parole e per ogni strada seguivalo, facendo suo proprio divertimento e trastullo […]» [5].
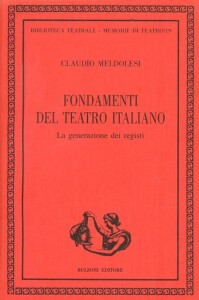 Dalla descrizione di Bartoli emergono due dati significativi. Nardu esercitò in un primo tempo la professione di comico, anche se sostanzialmente definito e circoscritto, come scriveva Meldolesi, nel suo ruolo e nel nome in quanto tale, e per quanto sapesse verosimilmente assimilare esempi di figurazioni buffe importate (fossero esse il pagliaccio o il pierrot dei giocolatori o ancora lo stesso pulcinella) stabilì un trait-d’union con l’ars mechanica della pratica artigiana, ma anche con l’intrattenimento di ispirazione feerica. Si determinarono in questo modo le condizioni per dare vita ad una sorta di attore-marionetta: un attore-icona in grado di trasformare il colore del volto (ora bianco per la paura, ora rosso per l’imbarazzo o per la vergogna) e capace di controllare il proprio corpo come fa il manovratore con i burattini o come avrebbero fatto nell’Ottocento gli inventori dell’Opera dei pupi.
Dalla descrizione di Bartoli emergono due dati significativi. Nardu esercitò in un primo tempo la professione di comico, anche se sostanzialmente definito e circoscritto, come scriveva Meldolesi, nel suo ruolo e nel nome in quanto tale, e per quanto sapesse verosimilmente assimilare esempi di figurazioni buffe importate (fossero esse il pagliaccio o il pierrot dei giocolatori o ancora lo stesso pulcinella) stabilì un trait-d’union con l’ars mechanica della pratica artigiana, ma anche con l’intrattenimento di ispirazione feerica. Si determinarono in questo modo le condizioni per dare vita ad una sorta di attore-marionetta: un attore-icona in grado di trasformare il colore del volto (ora bianco per la paura, ora rosso per l’imbarazzo o per la vergogna) e capace di controllare il proprio corpo come fa il manovratore con i burattini o come avrebbero fatto nell’Ottocento gli inventori dell’Opera dei pupi.
Nardu da Ferrazzano fu però al tempo stesso, ancora nella sua pur moderna eccezione di attore liberato dagli schemi cerimoniali, una sorta di prototipo. Per questa ragione la sua vita da comico orientato verso il professionismo non poté attuare una condizione autonoma, né tanto meno attorno a lui poté crearsi al momento un gruppo d’arte. La sua invenzione scenica fu tuttavia un fenomeno di rottura e al tempo stesso di nuovo arricchimento, in grado di congiungere l’alto e il basso, ossia il culto e il popolare. La costante della teatralità urbana ebbe modo così di sperimentare una nuova formula, al di fuori delle regole della ritualità paratattica, ma anche al di sopra della tradizione anonima delle rappresentazioni popolari. In questo senso un ruolo determinante ebbe la rappresentazione de La Conversione di Santa Margherita di Bernardo Bonajuto (in arte Aci Drepaneo), dell’Accademia degli Ereini, uno spettacolo destinato ad essere replicato per tutto il resto del secolo in centri grandi e piccoli della Sicilia.
In quest’opera Nardu intrecciava il suo ruolo di buffo con la storia di Santa Margherita rivelandosi protagonista comico, in grado di attirare il pubblico più che l’azione sacra. Egli nella veste del servitore di Olinto, l’innamorato di Santa Margherita, sfruttava le sue originali capacità interpretative, la varietà dell’uso del corpo in scena, e la tempestività reattiva rispetto alla battuta dell’interlocutore, sì da attirare le simpatie del pubblico sempre, in qualsiasi situazione si trovasse, sia che prendesse alla berlina il padrone innamorato, sia che entrasse nel gioco scherzoso con Fiammetta, la serva di Margherita, sia nell’indossare la veste del monaco, pur senza ricorrere agli standard comici della commedia dell’arte, ma anche ai poco spettacolari buffi entrati nella letteratura teatrale popolaresca degli imitatori del Della Porta [6] proprio come un artista da foire.
 L’attore popolare Nardu si era trasformato in una vera e propria maschera. Ma fu proprio allora che decise di scendere dal palcoscenico e conquistare la strada con le stranezze del suo corpo e le arguzie del suo parlare, prendendo in giro la gente che incontrava senza risparmiare esponenti della borghesia e commercianti, da lui visti come usurai. Poi, terminato il tempo delle esibizioni burlesche divenne una sorta di cortigiano parassita della nobiltà, conquistando il plauso di una aristocrazia a sua volta liberata dagli schemi cerimoniali del passato.
L’attore popolare Nardu si era trasformato in una vera e propria maschera. Ma fu proprio allora che decise di scendere dal palcoscenico e conquistare la strada con le stranezze del suo corpo e le arguzie del suo parlare, prendendo in giro la gente che incontrava senza risparmiare esponenti della borghesia e commercianti, da lui visti come usurai. Poi, terminato il tempo delle esibizioni burlesche divenne una sorta di cortigiano parassita della nobiltà, conquistando il plauso di una aristocrazia a sua volta liberata dagli schemi cerimoniali del passato.
La maschera di Nardu, sia pure con varianti topiche, dovette tuttavia rimanere nelle consuetudini della festa popolare di alcuni centri minori della Sicilia. Nardu ricompare ancora oggi nel giorno dell’Epifania a Santa Elisabetta, un piccolo paese dell’agrigentino. Qui in veste di un trasandato pastore buffo si presenta alla comunità locale infastidendo e divertendo al tempo stesso tutti coloro con cui viene a contatto con finti sputi di cibo ed erba, come dire che frammenti del nostro personaggio sono rientrati in quell’humus di cultura popolare sempre in grado di prodursi in nuove invenzioni sceniche così antiche e al tempo stesso così nuove ed originali.
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023
Note
[1] C. MELDOLESI, Les Siciliens: da Vincenzo Belando allo Scaramouche dei pittori, in Scritti in onore di Giovanni Macchia, Mondadori, Milano 1983, n. II: 655.
[2] ibidem
[3] F. M. EMMANUELE E GAETANI, MARCHESE DI VILLBIANCA, Opuscoli palermitani, n. XII, De’ teatri antichi e moderno della città di Palermo, ms .Bibl. Comunale di Palermo, Qq E 88, n. 4, ff. 5-16
[4] Si veda G. ISGRO’, Il Teatro degli artigiani a Palermo fra Sette e Ottocento, in «Teatro e Storia» nuova serie 2-2010 [a. XXIV vol. 31]: 321-341
[5] F. BARTOLI, Notizie istoriche de’ comici italiani, Consatti, Padova, 1782, !, s.v. “Nardu”).
[6] Fra i più famosi: Fantastico Rapa della Servitù d’amore, Todaro Calcagna degli Amorosi ritratti, Berti Spicchiu degli Sposi Ingannati, Nino della Moglie Odiata, Tiberio de Gli amorosi sospiri, di Alessandro Dionisio, ma anche de La Notti di Palermu.
______________________________________________________________
Giovanni Isgrò, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università di Palermo, è autore e regista di teatralizzazioni urbane. Ha vinto il Premio Nazionale di Saggistica Dannunziana (1994) e il premio Pirandello per la saggistica teatrale (1997). I suoi ambiti di ricerca per i quali ha pubblicato numerosi saggi sono: Storia del Teatro e dello Spettacolo in Sicilia, lo spettacolo Barocco, la cultura materiale del teatro, la Drammatica Sacra in Europa, Il teatro e lo spettacolo in Italia nella prima metà del Novecento, il Teatro Gesuitico in Europa, nel centro e sud America e in Giappone. L’avventura scenica dei gesuiti in Giappone e Il Teatro dei gesuiti sono i titoli delle sue ultime pubblicazioni.
______________________________________________________________









