di Annalisa di Nuzzo
Etnografia, Antropologia, Cinema
L’antropologia interpretativa osserva, raccoglie, rielabora e si confronta con tutto quanto può essere utile a realizzare una etnografia complessa, risultato di una thick description. Per un’antropologa della complessità, che ha studiato e continua a studiare Napoli attraverso la sua ipertrofica cultura, il cinema rappresenta una particolare forma di etnografia inconsapevole che mette insieme linguaggi diversi e complementari – immagini, suoni, parole – realizzando un prepotente ed efficace sguardo olistico.
Il sapere e la ricerca antropologica sono inevitabilmente legati all’etnografia, che dà vita e concretezza a principi e connotazioni di un’antropologia che costantemente rielabora e riflette sulle sue interpretazioni del mondo e delle culture, nonché sugli strumenti interpretativi più idonei. È ovvio ribadire che una non può esistere senza l’altra. Negli ultimi cinquant’anni, le forme possibili di etnografia si sono moltiplicate e le relazioni con altri statuti epistemologici e disciplinari si sono consolidate. Antropologia e storia, antropologia e letteratura e, più recentemente, antropologia e web nella forma della netnografia. Gli antropologi, specialisti delle contaminazioni, si sono impegnati utilizzando materiali e linguaggi di “etnografie inconsapevoli” (Di Nuzzo 2018) come strumenti interpretativi delle forme culturali, contribuendo ad arricchire il punto di vista antropologico. In un mondo che non è né “già” né “ancora”, il campo in cui si muove l’antropologo è costantemente in tensione tra confini, in uno spazio intermedio, nell’esperienza dei margini che sfumano e delle soglie che si spostano. In questo contesto, in cui nulla può essere ridotto a schemi unilaterali e unidirezionali, l’osservatore stesso fa parte della propria osservazione, poiché guardare ed essere guardati sono intrinsecamente collegati.
I film e i video sono ormai parte integrante delle nostre vite, ma cosa succede quando il cinema incontra l’antropologia? Da questa unione nasce l’antropologia visiva, una specializzazione dell’antropologia culturale. L’antropologia ha sempre utilizzato mezzi audiovisivi per le sue ricerche, inizialmente attraverso la fotografia e successivamente con l’avvento delle videocamere. Tuttavia, inizialmente le foto e i filmati erano solo un supporto aggiuntivo per la ricerca e non un vero e proprio metodo. Margaret Mead e Gregory Bateson sono stati i pionieri nello studio dell’antropologia visiva e hanno gettato le basi per lo sviluppo di questa disciplina. L’antropologia visiva è stata istituzionalizzata negli anni ‘70 e nel 1973 è stato discusso durante il convegno biennale dell’American Anthropology Association, che ha portato alla pubblicazione del testo curato da Paul Hockings Principi di Antropologia Visuale (1975). Negli anni ‘90 è emerso un nuovo interesse, come illustrato nel testo Rethinking Visual Anthropology (1997) curato da Markus Banks e Howard Morphy, che suggeriva di estendere il campo dell’antropologia visiva allo studio delle espressioni visive della cultura e di qualsiasi forma culturale visibile.
Da questa prospettiva, i film possono essere considerati come testi etnografici che testimoniano un “campo specifico” e offrono una visione interpretativa di una cultura specifica da parte del regista. Sono emersi diversi approcci e filoni di studio nel linguaggio visivo, come il filmato etnografico, l’etnofiction e il docufilm (Canevacci 2001). Seguendo la lezione di Malinowski e le successive reinterpretazioni del metodo dell’osservazione partecipante, si riconsidera il rapporto emico ed etico e si creano scambi di sguardi reciproci tra osservatori e osservati, in cui entrambe le parti si riconoscono e si definiscono reciprocamente. Nell’utilizzo del filmato etnografico, l’uso della telecamera a mano permette di ridurre le distanze con i soggetti ripresi, incluso quando il regista stesso partecipa agli eventi che vengono filmati. In questo modo si utilizza la prospettiva soggettiva, in cui il campo visivo della telecamera corrisponde all’occhio di uno degli “attori” presenti sulla scena, in questo caso lo stesso osservatore.
 Il secondo approccio è caratterizzato dall’etnofiction, in cui gli argomenti trattati sono di interesse antropologico, ma viene introdotta la finzione. Le storie vengono recitate da persone comuni che mettono in scena le proprie esperienze. Quindi, ciò che differenzia la fiction dall’etnofiction è il fatto che non ci siano attori a interpretare le storie e che le storie non siano frutto dell’immaginazione del regista. Un terzo modo ha a che fare con quello che possiamo definire docufilm. Questa modalità è un esempio di cinéma verité, così definito da Morin: «Si tratta di fare un cinema verità che superi l’opposizione fra cinema romanzesco e cinema documentaristico, bisogna fare un cinema di autenticità totale, vero come un documentario ma col contenuto di un film romanzesco, cioè col contenuto della vita soggettiva» (Fofi, Morandini e Volpi 1988: 343).
Il secondo approccio è caratterizzato dall’etnofiction, in cui gli argomenti trattati sono di interesse antropologico, ma viene introdotta la finzione. Le storie vengono recitate da persone comuni che mettono in scena le proprie esperienze. Quindi, ciò che differenzia la fiction dall’etnofiction è il fatto che non ci siano attori a interpretare le storie e che le storie non siano frutto dell’immaginazione del regista. Un terzo modo ha a che fare con quello che possiamo definire docufilm. Questa modalità è un esempio di cinéma verité, così definito da Morin: «Si tratta di fare un cinema verità che superi l’opposizione fra cinema romanzesco e cinema documentaristico, bisogna fare un cinema di autenticità totale, vero come un documentario ma col contenuto di un film romanzesco, cioè col contenuto della vita soggettiva» (Fofi, Morandini e Volpi 1988: 343).
Il cinema ormai da anni fa parte della nostra vita e trovo che sia interessante vedere in che modo si sia intrecciato con l’antropologia. Così Jean-Luc Godard in un’intervista del 1964: «Ora ho delle idee sulla realtà, mentre quando ho cominciato avevo delle idee sul cinema. Prima vedevo la realtà attraverso il cinema, e oggi vedo il cinema nella realtà».
Un altro tema emergente nella produzione e nella riflessione riguarda quello che potremmo definire la “politique des auteurs”. Analogamente a quanto accaduto nell’antropologia scritta, anche nel campo visivo si è assistito a uno sviluppo delle istanze autoriali, sia nella produzione fotografica che in quella cinematografica, che ha dato origine a diverse sperimentazioni relative all’uso di tecniche narrative e stilistiche particolari. In questo contesto, l’opera di Robert Gardner, autore di alcuni classici del cinema etnografico, ha progressivamente sviluppato una ricerca estetico-espressiva che cerca di trovare una dimensione di finzione per il “non-fiction film”, sperimentando un linguaggio cinematografico che evoca e suggerisce poeticamente temi e situazioni, allontanandosi sempre di più dalla ricerca di una rappresentazione scientifica e oggettiva della realtà etnografica (Gardner 1986:23).
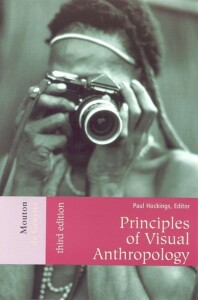 Anche i linguaggi audiovisivi e i loro prodotti diventano oggetto di studio nell’ambito dell’antropologia. Se l’antropologia a distanza, già negli anni ‘50, aveva sperimentato l’uso del cinema di finzione come fonte per l’analisi sociale (Mead e Métraux 2022), negli anni ‘90 vari prodotti delle industrie cinematografiche e televisive locali sono stati utilizzati nelle indagini antropologiche, come i quiz show giapponesi (Martinex 1997) o la programmazione televisiva balinese (Hughes-Freeland 1997).
Anche i linguaggi audiovisivi e i loro prodotti diventano oggetto di studio nell’ambito dell’antropologia. Se l’antropologia a distanza, già negli anni ‘50, aveva sperimentato l’uso del cinema di finzione come fonte per l’analisi sociale (Mead e Métraux 2022), negli anni ‘90 vari prodotti delle industrie cinematografiche e televisive locali sono stati utilizzati nelle indagini antropologiche, come i quiz show giapponesi (Martinex 1997) o la programmazione televisiva balinese (Hughes-Freeland 1997).
Il regista offre all’operatore una selezione e interpretazione soggettiva, simile a quello dello scrittore, e indaga come un antropologo sul campo per creare il frutto della sua etnografia. Il cinema richiede un’immersione sospesa nello spazio della rappresentazione più sorprendente, coinvolgendo, ricreando, formulando e riformulando l’idea del mondo, reale o onirico, passato, presente o futuro, sia il nostro mondo che quello dell’altro. Finzione e realtà si fondono e convergono nell’occhio dello spettatore, creando un’unica entità cinematografica in cui l’attore e ciò che rappresenta diventano uno, fino a diventare indissolubili nel volto e nel ruolo del personaggio.
Il regista è un compagno di strada per l’antropologo e il cinema è un modo di interpretare la vita umana, che può essere illuminante per gli studi. Quindi, per gli antropologi, l’obiettivo non è tanto quello di studiare il cinema per comprenderlo come settima musa, ma piuttosto di integrare il suo specifico contenuto conoscitivo nell’approccio antropologico alla realtà, cogliendo le convergenze senza ignorare le differenze. Le modalità espressive e comunicative del cinema possono aiutare il lavoro di descrizione e interpretazione delle culture, che è proprio dell’antropologo. Quando il cinema sfrutta appieno la sua natura di mezzo espressivo principale per la visione e la partecipazione, lo spazio dell’osservatore si fonde con quello delle inquadrature, il battito si allinea al tempo scandito e si procede insieme lungo un percorso di sensi e conoscenza.
Tuttavia, ciò avviene solo se l’immagine che il cinema proietta è credibile, riconoscibile o condivisibile agli occhi dell’osservatore, ma soprattutto se rappresenta il punto di vista di chi osserva. Tutto questo ci consente di avere una visione sullo sguardo che la società ha nei confronti del film, e dunque di se stessa e degli altri. Il cinema è un mirabile artefatto rappresentativo che al tempo stesso si fa specchio in cui riconoscersi e riconoscere la figura di ciò che non è il “noi”. Questo, dunque, il senso primitivo e arcaico del cinema: la percezione di un altro mondo che, tuttavia, diventa semplicemente il mondo. Figlio di un teatro antico fa di sé quella maschera che si frappone fra l’io che recita e l’io che osserva, diventa il diaframma tattile che per finzione separa le realtà, permettendo invece un osmotico dialogo. Una sorta di antropologia riflessiva (Bourdieu 1992) che dice di noi e dell’altro, dunque una forma di etnografia inconsapevole che ci regala spunti di complessa definizione.
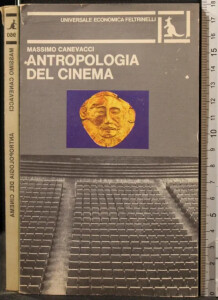 Ciò che vediamo nel momento in cui un film ci scorre attraverso è l’insieme ricchissimo di ciò che l’artista ha voluto rappresentare e quello che il nostro io ha letto e condiviso con la pellicola. Dunque spazi, luoghi, appartenenze, una realtà geoculturale entro la quale il cinema agisce, e attraverso cui possiamo cogliere ciò che una cultura vuole vedere di sé e qual è l’immagine nella quale identifica e riconosce l’altro. Nel ribadire che il linguaggio filmico ha una sua autonomia come lo ha la letteratura, tuttavia può essere una fonte di osservazione antropologica e fornire una sua etnografia proprio perché regala il suo punto di vista. Così scrive Calvino: sono interessanti «i film da cui posso imparare o verificare determinate cose della vita (tipizzazioni, modi di rapporti umani, rapporti tra persona e ambiente, ecc.) che se non c’era il cinema a dirmele, non sarei riuscito a capire in altro modo» (in Palumbo 2012: 519).
Ciò che vediamo nel momento in cui un film ci scorre attraverso è l’insieme ricchissimo di ciò che l’artista ha voluto rappresentare e quello che il nostro io ha letto e condiviso con la pellicola. Dunque spazi, luoghi, appartenenze, una realtà geoculturale entro la quale il cinema agisce, e attraverso cui possiamo cogliere ciò che una cultura vuole vedere di sé e qual è l’immagine nella quale identifica e riconosce l’altro. Nel ribadire che il linguaggio filmico ha una sua autonomia come lo ha la letteratura, tuttavia può essere una fonte di osservazione antropologica e fornire una sua etnografia proprio perché regala il suo punto di vista. Così scrive Calvino: sono interessanti «i film da cui posso imparare o verificare determinate cose della vita (tipizzazioni, modi di rapporti umani, rapporti tra persona e ambiente, ecc.) che se non c’era il cinema a dirmele, non sarei riuscito a capire in altro modo» (in Palumbo 2012: 519).
Allora l’antropologia nella sua aspirazione a voler essere olistica diventa la sintesi in cui i diversi piani e punti di osservazione di una cultura si possono unificare. Tuttavia il rischio In quest’ottica è che spesso il mestiere dell’antropologo è caratterizzato da un eccesso di senso e di informazioni che possono far smarrire gli elementi significativi fino a banalizzarli con il rischio di perdere un’identità epistemologica. Ma l’antropologia “interpretativa” (Geertz 1995) e “riflessiva” (Bourdieu 1992) sfugge a questo rischio: osserva, raccoglie, rielabora e si confronta con tutto quanto può essere utile e realizza una etnografia complessa, risultato di una thick description (Geertz 1995).
La considerazione finale in questa premessa metodologica è che ciascun testo etnografico va al di là del quadro antropologico dentro il quale nasce e ad esso sopravvive, e che comunque la teoria antropologica è univoca, mentre il testo etnografico consente, come proverò a fare nelle pagine seguenti, una molteplicità di letture in cui sembra necessario il coinvolgimento e la complicità dello spettatore/lettore. Il commento dell’etnografo tallona il racconto, le singole scene e i gruppi di sequenze orientandone l’interpretazione dei significati ma queste stesse istantanee continuano ad avere una capacità di informazione e suggestione relativamente autonoma. Dunque, nonostante i nostri progressi come sociologi, antropologi, registi e analisti del comportamento, dobbiamo ancora dimostrare per dirla con Kenneth Burke: «come la cultura immagazzini quell’anarchia di motivi, che è forse l’essenza dell’esperienza umana» (Belmonte 1997: 19). Si tratta ancora una volta di un esercizio di antropologia interpretativa e riflessiva allo stesso tempo, si spera proficuo sia per l’antropologo sia per il regista.
Mettere a punto strumenti di indagine utili per riconoscere e descrivere Napoli, come questa città possa essere studiata, descritta, raccontata sia da chi ne vive e respira le perenni e affascinati contraddizioni, sia da chi ne viene coinvolto come osservatore esterno, non è impresa da poco. Si tratta per l’antropologia culturale di ripensare il rapporto tra emico ed etico insieme alla possibilità di definire materiali utili per interpretare la complessità delle culture nella post-modernità.
Definire Napoli anche dopo diversi anni di indagini e riflessioni è davvero impossibile e potrei provare a farlo a partire dalle parole di Thomas Belmonte (1997:19): «Amo Napoli perché sono molto newyorkese. C’è molto in comune tra questa città e la mia: un’energia esplosiva che con la stessa rapidità crea e distrugge uomini e cose. Lo spirito del luogo a Napoli è la forza vitale. È risoluto e appassionato, ma è anche inconsapevole e insensibile allo sprone della consapevolezza e della ragione, per questo, o ti respinge o ti ipnotizza» (Belmonte 1997: 21). A Napoli anche il fatto più banale può diventare un dramma. L’aspetto sociale della città ha sempre un che di istrionico, seppure, per le classi borghesi, velato di disincanto e di apparente distaccata ironia. I toni sono teatrali. «Se il dramma fu inventato come metafora della vita, a Napoli la metafora ha sopraffatto il referente, e la società si presenta con una serie infinita di commedie dentro le commedie. Se l’arte rischiara il cammino dell’etnografo l’esperienza etnografica si trasforma in arte di vivere» (Belmonte 1997: 45).
 Molte stagioni cinematografiche hanno avuto come protagonista la città, in particolare quella del neo-realismo: dal L’Oro di Napoli di De Sica (1954), a Le Quattro giornate di Napoli di Loy (1962), a Viaggio in Italia di Rossellini (1954) che dedica alcune scene finali del film alle processioni religiose e al senso del sacro. Negli ultimi anni la cinematografia italiana si è di nuovo rivolta a Napoli e ha avuto una singolare attenzione alla sua cultura, connotata da una transculturalità sempre più incisiva. Nelle pagine che seguono ho scelto di esaminare, utilizzando strumenti tipici dell’antropologia come quello di comparare in sinergia lo sguardo emico ed etico, la Napoli di Özpetek e quella di Sorrentino, su come l’hanno messa in scena, interpretata, raccontata.
Molte stagioni cinematografiche hanno avuto come protagonista la città, in particolare quella del neo-realismo: dal L’Oro di Napoli di De Sica (1954), a Le Quattro giornate di Napoli di Loy (1962), a Viaggio in Italia di Rossellini (1954) che dedica alcune scene finali del film alle processioni religiose e al senso del sacro. Negli ultimi anni la cinematografia italiana si è di nuovo rivolta a Napoli e ha avuto una singolare attenzione alla sua cultura, connotata da una transculturalità sempre più incisiva. Nelle pagine che seguono ho scelto di esaminare, utilizzando strumenti tipici dell’antropologia come quello di comparare in sinergia lo sguardo emico ed etico, la Napoli di Özpetek e quella di Sorrentino, su come l’hanno messa in scena, interpretata, raccontata.
Napoli velata (2017) di Özpetek ci restituisce una Napoli dionisiaca e apollinea in cui tutto è mistero nell’intreccio vita /morte con richiami agli elementi atavici delle sue profonde radici, attraverso una geografia della visione che seleziona e rielabora i luoghi e le suggestioni emotive e spaziali, così da svelare una città vista dagli occhi dell’osservatore esterno ─ come lo è Özpetek, con le sua identità transculturale turco/italiana, che osserva una cultura altra di cui è ormai parte dando una sua lettura che descrive noi napoletani (sono una napoletana). I protagonisti si muovono dentro orizzonti e luoghi che costruiscono una “psicogeografia” emozionale talvolta stereotipata, a volte straniante.
La Napoli di Sorrentino in È stata la mano di dio (2021) è una autobiografia, uno sguardo emico, dunque, in cui vengono descritti e vissuti miti vecchi e nuovi della napoletanità, come quello di Maradona, sistemi familiari, appartenenze a luoghi legati alla vita e all’infanzia del regista. Tragedia e commedia come in ogni tratto della cultura napoletana sono indissolubilmente connessi.
In entrambi i film emerge la convinzione che Napoli sia un universo di ambivalenze e contrasti che si coniugano in un equilibrio vitale impossibile da realizzare e che si può solo amare. Questa cinematografia richiama l’immagine ingombrante ed esaltante di un sogno che continua ma che non si realizzerà. Una definizione di Napoli come città complessa, ove la Babele dei segni e la varia congestione /commistione funzionale possono essere considerate risorse oltre che vincoli.
Attraverso questo esercizio di etnografia cinematografica, si definisce una dimensione glocale del sud dell’Italia che si connette ad una dimensione di dinamica rivisitazione di se stesso, confermando ancora una volta, attraverso i secoli, la dinamicità di questa città e l’attitudine alla proficua contaminazione che non ha mai smesso di ripensare e ricreare se stessa. Questo rende Napoli una città unica, di grande tolleranza e apertura: qualcuno l’ha definita «grande spugna mediterranea», la città porosa (Velardi 1992) che trattiene e poi emana il calore; una città che riesce a condensare, a contenere, a conciliare. In tutte le sue manifestazioni la napoletanità è ricca di ambivalenze, di apparenti polarizzazioni che in realtà realizzano impossibili integrazioni.
I due film regalano istantanee di quella cultura del Mediterraneo di cui Napoli è forse il crocevia più complesso, in cui, come diceva Nietzsche, c’è una irresistibile pienezza. In questo groviglio di sguardi incrociati sembrano emergere apparenti stereotipi: una confidenza sia con il senso della morte che con la gioia, nonché con il sacrificio e la festa. Dalla cinematografia dei due registi emergono forme del repertorio culturale napoletano che guardano al mondo globalizzato con la certezza che la cultura napoletana non può essere dissolta e assimilata, forme che sembrano voler ribadire che si tratta di un “luogo” aperto al mondo. Soprattutto, queste etnografie inconsapevoli ci restituiscono una geografia artistica che ci salva da ogni minaccia di logoro folklorismo. Per entrambi è una Napoli borghese che si rivela e si racconta dai toni a tratti discreti ma che espone le sue profonde radici, una dimensione meno esasperatamente legata ad un folklore stereotipato ma che tuttavia condivide e restituisce a pieno frammenti significativi della cultura popolare.
 Lo sguardo etico: la Napoli velata di Özpetek
Lo sguardo etico: la Napoli velata di Özpetek
Niente è come sembra a Napoli: il gusto della rappresentazione e della narrazione è esasperato, costante e teatrale, coinvolge sia gli osservatori che gli osservati invitati ad entrare in un gioco accattivante di reciprocità. L’occasione dell’incontro con Napoli per Özpetek nasce dal lavoro che gli viene offerto per la regia della Traviata al teatro San Carlo. Da quelle tre settimane di soggiorno a Napoli il regista scopre la città. Gli amici che lo accompagnano in questo incontro appartengono sostanzialmente alla borghesia e diventano veri e propri “mediatori” di questa esperienza. C’è un singolare rapporto tra le classi sociali a Napoli: tra i ceti “alti” e la “plebe” è sempre corsa una distanza abissale sul piano degli interessi specifici di classe cui corrispondeva e corrisponde una straordinaria vicinanza su altri piani di appartenenze strettamente culturali. Un acuto osservatore come Pasolini notava qualche decennio fa: «A Napoli certe distinzioni di condizione sociale sono stilisticamente meno lecite che altrove, data l’unità psicologica che vi regna» (Pasolini 1973: 224). Questo continuum culturale si evince ancora una volta sia dalle scene dei film di Özpetek che di quelle di Sorrentino.
Özpetek ha avuto modo attraverso i suoi mediatori/amici di scoprire aspetti della città che non conosceva, rimanendo colpito in primis dalla somiglianza che lega Napoli a Istanbul, sua città natale: «sono simili per il sentimento delle persone e per il loro atteggiamento, poi entrambe hanno il mare. Ci sono legami strani.» In particolare, aggiungo, il mito di fondazione della città che ha a che fare con la sirena Partenope. Un mito legato alle creature mitologiche marine alla Sirena Partenope e al fallimento di una particolare tipologia di femminilità. La sirena si lascia morire sulla spiaggia dove nascerà la città, perché non è riuscita a sedurre Ulisse. Passione, vita, morte, femminilità si coniugano. Così come si armonizza una dimensione transculturale all’interno dell’identità plurima di Özpetek, frutto delle sue due culture e delle sue due città tra Occidente e Oriente lambite da un Mediterraneo che si insinua tra penisole ed isole, stretti attraversamenti come il Bosforo. Il regista, turco naturalizzato italiano, ha raccontato il suo rapporto con Napoli e con Istanbul: la prima è una città scoperta e vissuta come una “Napoli velata”; l’altra è la sua città natale, una Istanbul che diventa, “Rosso Istanbul”.
Il regista riconosce e intuisce tutto questo, lo respira e ne resta colpito. Soprattutto dal singolare e creativo forte senso di morte che aleggia a Napoli, «ma i napoletani ci giocano e la fanno diventare una cosa di cui non avere paura» ha affermato. Per questo motivo ha deciso di ambientarci un film a tinte noir ma, come ha dichiarato, volendosi radicalmente distaccare dalle rappresentazioni stile Gomorra della città. «Ho conosciuto molte persone, alcune in particolare mi hanno fatto scoprire aspetti della città che non conoscevo, ogni angolo custodisce pezzi di storia, aneddoti, dettagli. Tutto si mescola, l’attualità e i ricordi antichi. La miseria accanto alla nobiltà dei palazzi storici. Il maschile e il femminile». In queste affermazioni emergono le scelte interpretative della cultura che Özpetek incontra.
Gli interni del suo film sono legati a palazzi storici abitati trasversalmente dalle diverse classi sociali, che hanno reso possibile nel tempo una trasmissione continua della cultura popolare ai ceti nobiliari prima e dell’alta borghesia poi, una sorta di reciprocità continua che ha prodotto e continua a produrre, come lo stesso film testimonia, forme di condivisione di simboli, valori, orizzonti di senso, per cui si realizza una «circolarità» culturale tra le diverse classi sociali (Scafoglio 1989) e una rivitalizzazione continua della stessa cultura popolare. Non è un caso la scelta di appartamenti vissuti e utilizzati quotidianamente, non ci sono allestimenti cinematografici ma scene di vita quotidiana, seppure gli interni sono arredati in una densità barocca che in un raffinato gioco di chiaro-scuri ripropongono il tema e il filo conduttore della densa e complessa trama vita/morte. Un noir in cui la professione della protagonista (è un medico legale) resta significativamente legata a questa dicotomia. Ma niente a Napoli è come appare.
 La città che si svela tra miti, riti, luoghi
La città che si svela tra miti, riti, luoghi
Le prime inquadrature sono dedicate ad una scala particolare di uno dei palazzi storici Palazzo Mannajuolo che è un monumento al liberty partenopeo una scala elicoidale ardita nella sua forma e che indica una sorta di infinito, uno svolgersi e riavvolgersi del tempo come avviene solo a Napoli.
Una delle scene successive del film è legata a questa condivisione trasversale degli elementi più atavici della città. Si coniuga la Napoli moderna e i riti antichissimi, come quello della “Figliata” dei femminielli a cui ha assistito lo stesso regista e nel quale è racchiuso, in parte, il senso del film. Durante la messinscena, che si svolge proprio nel salotto borghese si alza un telo semitrasparente (così come vuole la tradizione) perché la verità non va guardata in faccia nuda e cruda ma come dirà uno dei femminielli [1]: «la devi sentire, intuire rappresentare».
Nel femminiello la teatralizzazione e l’acquisizione del ruolo determinano una sorta di schismogenesi (Beatson 2022) individuale nella quale si ironizza, si drammatizza il comportamento sociale e sessuale del maschile e del femminile in una omeostasi che talvolta è strabiliante e che magicamente attiva processi di integrazione di una identità altrimenti impossibile. Complementarità e simmetria si coniugano attraverso questa continua interpretazione e inversione dei ruoli, anche se la scelta del partner per il femminiello è rigidamente quella di un maschio eterosessuale verso il quale si elabora una forma singolare di amore e di dinamica di coppia. La dimensione più condivisa del femminile nasce, ancestralmente, da uno scacco seduttivo (vedi Partenope) che mette in crisi il potere sessuale della femminilità a vantaggio della verginità e della maternità. In questo senso il femminello reintegra nella diversità questi due elementi, ribadendo la sconfitta ma rinnovando elementi passionali e trasgressivi che vengono contestualizzati. Il femminiello ama come e più di una donna, ha modalità sessuali femminili, la sua passione è spesso destinata a fallire perché non ha il potere della maternità e della purezza che sono gli elementi di forza del matricentrismo meridionale.
Napoli ha ritualizzato la diversità attraverso i femminielli, identità costruita non per semplici opposizioni, ma per trasgressione del sesso attraverso il genere, insieme ad una costruzione sociale che produce integrazione. Tanto è vero che i femminielli hanno matrimoni, battesimi, tutta una serie di riti nella loro vita sociale a cui partecipano tutti gli altri del quartiere, del vicolo ancora oggi. I femminielli accudivano e accudiscono i neonati, i figli delle donne a loro affidati perché essi hanno un proprio codice etico che è quello del rispetto dell’infanzia, senza fantasie pedofile. Le madri si fidano di lasciare in accudimento temporaneo i loro figli rafforzando e stabilendo paradossali alleanze per riaffermare il forte matricentrismo napoletano. Dopo nove mesi, come in un qualsiasi buon matrimonio nasce il figlio – che è sempre maschio – e il parto diventa una rappresentazione rituale che avviene all’interno di una casa (Di Nuzzo 2017). In questa particolare coppia omosessuale, quello che ha interpretato il ruolo della sposa finge di avere il ventre gonfio e si procede al noto rito della figliata nel quale il femminiello mette in scena tutte le fasi di un parto: ha il ventre gonfio, si riposa sul letto e partorisce un figlio maschio (paradosso più forte), che in genere è un fantoccio di legno dalla dimensione di un neonato con un grosso fallo per sottolineare il sesso maschile e la sua forza.
Özpetek in pochi fotogrammi (ambienta la scena nel salotto borghese) sottolinea la forza metastorica del rito che attraversa i secoli, sottolinea la forte connotazione del travestitismo esasperato che rende palpabile l’eccesso e la costruzione sociale teatralizzata di un genere non inscritto nel sesso definito dal corpo ma pur sempre possibile condivisibile nell’orizzonte simbolico dell’integrazione della diversità. Napoli non è solo camorra ma un luogo abitato da persone curiose, cittadini consapevoli e disincantati, una città in cui convivono i contrasti più stridenti e in cui le stratificazioni del tempo sono visibili e si possono vivere e attraversare. Il viaggio di Özpetek in questa città attraversa queste complesse stratificazioni. Le inquadrature di Piazza del Gesù ci dicono di una Napoli che svela la sua storia, i suoi luoghi sacri che hanno a che fare però, come in altri momenti del film, con il mistero di una religiosità complessa, fatta anche di possessioni benigne e di Sibille popolari. Donne segnate da poteri extraumani, incarnazioni di spiriti buoni.
Özpetek non si lascia sfuggire questo rapporto con la divinazione e la guarigione sia di disagi psicofisici sia esistenziali nella scena della Sibilla. Molte sono ancora in area campana le guaritrici che attraverso “rimedi altri” configurano la possibilità di essere guide di riferimento per una comunità angustiata da momenti di scompenso anche individuali, come nel caso della nostra protagonista. Donne guaritrici che spesso sono all’interno di una vera genealogia di guide spirituali carismatiche al femminile (Di Nuzzo 2019). Il “dono”, come lo si definisce, viene tramesso dopo un lungo periodo di apprendistato, sempre attraverso altre figure femminili che a loro volta hanno poteri sciamanici e sono avvezze a gestire incorporazioni benigne di anime perse, segnali di una forma di religiosità fatta di assertività e cura della comunità. Un susseguirsi di trasmissioni di poteri spirituali in linea femminile con funzioni di guida del gruppo e delle comunità, rivolti a soddisfare richieste e bisogni d’ordine immediatamente mondano, cioè salute, benessere, fertilità, successo, vitalità. Sono “religioni di guarigioni” (Di Nuzzo 2022) in cui l’incorporazione delle anime perse e dunque dell’adorcismo [2] ha un posto fondamentale. Un percorso di visioni, sogni, voci di entità divine che diventano il fattore di legittimazione del loro prestigio. Culti pre-cristiani e forme di religiosità popolare cattolica si fondono, confondono si sincretizzano, e non è strano che la borghesia colta si rivolga a queste forme rituali per liberarsi da uno spirito che tormenta, come per la protagonista del film, per una sorta di liberazione esorcistica. Ancora una volta a Napoli niente è come sembra.
 La divinazione e il controllo del futuro sono declinati anche attraverso il gioco, il rischio, l’azzardo. In un altro momento corale del film viene rappresentata la “tombola vaiassa” ambientata nel chiostro di San Martino. Ancora una volta sacro e profano si uniscono in questo gioco/rito, vi coagulano i motivi della divinazione, del rischio, del caso e della fortuna in cui i numeri sono gli elementi di una particolare grammatica che interpreta il mondo. Il gioco della tombola [3] si coniuga nella cultura popolare alla cabala che a Napoli diventa La smorfia e definisce uno specifico linguaggio dei numeri. L’ordine del mondo e la sua lettura slittano in una trasposizione popolare di corrispondenze che hanno a che fare con antichissime possibili ascendenze pitagoriche.
La divinazione e il controllo del futuro sono declinati anche attraverso il gioco, il rischio, l’azzardo. In un altro momento corale del film viene rappresentata la “tombola vaiassa” ambientata nel chiostro di San Martino. Ancora una volta sacro e profano si uniscono in questo gioco/rito, vi coagulano i motivi della divinazione, del rischio, del caso e della fortuna in cui i numeri sono gli elementi di una particolare grammatica che interpreta il mondo. Il gioco della tombola [3] si coniuga nella cultura popolare alla cabala che a Napoli diventa La smorfia e definisce uno specifico linguaggio dei numeri. L’ordine del mondo e la sua lettura slittano in una trasposizione popolare di corrispondenze che hanno a che fare con antichissime possibili ascendenze pitagoriche.
La smorfia è protagonista oltre che della tombola anche del gioco del lotto [4], ritenuto il gioco per antonomasia dei napoletani in cui è presente il desiderio del rischio stocastico, del poter vincere la miseria e la povertà con un colpo di fortuna. Il mistero della divinazione e del voler entrare in contatto con poteri extraumani e divini sono gli elementi di una strategia della speranza di poter governare il futuro e di ricevere i numeri giusti per lo più attraverso i sogni. Una complessa costruzione culturale che resiste alle contraddizioni empiriche, perché i suoi scopi vanno aldilà dei risultati materiali del gioco. Vari sono i modi per conoscere i numeri giusti e per interpretare correttamente il rapporto tra sogni, realtà e corrispondenza con i numeri che la smorfia traduce insieme ad altri “intermediari”, come per esempio i femminielli, protagonisti anche della tombola. Per giocare bisogna mediante riti e preghiere rivolgersi sia agli intermediari sia a potenze soprannaturali che conoscono il futuro (e quindi anche il futuro dei numeri) e lo possono comunicare ai loro devoti. Sono molte le categorie a cui si ci può rivolgere: i santi, i morti e una serie di figure extraumane come il monacello.
Özpetek riconosce le stratificazioni e la complessità degli elementi in gioco, e offre fino alla fine del film un ricco caleidoscopio in cui ci si può smarrire e che a tratti diventa superficiale. Così la “stanza segreta” del museo archeologico si ricollega alla potente energia erotica, carnale, enigmatica, dionisiaca, della città attraverso i dipinti dell’antica Pompei in una morbosa e singolare fruizione del patrimonio archeologico. Intanto la città borghese, colta e illuministica continua ad incontrare il mistero e le sue diverse forme culturali. Si susseguono altri luoghi simbolo, come la farmacia degli incurabili e la cappella San Severo in cui avviene l’epilogo del racconto. La sala della farmacia nella quale si viene catapultati nel film è un’esplosione di maioliche – circa 400 – e scaffali in legno dagli intagli dorati, col pavimento in maiolica e la tela del Bardellino che decora il soffitto, rappresentante Macaone che cura Menelao ferito (1750). Qui arte, scienza e mistero si incontrano nella massima espressione del barocco rococò. In questa stessa stanza, che è poi quella che ci è concesso vedere meglio in Napoli Velata, è esposto l’Utero Velato: un grande utero verginale su cui si sofferma la scena del film, che domina l’intera sala, sezionato come per un taglio cesareo longitudinale.
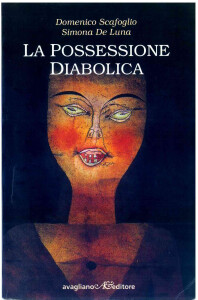 Özpetek passa dal ventre fittizio e teatralizzato dei femminielli al ventre virginale e gelidamente sezionato della farmacia. Tra questi due momenti scorre nelle immagini del suo film la cultura e la vita della città. Il personaggio di Pasquale tesse i legami tra le diverse contraddizioni della cultura napoletana. Il punto più esaltante e conclusivo di questa sinergia è sicuramente la cappella del Principe di San Severo in cui si trova il Cristo Velato, una delle opere più suggestive e affascinanti dell’arte napoletana, scolpita nel 1753 da Giuseppe Sanmartino. Il velo, anziché occultare la sofferenza di Gesù, la mette in mostra grazie al movimento della stoffa scolpita con impeccabile sapienza; nelle morbidezze della coltre si radunano il tormento e la misericordia della crocifissione. La statua, che appare in una delle scene conclusive di Napoli Velata, è posizionata nella navata centrale della chiesa sconsacrata di San Severo che ci restituisce un velo che non nasconde ma svela. Svela anche la complessa personalità del principe mago alchimista e studioso dell’anatomia umana, protagonista di racconti popolari tra crudeltà e passioni.
Özpetek passa dal ventre fittizio e teatralizzato dei femminielli al ventre virginale e gelidamente sezionato della farmacia. Tra questi due momenti scorre nelle immagini del suo film la cultura e la vita della città. Il personaggio di Pasquale tesse i legami tra le diverse contraddizioni della cultura napoletana. Il punto più esaltante e conclusivo di questa sinergia è sicuramente la cappella del Principe di San Severo in cui si trova il Cristo Velato, una delle opere più suggestive e affascinanti dell’arte napoletana, scolpita nel 1753 da Giuseppe Sanmartino. Il velo, anziché occultare la sofferenza di Gesù, la mette in mostra grazie al movimento della stoffa scolpita con impeccabile sapienza; nelle morbidezze della coltre si radunano il tormento e la misericordia della crocifissione. La statua, che appare in una delle scene conclusive di Napoli Velata, è posizionata nella navata centrale della chiesa sconsacrata di San Severo che ci restituisce un velo che non nasconde ma svela. Svela anche la complessa personalità del principe mago alchimista e studioso dell’anatomia umana, protagonista di racconti popolari tra crudeltà e passioni.
Le riprese del film e la sceneggiatura del regista sono dunque una sorta di diario sul campo che offre la possibilità di interagire tra lettura antropologica ed etnografia visiva e sonora. La musica, il rumore, il frastuono, le voci sono nel corpo della città. Seguendo la sua dinamica tra luoghi e storie emerge la cultura napoletana che consegna allo spettatore ma anche all’etnologo una mappa precisa e densa. In questa radicale contrapposizione i rimedi della cultura colta e popolare si intrecciano attraverso la visione borghese che più che mai è cultura anfibia che attraversa il tempo e lo spazio come la macchina da presa del regista. Emerge una città “femmina” caratterizzata da quel matricentrismo descritto da Thomas Belmonte (1997: 108) dove mito, seduzione, dolente rassegnazione, energia vulcanica (che solo chi vive sotto un vulcano conosce) e disincanto si coniugano dentro i suoi miti e racconti così come dentro le sceneggiature e le immagini.
“Napoli è femmina” conferma il regista e ne è la prova tutta la stesura della sceneggiatura, in cui sono protagoniste le diverse polimorfe figure femminili con il richiamo a forme di maternità compresa quella del femminiello. Dentro questo grande e onnicomprensivo ventre materno c’è sapere alchemico e magico ma anche altro, la smorfia, i numeri, e gli oggetti apotropaici come l’occhio portafortuna passato di mano tra i vari personaggi fino a tornare misteriosamente nelle mani della protagonista. L’occhio-amuleto che la protagonista del film conserva gelosamente come ricordo del padre, è sicuramente metafora dello sguardo del regista ma rappresenta anche la continuità e la vitalità di tutta la cultura napoletana. Quella cultura che si definisce dell’invidia (Scafoglio, De Luna 1999) che opera attraverso “il fascino” ovvero l’influenza che esercitano alcune persone su altre per lo più senza saperlo e/o volerlo attraverso lo sguardo in cui affascinatori e affascinati si contendono i poteri. Lo sguardo e dunque l’occhio, in tutta la cultura del fascino, è l’arma seducente che ha potere distruttivo e propositivo ma è anche, nel nostro caso, lo sguardo della macchina da presa, lo sguardo dell’autore. Forse Napoli è come la protagonista del film: si abbandona agli eventi, perde lucidità ma poi acquista consapevolezza di ciò che è della sua bellezza, del suo fascino e si distende serena ad affrontare la sua storia e a vivere le sue energie lasciando al fondo il suo mistero.
 Lo sguardo emico: È stata la mano di Dio. La Napoli di Sorrentino
Lo sguardo emico: È stata la mano di Dio. La Napoli di Sorrentino
Nel film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio realizzato nel 2021, siamo di fronte alla Napoli raccontata da un napoletano. Una etnografia inconsapevole dettata, a voler utilizzate le chiavi interpretative antropologiche, dallo sguardo emico ossia da chi è parte della cultura che descrive. Il filo conduttore che ci consente immediatamente di essere accompagnati in questo viaggio all’interno del modo napoletano, è l’elemento costitutivo del paesaggio che attraversa gran parte delle scene del film: il mare. Il film si apre con l’inquadratura dall’alto del mare del golfo di Napoli. Il mare che ritorna ossessivamente in molte scene, fatto di gite in gozzo, di bagni, di tuffi. Un mare che è orizzonte e speranza («tu non hai un dolore, hai una speranza», grida uno dei personaggi al giovane Fabio Schisa, alter ego sorrentiniano nel film). Il mare che è Napoli stessa che racconta la città e le mille storie che contiene, oltre che la storia di formazione di Fabio/ Paolo Sorrentino.
Siamo di fronte ad un racconto cinematografico di formazione, una storia di vita, una particolare forma di autobiografia. In questa Napoli della fine degli anni 80 più che il mistero, più volte richiamato da Özpetek, c’è la follia, il riso, la malinconia, il dolore e su tutto la famiglia meridionale della media borghesia che conserva i tratti specifici del legame rituale con il cibo, con forme di eccesso emotivo e di teatralità dei sentimenti come il dolore, come l’amore. È la sua Napoli segnata, come sottolinea il regista, da conflitti esasperati che sono prove di rituali di passaggio e di iniziazione alle diverse fasi della vita in cui c’è ancora una volta un profondo rapporto con la morte e l’elaborazione drammatica di un lutto.
La quantità di dettagli e sfumature messi in scena nel film è ipertrofica. Sorrentino racconta le case napoletane, il loro arredamento, i ninnoli, i soprammobili. Si susseguono in questa galleria visiva il barocco borbonico della casa della baronessa Focale, il minimalismo borghese e un po’ kitsch della famiglia del protagonista, il modernismo anni Ottanta di casa di zia Patrizia. Non più i palazzi del centro storico come per Napoli Velata ma i quartieri e i parchi condominiali della Napoli del Vomero, costruiti dopo la Seconda guerra mondiale in cui però si ritrovano residui di nobiltà decaduta, borghesia colta e una parentela enormemente estesa. Un familismo meridionale con tutte le nuove e antiche contraddizioni che ripropone il legame con il cibo, le tavolate di famiglia, i pentoloni di sugo di pomodoro, il rito alimentare legato all’estate che coinvolgeva tutte le generazioni per la preparazione delle bottiglie di passata di pomodori fatte in casa, riempite da tutti i componenti della famiglia a seconda dell’età e del sesso. Ricordi e modalità del condividere che appartengono a tutti i meridionali.
Sullo sfondo le violente liti di zia Patrizia con il marito, la sua follia, la sua prepotente carica erotica. Si intravede con discrezione significativa il legame della Napoli borghese con l’altra Napoli, con la Napoli dell’illecito che in quegli anni era il contrabbando delle sigarette rappresentato con le scene dei velocissimi motoscafi dei contrabbandieri che solcano le acque del golfo ma anche attraverso l’amicizia di Fabio con il contrabbandiere Armando, che lo porterà a scoprire il sottobosco della delinquenza napoletana. Sorrentino si confronta col suo passato attraverso la sua città, riletta e rivista attraverso l’occhio del cinema, così come Fellini fece con la sua Rimini in Amarcord.
Sono luoghi dell’anima e della memoria che diventano i segni e i simboli di una cultura che gli offre il modo di superare una fase della sua vita, che gli consente di elaborare il lutto per la perdita dei suoi genitori in un incidente domestico (esalazioni di gas). Lo sguardo emico di Sorrentino restituisce la sua storia, la sua appartenenza che è poi la storia della cultura stessa della città un esercizio di esorcismo per ricomporre il drammatico scontro vita/morte. C’è il desiderio di consolidare il legame tra umano e extraumano, tra sacro e profano. Un tratto potente della cultura meridionale, una forma di religiosità dei napoletani che Sorrentino ci restituisce fino in fondo, che si percepisce in tutto il film e che assume un’ulteriore declinazione con il legame verso Maradona a partire dallo stesso titolo del film.
Una della prime scene dal sapore surreale, ripropone la presenza del monacello visto con disincanto e ironia ma con un tocco di partecipazione che, per dirla con Eduardo, si potrebbe riassumere così: «Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male». La versione borghese di questa vicenda è stata raccontata dalla scrittrice giornalista Matilde Serao (1880) che ne documenta la radicata e diffusa presenza a Napoli. Il Monacello è il frutto di un amore contrastato tra Catarinella, figlia di mercanti, e Stefano, giovane aristocratico. Durante un incontro amoroso Stefano è ucciso, e la donna impazzita dal dolore, è ricoverata in un convento dove partorisce. Il bambino rimane, con il passare degli anni, un essere minuto, e la madre, per farlo crescere, si vota alla Madonna e veste la sua creatura da piccolo monaco, bianco e nero. Il bambino resta un nanetto dalla testa enorme, il volto terreo e gli occhi grandi; la gente lo chiama per derisione “lu munaciello” e gli attribuisce poteri soprannaturali che può esercitare a suo piacimento nel bene e nel male. Poi improvvisamente svanisce nel nulla, secondo alcuni portato via dal diavolo, secondo altri ucciso dai parenti del padre. I napoletani sono convinti che si aggiri ancora nelle case della città, ormai puro spirito, capace di fare il bene e il male, di premiare o di vendicarsi. Ha molti poteri: può far trovare soldi e tesori, può picchiare e tormentare, può dare i numeri giusti per giocare al lotto. Per zia Patrizia, nella scena del film è un “intermediario” insieme a San Gennaro che può, nella sua follia visionaria, restituirle la fertilità.
Ma Sorrentino, se attinge alla tradizione e alle antiche ritualità sacre per dare sostanza e forma alla costruzione di uno dei miti fondativi della vita della città e del suo pantheon, è anche testimone, acuto interprete e artefice di nuove mitografie e forme di religiosità come per Maradona. C’è in questo senso un continuum tra tradizione e riplasmazione della stessa. Il mito di Maradona e la sua divinizzazione sono inscritti nelle vicende della città; i napoletani lo hanno reso eterno senza essere né blasfemi né folkloristici. Napoli lo ha divinizzato perché rappresenta uno scacco alla sconfitta; è l’eroe sportivo che come per l’antica Grecia onora gli dèi e viene assunto all’Olimpo; è il rovesciamento della sorte e del rapporto vita/morte. La vicenda personale di Sorrentino lo ratifica. Il giovane Fabietto non ha subìto la stessa sorte dei genitori con cui doveva essere nella casa in montagna, solo perché la sua devozione /fede verso Maradona (doveva seguire la partita Napoli-Empoli), lo ha salvato dal suo destino e ha rovesciato il rapporto vita /morte. Significativo il breve dialogo tra lo zio Alfredo e il protagonista:
Alfredo: Come mai non eri a Roccaraso? A te piace sciare.
Fabietto: C’era il Napoli allo stadio. Dovevo vedere Maradona.
Alfredo: È stato lui! È stato lui che ti ha salvato.
Fabietto: Ma chi zio?
Alfredo: È stato lui! È stata la mano di Dio!
In queste poche battute si riassume la relazione dei napoletani con il divino e il sacro, il modo popolare in cui la divinità è persona, è confidenza, è legame quotidiano e si finisce per parlargli a tu per tu, lo si incontra e ne si riconosce il tratto divino. Del resto, il titolo richiama questa particolare relazione a cui Maradona stesso fece riferimento in un suo famoso goal agli inglesi fatto con la mano, durante una partita del campionato del mondo del 1986. Ma non è la dimensione del calciatore che il film evoca, è piuttosto il simbolo e l’incarnazione di un universo culturale che ha reso possibile oggi l’esistenza nei quartieri spagnoli della città di un luogo che è diventato un altare laico e celebrativo a cui migliaia di napoletani, e non, vanno a fare visita. Precisa Sorrentino: «A me piace moltissimo questo aspetto perché è una mescola di sacro e profano che poi nel caso di Maradona neanche tanto profano perché Maradona in realtà si può comprenderlo solo attraverso il rapporto con il divino è una figura che ha a che fare con il divino, Maradona non è arrivato a Napoli, è apparso» (Netflix Italia 2022).
Quella Napoli dalla quale, come dice ancora il personaggio Antonio Capuano a Fabio, «nessuno se ne va mai davvero. Tantomeno quelli che sono andati a Roma: “i strunz”». Invece per Fabio, lasciare Napoli, certi luoghi, certi ricordi, la città in cui si è sentito abbandonato, significa la possibilità di continuare a sognare. Alla fine anche Fabietto incontrerà il monacello quando comprende di non poter più resistere al dolore della perdita dei genitori e decide quindi di tener fede al proposito di recarsi a Roma: lungo il tragitto in treno, in una stazione desolata, vede apparire un munaciello, che lo saluta con lo stesso fischio adoperato dai genitori per esprimere affetto reciproco e ai figli. Quello stesso munaciello che era apparso a sua zia Patrizia e di cui lui solo aveva pensato possibile l’esistenza.
 È stata la mano di Dio è anche e soprattutto la possibilità di una cultura di lasciare lo spazio al sogno e allo stesso tempo al disincanto. In un altro momento del film Sorrentino fa dire al suo protagonista la funzione e il ruolo del cinema nei confronti del reale: «La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Ecco perché voglio fare il cinema». In una delle interviste rilasciate dopo l’uscita del film Sorrentino ribadisce: « Far parlare la verità è il punto di partenza per tutti i racconti, però la verità va reinventata, il modo con cui i napoletani lo fanno è molto divertente e questo sicuramente l’ho rubato ai napoletani. É molto utile vivere qua se si vuole raccontare delle storie; rubo quello che vedo senza sapere bene che cosa sono, questo è stato un primo approccio con l’invenzione del racconto» (Netflix Italia 2022).
È stata la mano di Dio è anche e soprattutto la possibilità di una cultura di lasciare lo spazio al sogno e allo stesso tempo al disincanto. In un altro momento del film Sorrentino fa dire al suo protagonista la funzione e il ruolo del cinema nei confronti del reale: «La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Ecco perché voglio fare il cinema». In una delle interviste rilasciate dopo l’uscita del film Sorrentino ribadisce: « Far parlare la verità è il punto di partenza per tutti i racconti, però la verità va reinventata, il modo con cui i napoletani lo fanno è molto divertente e questo sicuramente l’ho rubato ai napoletani. É molto utile vivere qua se si vuole raccontare delle storie; rubo quello che vedo senza sapere bene che cosa sono, questo è stato un primo approccio con l’invenzione del racconto» (Netflix Italia 2022).
Invenzione, realtà, etnografia inconsapevole tutto si integra. Il cinema ha il merito di non disunire, è la possibilità per il protagonista (ma poi per quanti altri nella realtà) di andare via dalla città ma di restare con lei e con il suo mondo, di poter rappresentare il salotto buono della città come la Galleria Umberto I e Piazzetta Serao, Piazza del Plebiscito, luoghi iconici del centro storico, come spazi della memoria e segni di un’appartenenza così come lo sono le anguste case dei quartieri spagnoli.
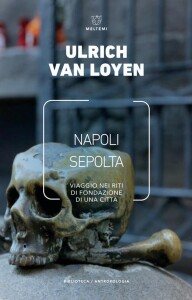 Queste contraddizioni sono i sintomi di quella complessità propositiva che è allora lo specifico più accattivante di questa «grande spugna distesa sul mare, che non affronta i suoi problemi attraverso macro-progetti, sulla base di una ratio logocentrica, che non riduce il complesso delle tensioni, dei conflitti, che non tende ad annullarli, bensì ad assimilarli e, quasi, a nutrirsene». Per Napoli si potrebbe allora concludere che «Last things before the last: si trovano a Napoli o nelle sue vicinanze le tombe di Virgilio e Leopardi, le grotte profetiche nei dintorni (l’antro della Sibilla cumana), l’ingresso a regno dei morti (il lago d’ Averno), la Camorra, i grandi e piccoli delinquenti, le sceneggiate napoletane rese celebri dal cinema, l’innata arguzia degli umiliati e offesi, la loro ironia fatalistica e l’illuminismo iperbolico, esercitato come fine a se stesso perché tanto non c’è verso di cambiare le cose. Lungo le strade, superficiali o sotterranee, all’ombra del Vesuvio, gli uomini inseguono i misteri della morte e della fertilità: ma dove c’è pericolo cresce /anche ciò che salva» (Van Loyen 2020: 9).
Queste contraddizioni sono i sintomi di quella complessità propositiva che è allora lo specifico più accattivante di questa «grande spugna distesa sul mare, che non affronta i suoi problemi attraverso macro-progetti, sulla base di una ratio logocentrica, che non riduce il complesso delle tensioni, dei conflitti, che non tende ad annullarli, bensì ad assimilarli e, quasi, a nutrirsene». Per Napoli si potrebbe allora concludere che «Last things before the last: si trovano a Napoli o nelle sue vicinanze le tombe di Virgilio e Leopardi, le grotte profetiche nei dintorni (l’antro della Sibilla cumana), l’ingresso a regno dei morti (il lago d’ Averno), la Camorra, i grandi e piccoli delinquenti, le sceneggiate napoletane rese celebri dal cinema, l’innata arguzia degli umiliati e offesi, la loro ironia fatalistica e l’illuminismo iperbolico, esercitato come fine a se stesso perché tanto non c’è verso di cambiare le cose. Lungo le strade, superficiali o sotterranee, all’ombra del Vesuvio, gli uomini inseguono i misteri della morte e della fertilità: ma dove c’è pericolo cresce /anche ciò che salva» (Van Loyen 2020: 9).
Napoli continua ad essere una delle porte di accesso di un Mediterraneo che è un continente liquido, una fossa circondata da gradini su cui sporgono le culture, un anfiteatro con lo scenario di pietra, tagliato una volta per tutte nella roccia come nelle tragedie greche e con il mare come sfondo (Morand 2007: 94). Una delle scene conclusive del film girata alla Piscina Mirabilis, di Bacoli sembra confermare tutto questo. Vestigia dell’antico passato si coniugano alla natura del luogo, che accoglie il mare che si insinua tra le grotte tufacee in quella eterna dialettica di apertura e chiusura di un luogo e di una cultura pervicacemente legata alle sue radici ma radicalmente aperta alle contaminazioni e alle trasformazioni.
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023
Note
[1] Il femminiello è una forma particolare di omosessualità legata alla tradizione popolare della cultura napoletana. Uomini nel corpo si travestono accuratamente da donne e interpretano il genere femminile in tutte le forme del quotidiano e delle relazioni sociali. Per approfondimenti: “Napoletanità e identità post-moderne. Riplasmazioni del femminiello a Napoli”, in Femminielli. Corpo, genere, cultura, Eugenio Zito e Paolo Valerio (a cura di), ed. Libreria Dante & Decartes, Napoli 2019: 149-184.
[2] Si definisce adorcismo l’incorporazione di uno spirito benevolo l’accettazione da parte del soggetto posseduto dall’entità extraumana.
[3] Gioco della tradizione italiana in particolare a Napoli diventa una forma di teatralizzazione vissuta da tutto il gruppo dei partecipanti. Chi dirige il gioco ha un “cartellone” in cui sono indicati i numeri da 1 a 90 e il suo compito è di estrarre da un piccolo paniere uno dei 90 numeri che sono all’interno. A ciascun giocatore viene data una cartella con un gruppo di numeri casuali vince chi per primo completa la cartella che ha ricevuto, ad ogni numero corrisponde a Napoli un significato ed una corrispondenza con fatti e persone e pertanto chi estrae i numeri si esprime secondo questo particolare linguaggio.
[4] Antico gioco d’azzardo. La nascita è incerta sembrerebbe intorno alla metà del Quattrocento. Si diffuse In Italia e in Francia; ricalca il gioco della tombola ma in questo caso è lo Stato che estrae ufficialmente e pubblicamente cinque numeri tra 1 e 90, con premio in denaro per coloro che ne indovinano almeno uno. I giocatori puntano anche su combinazioni di numeri, ad ogni grande città italiana corrisponde una “ruota da cui vengono estratti i numeri”. Per approfondimenti: D. Scafoglio, “Il lotto. Il gioco, la beneficenza e le strategie della speranza”, in Contesti culturali e scambi vernali nella Napoli contemporanea, Gentile, Salerno, 1989: 31-96.
Riferimenti bibliografici
Appadurai, Arjun (2001), Modernità in polvere, Meltemi: Roma.
Augè, Marc (1993), Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera: Milano.
Banks, Marcus and Morphy, Howard (1997), Rethinking visual anthropology, Yale University Press.
Belmonte, Thomas (1997), La fontana rotta. Vite napoletane, Meltemi: Roma
Bourdieu, Pierre (1992), Risposte. Antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri: Torino
Canevacci, Massimo (2001), Antropologia del cinema, Feltrinelli: Milano.
Di Nuzzo, Annalisa (2017), ‘Neapolitan social-transgenderism: the discourse of Valentina OK in Naples’, in Baker, P. and Balirano, G. (eds.), Queering Masculinities in Language and Culture, Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
Di Nuzzo, Annalisa (2018), ‘Napoli allo specchio. Itinerari napoletani tra etnografia, letteratura e riflessioni antropologiche’, in Etnoantropologia Rivista SIAC (Società italiana di antropologia culturale), 6(2): 31-44
Di Nuzzo, Annalisa (2019), “Napoletanità e identità post-moderne. Riplasmazioni del femminiello a Napoli”, in Zito, Eugenio and Paolo Valerio (eds), Femminielli. Corpo, genere, cultura, Libreria Dante &Decartes,: Napoli: 149-184.
Di Nuzzo, Annalisa (2022), “Napoli tra utopie, eterotopie, rinascenze”, in Dialoghi Mediterranei, 55: 35-53
Fofi, Goffredo, Morandini, Morando, Volpi, Gianni (1988), Storia del cinema. Dalle “Nouvelles vagues” ai nostri giorni, vol. 1, Garzanti: Milano.
Gardner, Robert (1986), “The fiction of non-fiction film”, in Cilect Review, 1: 23-24.
Geertz, Clifford (1988), Interpretazione di culture, Il Mulino: Bologna
Hockings, Paul (2003), Principles of visual anthropology, New York: Mouton De Gruyter.
Hughes-Freeland, Felicia (1997), “Balinese on television: Representation and response”, in Banks, M. and Morphy, H. (eds.), Rethinking visual anthropology, New Haven-London, pp. 120-138.
Martinez, Dolores. (1997), “Burlesquin knowledge: Japanese quiz shows and models of knowledge”, in Banks, M. and Morphy, H. (eds.), Rethinking visual anthropology, New Haven-London: 105-119.
Mead, Margaret and Métraux, Rhoda (2022),’The study of culture at a distance’, in Socio-Anthropologie, 45: 281-296.
Morand, Pierre (2007), “Méditerranée Mer des surprises” cited in Guarracino, S., Mediterraneo. Immagini, storie e teorie da Omero a Braudel, Bruno Mondadori: Milano.
Netflix Italia (2022), È stata la mano di Dio: attraverso gli occhi di Sorrentino [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VhNOsA1wBns
Palumbo, Matteo Angelo (2012), “Quell’altro mondo che era il mondo”. Calvino e il cinema, in “Italies”,16: 519 -517
Pasolini, Pier Paolo (1973), Passione e ideologia, Garzanti: Milano.
Pasolini, Pier Paolo (1975), Scritti corsari, Garzanti: Milano
Scafoglio, Domenico (1989), Contesti culturali e scambi verbali nella Napoli contemporanea, Gentile: Salerno.
Scafoglio, Domenico (2000), Numeri. Il gioco del lotto a Napoli, Ed. Ancora del Mediterraneo: Napoli.
Scafoglio, Domenico e Simona De Luna (1999), La cultura dell’invidia. Il malocchio e la iettatura nell’Italia meridionale, Gentile: Salerno
Serao, Matilde (ed.or.1880), Leggende metropolitane, Gazzetta di Napoli: Napoli
Van Loyen, Ulrich (2020), Napoli sepolta. Viaggio nei riti di fondazione di una città, Meltemi: Milano.
Velardi, Claudio (1992), La città porosa. Conversazioni su Napoli, Cronopio: Napoli.
_____________________________________________________________
Annalisa Di Nuzzo, docente di Antropologia culturale, insegna Geografia delle lingue e delle migrazioni al Suor Orsola Benincasa; già professore a contratto di Antropologia culturale presso DISUFF Università di Salerno, e membro del Laboratorio antropologico per la comunicazione interculturale della stessa università fino al 2020- Ha conseguito il PhD in Antropologia culturale, processi migratori e diritti umani. È membro dell’Osservatorio Memoria storica, Intercultura, Diritti Umani e Sviluppo Sostenibile “MInDS” Univ. di Cassino, socia del Centro di Ricerca Interuniversitario I_LAND (Identity, Language and Diversity) nonché del Centro Interuniversitario di Studi e ricerche sulla storia delle paste alimentari in Italia (CISPAI). I suoi campi d’indagine sono l’antropologia delle migrazioni e del turismo, antropologia e letteratura, antropologia e genere, antropologia urbana. È autrice di numerose monografie, tra le ultime pubblicazioni si segnalano: Il mare, la torre, le alici: il caso Cetara. Una comunità mediterranea tra ricostruzione della memoria, percorsi migratori e turismo sostenibile, Roma Studium 2014; Fuori da casa. Migrazioni di minori non accompagnati, Carocci, Roma, 2013; Conversioni all’Islam all’ombra del Vesuvio, CISU, Roma, 2020; Minori Migranti. Nuove identità transculturali, Carocci, Roma, 2020.
______________________________________________________________












