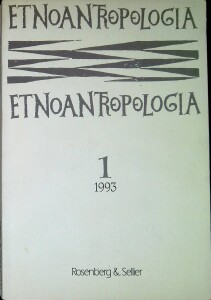Riviste scientifiche e riviste scientifiche di fascia A svolgono un ruolo indubbiamente prezioso, quello di rendere interconnessa una comunità di ricercatori, una platea di soci quando la testata sia più specifica espressione di un sodalizio accademico e non, di un’associazione di studiosi. Funzione precipua di codeste riviste è in prima istanza la circolazione di idee, la condivisione di tematiche, il confronto di posizioni sia convergenti che critiche, l’aggiornamento.
Il progressivo spostamento di siffatta editoria sulla rete, abbandonando la pur fascinosa veste cartacea, sta ovviamente potenziando le menzionate funzioni. Se pur l’impostazione e il confezionamento di un numero è pur sempre procedura complessa che richiede i suoi debiti tempi, è altrettanto indubbio che la veste digitale incrementa le facoltà di queste riviste. Si pensi soltanto all’immediatezza della consultazione, al recupero mediante parole chiave di contenuti presenti in differenti numeri, in uscite recenti come pure di anni precedenti. Più prosaicamente anche solo il fisico costo di una edizione digitale appare significativamente più contenuto di una cartacea.
Tutti siamo a conoscenza delle frequenti “contrattazioni” tra autore ed editore nella determinazione del numero massimo di pagine in cui contenere un saggio o un libro a stampa, quando, appunto, cartaceo. Pur avendo un costo anche l’impaginazione digitale, virtualmente, una rivista ricollocatasi sulla rete può accogliere senza gravi oneri un numero cospicuo di contributi, sezione monografiche decisamente corpose e pure saggi dotati di documentazioni visive. Su questo ultimo aspetto ci soffermeremo più avanti, appuntando la nostra attenzione proprio sulle opportunità di concepire contributi non solo scritti ma anche iconografici da organizzare non secondo criteri spesso aleatori, ma maggiormente cogenti e strutturati, in dialogo e non in subordine alla parola scritta.
Il retroterra accademico delle riviste, e, segnatamente per quanto ci riguarda di quelle antropologiche, la loro medesima antica storia, che dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Italia all’Inghilterra, alla Francia, alla Germania risale in diversi casi alla seconda metà dell’Ottocento ci dice di testate periodiche propedeutiche alla valutazione dello stato dell’arte, alla comunicazione sulle condizioni di avanzamento di ricerche e sperimentazioni di terreno, all’alimentazione di un dibattito teorico e dei suoi filoni, nazionali e internazionali.
Si tratta con molta frequenza di testate che sono espressione, ieri come oggi, di società scientifiche, con vocazioni ora maggiormente pluralistiche ora più di settore. Pubblicare su di esse è dipeso nel tempo da varie forme di controllo e valutazione delle proposte editoriali oggi formalizzate dal ricorso a schede di valutazione compilate da revisori anonimi dei saggi. In tutto questo, come è ovviamente inevitabile che sia, la parola, la scrittura hanno esercitato un ruolo assolutistico e dominante a garanzia della qualità dei contributi ammessi alla pubblicazione.
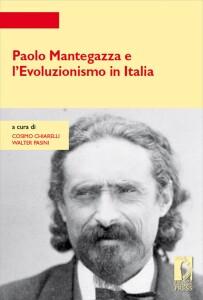 Nihil obstat, ma le cose cambiano. Si deve ricordare che l’antropologia e, a monte, l’etnografia hanno viaggiato su diversi binari: taccuini, diari, monografie ma parimenti osservazioni, descrizioni affidate anche alla macchina fotografica, poi alle cineprese, spesso e volentieri 16mm, alle telecamere, alle camcorder. L’istanza documentaria audio visuale è perciò nelle corde della ricerca antropologica da sempre o perlomeno da quando gli avanzamenti tecnici permisero il trasporto sul terreno delle prime macchine con lastre al collodio, delle cosiddette “campagnole” e quindi con Eastman degli apparecchi con pellicole avvolgibili. Volendo rimanere solo sul suolo nazionale da Mantegazza, a Modigliani, a Loria, a Pinna, de Martino e Mazzacane la storia della disciplina è costellata di ricerche spesso ampie e molto impegnative, tutte caratterizzate da una evidente e pregnante quota visiva che i ricercatori in modi e con strumenti differenti seppero però cogliere e far emergere (Baldi A. 1985, 2016a, 2016b; Chiarelli B. (eds) 1986; Dimpflmeir F. 2014; Faeta F. 1995: Faeta F., Ricci A. (eds) 1997; Mazzacane L. 1996; Ricci A. 2015.
Nihil obstat, ma le cose cambiano. Si deve ricordare che l’antropologia e, a monte, l’etnografia hanno viaggiato su diversi binari: taccuini, diari, monografie ma parimenti osservazioni, descrizioni affidate anche alla macchina fotografica, poi alle cineprese, spesso e volentieri 16mm, alle telecamere, alle camcorder. L’istanza documentaria audio visuale è perciò nelle corde della ricerca antropologica da sempre o perlomeno da quando gli avanzamenti tecnici permisero il trasporto sul terreno delle prime macchine con lastre al collodio, delle cosiddette “campagnole” e quindi con Eastman degli apparecchi con pellicole avvolgibili. Volendo rimanere solo sul suolo nazionale da Mantegazza, a Modigliani, a Loria, a Pinna, de Martino e Mazzacane la storia della disciplina è costellata di ricerche spesso ampie e molto impegnative, tutte caratterizzate da una evidente e pregnante quota visiva che i ricercatori in modi e con strumenti differenti seppero però cogliere e far emergere (Baldi A. 1985, 2016a, 2016b; Chiarelli B. (eds) 1986; Dimpflmeir F. 2014; Faeta F. 1995: Faeta F., Ricci A. (eds) 1997; Mazzacane L. 1996; Ricci A. 2015.
Ciò detto se le riviste hanno pure il compito di annusare l’aria, di prefigurare i tempi, accogliendo le suggestioni che possono derivare da giovani studiosi che proprio sulle riviste scientifiche cercano uno spazio e una visibilità per le proprie indagini, tale compito non sempre interpretano con lungimiranza. Le cose cambiano, dicevamo. Impressionanti sono le forme attraverso le quali oggi si determina la comunicazione sempre più spostata sulla rete e da essa influenzata e connotata innanzitutto sul piano visivo e audiovisivo. Nell’ambito del tema che qui stiamo sinteticamente affrontando, a nostro modesto modo di vedere, due parrebbero essere gli ambiti in cui la ricerca antropologica in primis e le riviste in secundis dovrebbero muoversi.
 Da un lato la disciplina dovrebbe attrezzarsi linguisticamente, concettualmente ma anche tecnicamente per imbastire e articolare una indagine in grado di muoversi e orientarsi sulla rete, investigandone i modi di comunicazione oramai fortemente integrati in termini di uso combinato di tecnologie e linguaggi digitali, di immagini frequentemente elaborate, di icone tridimensionali e di molto altro ancora. Esistono, in questa prospettiva, contributi incoraggianti che riflettono soprattutto sui modi in cui l’etnografia possa riformularsi così da cogliere, interpretare e analizzare i linguaggi della rete. Sono contributi nella gran parte dei casi recenti come recente è dunque codesta nuova frontiera.
Da un lato la disciplina dovrebbe attrezzarsi linguisticamente, concettualmente ma anche tecnicamente per imbastire e articolare una indagine in grado di muoversi e orientarsi sulla rete, investigandone i modi di comunicazione oramai fortemente integrati in termini di uso combinato di tecnologie e linguaggi digitali, di immagini frequentemente elaborate, di icone tridimensionali e di molto altro ancora. Esistono, in questa prospettiva, contributi incoraggianti che riflettono soprattutto sui modi in cui l’etnografia possa riformularsi così da cogliere, interpretare e analizzare i linguaggi della rete. Sono contributi nella gran parte dei casi recenti come recente è dunque codesta nuova frontiera.
Si riflette sulle relazioni in termini di campi di indagine, di metodo e di statuto tra l’antropologia visuale e un’antropologia in veste stricto sensu digitale, sulle ibridazioni indispensabili a una etnografia che pratichi la rete, applicandosi pure a studi di casi, dalla morte digitale, alla serendipità, a Facebook (Aouragh M. 2018; Baldi A. 2011, 2021; Beneito-Montagut R., Begueria A., Cassiá N. 2017; Biscaldi A. 2019; Biscaldi A., Matera V. 2019; Caliandro A. 2018; Dalsgaard S. 2016; Geismar H., Knox H. (eds.) 2021; Hine C. 2015; Horst H.A., Miller D. (eds) 2012; Matera E. (eds) 2020; Miller D., Costa E., Haynes N., McDonald T., Nicolescu R., Sinanan J., Spyer J., Venkatraman S., Wang X. 2018; Pink S., Horst H., Postill J., Hjorth L., Lewis T., Tacchi J. 2016; Przybylski L. 2020; Sisto D. 2018, 2020; Walton S. 2018).
Dall’altro le riviste, da par loro, dovrebbero congruentemente riconfigurarsi per adeguare la propria “offerta” scientifica a questi scenari oramai fortemente, oniricamente e simbolicamente intrinsecamente audiovisivi. Di concerto sarebbe auspicabile che le riviste, quale sensibile e ricettivo avamposto della conoscenza antropologica, accettassero ulteriori, diverse e obbligatoriamente audiovisuali modalità di restituzione di queste etnografie oramai digitali sulle loro “pagine”.
 Nonostante ciò, come più sopra si anticipava, quel che ci pare dunque in subordine è proprio il tipo di comunicazione che le riviste scientifiche continuano a praticare, saldamente in mano alla parola scritta. Non si contesta questo ma la mancanza di una correlativa apertura a una saggistica anche visiva e, stando sulla rete, anche audiovisiva mediante, ad esempio, l’attivazione di link, di contributi documentaristici, di brani di videointerviste raggiungibili mediante Qr code che arricchirebbero e modulerebbero una diffusione degli esiti delle indagini più simile a una navigazione ipertestuale.
Nonostante ciò, come più sopra si anticipava, quel che ci pare dunque in subordine è proprio il tipo di comunicazione che le riviste scientifiche continuano a praticare, saldamente in mano alla parola scritta. Non si contesta questo ma la mancanza di una correlativa apertura a una saggistica anche visiva e, stando sulla rete, anche audiovisiva mediante, ad esempio, l’attivazione di link, di contributi documentaristici, di brani di videointerviste raggiungibili mediante Qr code che arricchirebbero e modulerebbero una diffusione degli esiti delle indagini più simile a una navigazione ipertestuale.
Alquanto modesta è addirittura anche la sola presenza, sempre sulle riviste, di una saggistica che si appoggi a contributi fotografici che peraltro, quando presenti, secondo una logica tanto antica quanto poco significativa sul piano dei contenuti, si limita a un rosario di immagini ancillari rispetto al testo, in altre parole di più o meno mero “abbellimento” di quanto già espresso con la parola. Ecco allora saggi intervallati, qua e là, da qualche foto, o da sequenze debitamente finali, collocate in coda all’articolo e dopo la bibliografia. Si tratta di siparietti per lo più poco significativi, talora pleonastici.
Codesti pleonasmi derivano dal fatto che già a monte, nel corso della ricerca e quindi nella restituzione dei risultati, nel caso delle riviste – ma il discorso potrebbe essere esteso anche alle monografie – non si è riflettuto e non si riflette adeguatamente sul peso specifico delle immagini, sul loro valore euristico, sulla loro integrazione nel più ampio consesso delle metodiche e delle tecniche di rilevazione. Ciò dipende dal fatto che, nei fatti, non ci si interroga sullo specifico visivo e audiovisivo, sulla capacità di captazione e documentazione dell’immagine rispetto alla natura dell’oggetto di indagine. Se, per quanto attiene, alle tecniche classiche dell’indagine antropologica, ancorata a un privilegiato e prioritario rapporto con le fonti orali e con la scrittura, si è sovente inclini, e giustamente, a spaccare il capello in quattro, nulla di questo accade quando si transiti all’immagine e al suo coinvolgimento nella ricerca. Non esiste un’accurata metodologia che stigmatizzi ambiti e modalità tecniche ed euristiche della documentazione iconografica.
Capita, ad esempio, che la foto venga impiegata su terreni ove il suo contributo sia inutile, ridondante. Accade, all’opposto, che nel caso di temi ove l’intrinseca, evidente e preponderante natura visiva dell’oggetto di indagine esigerebbe il prioritario uso di apparecchi fotografici e di video ripresa, ci si dilunghi invece in una scrittura che per quanto efficace mai potrà articolare una descrizione sufficientemente densa ed esplicita dei fenomeni osservati.
 La formazione prevalentemente umanistica dell’antropologo non lo rende sufficientemente edotto di grammatica e sintassi fotografica e filmica, e ancor meno dell’attuale fecondo moltiplicarsi e differenziarsi dei linguaggi digitali che intersecano, secondo strategie spesso intriganti e feconde, grafica, cromatismi, testi, commentari, sequenze. Qui sottolineiamo l’importanza dell’uso consapevole del mezzo riproduttivo nella misura in cui la tecnica, mai neutra, ha ben precisi riverberi sui contenuti. Non ci si improvvisa nei ruoli di fotografi, operatori video, registi. Al contempo, nella restituzione dei risultati di una ricerca, nell’impaginazione di una monografia o di un saggio, non ci si improvvisa nei ruoli di redattori, progettisti del menabò, grafici e montatori digitali.
La formazione prevalentemente umanistica dell’antropologo non lo rende sufficientemente edotto di grammatica e sintassi fotografica e filmica, e ancor meno dell’attuale fecondo moltiplicarsi e differenziarsi dei linguaggi digitali che intersecano, secondo strategie spesso intriganti e feconde, grafica, cromatismi, testi, commentari, sequenze. Qui sottolineiamo l’importanza dell’uso consapevole del mezzo riproduttivo nella misura in cui la tecnica, mai neutra, ha ben precisi riverberi sui contenuti. Non ci si improvvisa nei ruoli di fotografi, operatori video, registi. Al contempo, nella restituzione dei risultati di una ricerca, nell’impaginazione di una monografia o di un saggio, non ci si improvvisa nei ruoli di redattori, progettisti del menabò, grafici e montatori digitali.
Esistono, per paradosso, collane editoriali e riviste di antropologia visuale che nella loro versione soprattutto cartacea, insistono nell’adozione di un formato rettangolare verticale, formato che l’editoria d’arte, nella realizzazione di cataloghi di mostre pittoriche ma pure fotografiche notoriamente aborre, ben guardandosi dall’adottarlo a tutto favore di formati quadrati o quadrangolari. Nell’impaginazione di una sequenza di immagini l’avere a disposizione una superficie quadrata consente plurime scelte che ineriscono la determinazione del formato, la sua dimensione, la sua disposizione, la giustapposizione con altre immagini nella singola ma pure nella doppia pagina con patenti e proficui riverberi sul piano di contenuti destinati a incrementarsi, a farsi maggiormente cogenti.
Tutto questo va a vantaggio del ritmo narrativo armonizzando ma pure enfatizzando la dialettica imposta alle immagini. Ricondursi viceversa a pagine rettangolari e verticali crea dei colli di bottiglia che spesso mortificano la densità documentaria delle immagini. Impaginare una foto verticale impone l’uso dell’intera pagina; in alternativa si possono accoppiare due foto verticali, sempre nella medesima pagina riducendone però drasticamente le dimensioni e dunque l’intelligibilità. Di contro una foto orizzontale, pur nel caso in cui si dedichi a essa una pagina a sua sola disposizione, rimarrà “compressa” e mortificata dal verticalismo dell’impaginato. Si pensi al ritratto di un gruppo familiare, a una moltitudine di partecipanti a una festa popolare: i numerosi soggetti raffigurati e la notevole densità documentaria di codesta immagine non potrà esprimersi come invece potrebbe fare se avesse a disposizione un impaginato quadrato. Il verticalismo offre inoltre il fianco a indesiderati salti di scala per cui una foto rettangolare a piena pagina esacerba inutilmente i soggetti raffigurati che fagocitano quelli, ben più numerosi ma costipati di una foto orizzontale collocata nella pagina a fianco.
Siamo dunque al cospetto di retoriche che ineriscono la definizione e l’organizzazione di una narrazione visiva alla quale si deve riconoscere piena dignità, al pari di un testo scritto che, a sua volta, ricorre ad altrettante e proprie retoriche spesso espresse e dettagliate nelle norme editoriali che coloro che scrivono sulle riviste sono tenuti a rispettare. Dando una scorsa a codeste norme, così come esplicitate in diverse testate, le indicazioni che riguardano l’inclusione di immagini si limitano sovente a segnalare l’esigenza di una didascalia.
Da quando abbiamo assunto oneri ed onori della direzione della già citata EtnoAntropologia, rivista di fascia A, espressione assieme alla consorella Anuac della Siac e dei suoi affiliati, ci siamo premurati di dettagliare con più attenzione i criteri relativi all’inserimento e alla disposizione delle immagini. Pur, ahimè, non potendo contare su formati quadrati, si incoraggiano gli autori alla rinuncia di immagini da inserire più o meno in ordine sparso con qualche striminzita didascalia. Si suggerisce invece di ricorrere alle immagini solo nei casi in cui il loro ruolo, già sul campo e quindi in fase di stesura di un articolo, sia stato complementare ma assolutamente non ancillare rispetto al testo. Si suggerisce perciò di organizzare le immagini in sezioni autonome dotate non solo di apparato didascalico ma anche di commentari che motivino e definiscano le differenti sequenze destinate a comporre la parte iconografica del contributo.
 Siamo all’a b c, ce ne rendiamo conto. L’auspicio di una comunicazione scientifica sulle riviste mediante una saggistica formalmente in linea con i contenuti digitali che analizza e di cui rende conto anche visivamente, interattivamente ci pare ancora e solo in nuce. Verrebbe da dire che la modularità comunicativa si arresta quindi alla pur lodevole organizzazione di una sitografia e di qualche foto.
Siamo all’a b c, ce ne rendiamo conto. L’auspicio di una comunicazione scientifica sulle riviste mediante una saggistica formalmente in linea con i contenuti digitali che analizza e di cui rende conto anche visivamente, interattivamente ci pare ancora e solo in nuce. Verrebbe da dire che la modularità comunicativa si arresta quindi alla pur lodevole organizzazione di una sitografia e di qualche foto.
Per chi intenda nel frattempo dare vita a saggi che facciano dialogare testi e immagini stiamo ipotizzando, sempre per EtnoAntropologia, una scheda di valutazione che contempli un giudizio anche sui contributi visivi, sul modo in cui, parallelamente alla parte testuale di uno scritto, si sia realizzato un documento di natura precipuamente iconografica. Saranno particolarmente apprezzati quei contributi in cui gli autori avranno dimostrato di modulare il loro contributo in due parti sinergiche ove l’una completa l’altra e viceversa. Mai dimenticandoci che l’Antropologia visuale accoglie e riusa lessici e strumentazioni di documentazione visiva propri, ab ovo, delle discipline estetiche e artistiche, ci si attende che i documenti iconografici siano pienamente intellegibili e decrittabili così come un testo scritto, parimenti, non può ammettere prose grammaticalmente e sintatticamente approssimative, citazione errate, bibliografie incomplete.
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023
Riferimenti bibliografici
Aouragh M. 2018, Digital anthropology, in Callan H. (ed.) 2018, The International Encyclopedia of Anthropology, Chichester: Wiley-Blackwell, 1-10
Baldi A.1985, Paolo Mantegazza: alle origini dell’Antropologia visiva italiana, in AA.VV. Paolo Mantegazza e il suo tempo: l’origine e lo sviluppo delle Scienze antropologiche in Italia, Milano, Ars Medica Antiqua: 69-79.
- 2011, L’Antropologia visuale, in Signorelli A. Antropologia culturale, Milano, McGraw Hill Companies: 232-237.
- 2016 a, Ipse vidit: fotografia antropologica ottocentesca e possesso del mondo, «EtnoAntropologia», Vol. 4 n. 1: 3-28.
- 2016 b, Etno-show. Quando l’antropologia andò in scena, un’antropologia bella da vedere, «EtnoAntropologia», Vol. 4 n. 2: 37-82.
- 2021, Pandemia, imago mortis e sue migrazioni digitali, «EtnoAntropologia», Vol. 9 n.1: 253-268.
Beneito-Montagut R., Begueria A., Cassiá N. 2017, Doing digital team ethnography: Being there together and digital social data, «Qualitative Research», 17 (6): 664–682.
Biscaldi A. 2019, La serendipity dell’antropologo nell’epoca dei social media, «Antropologia» Numero Speciale, Per caso e per sagacia. Dialoghi con Ugo Fabietti, 6 (1): 185-198.
Biscaldi A., Matera V. 2019, Antropologia dei social media. Comunicare nel mondo globale, Roma: Carocci.
Caliandro A. 2018, Digital methods for ethnography: Analytical concepts for ethnographers exploring social media environments, «Journal of Contemporary Ethnography», 47 (5): 551-578.
Chiarelli B. (eds) 1986, Paolo Mantegazza e il suo tempo: l’origine e lo sviluppo delle Scienze antropologiche in Italia, Milano: Ars Medica Antiqua.
Dalsgaard S. 2016, The Ethnographic Use of Facebook in Everyday Life, «Anthropological Forum», 26 (1): 96-114.
Dimpflmeier F. 2014, Dal campo al museo. Per una storia delle collezioni antropologiche, etnografiche e fotografiche della Nuova Guinea Britannica, «Lares» , Vol. LXXX/1: 87-101.
Faeta F. 1995, Strategie dell’occhio. Etnografia, antropologia, media, Milano: Franco Angeli.
Faeta F., Ricci A. (eds) 1997, Lo specchio infedele. Materiali per lo studio della fotografia etnografica in Italia, Roma: Documenti e ricerche del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari.
Geismar H., Knox H. (eds) 2021, Digital Anthropology, 2nd Edition, London: Routledge.
Hine C. 2015, Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday, London: Bloomsbury.
Horst H.A., Miller D. (eds) 2012, Digital Anthropology, London: Routledge.
Matera E. (eds) 2020, Storia dell’etnografia. Autori, teorie, pratiche, Roma: Carocci.
Mazzacane L. 1996, Pinna e De Martino: una vicenda complessa, in Pinna G., Bruno M.S., Domini C., Olmoti G. (eds) 1996, Franco Pinna. Fotografie 1944 -1977, Milano, Motta: 125 -135.
Miller D., Costa E., Haynes N., McDonald T., Nicolescu R., Sinanan J., Spyer J., Venkatraman S., Wang X. 2018, Come il mondo ha cambiato i social media, edizione italiana a cura di Gabriella D’Agostino e Vincenzo Matera, Milano: Ledizioni.
Pink S., Horst H., Postill J., Hjorth L., Lewis T., Tacchi J. 2016, Digital ethnography: Principles and practice, Thousand Oaks: Sage Publications.
Przybylski L. 2020, Hybrid ethnography: Online, offline, and in between, Thousand Oaks: Sage Publications.
Ricci A. 2015, Su etica, fotografia, ricerca sul campo, etnografia in Perna R., I. Schiaffini (eds.), Etica e fotografia. Potere, ideologia, violenza dell’immagine fotografica, Roma:DeriveApprodi: 28-41.
Sisto D. 2018, La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale, Torino: Bollati Boringhieri.
- 2020, Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio, Torino: Bollati Boringhieri.
Walton S. 2018, Remote ethnography, virtual presence: Exploring digital-visual methods for anthropological research on the web, in Costa C., Condie J. (eds.) 2018, Doing research in and on the digital, New York: Routledge, 116–133.
Ringraziamento
Si ringrazia Eugenio Zito per alcune preziose indicazioni bibliografiche che ci hanno consentito un aggiornamento sulle ricerche soprattutto più recenti inerenti il tema da noi trattato in questa sede.
_____________________________________________________________
Alberto Baldi Professore ordinario di Antropologia culturale, Antropologia visuale ed Etnografia visuale c/o Dipartimento di Scienze Sociali e direttore del MAM – Museo Antropologico Multimediale c/o Università degli Studi di Napoli Federico II, direttore della rivista EtnoAntropologia (fascia A) e dei quaderni del Museo Antropologico Multimediale editi da Squilibri. Tra gli interessi di ricerca: storia dell’antropologia italiana e russa, antropologia teatrale e teatro di figura, antropologia visuale, antropologia delle rappresentazioni, antropologia delle culture alieutiche e marinare.
______________________________________________________________