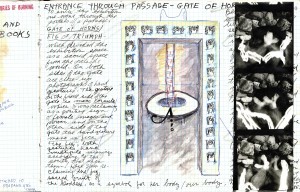di Mariella Pasinati
Il femminismo e la creazione di simboli iconici per le donne, l’indagine sulle origini della sacralità femminile e l’uso del proprio corpo nella rappresentazione, l’inclinazione alla collaborazione artistica e la costante sollecitazione del pubblico per un approccio attivo all’arte sono stati i princìpi cardine del lavoro di Mary Beth Edelson (East Chicago 1933-Ocean Grove 2021) scomparsa all’età di 88 anni, lo scorso 20 aprile.
Utilizzando una grande varietà di media (dalla fotografia e il disegno alla performance, i collage, i libri d’artista, oltre alla pittura e scultura), per oltre cinquant’anni Edelson è stata fra le artiste che maggiormente hanno centrato la propria opera sulla forza vitale del femminismo e sulla ricerca di una diversa rappresentazione dell’essere donna trasformando la critica e la lotta politica al patriarcato in affermazione feconda e immaginifica di soggettività artistica femminile.
Di questo impegno il foto-collage Some Living American Women Artists del 1972 (SLAWA) costituisce forse l’immagine che meglio definisce visivamente proprio le istanze del movimento femminista degli anni ‘60-’70 in rapporto al mondo dell’arte. Si tratta di una riappropriazione alla Duchamp dell’Ultima Cena di Leonardo: un fotomontaggio in cui Edelson sostituisce ai volti di Gesù e dei discepoli quelli di artiste americane contemporanee, “incorniciando” poi l’immagine con le fotografie di altre, numerose artiste, tutte rigorosamente indicate per nome. Il lavoro è una critica, non priva di una vena umoristica, sull’assenza delle donne dalla storia e dalla scena contemporanea dell’arte americana ma anche, secondo un ulteriore livello di lettura, dalle istituzioni religiose.
Il collage, infatti, fu elaborato in seguito ad una sollecitazione di Ed McGowin, uno degli artisti coinvolti nel progetto 22 Others iniziato da Edelson nel 1971 e concepito come un “esperimento collaborativo”. Ispirata dall’idea di Jung dell’inconscio collettivo, l’artista aveva invitato ventidue persone a discutere del suo lavoro e a fornirle spunti di riflessione su un’opera che avrebbero voluto che lei realizzasse. I prodotti di questo scambio di energia creativa furono «un certo numero di lavori di rottura», come li definì la stessa artista, esposti a Washington nel 1973 e, fra questi, SLAWA.
In quell’occasione, il suggerimento di McGowin era stato: partire da uno sguardo critico alla religione organizzata. Edelson ha raccontato di aver pensato subito all’esclusione delle donne da un mondo dominato dagli uomini nelle religioni, ma anche nell’arte. Così nel collage fa spazio alle donne, collocando Georgia O’Keeffe al posto di Gesù mentre tra gli apostoli figurano, fra le altre, grandi artiste come Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Louise Nevelson, Yoko Ono che allora, però, non godevano ancora del dovuto riconoscimento nel mondo dell’arte. È interessante notare, tuttavia, che la selezione delle artiste collocate nel pannello centrale, a detta della stessa Edelson, era stata «abbastanza arbitraria» e che non tutte quelle che formavano la “cornice” erano note alla stessa Mary Beth che incluse infatti tutte le fotografie di artiste che era riuscita a trovare. Il collage, pubblicato come manifesto, rivestì in questo modo anche l’importante funzione di una sorta di catalogo delle artiste americane contemporanee, molte delle quali ancora non si conoscevano personalmente.
L’occasione per un incontro fecondo fra artiste provenienti da tutto il Paese (fra loro Judy Chicago, Elaine de Kooning, Alice Neel, Miriam Schapiro e la storica dell’arte Linda Nochlin) si presentò sempre nel 1972 con la prima Conferenza Nazionale delle Donne nelle Arti Visive, un’iniziativa provocata dall’ennesima biennale senza donne alla Corcoran Gallery of Art di Washington e alla cui organizzazione collaborò anche Edelson, fin da giovanissima sempre impegnata politicamente e attiva anche nel campo dei diritti civili.
Portando alla luce e nominando ciò che era ancora invisibile nel mondo dell’arte mainstream – la presenza delle donne – la Conferenza costituì per le artiste un importante momento di crescita di auto-consapevolezza e valorizzazione, capace di trasformarle profondamente. In quegli anni, Edelson entrò anche a far parte della A.I.R. Gallery (Artists in Residence) di New York, la prima galleria d’arte cooperativa femminista degli Stati Uniti che ebbe fra le fondatrici Howardena Pindell, Agnes Denes, Nancy Spero; nel 1977, insieme a Joan Braderman, Lucy R. Lippard, Miriam Schapiro fra le altre, fu tra le promotrici dell’autorevole rivista Heresies: A Feminist Publication on Art and Politics [1].
In quegli anni nacquero anche altri collage-manifesti che, come SLAWA, ruotavano intorno al tema del patriarcato ed erano segnati da un’intenzione apertamente pubblica e politica. I lavori, oggi tutti al Moma, si basano sempre su capolavori della storia dell’arte maschile nei quali Edelson sostituisce ai personaggi raffigurati i ritratti di donne artiste. La lezione d’anatomia del Dr. Nicolaes Tulp di Rembrandt diventa così Death of the Patriarchy/A.I.R. Anatomy Lesson (1976) (La morte del patriarcato/Lezione di anatomia dell’A.I.R.), in cui solo il cadavere è maschio mentre al posto dei volti degli uomini del ritratto di gruppo di Rembrandt Edelson colloca quelli delle prime artiste componenti della A.I.R. Gallery.
Happy Birthday America (1976) fu invece concepito per il primo numero della rivista Chrysalis: A Journal of Women’s Culture. Nell’opera, sui corpi nudi delle odalische del quadro di Ingres Il bagno turco (1862) sono posti i visi delle responsabili della rivista (artiste, curatrici e storiche dell’arte) per affermare un cambiamento di sguardo: corpi di donna che si trasformano da oggetto – immaginario – del desiderio maschile in figure femminili esistenti, donne sicure di sé e padrone del proprio sguardo. È il tentativo di creare una cultura delle donne all’interno di un contesto dominato dal maschile: «Stiamo prendendo la nostra energia e restituendola a noi stesse» dirà Mary Beth Edelson a proposito di Happy Birthday America [2].
Nello stesso periodo, il tema del foto-collage fu sviluppato anche in una versione da parete, un contributo originale ottenuto riutilizzando le immagini rimaste dalla lavorazione dei manifesti e collocate su muro in composizioni dalle forme complesse, intrecciate, che rompono i confini dell’inquadratura, realizzate in diverse e varie dimensioni. Eseguiti già nel 1972 ma concepiti come installazioni su larga scala a partire dal 1985 [3], questi Wall Collage continuano la celebrazione dei collettivi o di singole artiste di cui Edelson ripete i volti, a volte reiterandoli in dimensioni diverse, oppure presentano anche soggetti e temi quali Medusa, la dea uccello egizia e le dee serpente minoiche, la Sheela-Na-Gig, Baubo.
Questi temi fanno parte dell’immaginario cui l’artista attinse nel realizzare i primi lavori di body art e le performance in solitario che caratterizzano una seconda direzione impressa alla sua ricerca visiva, sempre nei primi anni ‘70. Si tratta di un percorso sviluppato in forma più personale, influenzato anche dallo interesse per la spiritualità femminile, oltre che dal concetto di inconscio collettivo e dalla teoria degli archetipi di Jung dal cui pensiero, tuttavia, l’artista si sarebbe in seguito allontanata.
È del 1973 la Woman Rising Series la sua opera forse più nota. La serie si fonda sulla ricerca e la rivisitazione di immagini di potenza femminile ispirate all’archetipo della Grande Dea [4] che l’artista utilizzò per esplorare la dimensione del divino e della spiritualità femminili, sfidare il patriarcato con le sue diverse forme di oppressione religiosa millenaria e fornire un immaginario ginocentrico di grande impatto. «La Dea è sempre stata per me metafora di un cambiamento radicale e di una nuova coscienza, per cancellare codici sociali consentiti e aprire ad altri campi dell’esperienza. Questa spiritualità ha occupato un’area che nella cultura occidentale era un territorio maschile e pertanto questa azione era in sé e per sé un atto profondamente politico contro il patriarcato e per la liberazione spirituale», così avrebbe spiegato il suo interesse per la Dea, nel corso di una lezione all’Università dell’Illinois, nel 1988 [5].
Si tratta di performance eseguite dall’artista in paesaggi naturali, veri e propri rituali privati messi in scena in solitudine e fotografati in bianco e nero. In questi “autoritratti” si rappresenta nuda di fronte alla macchina fotografica, in pose decise e imperiose: a testa alta, gambe larghe, braccia alzate, nella posizione delle antiche figurine della statuaria egizia predinastica o di quelle minoiche della Dea dei serpenti. Le foto in bianco e nero erano poi lavorate, spesso ironicamente, con segni grafici e pittorici di forme simboliche – cerchi, lune, spirali, linee che suggeriscono campi di energia e diramazioni – e con immagini mitologiche di figure provenienti da altre culture – dalla dea Kalì ad Artemide, da Baubo alla Sheela-na-gig, sintetizzate in Sophia of Wisdom del 1973 – che l’artista imprime sul suo corpo in un percorso di trasformazione di sé in archetipo o dea.
Differentemente riconfigurato, il suo corpo diventa così esso stesso materia oltre che contenuto dell’opera, un oggetto trovato che Edelson usa per trasformarlo, come lei stessa ha sottolineato, in un soggetto trovato. È questa infatti la sua intenzione: recuperare «l’antica relazione, naturale e priva di vergogna con il corpo» [6] e attraverso il corpo riaffermare la soggettività femminile, grazie a un nuovo linguaggio simbolico che, utilizzando la Dea e i suoi simboli, dia forma e definizione ad una nuova cultura che sovverte e sfida il linguaggio patriarcale. Le sue performance e i lavori fotografici della serie ci restituiscono pertanto un femminile potente ed autonomo in cui, come notato dall’artista stessa, sessualità, mente e spirito convivono in un unico corpo.
Ecco allora che Edelson si presenta ora come una mantide religiosa con i tacchi a spillo (Monday’s Prayer Dinner Party, 1973); ora come la dea Kalì che esibisce come trofei i teschi di “patriarchi” mentre con il piede sinistro disegnato un po’ al di fuori del contorno della foto schiaccia il volto di un uomo sconfitto (Red Kali, 1973); oppure assume (molte volte ed in vari modi) le sembianze della Sheela-na-gig, la dea celtica della fertilità e della distruzione, con i genitali sfacciatamente esposti (Jumping Jack Sheela, 1973), per arrivare ai miti contemporanei, trasformandosi in una Wonder Woman (To the Rescue, 1973). Fanno parte della serie anche due doppie trasformazioni con sostituzione del volto di Edelson con quello dell’artista Louise Bourgeois (Louise Creating Her Own Energy, 1973) e della storica dell’arte Lucy Lippard (Many Breasted Great Mother [Lucy Lippard], 1973), quest’ultima interpretata come una Grande Dea dai molti seni, un’immagine simbolo di fecondità che rimanda all’Artemide efesia.
La serie anticipava anche temi che di lì a poco sarebbero stati affrontati a livello di teoria femminista, come la questione dello sguardo e la rappresentazione del sé. In Seeing Double (1973), ad esempio, la foto è lavorata con il disegno di tre paia di occhi che guardano direttamente chi osserva l’opera e se il primo paio ridisegna quelli di Edelson, il secondo si sovrappone ai suoi seni mentre il terzo è sospeso in aria al di sopra della figura ed è collegato con delle linee agli “occhi” del seno. L’immagine visualizza il controllo esercitato dall’artista sull’atto stesso del guardare, ed è la stessa Edelson a sottolineare che presentando il suo corpo, riconfigurava la sua femminilità «rendendo il corpo femminile visibile attraverso il [suo] sguardo di donna e alle [sue] condizioni» [7]. Come alle origini dell’arte, il corpo e la sessualità femminili tornavano così ad esprimere la fonte originaria della creatività umana.
Per tutti gli anni ‘70 la ricerca sulla Grande Dea prese anche strade diverse, dal punto di vista dei media impiegati. Fra il 1974 e il ‘75 infatti l’artista diede vita alle Great Goddess Cut-Outs, figure maestose in acrilico su compensato che rappresentano una diversa versione, plastica e bidimensionale della Dea. In posizione eretta, queste antiche sorelle, secondo la definizione di Edelson, si presentano come grandiosi idoli policromi caratterizzati da forme geometriche elementari sulle cui superfici, molto tattili, sono impressi motivi che rimandano ai simboli dell’arte preistorica, graffi, semplici segni grafici, testi scritti.
La serie comprende due dee Sophia, imponenti triangoli coronati da grandi cerchi che rappresentano la filosofia che porta il disco dello zodiaco [8] e ancora, secondo l’artista, «il Sé Femminile come centro creativo del Mandala… il simbolo di ogni donna unita nella trasformazione spirituale». Oltre alle dee di varie culture, le immagini celebrano anche Louise Bourgeois e Georgia O’Keeffe, per Edelson vere icone contemporanee dell’arte. La loro presenza rimanda alla continuità e comunione universale delle donne nel tempo e nello spazio.
Nel 1977, influenzata dal primo testo di Maria Gijmbutas, l’artista intraprese un viaggio-pellegrinaggio all’isola di Hvar in Croazia per realizzare una performance rituale in un sito di epoca neolitica, la grotta Grapceva. La performance ha dato origine ad una serie fotografica realizzata in condizioni di oscurità estrema, alla sola luce di alcune candele, la Grapceva Neolithic Cave Series: See for Yourself (Guarda tu stesso/a) che Edelson ha raccontato nel numero della rivista Heresies dedicato alla Grande Dea [9].
Il ‘77 fu anche l’anno di due importanti eventi nei quali il soggetto politico e spirituale femminista si espose compiutamente, aprendosi anche al pubblico. Il primo fu la mostra all’Università di San Diego in California Your 5,000 Years Are Up (I vostri 5.000 anni sono finiti). Qui, oltre alla performance pubblica dei rituali, nel giorno dell’inaugurazione, Endelson costruì un’esposizione che comprendeva: le Story Gathering Boxes – scatole per la raccolta di storie –; gli anelli di fuoco che costituivano la scena per i rituali della performance e parte dell’installazione permanente; un’installazione scultorea in sette parti Mourning Our Lost History (Lutto per la nostra storia perduta); le foto e i disegni di documentazione dei rituali.
Il secondo evento Memorials to the 9,000 Women Burned as Witches in the Crhristian Era (Monumenti alle 9.000 donne bruciate come streghe nell’era cristiana) fu un progetto installativo complesso sulla caccia alle streghe che prevedeva anche una performance. Era costituito da alcune serie fotografiche – compresa la Grapceva Neolithic Cave Series – e da un cerchio di libri fatti a mano (che rappresentavano i libri di magia) all’interno del quale era collocata un scala a pioli, come quelle cui si legavano le donne condannate al rogo come streghe, in un’evidente allusione alla spiritualità femminile e alla capacità delle donne di elevarsi oltre la persecuzione.
Edelson ha raccontato in un’intervista che la performance era completata da «suoni e canti che riflettevano in modo non verbale la storia del movimento femminista, di donne che si riuniscono, di suoni per trovare la nostra voce e il nostro linguaggio … Alla fine della performance … abbiamo iniziato a ballare e invitato il pubblico a unirsi a noi, così non c’era alcuna differenza tra il pubblico e gli interpreti» [10]. La ricerca di forme e modi di sensibilizzazione e coinvolgimento diretto del pubblico è stata infatti una costante del suo lavoro fin ai primissimi anni ‘70, quando l’artista era mossa anche dall’intenzione di mettere in discussione la stessa “autorità” costituita del fare artistico ed espositivo per sostituirla con un’economia di relazione in cui il pubblico non fosse più solo spettatore passivo.
Le Story Gathering Boxes (1972-2014) furono create proprio con il proposito di «rompere le barriere tradizionali create tra il pubblico, lo spazio artistico e le opere d’arte» e costituirono un modo originale di fare spazio al pubblico all’interno di una mostra, dal momento che le persone in visita erano invitate a partecipare alla scrittura di storie. Nel corso del suo lungo percorso creativo l’artista ha riproposto molte volte questa pratica, realizzando più di trenta Story Gathering Boxes.
Le scatole sono semplici contenitori in legno per i quali l’artista si ispirò, per dimensione e configurazione, agli «antichi scrigni canopici egiziani che custodivano gli organi del faraone». Ogni scatola è divisa in quattro sezioni e contiene due tipi di tavolette: quelle in legno che comprendono testi e immagini costruite con materiali diversi e quelle solo di carta che, a seconda del tema generale affrontato nella scatola, portano una domanda diversa in ciascuna sezione.
C’è la scatola che affronta il tema della Grande Madre e quella che interpella su Nuovi/Vecchi Miti ponendo un’unica domanda: “Quali sono i nostri miti contemporanei?” Ci sono quelle che interrogano sul rapporto fra i sessi con 4 domande: “Cosa ti ha insegnato tua madre/tuo padre sugli uomini?” “Cosa ti ha insegnato tua madre/tuo padre sulle donne?” e quelle che invitano a raccontare Storie di immigrazione familiare. Altre ancora spingono ad immaginare il nostro agire in un futuro prossimo o ancora, in Infanzia, a riflettere su “Com’è stato essere una ragazza/un ragazzo?”
Ogni persona può guardare le risposte già raccolte e aggiungere le proprie, inserendo il proprio tassello ad una nuova narrazione; sono disegni, ricordi, racconti, battute, lamentele, preghiere e anche qualche volgarità, manifestate con immediatezza, a volte sbrigative o appena scarabocchiate. Insieme contribuiscono a rendere visibile, attraverso le risposte espresse in tempi diversi alle stesse domande, i cambiamenti di pensiero e atteggiamenti rispetto alle questioni poste dall’artista; tutte insieme definiscono una grande narrazione collettiva.
Nei decenni successivi, Edelson ha evoluto il suo peculiare percorso creativo intrecciando strettamente arte, attivismo politico e impegno nel movimento delle donne, sempre alla ricerca di modi efficaci per collaborare, fare comunità e dare vita, insieme ad altre, a nuove, impreviste narrazioni. Se per tutti gli anni Ottanta, oltre alle installazioni su larga scala, l’artista ha realizzato disegni, acquerelli, serigrafie su tela, agli anni ‘90 appartengono in particolare le opere in cui l’appropriazione – e decontestualizzazione – di immagini si sposta dalle divinità femminili alle attrici del cinema: Gena Rowlands, Marilyn Monroe, Judy Garland, Mae West, fra le altre. Il suo proposito era di «ri-scrivere Hollywood», reinventare la rappresentazione delle donne espressa in quei film e reimmaginarle come soggeti indipendenti e intraprendenti che sfidano gli stereotipi del cinema hollywoodiano e si sottraggono allo sguardo maschile reificante.
Era interessata dalle storie in cui la protagonista impugna una pistola, simbolo principale del potere maschile. Il registro è tipicamente umoristico, interpretato come un modo efficace per sconvolgere l’ordine sociale. In alcuni lavori le raffigurazioni delle attrici si combinano anche con la figura di Baubo, la divinità legata alla risata e all’“oscenità”, sessualmente libera ma saggia (The Question Of The Subject-Gena Rowlands, 1996), in altri a quella della dea Kali, in altri casi infine le immagini si accompagnano ad brevi notazioni scritte che arricchiscono e potenziano il messaggio dell’opera.
Gli anni ‘90 sono stati caratterizzati anche dall’attenzione al tema della violenza maschile sulle donne, come risposta a un problema che nella cultura americana dei primi anni ‘90 cominciava a venire sempre più alla luce. È il momento della serie dedicata a Lorena Bobbit, costruita reinterpretando, ancora una volta con ironia, un atto di violenza avvenuto nel 1989 e balzato all’attenzione dei media per la sua peculiarità: la castrazione di un marito maltrattante ad opera della moglie abusata. Fa parte della serie The Last Temptation of Lorena Bobbitt (L’ultima tentazione di Lorena Bobbit, 1993) in cui la scena di violenza è interpretata come una scena religiosa, una Pietà, con Bobbitt che tiene in grembo il marito sanguinante, inquadrata da una catena chiusa da cui pendono dei falli.
Il tema è stato interpretato anche in chiave monumentale in una scultura, Kali/Bobbitt (1994) per la quale Edelson ha utilizzato e trasformato un manichino, rappresentando la donna come la dea indù in abbigliamento sadomaso mentre brandisce, in due delle sue numerose mani, un coltellaccio e il fallo reciso, trionfante di vendetta. L’opera era stata esibita, nello stesso anno, all’interno del progetto a sostegno delle donne maltrattate Combat Zone: Campaign HQ Against Domestic Violence (Zona di combattimento: Sede della campagna contro la violenza domestica, 1994) sviluppato dall’artista per Creative Time, un’organizzazione che da quarant’anni commissiona ambiziosi progetti di arte pubblica non solo a New York ma in in tutto il mondo. La scultura fu inserita nello spazio di SoHo che Edelson aveva concepito come il quartier generale di una campagna politica contro tutte le forme di abuso domestico, attrezzandolo completamente per offrire una risposta alle donne in difficoltà attraverso consulenze, laboratori di autodifesa, conferenze, una linea telefonica, servizi online. Così, tramite un modello di attivismo comunitario e coerentemente con la sua concezione della funzione pubblica dell’arte, Combat Zone gettava luce su un problema che in quel momento era ancora troppo poco oggetto di attenzione.
Fra le opere degli anni 2000 vanno ricordate due esperienze che sintetizzano perfettamente, nello sviluppo del suo lavoro, l’attenzione alla relazione come dimensione politica, sia nella quotidianità dei rapporti umani, sia nella dimensione genealogica: l’azione di performance art Making eye contact (Stabilire un contatto visivo) e la serie di ritratti Portraits Behind the Desk (Ritratti dietro la scrivania). Con Making eye contact Edelson ha esplorato il tema del contatto visivo tra sconosciuti nello spazio pubblico sviluppando un’idea, nata negli anni ‘70, in seguito alla lettura di un articolo nel quale si rilevava come i bianchi allora non guardassero negli occhi le persone di colore. L’articolo l’aveva fatta riflettere sul fatto che non avere un contatto visivo, non guardare neanche coloro che ci troviamo davanti, può far sentire invisibili: un’importante questione politica, dal momento che riguarda le relazioni umane.
La performance è stata eseguita in numerosi luoghi sia negli Usa che in Europa e in particolare in Norvegia, durante un programma durato tre mesi nel 2004, si è esplicitata tutta la potenzialità della dimensione politica di questo intervento artistico. Lì infatti la performance ha messo in contatto visivo, durante la Fiera internazionale d’arte delle isole Lofoten, i rifugiati appena arrivati dalle zone di guerra e i riservati cittadini scandinavi.
Edelson ha realizzato per l’ultima volta Making eye contact nel 2010, a seguito di un workshop tenuto alla scuola di arte e di disegno della Southern Illinois University di Carbondale. Le/gli studenti coinvolti nel laboratorio hanno condotto l’esperienza dell’entrare in relazione tramite contatto visivo con altri studenti del campus che non conoscevano e hanno anche realizzato il video e le foto dell’azione. L’esperienza si è dimostrata ancora una volta strumento potente per mettere a fuoco il tema del riconoscimento dell’altro/a e per attraversare confini di cui magari neanche ci rendiamo conto. Ogni performance svolta, così come ogni contatto sperimentato nelle varie azioni si sono rivelati unici, personali e hanno mostrato quanto la comunicazione non verbale può riservare.
La series Portraits Behind the Desk (2005/6) è stata concepita per visualizzare la necessità politica, per le donne, di avere modelli femminili autorevoli. Edelson ha raccontato di aver osservato che in genere nelle rappresentazioni dei vari media, gli uomini sono spesso raffigurati seduti ad una scrivania con il ritratto di un altro uomo di valore dietro di sé, con l’effetto indiretto di potenziare il senso della propria autorità, assimilando a sé quel modello. La stessa cosa non capita con le donne.
Sono nati così i ritratti di importanti figure femminili [11] che, ancora una volta l’artista ha realizzato dopo aver chiesto a persone amiche quale donna autorevole avrebbero voluto sul muro dietro la propria scrivania. Montati su appariscenti cornici dorate, questi ritratti sono stati esposti nel 2006 alla retrospettiva del Konstmuseum di Malmö e la sera dell’inaugurazione le persone del pubblico che lo volevano sono state fotografate dietro un’imponente scrivania con un ritratto alle loro spalle.
Già dai primi anni 2000, l’opera di Mary Beth Edelson è stata oggetto di un rinnovato interesse e riproposta in importanti esposizioni [12], ricevendo l’attenzione e il riconoscimento che merita [13] e che non sempre le sono stati tributati, nel corso della sua lunga carriera. Il suo lavoro, infatti, è stato parte di una storia in buona misura eclissata dal prevalere di altre forme espressive e da diverse posizioni critiche emerse anche all’interno del femminismo già dagli anni ‘80. In quegli anni, mentre gli spazi conquistati dalle donne nelle istituzioni museali, nella stampa e negli studi specialistici si moltiplicavano, sulla ricerca/affermazione di un segno femminile nell’arte si arrivava a posizioni teoriche e pratiche estetiche contrastanti, in un dibattito a volte aspro e non privo di fraintendimenti, più o meno intenzionali.
In questo contesto, con il prevalere della critica postmoderna proprio in ambito accademico femminista, l’opera di Edelson, in particolare i suoi lavori sulla dea (come quelli di altre artiste e critiche centrati in particolare sul corpo), è stata sottovalutata, presentata come un tentativo ingenuo di contrastare la cultura patriarcale e tacciata di essenzialismo, in una sorta di “caccia alle streghe” nel mondo dell’arte, come l’ha definita la stessa Mary Beth [14]. Nel suo caso si è così trascurata la portata di un lavoro capace di creare un immaginario imprevisto nell’ordine simbolico patriarcale dominato dalla figura del dio padre e nel quale, per il femminile, è del tutto assente l’esperienza della trascendenza e del divino. Riferirsi alla dimensione della dea significava, in quel momento, accedere ad un potenziale di risignificazione fortemente trasformativo nella rappresentazione dell’essere donna, un’importante risorsa politica e culturale per un nuovo dirsi del soggetto femminile.
Il rinnovato interesse e la riconosciuta importanza dell’arte femminista nello sviluppo dei linguaggi artistici contemporanei, hanno riportato alla ribalta temi e artiste da sempre impegnate in una modalità del fare arte profondamente segnata dal femminismo. Sull’arte femminista si è recentemente riaperta una riflessione; nel 2019, infatti, gli Archivies of American Art dello Smithsonian Institution hanno riproposto la stessa domanda Cos’è l’arte femminista? che già nel 1977 le storiche dell’arte e femministe Ruth Iskin, Lucy Lippard e Arlene Raven avevano avanzato, invitando le artiste a produrre disegni, collage, manifesti, stampe, testi poi presentati in una mostra che portava lo stesso titolo. Più di quarant’anni dopo, quella domanda è stata sottoposta sia a diverse artiste che avevano partecipato alla prima esposizione, sia ad altre più giovani e le vecchie e nuove risposte sono state esposte insieme [15].
Mery Beth Edelson ha risposto soltanto alla richiesta del 1977. Il suo testo di allora, nel sottolineare col solito umorismo le difficoltà incontrate nel rispondere alla domanda – «Ho avuto così tanti problemi con questa domanda che ho provato a scrivere su un foglio rosa e nemmeno questo mi ha aiutato» – ci restituisce il suo chiaro, preciso pensiero: «per me l’arte femminista è innanzitutto l’arte fatta da donne che desiderano essere considerate femministe e che il loro lavoro sia interpretato come tale. … un lavoro che si assume un rischio, un rischio che si aggiunge alla coscienza della cultura femminista e che non è solo una riproposizione di atteggiamenti noti. Poiché parliamo di una cultura la cui forma non è quella della cultura patriarcale, passata o presente … mi è difficile immaginare che … la collaborazione e nuovi modi di lavorare insieme non siano parte integrante di questa nuova forma».
Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021
Note
[1] Pubblicata dal 1977 al 1993 da un collettivo di intellettuali ed artiste – Heresies Collective, la rivista si pose come luogo di riflessione sull’arte e la politica da una prospettiva femminista. Il tema di ognuno dei 27 numeri stampati era definito dal collettivo ma curato da un diverso gruppo redazionale formato da soggetti esterni ed interni al collettivo; ogni numero pertanto era diverso per stile e configurazione visiva.
[2] Gli altri collage sono Bringing Home the Evolution (1976), costruito sull’opera del pittore norvegese Gustaf Cederström Bringing Home the Body of King Karl XII of Sweden (1884), Death of the Patriarchy/Heresies (1976) in cui le artiste di Heresies stanno al posto dei soldati nell’opera di John Trumbull, The Death of General Warren at the Battle of Bunker’s Hill, June 17,1775, 1786.
[3] È del 1988 la prima retrospettiva (1973-1988) Shape-Shifter: the Art of Mary Beth Edelson, che li comprendeva e che dopo Washington fu esposta in varie sedi degli Stati Uniti.
[4] Quando Edelson iniziò la sua serie, il fondamentale testo di Erich Neumann The Great Mother: An Analysis of the Archetype era già stato pubblicato (1963), mentre è del 1974 il primo studio dell’archeologa lituana Marija Gimbutas sulle culture pre-patriarcali basate sul culto della Grande Dea The Gods and Goddesses of Old Europe, 7000-3500 B.C., riedito nel 1982 con il titolo The Goddesses and Gods of Old Europe: Myth and Cult Images cui seguiranno i più noti The Language of the Goddess, nel 1989, The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe, nel 1991.
[5] Mary Beth Edelson, Male Grazing: An Open Letter to Thomas McEvilley in Hilary Robinson (ed.), Feminism Art Theory: An anthology 1968-2014, Wiley-Blackwell, Chichester, 2015: 58
[6] Lucy Lippard, From the centre, Dutton, New York 1976: 138
[7] Mary Beth Edelson, The Art of Mary Beth Edelson, Seven Cycles, New York, 2002: 173
[8] Il riferimento è alle rappresentazioni più comuni dell’antichità in cui i simboli zodiacali sono raffigurati in piano in dischi circolari e disposti secondo una disposizione ad anello, come bordo del disco.
[9] Heresies: A Feminist Publication on Art and Politics. The Great Goddess, n. 5, Spring 1978.
[10] Dalla trascrizione della videointervista di Lynn Hershman-Leeson a Mary Beth Edelson, 7 Febbraio 2007, Archivies of American Art, Smithsonian Institution.
[11] da Hannah Arendt a Emily Brontë, Rosa Luxemburg, Iris Murdoch, Maria Callas, Colette, Angela Davis, Valerie Solanas, Marina Abramovic, la stessa Mery Beth Edelson solo per citarne alcune.
[12] Fra queste: nel 2006 la retrospettiva “Mary Beth Edelson: A Well Lived Life” del Konstmuseum di Malmö; nel 2007 la mostra “lt’s Time for Action (There’s No Option). About Feminism” del Migros Museum di Zurigo e “WACK! Art and the Feminist Revolution” al Museum for Contemporary Art di Los Angeles, poi esposta a Washington, New York e Vancouver; la mostra della Sammlung Verbund Collection di Vienna “Feminist Avant-Garde: Art of the 1970s” che ha girato in tutta Europa dal 201O al 2019; la retrospettiva del 2018-19 “Nobody Messes with Her” (Nessuno la fa arrabbiare) alla Kunsthalle Münster, Germania e nel 2017 nella personale “The Devil Giving Birth to the Patriarchy” (Il diavolo genera il patriarcato) alla David Lewis Gallery di New York, l’ultima mostra alla cui realizzazione l’artista ha effettivamente collaborato.
[13] Oggi i suoi lavori si trovano nelle più prestigiose collezioni d’arte contemporanea dalla Tate Modern al MOMA, dal Whitney Museum al Guggenheim di New York, dal Museum of Contemporary Art di Chicago al Malmö Kunstmuseum, per citarne alcune.
[14] Si vedano a proposito il saggio di Thomas McEvilley “Redirecting the Gaze”, nel testo a cura di Katy Deepwell, New Feminist Art Criticism: Critical Strategies, Manchester University Press, Manchester, 1995: 187-95 e la lettera aperta scritta nel 1989 da Mary Beth Edelson in risposta a quel saggio pubblicata in Hilary Robinson (ed.), op. cit.: 54-59
[15] L’esposizione di oltre 75 opere è ancora presente anche online sul sito dell’Archivies of American Art a questo link https://www.aaa.si.edu/exhibitions/what-is-feminist-art
______________________________________________________________
Mariella Pasinati, già insegnante di storia dell’arte, è impegnata nella ricerca e nella pratica pedagogica ed è presidente della Biblioteca delle Donne e centro di consulenza legale UDIPALERMO onlus. Autrice di saggi di storia e critica d’arte sull’opera di artiste contemporanee, ha anche curato: Insegnare la libertà a scuola. Rendere impensabile la violenza maschile sulle donne (Carocci, 2017); Riletture (Ila Palma, 1999); Parole di libertà (Ila Palma, 1992).
_______________________________________________________________