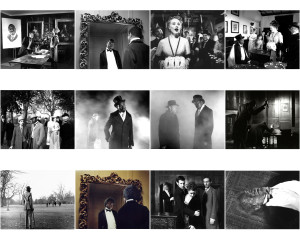di Mariachiara Modica
Yinka Shonibare è un’artista anglosassone contemporaneo di origini nigeriane la cui espressione artistica risulta basata su una certa idea di ibridazione culturale. Attraverso l’uso di diversi media, come pittura, scultura, fotografia e video, esplora il problematico concetto di “autenticità” legato all’arte africana e alla più generale categoria di arte primitiva (o tribale).
Yinka Shonibare nasce a Londra nel 1962, ma è a Lagos, in Nigeria, che trascorre la sua infanzia. All’età di 16 anni ritorna a Londra dove continua gli studi d’arte alla Byam School of Art (ora Central Saint Martins College), poi presso il Goldsmiths College [1]. Durante i suoi studi, Yinka inizia a concepire la propria creazione artistica come generatrice di uno spazio dove la riflessione critica sulla realtà si sposa con l’incanto e la bellezza di altri mondi possibili; così comincia a realizzare delle opere legate agli avvenimenti di politica internazionale di quegli anni (fine anni ’80 inizi anni ’90).
Il giovane artista racconta il momento decisivo di sviluppo della sua pratica artistica nel seguente modo:
«[…] At the art school I was introduced politics, […] so I made work about Perestrojka basically, that was going on in Russia, one of my tutor saw that and said: “well, why are you making work about Russia, why aren’t you making authentic African art ?”. I needed to find out really what he meant and I was looking for what authenticity, what might constitute authenticity really. I just found African masks, ritual African objects. At the time I felt no connection to my modern African life. […] I went to Brixton markets and found some fabrics there. […] I was imagined that the fabrics were authentically African and I was told that the fabrics are Indonesian influenced fabrics produced by the Dutch. But I like the history of the fabric and I like the global connections and the kind of trade routes of the fabrics. The fabrics are a very good metaphor for a contemporary African existence, if you like. That how I started to incorporate the fabrics into my works and Double Dutch was one of the first pieces I made on the fabrics […]» [2].
Dunque Shonibare utilizza i cosiddetti wax fabrics per riflettere sulla controversa questione di cosa implichi “autentica africanità”. I wax sono stoffe colorate spesso con toni molto accesi, frutto di una bizzarra connessione globale: derivano dai batik indonesiani, di cui si appropriarono gli olandesi (e in seguito altri Paesi europei) per avviare una produzione industriale in seguito commercializzata nell’Africa subsahariana e ancora oggi sono molto utilizzati per confezionare abiti. Successivamente i tessuti wax sono diventati simbolo di rinascita nazionale in Africa, nel periodo di indipendenza politica tra gli anni ‘60-‘70. Il tessuto, elevato a simbolo di orgoglio e differenza di un continente che rinasce, costituiva un particolare segno identitario che inglobava la storia coloniale come parte della costruzione della modernità dell’Africa. (Oguibe 1999: 39),
Con l’opera Double Dutch (1994) i wax/batik irrompono nella scena artistica contemporanea: piccole tele rettangolari di variopinti tessuti, su un fondo rosa, destrutturano il paradigma primitivista e il correlato discorso sull’autenticità giocando con l’estetica della serialità, ovvero, «la gradevole ripetizione di un modello già noto» (Steiner 2008: 143), fenomeno tipico della postmodernità e di una cultura di massa che si nutre di immagini iterate e ridondanti (Eco 1985: 169).
È ciò che concerne anche l’esperienza estetica dell’artigianato, nonché l’estetica classica, in base alla quale, è “bello” e apprezzato ciò che corrisponde alla ripetizione di un modello accettato e dunque familiare; a differenza della frenetica ricerca di romantiche forme di creatività, originalità e autenticità, che sono il terreno da cui prende avvio la rivoluzione artistica operata dal Modernismo.
Al tempo della riproducibilità dell’opera d’arte, gli artisti del Novecento, di indole progressista, sfidano le convenzioni visive della rappresentazione e lo statuto stesso dell’arte, troppo a lungo tenuta separata dalla vita, dunque da tutto ciò che essa implichi, compresa la quotidianità, la materialità e la produzione di massa. Si pensi, in tal senso, alla rivoluzione estetica apportata dal Dadaismo prima e dalla Pop Art dopo, che determina l’ingresso della serialità nel reame dell’arte ufficiale.
In Double Dutch, la frammentazione dell’idea di un grande eroico quadro si ricollega all’Espressionismo Astratto di Bernet Newman e Rothko (Chikukwa-Rebecchi 2006: 35). Nulla di nuovo che un’artista contemporaneao si riallacci a tali prassi, ma che ciò sia diventato appannaggio di un artista di origini nigeraniane, negli anni ’90, ha costituito una grande novità. Shonibare, in tal senso, è stato una fonte d’ispirazione per quegli artisti africani della diaspora desiderosi di volersi liberare dall’etichetta “arte tribale”, “neoprimitivsmo” o da qualsiasi riferimento all’etnicità ed avere uno spazio alla pari nel sistema dell’arte contemporanea (Oguibe 1999: 41). Sicuramente oggi gli artisti sono più inclini a valorizzare forme ibride, ovvero la contaminazione dell’arte africana con culture diverse (Cafuri 2005: 38), piuttosto che evocare un’Africa perduta, la selvaggia e primitiva Africa delle narrazioni occidentali.
Per quanto riguarda la definizione di “arte primitiva”, essa – come è noto – nasce dalla storia di fascinazione ad opera di Picasso e la sua generazione, nei primi decenni del XX secolo, nei confronti di quei manufatti non-occidentali che materializzavano il desiderio di oltrepassare i limiti della percezione e dell’immaginazione imposti all’arte occidentale fino a quel momento. In aggiunta, questi artisti individuavano nei prodotti di altre culture l’esistenza di forme di umanità integre e coese che agivano come totalità, in contrapposizione ad una modernità che appariva sempre più frammentata (Marcus-Myers 2008: 170).
Tali manufatti da “feticci etnografici” venivano promossi al rango di opere d’arte da collezionare e musealizzare. Una vicenda tra le altre che fa emergere un lato oscuro del modernismo: appropriarsi dell’alterità, selezionarla e riscattarla, secondo prassi nate di pari passo con le politiche imperialistiche e le logiche di potere del colonizzatore e del colonizzato (Clifford 1993: 231-234). Questa tendenza si manifestava con particolare evidenza nel 1984, con la mostra “Primitivism in the 20th Century Art. Affinity of the tribal and the modern” al MoMa (Museum of Modern Art) di New York, in cui artefatti non-occidentali (ribattezzati poi come “arte tribale”), venivano esposti in comunicazione con le opere delle avanguardie (Picasso, Matisse, Giacometti), sulla base di affinità che di sostanziale non avevano nulla, come James Clifford acutamente osservava (Clifford 1993: 221-226).
Ciò che accomunava le opere esposte è la comune predilizione per l’astrazione e il concettualismo, quindi una modalità differente di porsi nei confronti di quei canoni estetici che avevano dominato il concetto di arte dal Rinascimento al tardo Ottocento. La scelta espositiva non ha tenuto conto, né per le opere delle avanguardie, né per gli artefatti di interesse antropologico, di mostrare l’arte come processo culturale legato alla storia, alla società, alla politica. Nell’ esposizione al Moma, i manufatti di arte tribale sono stati collocati a sostegno di una migliore comprensione delle opere delle avanguardie, enfatizzando la tendenza, propria del paradigma primitivista, a costruire una definizione del sé sociale e culturale in opposizione all’altro, il diverso, l’estraneo.
Il diverso è spesso inteso come proiezione di ciò che penso che l’altro sia, secondo un modello oppositivo espresso in modo definitivo da Edward Said in Orientalismo (1991). Said spiega infatti che «[…] l’Occidente, nei suoi rapporti con l’Oriente, dà per scontato che quella realtà corrisponda effettivamente al modello che si è formato di essa e la tratta in conformità con questo assunto» (Miller 2008:119). Tuttavia, accade pure che la costruzione di modelli oppositivi lasci spazio all’istaurarsi di una relazione, che in quanto processo bidirezionale, si basa sulla reciprocità, come suggerisce un’altra storia che ha come protagonista il tessuto di stile orientale (motivi fitomorfi e infiorescenze stilizzate realizzate con ricchi broccati, seta e altre stoffe che palesano influenze cinesi, indiane, persiane). Andando alla ricerca del modello originario a cui si riferisce lo stile orientale, è emerso che esso è nato dalla mediazione tra le originarie decorazioni presenti in India e una certa idea di decorazione esotica maturata dagli inglesi (Miller 1991: 119-120).
I tessuti di stile orientale come i wax africani diventano l’oggettivazione di una connessione globale che avviene sulla base di un certo grado di bilaterità. Inoltre, spesso accade in storie come queste, che le rappresentazioni che ne scaturiscono, trasformate e risignificate, possono agire come importanti simboli identitari. Pertanto, il senso della poetica di Shonibare sta racchiuso nel suo continuo interrogarsi e interrogarci sui processi che si innescano nelle definizioni di forme culturali e costruzioni identitarie. Cos’è africano? Cos’è autentico?
Shonibare esplora questi temi attraverso precise scelte estetiche: introduce elementi di africanità in contesti vittoriani, come nell’opera The Victorian Philanthropist’s Parlour (1997-98); attraverso strategie performative, abitando i panni di Dorian Gray (2001) [3], l’emblema del Victorian dandy. Il tessuto “African” è utilizzato anche per confezionare abiti settecenteschi e ottocenteschi che avvolgono manichini senza volto dall’identità negata, che sfuggono ad ogni tentativo di steriotipizzazione e nello stesso tempo, ironicamente, rimandano alla decapitazione degli aristocratici durante la Rivoluzione francese.
Yinka racconta così la sua poetica:
«[…] I can grab people’s attention a bit more by displacing a territory they are familiar with. It’s not trying to make them get their heads around something that is totally removed from their cultural territory. It’s something they know. Then they can think “why is he doing that?”[…]» (Chikukwa-Rebecchi 2006: 36).
«I think there is a sort of re-contextualizing going on. If you see a Victorian man’s suit, but then it’s made by ethnic fabrics […] you do a double take because, both things are familiar to you and yet not familiar, there is a kind of confusion but then you are forced to reconsider what you are looking at […] what’s the relationship? Fashion always forces you to ask questions. There is the desire to challenge the establishment on one hand […] but occupying this space of the establishment I’m sort of minimizing the power of it, if you like» [4]
In questa visione, alcuni elementi risultano familiari e contemporaneamente si discostano da un modello originario, innescando l’esperienza della differenza:
«L’esperienza della differenza infatti esclude l’assoluta estraneità: il differente ci è in qualche modo familiare, ma “differisce” appunto da un presunto modello originario, generando un groviglio inestricabile e sconcertante fra identità e alterità» (Tosatti 2000: 84-85).
Sensazioni simili a quelle descritte da Kandinsky quando, entrando nel suo appartamento distrattamente, ritrovò un suo quadro capovolto e provò quella sensazione di dolce spaesamento che sopraggiunge quando ciò che è familiare si tramuta simultaneamente in qualcosa che non lo è più. La folgorazione della visione differente è un concetto imprescindibile di tutta l’estetica novecentesca [5] che, dopo Freud, si apre ad un mondo fatto di caos e di differenze e rinasce come spazio in cui coesiste la simultaneità e l’ambivalenza, in una parola il “perturbante” (da un noto saggio di S. Freud del 1919).
In Shonibare assistiamo alla ripetizione differente a partire da nuovi rapporti intessuti con il segno, la traccia tangibile del già dato e ripetuto che si carica di nuove sfumature di significato, quindi non cessa mai di divenire. Con la differenza si procede tra il noto e l’ignoto con passo di danza.
Shonibare descrive se stesso come “the rebel within”, poichè apre delle criticità e delle prospettive divergenti nel cuore stesso del sistema dell’arte, all’interno del quale occupa una solida posizione; infatti, al culmine del paradosso, è stato insignito nel 2004 del titolo di MBE (Member of the Order of British Empire) che da quel momento associa al suo nome.
Con l’opera di Yinka Shonibare il tessuto diventa metafora esistenziale dell’Africa e dei suoi rapporti con l’Europa, trasforma in esperienza estetica ciò che africanità implica alla luce della storia di mutuo scambio tra Primo e Terzo Mondo, di ieri e di oggi: una storia fatta di supremazia, schiavismo, colonialismo e post-colonialismo, diaspore e migrazioni, ma anche di affascinanti e bizzarre connessioni globali. Il tessuto wax è l’“autentica” espressione di questa bizzarra e affascinante relazione, permette di cogliere l’incanto e la bellezza anche nell’oscura storia di dominazione.
Inoltre, la poetica di Shonibare ci conduce oltre i vincoli imposti dal rapporto con un mondo dominato da una singola storia, generatrice di asimmetrie di potere, rivelandoci l’importanza di osservare svariate prospettive ed ascoltare molteplici narrazioni per riflettere a fondo su categorie culturalmente determinate, quali autentico/non autentico, africano/occidentale, per non cadere nel rischio della singola storia, usando l’espressione della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie «the danger of a single story»:
«This is how to create a single story: shows people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become […] The consequence of a single story is this: it robs a people of dignity. It makes recognistion of humal equality difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. Stories matter, many stories matter. Stories have been used to disposess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair the broken dignity […] When we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise» [6].
Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2019
Note
[1] Per ulteriori notizie biografiche cfr. http://www.yinkashonibare.com/biography/.
[2] “Portraying the Sordid Shadow of Colonial History: Yinka Shonibare” | Brilliant Ideas Ep. 4”.
Intervista diretta e prodotta da Fordham R. (2015), presente sul canale youtube della Bloomberg https://www.youtube.com/watch?v=x0rAIMV0k4M&t=23s (dal min. 5:53 al min. 8:02).
[3] L’estetica decadente di O. Wilde, circa cento anni dopo, viene risemantizzata da Yinka Shonibare cfr. Stilling R., “An Image of Europe:Yinka Shonibare’s Postcolonial Decadence”, in PMLA, Vol. 128, No. 2 (March 2013): 299-321.
[4] “Yinka Shonibare – Nigerian Identity and Art’s Limitations”, filmato da Bickerstadd D., prodotto da Waugh M. per DACS (2013), presente sul canale youtube della DACS for Artists https://www.youtube.com/watch?v=Za_E5xl1Qek&t=4s (dal min. 9:10 al min.10:17).
[5] Per un approfondimento sull’estetica del Novecento imperniata sull’esperienza della differenza cfr. Perniola 1997.
[6] “The danger of a single story” Chimamanda Ngozi Adichie in https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg&t=600s ( dal min. 13:50).
Riferimenti bibliografici
Amselle J. L. (2007), L’arte africana contemporanea, Bollati Boringhieri, Torino.
Bellucci V. (2003), Gli “atleti” della differenza: Derrida e Deleuze, in http://isonomia.uniurb.it/vecchiaserie/2003bellucci.pdf.
Benjamin W. (1991), L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi.
Cafuri R. (2005), L’arte della migrazione. Memorie africane tra diaspora, arte e musei, Trauben, Torino.
Chikukwa R., Rebecchi M. (2006), “Yinka Shonibare, MBE”,in Contemporary, No.88: 34-37, in http://www.yinkashonibare.com/press/.
Clifford J. (1993)., I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura ed arte nel XX secolo, Bollati Boringhieri, Torino.
Clifford, J. (2008), Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino.
Deleuze G. (1997), Differenza e Ripetizione, Raffaello Cortina, Milano.
Deridda J. (1991), La verità in pittura, Newton Compton, Roma.
Eco U. (1985), Sugli specchi e altri saggi. Il segno, la rappresentazione, l’illusione, l’immagine, Bompiani, Milano.
Giordano M. (2012), Trame d’artista. Il tessuto nell’arte contemporanea, Postmedia, Milano.
Marcus G.E., Myers F.R. (2008), “Lo scambio nell’arte e nella cultura”, in Caoci A. (a cura di), Antropologia, estetica e arte. Antologia di scritti, Milano: 151-204.
Miller D. (2008), “L’arte primitiva e la necessità del primitivismo per l’arte”, in Caoci A. (a cura di), Antropologia, estetica e arte. Antologia di scritti, Milano: 111-132.
Oguibe O. (1999), “Finding a Place: Nigerian Artists in the Contemporary Art World”, in Art Journal, vol. 58, No. 2: 31-41.
Perniola M., (1997), L’estetica del Novecento, Il Mulino, Bologna.
Steiner C. B. (2008), “Autenticità, ripetizione ed estetica della serialità. L’opera d’arte per turisti nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, Caoci A. (a cura di), in Antropologia, estetica e arte, Antologia di scritti, Milano: 133-150.
Stilling R. (2013), “An Image of Europe:Yinka Shonibare’s Postcolonial Decadence”, in PMLA, Vol. 128, No. 2: 299-321.
Tosatti B. (2000), “Io scrivo le parole sulla fronte e agli angoli della bocca (Paul Klee)”, in Bedoni G., Tosatti B., Arte e Psichiatria. Uno sguardo sottile, Gabriele Mazzotta, Milano.
___________________________________________________________________________
Mariachiara Modica, ha conseguito la Laurea Magistrale in Arti Visive presso l’Alma Mater Studiorum -Università di Bologna con tesi di laurea dal titolo: “La Collezione olandese De Stadshof. Peculiarità di una raccolta d’arte outsider approdata nel museo Dr. Guislain in Belgio”. Attualmente insegna presso gli istituti secondari di secondo grado, parallelamente continua ad approfondire il discorso sull’arte, in particolare contemporanea, da un punto di vista fenomenologico e semiotico; il linguaggio artistico come campo d’indagine delle dinamiche socio-culturali e generatore di azioni politiche.
___________________________________________________________________________