di Franca Bellucci
“Scuola” ha oggi un significato intenso e programmatico: oggi ‒ ed è una sfumatura che non risulta risalendo nei capitoli precedenti di questa parola antichissima ‒ il significato coincide con “percorso di cittadinanza”. Mi domando quando è accaduto e come me ne sono resa conto. Rifletto sulle parole, su questi “segni” o “cartellini” (“labels”, leggiamo nei testi sulle decifrazioni, per la corrispondenza di segni e significati): mentre disturba che le parole risultino nuove, le preferiamo in una vita lunga, e quindi inclini a riusi, nello svolgersi dei tempi.
Dalla singola parola, “scuola”, la riflessione si dilata. Penso alla combinazione di parole e cose nel tempo, nella storia. Mi dico che l’interpretazione con cui giudichiamo panorami reali e mentali ha bisogno di combinare insieme la fluidità del divenire e la stabilità del definire. Questo “definire” è tuttavia convenzione “non-puntuale”, che avrebbe bisogno periodicamente di “edizioni rivedute e corrette”. Il raccontare impone riferimenti e anche parole che, usate nella comunità dei parlanti, accettano di divenire approssimate o reinterpretate a distanza di tempo.
Torno alla parola “scuola”, che, scenario per me della professione e di anni intensi e fervidi, ho considerato cambiata nel concetto, dall’antico greco in cui “scholè” valeva “ozio”. La parola ha attraversato fasi: per secoli essa è stata appropriata per ambienti e curricoli fatti per sentieri in disparte, particolari. Anzi, i numeri dei coinvolti sono stati allora molto limitati, con evidenti contrasti che, sul tema di allargare e generalizzare la capacità di leggere, hanno definito addirittura regioni geografiche: in particolare, quelle delle confessioni religiose. Poi la parola è stata adattata per la formazione larga ma configurata gerarchicamente, ampia all’inizio ma ristretta nella conclusione, nelle nazioni del XIX-XX secolo. Ma la rifondazione dello Stato italiano in senso repubblicano e costituzionale ha imposto una ulteriore, profonda svolta: questa volta da intendere come orizzonte di opportunità percorribile da ciascuno, come base per gestire la propria vita. Dovrei approfondire per poter dire se questa situazione valga per il mondo intero: incontri internazionali su scuola e formazione sono attivi, efficaci per alcuni aspetti, ma ci sono tensioni e cose “non dette” che segnalano divergenze.
C’è stata una situazione specifica in cui l’attuale significato mi è divenuto chiaro. Forse avvertivo questa condizione già personalmente, nelle mie stesse scelte e nella conduzione attiva di compagni e compagne nelle classi che avevo frequentato, e poi dei miei stessi studenti. Molti di loro venivano da quella parte d’Italia che non aveva beneficiato dell’industrializzazione e altri, anche, erano di ritorno, dopo essere stati emigranti nell’Europa settentrionale. Riflettendo a casa sull’approccio opportuno, scrivevo versi che, abbandonati nei cassetti, avrei osato raccogliere molto più tardi: «Molti i tratti svaniti alla cultura/ che tenevano salda i genitori/ come scorie disperse in un gran vento…» (Bellucci, 2002: 17).
Rifletto: “venivano da parti d’Italia”, eppure dire “immigrazione” era comune e legittimo. La richiesta con cui giungevano nel luogo d’arrivo era precisa: inserirsi nelle realtà lavorative in espansione, inserirsi, e affiancare l’inserimento dei familiari se e quando giungeva il nucleo, negli istituti sociali e formativi preesistenti. Il programma di quegli immigrati, insomma, era chiaro e circoscritto. Eppure non è fuori luogo presumerlo simile a quello degli immigrati odierni. Intorno a questi c’è una zona d’ombra ampia, con interrogativi che stentano a sciogliersi – e forse che non si cura di sciogliere – e, da parte di chi abita i territori del passaggio e dell’arrivo, con una scala diversificata di freddezza, fino all’ostilità.
Eppure anche quel lontano moto, per il quale la densità di popolazione nel territorio peninsulare cambiò totalmente, ebbe fasi decisamente difficili: la socializzazione lenta, le differenze linguistiche, le rivalità nel sistemarsi sui lavori durarono alcuni anni. Ma, imprevisti dagli stessi “immigrati”, si delinearono anche obiettivi ulteriori, quando le donne del gruppo esposero loro stesse il desiderio di avere una giornata lavorativa retribuita. Era una sfida al patriarcato: suscitava la stessa violenza fisica nei maschi “immigrati” che gli ospedali avevano già conosciuto, nel nuovo corso di industrializzazione che aveva spopolato le campagne anche nel Centro-Nord. Era normale che stazionasse un agente di polizia nel Pronto soccorso, per registrare i referti. La frequenza della scuola, in questa situazione, c’era: quanto manovrata dai patriarchi, o patteggiata con questi, non appariva né era argomento che veniva indagato.
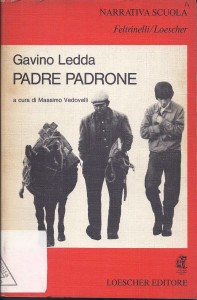 Che già si fosse fondata l’acquisizione del nuovo significato di “scuola” divenne inequivocabile, e direi generale, quando nel 1975 deflagrò il caso di Padre padrone, la storia della vita e della ribellione, o semplicemente della presa in carico di sé, di Gavino Ledda: nella Sardegna dei pastori, Ledda denunciava la relegazione nei ripari presso i recinti e tra i pascoli che, secondo la formazione tradizionale, i giovani, fossero pure eredi, erano costretti a continuare, in diniego del percorso indicato dalla legislazione. In urto con il padre egli allora aveva già fatto un percorso di studio da adulto, come filologo e glottologo.
Che già si fosse fondata l’acquisizione del nuovo significato di “scuola” divenne inequivocabile, e direi generale, quando nel 1975 deflagrò il caso di Padre padrone, la storia della vita e della ribellione, o semplicemente della presa in carico di sé, di Gavino Ledda: nella Sardegna dei pastori, Ledda denunciava la relegazione nei ripari presso i recinti e tra i pascoli che, secondo la formazione tradizionale, i giovani, fossero pure eredi, erano costretti a continuare, in diniego del percorso indicato dalla legislazione. In urto con il padre egli allora aveva già fatto un percorso di studio da adulto, come filologo e glottologo.
La vicenda può davvero considerarsi il saggio di una condizione non solo italiana. Quanto la situazione denunciata interpretasse una inadeguatezza diffusa nel mondo lo dimostrò il numero delle lingue in cui il libro fu tradotto, quaranta, e l’apprezzamento che riscosse il film, con lo stesso titolo, che nel 1977 ne trassero i fratelli Taviani, Palma d’oro in quello stesso anno al Festival di Cannes. Con il clamore del caso diventava evidente il senso nuovo della parola ‘scuola’, come percorso formativo principale e generalizzato per i giovani, passaggio fondativo della vita comunitaria. L’orizzonte era quello di una scuola inclusiva, da cui ciascuno impara a esplorare la società e le sue regole, e si dispone a impugnare personalmente la sua avventura.
Se il caso, per il valore anche simbolico che è proprio di un’opera narrativa e per l’ampio dibattito che sollevò, divenne prova inconfutabile della peculiarità intrinseca della scuola nell’età dell’Italia repubblicana, l’atmosfera in cui tutto questo si verificava era già carica: le varie cronache andavano testimoniando una operosità tesa a sviluppare inclusione nella scuola. È che, tra le molte difficoltà e i molti condizionamenti a riorganizzarsi che la vita complessiva avvertiva in Italia, dopo la catastrofe politica e bellica avvenuta, la Carta Costituzionale, pur se in un tempo lento, produceva una germinazione feconda.
A titolo di esempio, citerò il lungo dibattito, nelle commissioni parlamentari e sugli organi di stampa, intorno alla presenza e alla didattica del latino nella scuola dell’obbligo da prolungarsi, la trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, realizzata da Alberto Manzi, i movimenti per la “scuola del fare” di insegnanti e pedagogisti, collane editoriali come “La Ricerca” Loescher, il caso sollevato dalla comunità di Barbiana, piccola località non lontana da Firenze, guidata dal parroco Lorenzo Milani Comparetti: fu esposto per scritto come la Scuola di Stato respingesse, con il suo tradizionalismo ripetitivo che si teneva fuori del tempo. Ne scaturirono effetti istituzionali e sociali rilevanti, come la scuola media unificata a partire dal 1963, la fondazione di sindacati per la scuola nell’ambito del confederalismo, gli organi collegiali, il rinnovamento dei programmi scolastici e la legislazione per l’inclusione degli alunni svantaggiati. Nel 1978 lessi con la mia classe il libro di Ledda. Lo ritrovo fra molti ricordi e annotazioni (Ledda, 1978).
Oggi il riferimento alla scuola come percorso di inclusione per la compiuta cittadinanza è una potenzialità evidente, se consideriamo gli spostamenti in atto nel mondo, intensificati, messi alla prova anche senza situazioni prefigurate sicure. Ne ha, del resto, parlato di recente lo stesso Gavino Ledda, in un’intervista nel settembre 2020, in occasione della presentazione a Venezia del film Assandira, in cui lo studioso ha una parte: «Quello che scrissi era un atto dovuto per la mia storia ‒ egli ha detto. ‒ Quello che sono riuscito a fare dovevo raccontarlo, perché non era solo la mia vita, ma quella di molti pastori della Sardegna e del mondo».
 Ho presenti le parole di Gavino Ledda mentre leggo narrazioni fatte da migranti oggi in Italia: “racconti multimediali” che periodicamente si raccolgono per la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, con annotazioni che circostanziano adeguatamente. Leggo le riflessioni di Thierno Sadou Sow, quando decise di partire osservando i compaesani nella Guinea-Conakry, di cui molti erano «privati di molte possibilità, tipo aver accesso all’educazione …unica strada per trovarsi tra gli speranzosi» (Sadou Sow, 2019: 17). Aveva 13 anni Thierno Sadou Sow quando con compagni occasionali, ma solo, giunse a fine ottobre 2016 a Palermo, da dove fu trasferito a Polla in Calabria e poté concludere la scuola media. Aveva utilizzato le sue informazioni e la speciale versatilità per le lingue, fuggendo senza avvertire i familiari. Il padre, che l’aveva avviato alla scuola, era morto, e la madre, trasferitasi presso la famiglia d’origine, era in grande difficoltà nel Paese povero e disorganizzato, dopo l’uscita dalla Communauté Franco-Africaine.
Ho presenti le parole di Gavino Ledda mentre leggo narrazioni fatte da migranti oggi in Italia: “racconti multimediali” che periodicamente si raccolgono per la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, con annotazioni che circostanziano adeguatamente. Leggo le riflessioni di Thierno Sadou Sow, quando decise di partire osservando i compaesani nella Guinea-Conakry, di cui molti erano «privati di molte possibilità, tipo aver accesso all’educazione …unica strada per trovarsi tra gli speranzosi» (Sadou Sow, 2019: 17). Aveva 13 anni Thierno Sadou Sow quando con compagni occasionali, ma solo, giunse a fine ottobre 2016 a Palermo, da dove fu trasferito a Polla in Calabria e poté concludere la scuola media. Aveva utilizzato le sue informazioni e la speciale versatilità per le lingue, fuggendo senza avvertire i familiari. Il padre, che l’aveva avviato alla scuola, era morto, e la madre, trasferitasi presso la famiglia d’origine, era in grande difficoltà nel Paese povero e disorganizzato, dopo l’uscita dalla Communauté Franco-Africaine.
Dunque, la pista da valorizzare è questa: la scuola come grande via di emancipazione per ciascuno che si proponga alla visibilità, all’operatività del mondo. Questa formula è già sperimentata per quell’inserimento nella comunità, sotto il profilo personale e sociale, che vale il concetto di “cittadinanza”. La scuola potrà essere implementata nel tempo, in vari modi verificata per le fasi future di valorizzazione o reinserimento dei cittadini. Si direbbe acquisito che la scuola sta svolgendo oggi nel nostro Paese la funzione pienamente formativa, personale e istituzionale. Eppure risultano ancora difficoltà a trovare la formulazione che traduca in termini di articolato di legge il dato di fatto, quasi che, scorrendo dagli strati più direttamente coinvolti e dagli ambienti della formazione, a circoli di società chiusi su motivazioni altre, forse economicistiche, sbiadisse tale consapevolezza fino ad annullarsi.
L’attualità offre cronache contraddittorie e contrapposte, come se quelle zone che riteniamo meramente economicistiche esercitassero uno sguardo opaco. Così si fatica a trovare la sintesi, la scala condivisa per attivare norme adeguate ai nostri princìpi giuridici. Anzi la diversità delle disposizioni viene sintetizzata in slogan spregiudicati diffusi da alcuni politici nella speranza di accrescere il proprio peso. Ecco che l’immigrazione è citata anche fuori contesto in allusioni oscure e minacciose: aneddoti che contrappongono le strade del Paese svuotate dalla pandemia come nel coprifuoco, alle masse di immigrati che intanto “si rovesciano” (così viene detto) nei porti. Tutto questo ha un peso, frena fino a spegnere il moto di inclusione verso i migranti.
Ecco che la discussione latita: sulle comunità esterne al territorio nazionale non solo si ascoltano slogan qualunquisti, ma anche presuntuosi e ostili, residui di capitoli non ripensati della pur lontana colonizzazione italiana, dimenticando come sia analoga la situazione di tanti italiani approdati, e spesso rimasti, in Paesi lontani. Ed ha il suo peso, negli strati che curano soprattutto la ragione economica, avere a disposizione lavoratori meno tutelati: se, come pure si verifica per spontanee tradizioni, incontrare gruppi privi di tutele non è per molti di impedimento all’ospitalità e all’equità, si constata anche, e di frequente, che i soggetti meno tutelati dalla legislazione sono occasione di sfruttamento. Il Paese, nell’insieme, presenta sull’argomento degli immigrati sensibilità molto diverse, spesso contingenti: si danneggiano gli stranieri, ma si compromette anche la coesione del Paese. È da auspicare che l’opacità si superi con responsabili decisioni.
Più immediato e generale ascolto si attende per la regolamentazione sul tema della cittadinanza per i figli degli immigrati. Seguendo le cronache, in particolare traendole dal settimanale «L’Internazionale» diretto da Giovanni de Mauro, si ricavano sia dati di situazioni parallele da confrontare, sia approfondimenti sulla vita interna del Paese. L’argomento su questa rivista non è occasionale, e le formule ricorrenti, ius sanguinis, ius soli e ius culturae sono attentamente spiegate, le prime due in riferimento alle circostanze della nascita, ma il primo stringendo sui requisiti di entrambi o di almeno uno dei genitori, l’ultima riferita all’opportunità offerta dalla scuola. In un articolo del 5 agosto 2015, la nomenclatura è spiegata in occasione di un disegno di legge concordato alla Camera, che si sperava divenisse presto legge. L’argomento si è riacceso nel dibattito politico attuale, e Annalisa Camilli ne ha riferito il 15 marzo 2021.
 Rilevo anche appunti dal Belgio, utili per il confronto, ma anche per ricordare che l’Italia è Paese che conosce i due diversi movimenti: da una parte riceve immigrati, dall’altra ha sperimentato e sperimenta emigrazione. Il resoconto di Francesca Spinelli, l’8 aprile 2021, spiega appunto la questione della cittadinanza agli immigrati in Belgio, particolarmente riferendosi alla seconda generazione degli Italiani immigrati. L’argomento ha una storia lunga, in più episodi fra XX e XXI secolo, che ha oscillato fra ius soli e ius culturae, con interventi contingenti e quindi ripetuti, nella logica, come dice la giornalista, di “frenare e promuovere”. Ma particolarmente rilevanti considero due articoli, del 24 dicembre 2017 e del 19 novembre 2019, che Franco Lorenzoni scrive proprio esplorando l’argomento dal punto di vista della scuola. Nel primo si segnalavano le proteste per la delusione, non essendo maturata la legge sperata per regolamentare la cittadinanza, e in particolare si riferiva del coordinamento, denominato “Insegnanti per la cittadinanza”, realizzato per lo scopo dal Movimento di Cooperazione Educativa insieme con il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Nell’altro l’autore, condividendo la celebrazione della “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ratificata dall’Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991, intende rilanciare la mobilitazione per garantire «la cittadinanza al milione di minorenni figli di immigrati residenti nel nostro Paese». Egli descrive con attenzione le potenzialità delle attività a scuola come “classi mondo”, constatando: «Se ogni mattina guardiamo negli occhi bambine e bambini delle più diverse provenienze, ragazze e ragazzi le cui famiglie sono arrivate qui da lontano e crediamo con convinzione che la scuola sia il primo luogo pubblico dove sperimentare l’arte del convivere, è evidente che per noi la dignità di ciascuno è al primo posto e in qualche modo, nelle nostre classi, costruiamo giorno per giorno una sorta di piccola cittadinanza, che rende uguali tutti i nostri allievi e li sostiene nell’apprendimento».
Rilevo anche appunti dal Belgio, utili per il confronto, ma anche per ricordare che l’Italia è Paese che conosce i due diversi movimenti: da una parte riceve immigrati, dall’altra ha sperimentato e sperimenta emigrazione. Il resoconto di Francesca Spinelli, l’8 aprile 2021, spiega appunto la questione della cittadinanza agli immigrati in Belgio, particolarmente riferendosi alla seconda generazione degli Italiani immigrati. L’argomento ha una storia lunga, in più episodi fra XX e XXI secolo, che ha oscillato fra ius soli e ius culturae, con interventi contingenti e quindi ripetuti, nella logica, come dice la giornalista, di “frenare e promuovere”. Ma particolarmente rilevanti considero due articoli, del 24 dicembre 2017 e del 19 novembre 2019, che Franco Lorenzoni scrive proprio esplorando l’argomento dal punto di vista della scuola. Nel primo si segnalavano le proteste per la delusione, non essendo maturata la legge sperata per regolamentare la cittadinanza, e in particolare si riferiva del coordinamento, denominato “Insegnanti per la cittadinanza”, realizzato per lo scopo dal Movimento di Cooperazione Educativa insieme con il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Nell’altro l’autore, condividendo la celebrazione della “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, ratificata dall’Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991, intende rilanciare la mobilitazione per garantire «la cittadinanza al milione di minorenni figli di immigrati residenti nel nostro Paese». Egli descrive con attenzione le potenzialità delle attività a scuola come “classi mondo”, constatando: «Se ogni mattina guardiamo negli occhi bambine e bambini delle più diverse provenienze, ragazze e ragazzi le cui famiglie sono arrivate qui da lontano e crediamo con convinzione che la scuola sia il primo luogo pubblico dove sperimentare l’arte del convivere, è evidente che per noi la dignità di ciascuno è al primo posto e in qualche modo, nelle nostre classi, costruiamo giorno per giorno una sorta di piccola cittadinanza, che rende uguali tutti i nostri allievi e li sostiene nell’apprendimento».
Lo sguardo della rivista «Internazionale», e in particolare le considerazioni di Franco Lorenzoni sulla contiguità e la condivisione che quotidianamente esercitano ragazzi e insegnanti, sono appropriati e convincenti. Se, insieme ai dispositivi formativi e alle associazioni che egli descrive soprattutto nella scuola di base, consideriamo i vari cicli, i vari indirizzi della scuola, i corsi che, numerosissimi, vengono disposti ovunque per tutti i livelli degli apprendimenti, torniamo ad evidenziare come sia appropriato a raggiungere piena cittadinanza il sistema ampio e vario delle scuole intese come “laboratori culturali”: tali che rispondano a bisogni contingenti ma mantenendo attive le verifiche della tradizione e della scientificità, certo anche prevedendo verifiche e adattamenti a seconda delle fasi che il Paese vive e vivrà in futuro: e confrontandosi con la comunità internazionale, così che si avvicini la comprensione e il confronto, nell’elasticità, dei tanti modi di declinare le culture.
Volutamente lascio sospesa la questione, se l’ospitalità sia una caratteristica marcatamente diversa nelle comunità: se, insomma, ci siano culture di per sé ospitali o non ospitali. È vero, abitudini lunghe, ripetute, nel senso dell’ospitalità o nel senso della diffidenza possono incidere, come nei gesti, così nel profondo del pensiero. Tuttavia ontologizzare le caratteristiche provoca pregiudizi incrociati, che deteriorano il dialogo: come quando, ed è l’esperienza attuale, si catalogano “Paesi virtuosi” e “Paesi spendaccioni”. Seguo con qualche interesse gli interventi filosofici sul tema: tuttavia vince un’istanza di cautela, tale che anche l’esercizio per me più frequente, quello di pensare le parole, magari accanto a letture sparse dall’antico al contemporaneo, non mi dà soluzioni, ma piuttosto mi enfatizza i paradossi. Penso alle radici linguistiche dell’ospitalità, quella che in latino presiede al significato di “ospite” e insieme quella di “ostilità” – e che, si badi, nell’inglese odierno, come “ghost”, vale “fantasma” –, quella che in greco marca “l’essere uno di fuori”, vox media che dà “xenìa” come “ospitalità” e “xena” come “terra straniera”.
Difficile, mi pare, pensare che le soluzioni, le pacificazioni, scaturiscano dall’oblio della terra, quasi cancellata: “terra”, “luogo natale”, “patria”, sono, come si deve riconoscere, riferimenti profondi, magari in una molteplicità di elaborazioni, di gradi che vanno dall’amore all’odio, di metafore. Questi gradi di sentimento comunque valgono come sogno e/o propulsione, come lo è Itaca in Kavafis: «…Itaca – / raggiungerla sia il pensiero costante», ma non palese all’esterno, se molti e vari si succedono i programmi messi in opera da un individuo.
 Rivaluto come una straordinaria meditazione sull’ospitalità, quel gioiello poetico, per altro di cui non si rintracciano modelli anteriori, che Ovidio dedicò alla povera coppia dei vecchi Filemone e Bauci, nell’ottavo libro delle Metamorfosi. Sono Giove e Mercurio che approdano alla loro capanna in vetta a un monte, e, in un ambiente di povertà estrema, trovano l’eccezione, nella ricerca di una ospitalità che ovunque è stata negata. E ci si accorge di ironia e paradosso, o di amaro realismo: poiché proprio loro sono gli dèi dell’ospitalità, Giove nel regno degli eventi atmosferici e Mercurio in quello nascosto, oltremondano, forse di sconosciute perturbazioni. Insieme, dunque, i due dèi evocano il cosmo del noto e dell’ignoto, la sintesi pensabile dall’individuo umano. Eppure hanno raccolto ovunque sberleffi e dinieghi. Invece nella capanna povera ma concorde dei vecchietti coniugi, i due dèi ricevono un onore spontaneo, che sarebbe gratuito per la volontà degli ospitanti, se non fosse che Giove «il figlio di Saturno», insiste per compensarli, mentre punisce con sdegno apocalittico gli inospitali della valle, sommergendoli di acque.
Rivaluto come una straordinaria meditazione sull’ospitalità, quel gioiello poetico, per altro di cui non si rintracciano modelli anteriori, che Ovidio dedicò alla povera coppia dei vecchi Filemone e Bauci, nell’ottavo libro delle Metamorfosi. Sono Giove e Mercurio che approdano alla loro capanna in vetta a un monte, e, in un ambiente di povertà estrema, trovano l’eccezione, nella ricerca di una ospitalità che ovunque è stata negata. E ci si accorge di ironia e paradosso, o di amaro realismo: poiché proprio loro sono gli dèi dell’ospitalità, Giove nel regno degli eventi atmosferici e Mercurio in quello nascosto, oltremondano, forse di sconosciute perturbazioni. Insieme, dunque, i due dèi evocano il cosmo del noto e dell’ignoto, la sintesi pensabile dall’individuo umano. Eppure hanno raccolto ovunque sberleffi e dinieghi. Invece nella capanna povera ma concorde dei vecchietti coniugi, i due dèi ricevono un onore spontaneo, che sarebbe gratuito per la volontà degli ospitanti, se non fosse che Giove «il figlio di Saturno», insiste per compensarli, mentre punisce con sdegno apocalittico gli inospitali della valle, sommergendoli di acque.
Ed ecco quale è la ricompensa che i due vecchi accettano, nella capanna divenuta un tempio: «Poiché concordi abbiamo trascorso la vita, uno stesso istante ci faccia morire, che non veda io la tomba della consorte, né che sia lei a dovermi seppellire» (Ovidio, 2011: 132, mia traduzione). Così moriranno insieme, come insieme sono vissuti, diventando un doppio tronco, a memoria della loro storia. Nel racconto, si toccano insieme il dono che l’ospite riconoscente porge e il suo effetto mortale. Inevitabile pensare a quel “dono avvelenato” che gli antropologi hanno evidenziato e indagato, a partire da Marcel Mauss, segno precipuo di ambiguità, di spazio equivoco. Ma più ampio e profondo si intuisce uno spazio sapienziale da accettare, fra i due umani e le due divinità. Si intuiscono i modi del proporsi, del confrontarsi nel diverso piano dell’esistere. Pure si verifica una sintesi che è interpretazione e riemersione dei vecchi nel rango della vita vegetale. Le due coppie si sono intese, riconosciute, interpretate. Così H.-G. Gadamer (Gadamer, 2004: 605), parlando della comprensione nell’ambito dell’ermeneutica, indica lo sbocco «in una partecipazione ad un senso comune» della comprensione, che pure «non consiste in una comunione di anime».
La tradizione letteraria, benché sia centrale nell’istruzione e nella formazione del gusto, non può essere la luce che orienta per fornire dottrine e princìpi su cui si fondano molteplici quadri sociali, cambiati nel tempo. Dovrebbe esserlo la storia: ma opportunamente si confrontano tipologie diverse di fonti, perché i quadri si disegnino da più punti di vista, avendo costatato che i documenti scritti non sono ben interpretabili, se non si ricostruisce chiaramente su quali imput sono stati composti, a quale pubblico si rivolgevano e con quale intendimento.
Comunque i programmi scolastici non mirano davvero a far conoscere le diversità delle epoche. Disposti in successione di tempo per gli ordinamenti scolastici, sono tutt’altro che mirati ad un sapere scevro di pregiudizi: portano tracce vistose di quando furono disposti, fra XIX-XX secolo, in un’Europa che si disponeva a far sentire la sua prevalenza nei vari continenti: la guerra come motore di civiltà, il passato esposto per giustificare il programma ufficiale del presente ipotecano tuttora i programmi. Il nome di “nazione” che, ad indicare le entità statali, prevalse in quella fase costruttiva della contemporaneità, in cui quasi si rivendicò una continuità diretta dall’Impero augusteo: quel termine non era certo un’eredità classica, dove “natio, -onis” vale “schiera”, “ceto”, e in Tertulliano, apologeta cristiano vissuto fra II e III sec., indica chi era di religione pagana. In realtà la luce obliqua, poco affidabile, che imputo ai programmi scolastici di storia, ha anche impronte dilatate, poiché il modello del connettivo narrativo è stato esportato per molte altre discipline che costituiscono il curricolo scolastico.
Insofferente di fronte a sintesi didattiche corrispondenti a pregiudizi, ho letto con interesse, su «Domenica» del «Sole 24 Ore» del 13 Ottobre 2019, l’articolo-recensione di Nicola Gardini, Tacito e i Germani che incarnano l’oltre. Nei programmi scolastici, per lo più vige il luogo comune di inquadrare in modo contrapposto il viaggio nel mare, presentato come ambiente di fruttuosa collaborazione nel Mediterraneo in secoli considerati di espansione collaborativa, e quello in terraferma, esposto come “invasioni”, “barbarie”, “ingiusta sofferenza”. Nel suo testo invece Gardini va dritto sull’esegesi, che loda come pertinente nel libro commentato, così da mettere a fuoco il programma di Tacito nella specifica fase. Gardini va poi oltre, per un discorso di didattica che, fatto sul latino come disciplina, ritengo però valido in generale. L’autore, auspicando che la scuola lasci la consueta pretesa «di fare tutto, dall’inizio alla fine» mentre di fatto «si costringe a far bene ben poco di ciascuna cosa», suggerisce che, messa al centro una specifica lettura, si effettuino intorno excursus rigorosi, tracciati induttivamente dal testo, così da esplorare livelli formali e disciplinari, e si ricostruisca il contesto in modo critico e aggiornato. «Se studiamo induttivamente – egli dice – il dettaglio richiamerà il contesto, senza dissolversi nell’indistinto e nelle narrazioni generali; il semplice si articolerà nel complesso».
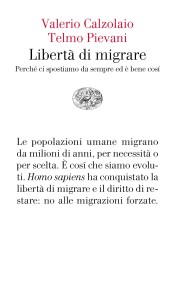 È evidente che questa critica non vuole affatto sminuire la scuola. Così anche da parte mia: malgrado le inadeguatezze dell’impianto disciplinare, confermo che la scuola si è costituita come l’asse principale della formazione come primo esercizio di cittadinanza. La vita della e nella scuola è infatti ben altro, oltre al quadro affollato eppure incerto dei manuali. Un grande peso nel percorso di formazione ha proprio il confronto serrato, nell’esercizio del dialogo, su un panorama sufficientemente ricco, aperto, problematico, tale da allargare la scuola a coinvolgere fonti culturali vive e molteplici, nonché gli stessi autori. Constato, per esempio, in esperienze scolastiche a me vicine, che è abituale fra gli studenti l’applicazione individuale e collettiva e, ben istradata a suscitare echi interiori durevoli, si dispone con sensibilità intorno alle opere: tesi aggiornate rispetto a quelle tradizionali danno adito a confronti pacati. Frutto di attenta e critica esplorazione, per quanto concerne l’ambito classico, pur con i loro titoli paradossali, sono, per esempio, le opere agili di piccolo formato che l’antropologo- filologo Maurizio Bettini pubblica presso il Mulino. Esplorando, in Hai sbagliato foresta, il lessico dell’“identità”, lo studioso osserva che l’uso specioso, presso media influenti, di parole spacciate per antiche ha un effetto di stortura ideologica. Invece in Elogio del politeismo Bettini valorizza e recupera il senso della molteplicità, la ricchezza ma anche la distanza di tradizioni e istituzioni che caratterizzava lo spazio mediterraneo, romanizzato con Augusto.
È evidente che questa critica non vuole affatto sminuire la scuola. Così anche da parte mia: malgrado le inadeguatezze dell’impianto disciplinare, confermo che la scuola si è costituita come l’asse principale della formazione come primo esercizio di cittadinanza. La vita della e nella scuola è infatti ben altro, oltre al quadro affollato eppure incerto dei manuali. Un grande peso nel percorso di formazione ha proprio il confronto serrato, nell’esercizio del dialogo, su un panorama sufficientemente ricco, aperto, problematico, tale da allargare la scuola a coinvolgere fonti culturali vive e molteplici, nonché gli stessi autori. Constato, per esempio, in esperienze scolastiche a me vicine, che è abituale fra gli studenti l’applicazione individuale e collettiva e, ben istradata a suscitare echi interiori durevoli, si dispone con sensibilità intorno alle opere: tesi aggiornate rispetto a quelle tradizionali danno adito a confronti pacati. Frutto di attenta e critica esplorazione, per quanto concerne l’ambito classico, pur con i loro titoli paradossali, sono, per esempio, le opere agili di piccolo formato che l’antropologo- filologo Maurizio Bettini pubblica presso il Mulino. Esplorando, in Hai sbagliato foresta, il lessico dell’“identità”, lo studioso osserva che l’uso specioso, presso media influenti, di parole spacciate per antiche ha un effetto di stortura ideologica. Invece in Elogio del politeismo Bettini valorizza e recupera il senso della molteplicità, la ricchezza ma anche la distanza di tradizioni e istituzioni che caratterizzava lo spazio mediterraneo, romanizzato con Augusto.
L’esemplificazione non vuole essere né modello né prescrizione: ma solo dare il polso della vitalità complessiva che caratterizza mediamente l’istituzione scolastica. Entro questa vitalità individuo, ma in modo solo orientativo, dati i miei limiti, che l’analisi e la guida specifiche, su cui commisurare il disegno e le articolazioni, attengono al quadro giuridico. Lungo questo profilo, i contenuti, le attività, le narrazioni possono trovare la loro dimensione e il loro posto: in modo appropriato per i bisogni attuali complessivi e specifici. Muoversi migrando è fenomeno antico quanto sono antichi i gruppi umani, per bisogni e per aspirazioni: lo si fa all’interno del Paese ove si è nati e lo si fa cercando soluzioni in Paesi lontani. I due processi sono descritti insieme in un pamphlet del 2016 di V. Calzolaio e T. Pievani: la descrizione complessa che viene fatta della situazione porta i due autori a enfatizzare la necessità della “lungimiranza”: «Un processo così radicato nella storia e nella geografia dell’evoluzione umana può essere governato soltanto con lungimiranza… in vista di una attività comune e di un futuro aperto» (Calzolaio, Pievani, 2016: IX).
Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021
Riferimenti bibliografici
Bellucci, Franca, Immigrazione, in Bildungsroman. Professione insegnante 1973 ‒ 1991, Fucecchio, Edizioni dell’Erba, 2002: 17
Calzolaio, Valerio, Telmo Pievani, Libertà di migrare, Torino, Einaudi, 2016
Gadamer, Hans-Georg, Verità e metodo. II, 1, Storicità della comprensione intesa come principio ermeneutico, Milano, Bompiani, 2004: 550-635
Ledda, Gavino, Padre padrone (a cura di Massimo Vedovelli), Torino, Loescher editore, 1978
Ovidio, Metamorfosi, v. IV, Libri VII-IX, vv. 620-724. Traduzione di Gioachino Chiarini, Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori, 2011: 125-133
Sadou Sow, Thierno, La forza dei sogni, in Se il mare finisce, Milano, Terre di mezzo, 2019: 15-47.
Sitografia
https://www.internazionale.it/opinione/francesca-spinelli/2021/04/08/lezione-belgio-ius-soli
https://www.internazionale.it/notizie/2015/08/05/ius-soli-temperato-cittadinanza-immigrazione
https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2021/03/15/ius-soli-cittadinanza
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2019/11/19/ius-soli-insegnanti
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2017/12/24/ius-soli-scuola-senato
______________________________________________________________
Franca Bellucci, laureata in Lettere e in Storia, è dottore di ricerca in Filologia. Fra le pubblicazioni di ambito storico, si segnalano Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano (Pisa, 2008), nonché i numerosi articoli editi su riviste specializzate. Ha anche pubblicato raccolte di poesia: Bildungsroman. Professione insegnante (2002); Sodalizi. Axion to astikon. Due opere (2007); Libertà conferma estrema (2011).
______________________________________________________________








