Marcel Appenzzell, brillante allievo di Malinowski, dedicò la sua breve carriera accademica allo studio della popolazione Orang-Kubu di Sumatra cercando di applicare alla lettera gli insegnamenti del maestro. A ventitré anni lasciò la natìa Vienna per recarsi in Asia e intraprese un’avventurosa ricerca etnografica che lo tenne impegnato per quasi sei anni. Quando ricomparve, ritrovato da una squadra di esplorazione mineraria sulle rive del fiume Musi, pesava ventinove chili e aveva perso quasi del tutto l’uso del linguaggio.
Di ciò che era accaduto nella foresta di Sumatra non parlò a nessuno, ripromettendosi di presentare i dati raccolti durante un seminario sugli usi e costumi delle popolazioni Anadalam organizzato da Marcel Mauss a Parigi. Tuttavia, più il giorno della conferenza si avvicinava più Appenzzell si faceva nervoso e, a pochi giorni dall’avvio dei lavori (non aveva ancora preparato il testo del suo intervento), bruciò tutti gli appunti lasciando solo un conciso biglietto alla madre. Rinunciava al seminario e tornava a Sumatra: non si sentiva in diritto di divulgare alcuna informazione sulla tribù che aveva studiato. Dalle fiamme si salvò solo un quadernetto zeppo di note confuse che un gruppo di studenti dell’Istituto di Etnologia iniziò a decifrare. Per quasi cinque anni, essi appresero, Appenzzell aveva cercato invano di stabilire un contatto con i Kubu ma, ogni volta che raggiungeva i loro insediamenti, essi fuggivano inoltrandosi nella foresta. Negli appunti di campo l’etnografo austriaco aveva riportato i suoi turbamenti: che cosa spingeva la tribù a muoversi di continuo? Si trattava forse di motivazioni ecologiche legate all’attività di caccia e raccolta? O era piuttosto un comportamento legato a una pratica religiosa? Nulla di tutto questo, concluse lo studioso prima di arrendersi: «era per causa mia che abbandonavano i villaggi e solo per scoraggiare me sceglievano regioni ogni volta più ostili, imponendosi condizioni di vita sempre più tremende per farmi ben vedere che preferivano affrontare tigri e vulcani, paludi, nebbie soffocanti, elefanti, ragni mortiferi, piuttosto che l’uomo!».
Marcel Appenzzell non è mai esistito, egli è il frutto della penna e dell’ingegno di Georges Perec. Benché si tratti di finzione letteraria, però, la sua vicenda personale e scientifica testimonia bene, con la forza che solo la grande letteratura può avere, il gravoso compito toccato agli etnografi: produrre dati scientifici partendo da esperienze del tutto personali (Geertz 1990: 17).
Vediamo, dunque: cos’ha da mostrare agli antropologi in carne e ossa la sorte di Appenzzell? Per prima cosa, la problematicità della nozione malinowskiana di empatia e le inevitabili difficoltà della relazione antropologo/nativo che s’innescano durante una ricerca etnografica. Difficoltà acuite dal fatto che tale relazione non prevede un semplice schema binario bensì un sistema tripartito in cui accanto allo studioso e alla sua popolazione si colloca il pubblico (accademico e non) cui esso parla.
In secondo luogo, la triste storia di Appenzzell rivela che l’idea di «campo» come entità naturale e circoscritta (che esiste indipendentemente dall’arrivo e dall’azione conoscitiva dell’antropologo) è solo il frutto di certa immaginazione antropologica. Gli indigeni Kubu si spostano incessantemente e non hanno un centro ma l’etnografo malinowskiano di Perec è privo degli strumenti concettuali adeguati a concepirne il movimento rispetto alla permanenza.
In terzo luogo, il racconto rivela le difficoltà della testualizzazione dell’esperienza etnografica. La cronaca di un fallimento scientifico così netto, almeno nella percezione di Appenzzell, e dell’incapacità di poter scrivere al riguardo aiuta a mostrare lo scarto temporale, esistenziale, epistemologico tra, in termini geertziani, l’essere lì e l’essere qui.
Infine, la vicenda fa luce sulle implicazioni etico-politiche del lavoro antropologico. Le responsabilità dell’etnografo non si esauriscono sul campo, a contatto con la gente che studia, ma continuano anche a casa quando arriva il momento della scrittura e l’alterità deve essere resa comprensibile pur mantenendone l’estraneità.
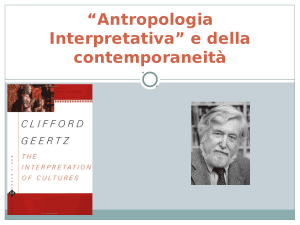 Di questi temi, e di molti di più, si discute nell’ultimo volume di Vincenzo Matera, Antropologia contemporanea. La diversità culturale in un mondo globale (Laterza 2017) in cui l’autore si confronta con le sfide che il mondo odierno pone all’antropologia. Forse apparirà curioso, o addirittura poco ortodosso, iniziare l’analisi di una pubblicazione scientifica con un esempio tratto da un romanzo. Tuttavia, per una disciplina che è ormai abituata a riflettere sulle proprie strategie narrative – fino a sostenere, con alcuni suoi rappresentanti, che molti dei propri nodi epistemologici nascondano in realtà problemi retorici (cfr. Miceli 2004) – credo non sia una scelta scandalosa. La storia di Appenzzell, tra l’altro, è rappresentativa di un certo modo (inattuale, lo definirebbe proprio Matera) di guardare alla cultura e alla ricerca sul campo.
Di questi temi, e di molti di più, si discute nell’ultimo volume di Vincenzo Matera, Antropologia contemporanea. La diversità culturale in un mondo globale (Laterza 2017) in cui l’autore si confronta con le sfide che il mondo odierno pone all’antropologia. Forse apparirà curioso, o addirittura poco ortodosso, iniziare l’analisi di una pubblicazione scientifica con un esempio tratto da un romanzo. Tuttavia, per una disciplina che è ormai abituata a riflettere sulle proprie strategie narrative – fino a sostenere, con alcuni suoi rappresentanti, che molti dei propri nodi epistemologici nascondano in realtà problemi retorici (cfr. Miceli 2004) – credo non sia una scelta scandalosa. La storia di Appenzzell, tra l’altro, è rappresentativa di un certo modo (inattuale, lo definirebbe proprio Matera) di guardare alla cultura e alla ricerca sul campo.
Data la densità del volume e l’ampiezza delle tematiche affrontate, anziché seguire linearmente lo sviluppo dei capitoli del libro, discuterò il filo rosso che percorre il ragionamento di Matera, almeno per come l’ho inteso, circa l’attuale stato dell’arte e il futuro dell’antropologia. In un mondo che non è mai stato così interconnesso, sostiene l’autore, l’antropologia non può più permettersi un ripiegamento eccessivo nella dimensione locale rinunciando ad applicare la sua finezza interpretativa all’analisi del cambiamento culturale nell’intero sistema-mondo. L’ecumene odierna, infatti, col movimento incessante che la contraddistingue, pone alla disciplina una grande sfida: affinare gli strumenti per porre tutti gli esseri umani in una dimensione di contemporaneità. Rispetto ad altri saperi (o al senso comune) che si rifugiano ancora in concetti vetusti e reificati (Tradizione, Modernità, Sviluppo, Sottosviluppo, Cultura, Identità etc.), essa può, in virtù dell’elasticità epistemologica che le è propria, far valere la sua storica frequentazione dell’alterità; a patto, però, di ridiscutere seriamente alcuni dei suoi dogmi. Per una disciplina che è sempre stata in crisi (in passato per la paura di perdere il proprio oggetto, il nativo, oggi per il timore di perdere l’esclusiva del metodo etnografico), si tratta davvero di una prova decisiva che mette in gioco responsabilità scientifiche, etiche e politiche che non si possono più ignorare.
Antropologia contemporanea non è un libro di storia della disciplina. Come scrive lo stesso autore, è piuttosto una “ricognizione” dell’antropologia odierna alla ricerca dei pregi e dei difetti che, da una parte, la rendono particolarmente adatta a leggere le dinamiche socio-culturali odierne e, dall’altra, la spingono verso una dimensione eccessivamente micro che, per troppo tempo (anche dopo che la disciplina è tornata a casa e ha cessato di essere solo lo studio dei selvaggi), ha impedito a molti dei suoi cultori di confrontarsi con la dimensione dei macro-scenari globali (Matera 2017: 12). Da questo punto di vista, l’etnografia (la metodologia basata sulla ricerca di campo) è croce e delizia: ecco il filo rosso che attraversa la riflessione di Matera. Con una posizione che sicuramente farà discutere, lo studioso individua nell’eccessivo appiattimento sul «campo» lo scarso peso pubblico rivestito oggi dall’antropologia:
«sono convinto che uno dei punti critici dell’antropologia contemporanea sia proprio dovuto a uno sbilanciamento tutto a favore della prima dimensione, quella etnografica, che mal si adatta alle esigenze dettate dai cambiamenti di portata planetaria degli ultimi decenni, che richiederebbero una forte capacità di teorizzare i processi culturali da cui deriverebbe, a mio parere, un altrettanto forte capacità di incidere nella sfera pubblica e nell’ambito accademico» (Ivi: 14).
Matera, infatti, critica «il fanatismo etnografico imperante» e l’idea – avanzata con forza da Clifford Geertz (1987) – che antropologia faccia rima con etnografia. Tale posizione, acriticamente accettata sull’onda dell’entusiasmo per il manifesto geertziano (Matera 2017: 22), ha condannato l’antropologia a una «frammentazione estrema» e a un «eccesso di specialismo». Ha spinto, cioè, i ricercatori a cercare minuzie negli angoli di mondo perdendosi il quadro generale e lasciando principalmente ad altri (privi, molto spesso, di conoscenze di prima mano) la riflessione sull’interconnessione delle società umane e, di conseguenza, la responsabilità di parlare della (e alla) sfera globale (Matera 2017: 23-24).
 La mistica del campo, meccanicamente riproposta oggi, rischia così di reiterare l’immagine inattuale di culture tradizionali non toccate dai flussi globali e di far richiudere la disciplina in se stessa condannandola alla marginalità. Matera, a questo proposito, si discosta dal richiamo di Francesco Remotti proprio a favore di un’antropologia inattuale (Ivi: 17). Remotti, infatti, ha recentemente difeso Malinowski ed Evans-Pritchard dalle accuse di aver deliberatamente ignorato gli effetti del contatto con l’Occidente dei gruppi da essi studiati ricordando che, per vocazione, l’antropologia deve dare precedenza a interessi archeologici:
La mistica del campo, meccanicamente riproposta oggi, rischia così di reiterare l’immagine inattuale di culture tradizionali non toccate dai flussi globali e di far richiudere la disciplina in se stessa condannandola alla marginalità. Matera, a questo proposito, si discosta dal richiamo di Francesco Remotti proprio a favore di un’antropologia inattuale (Ivi: 17). Remotti, infatti, ha recentemente difeso Malinowski ed Evans-Pritchard dalle accuse di aver deliberatamente ignorato gli effetti del contatto con l’Occidente dei gruppi da essi studiati ricordando che, per vocazione, l’antropologia deve dare precedenza a interessi archeologici:
«I nostri predecessori hanno fatto molto bene a non descrivere i Trobriandesi o i Nuer nella loro effettiva condizione di contemporaneità rispetto al ricercatore, ma a cercare di mettere da parte le trasformazioni, le occidentalizzazioni, le modernizzazioni, al fine di ricostruire le istituzioni e i costumi di prima. […] poniamoci questa domanda: se non avessero fatto così, se non avessero operato questa selezione, quanta ricchezza culturale sarebbe andata perduta?» (Remotti 2014: 102)
La scelta di Matera, al contrario, va in direzione di un’antropologia attuale e rilevante, di un sapere in cui chi conosce e chi è conosciuto possano essere se non soggetti simmetrici – giacché, come ha mostrato Talal Asad (1973: 17), in antropologia una totale simmetria tra i poli in relazione non può mai darsi – almeno contemporanei, figli dello stesso tempo:
«Scrivendo «siamo tutti contemporanei» intendo affermare che lo sforzo principale dell’antropologia […], il compito più impegnativo che ha davanti, consiste proprio nel presentare e interpretare le vite degli altri come impregnate di eventi che avvengono tra contemporanei e lungo una frontiera segnata da una lunghissima storia di incontri» (Matera 2017: 20).
Secondo Matera, porre tutti gli esseri umani in una dimensione di contemporaneità richiede un diverso modo di guardare all’etnografia e all’immagine di cultura che intorno ad essa si è formata. Seguendo i più recenti sviluppi della riflessione disciplinare, pertanto, «campo» e «cultura» vanno assunti non come dati naturali che si offrono allo sguardo del ricercatore, bensì come finzioni fabbricate in un periodo storico importante per il consolidamento dell’antropologia scientifica che non si possono più applicare dogmaticamente (Matera 2017: 41). L’autore, quindi, ne ripercorre genesi e sviluppo per argomentare la sua tesi: oggi che la «cultura» emerge come «trama complessa e costellata di intrecci tra tradizioni subordinate e dominanti» (Ivi: 45) è più che mai necessario andare oltre il campo. Lo esigono considerazioni epistemologiche: la straordinaria ricchezza interpretativa dell’antropologia, infatti, col suo corollario di continue decostruzioni di oggetti, teorie e categorie, resta inespressa se, una volta giunti sul terreno, i ricercatori ne restituiscono un’immagine anacronisticamente guidata dall’interesse professionale per l’autentico [1] (Ivi: 45-46). Lo reclamano motivazioni politiche: il paradigma della contemporaneità mette in primo piano la responsabilità verso l’altro e l’etica della ricerca (Ivi: 51-52).
È noto come l’accesso diretto al campo abbia rappresentato uno spartiacque nell’evoluzione del pensiero antropologico. Malinowski in Gran Bretagna e Boas negli Stati Uniti superarono la divisione tra etnografi (raccoglitori) e antropologi (teorici) tipica dell’antropologia vittoriana e considerarono fondamentale la ricerca etnografica decretandone i parametri. C’era un’evidente necessità alla base della loro azione: legittimare la propria disciplina offrendole un oggetto e una metodologia specifici. Fu in questo scenario che «campo» e «cultura» presero forma. Da quel momento, il terreno diventò una vera e propria ossessione e gli antropologi che seguirono gli insegnamenti dei maestri codificarono, spesso inconsapevolmente, alcune regole di messa a fuoco degli oggetti rimaste paradigmatiche. La celebre immagine della tenda dell’antropologo piazzata al centro del villaggio studiato (la tenda di Malinowski citata da Clifford o quella di Evans-Pritchard evocata da Rosaldo) si rivelò un potentissimo dispositivo utile a rafforzare l’idea di società e culture ancorate a un territorio e a creare l’illusione che il ricercatore potesse averne una conoscenza olistica coniugando le pratiche ossimoriche dell’osservazione e della partecipazione (Matera 2017: 41). Particolari scelte retoriche per restituire l’alterità al pubblico europeo, inoltre, fecero il resto (Ivi: 39-43).
 Così, da una parte, la trasposizione monografica dell’esperienza etnografica (con la scelta di privilegiare la terza persona plurale, il presente etnografico e l’occultamento dell’osservatore nel testo) contribuì a spostare l’altro in una dimensione allocrona negando – nonostante la relazione vis à vis sperimentata sul terreno – la coevità tra la società dell’antropologo e quella del nativo (cfr. de Certeau 2005; Fabian 2001). Dall’altra, l’accento sulla diversità culturale dell’indigeno portò a localizzare l’altro, a chiuderlo nel suo spazio (puro, incontaminato, isolato) a dispetto della mobilità e delle relazioni multiple con l’esterno da esso intrattenute (cfr. Clifford 1993 e 2001; Fardon 1990; Gupta, Ferguson 1997).
Così, da una parte, la trasposizione monografica dell’esperienza etnografica (con la scelta di privilegiare la terza persona plurale, il presente etnografico e l’occultamento dell’osservatore nel testo) contribuì a spostare l’altro in una dimensione allocrona negando – nonostante la relazione vis à vis sperimentata sul terreno – la coevità tra la società dell’antropologo e quella del nativo (cfr. de Certeau 2005; Fabian 2001). Dall’altra, l’accento sulla diversità culturale dell’indigeno portò a localizzare l’altro, a chiuderlo nel suo spazio (puro, incontaminato, isolato) a dispetto della mobilità e delle relazioni multiple con l’esterno da esso intrattenute (cfr. Clifford 1993 e 2001; Fardon 1990; Gupta, Ferguson 1997).
Tutto ciò produsse un nuovo modo di guardare alla «cultura». Gli etnografi, infatti, passarono dall’analisi della Cultura come disposizione comune a tutti gli esseri umani (pur all’interno di un’inaccettabile impostazione evoluzionista) allo studio delle culture come espressione di gruppi umani distinti. Un passaggio, all’apparenza neutro e pacifico (per via della giusta avversione verso la teoria evoluzionista) che – avverte Matera – ha lasciato in eredità problemi di enorme portata (Matera 2017: 74):
«Oggi che molto pensiero antropologico sulla cultura è rimasto radicato nei «siti di campo», gli antropologi sanno molto sulle culture locali […] ma non sanno granché più, rispetto a trent’anni fa, sulla Cultura, su come funzioni, e su come si trasformi nel mondo più esteso oltre il locale» (Ivi: 75).
Inoltre, per aver indugiato troppo sull’organicità delle culture (fino a trasformarle in isole chiuse sorde alle reti d’interazioni tra le società e alla fluidità dei confini), i ricercatori hanno forgiato una nozione rigidamente relativista che, nonostante le critiche cui è stata sottoposta negli ultimi anni, è sfuggita al loro controllo (Ivi: 76). Oggi, in effetti, sembra che nessuno possa fare a meno della «cultura» e, come ha spiegato Ugo Fabietti (2008), essa è diventata un «concetto spiega-tutto» usato per innalzare muri e chiudersi nella propria visione del mondo più che per produrre effettiva conoscenza. Una moneta di scambio, legittimata dal discorso politico e mediatico, da utilizzare per avanzare richieste di riconoscimento nello scacchiere globale [2].
Seguendo il ragionamento di Matera, quindi, si potrebbe sostenere che le strategie cognitive storicamente messe in atto dall’antropologia abbiano finito non solo per ingabbiare l’alterità ma per limitare le stesse potenzialità antropologiche a un approccio etnografico “parrocchiale”. Così, ciò che oggi manca a molti antropologi è il coraggio di produrre un grande discorso sul cambiamento culturale globale: sembra quasi abbiano paura di uscire dalle ristrettezze (e dalla comodità) dei contesti locali per tornare a sperimentare discorsi macro che, soprattutto dopo la crisi delle grandi narrazioni, sono visti con sospetto (Matera 2017: 85-86). Il superamento del fanatismo etnografico deve invece condurre a una concreta discussione del dogma della ricerca sul campo come conditio sine qua non della disciplina. L’antropologia, sostiene Matera, ovviamente non può non fondarsi su ciò che proviene dal «campo» [3 ]: decostruzione non vuol dire distruzione. Però non vi si deve arenare, a maggior ragione dopo averne rivelato il carattere costruito e finto: «il mondo è molto più ampio del campo» (Ivi: 56-57). Così, in un periodo in cui altre discipline (sociologia, psicologia sociale, storia, economia) scoprono il terreno, l’antropologia non può più legittimare se stessa solo attraverso l’etnografia; magari irrigidendosi nello stabilire parametri in grado di distinguere una vera esperienza etnografica da una fasulla. Essa, al contrario, dovrebbe distinguersi, più che per la metodologia (che può prevedere anche l’etnografia vis à vis), per «il modo di delineare i problemi di ricerca e di definire dal punto di vista concettuale i propri oggetti» (Ibidem).
 Tale posizione invita la disciplina ad adottare una prospettiva «bipolare»: «cogliere le trasformazioni che investono la vita delle persone […] adottando uno sguardo etnografico focalizzato sulla scala locale; allargare poi sempre di più la scala prospettica dilatando la nostra osservazione nello spazio e nel tempo» (Ivi: 91). Solo così si potranno evitare ambigui essenzialismi culturali e si riuscirà a cogliere l’intreccio tra discorsi locali e globali restituendo tutta l’umanità a una dimensione di contemporaneità. L’antropologia, infatti, – scrive Matera nell’Introduzione – «se intesa solo come studio della diversità sociale e culturale, perde un pezzo, resta incompleta, delude le aspettative» (Matera 2017: 8). Essa, al contrario, sulla scorta delle indicazioni di Fischer e Marcus (1998) e di De Martino (2000), deve farsi «analisi critica della realtà attuale»: un progetto intellettuale che non dimentichi mai la storicità del proprio sguardo sull’altro e che non resti imbrigliato nelle maglie della società che l’ha prodotto dandole per scontate (Matera 2017: 23-24). Alla base di una tale visione, oltre a considerazioni di ordine epistemologico, ci sono motivazioni di natura etico-politica poiché, per dirla con Geertz (2000: 551), oggi «la nebbia cala molto prima di giungere a Calais». I confini tra noi e loro, cioè, non sono più netti e chiaramente definiti (ammesso che lo siano mai stati!) e l’alterità è accanto a noi, magari nel nostro stesso pianerottolo: il modo in cui ci accosteremo a essa determinerà l’esito della convivenza (Matera 2017: 117-119).
Tale posizione invita la disciplina ad adottare una prospettiva «bipolare»: «cogliere le trasformazioni che investono la vita delle persone […] adottando uno sguardo etnografico focalizzato sulla scala locale; allargare poi sempre di più la scala prospettica dilatando la nostra osservazione nello spazio e nel tempo» (Ivi: 91). Solo così si potranno evitare ambigui essenzialismi culturali e si riuscirà a cogliere l’intreccio tra discorsi locali e globali restituendo tutta l’umanità a una dimensione di contemporaneità. L’antropologia, infatti, – scrive Matera nell’Introduzione – «se intesa solo come studio della diversità sociale e culturale, perde un pezzo, resta incompleta, delude le aspettative» (Matera 2017: 8). Essa, al contrario, sulla scorta delle indicazioni di Fischer e Marcus (1998) e di De Martino (2000), deve farsi «analisi critica della realtà attuale»: un progetto intellettuale che non dimentichi mai la storicità del proprio sguardo sull’altro e che non resti imbrigliato nelle maglie della società che l’ha prodotto dandole per scontate (Matera 2017: 23-24). Alla base di una tale visione, oltre a considerazioni di ordine epistemologico, ci sono motivazioni di natura etico-politica poiché, per dirla con Geertz (2000: 551), oggi «la nebbia cala molto prima di giungere a Calais». I confini tra noi e loro, cioè, non sono più netti e chiaramente definiti (ammesso che lo siano mai stati!) e l’alterità è accanto a noi, magari nel nostro stesso pianerottolo: il modo in cui ci accosteremo a essa determinerà l’esito della convivenza (Matera 2017: 117-119).
Ci sono segnali che, purtroppo, non spingono in questa direzione e il monito di Matera coglie nel segno quando l’etnografia si fa megafono di ambigue visioni antropologiche. Penso, ad esempio, alle contemporanee declinazioni militari dell’expertise etnografica che ho già trattato in questa sede (Inglese 2016) e all’idea che l’antropologia possa essere scienza al servizio delle strategie belliche. In questi casi, per riprendere le parole di Matera (2017: 28), l’etnografia funge da metodologia pacchetto applicabile acriticamente ma ciò che manca è una seria riflessione sull’epistemologia che la nutre; in particolare, sul concetto di cultura e su quanto sia difficile (se non impossibile) parlare di autenticità, purezze ed essenze culturali. Quando gli antropologi al seguito delle truppe affermano di voler «conoscere la cultura del nemico», infatti, dimenticano che il terrorismo è un fenomeno transnazionale la cui anima non si può certo scovare in una porzione di territorio. Ignorano, cioè, che esso non è il prodotto atavico e primordiale di una supposta cultura o mentalità islamica avulsa dal globale ma l’esito di complesse dinamiche scalari (Appadurai 2005; Asad 2009).
D’altra parte, a mio avviso, la frequentazione dell’alterità da parte degli antropologi resta ancora una carta decisiva per comprendere meglio di altri un’ecumene mondiale in cui, a dispetto delle paure di mcdonaldizzazione, la globalizzazione produce e riproduce nuovi ordini di differenza [4]: i più recenti studi etnografici sulle migrazioni, sulle retoriche e le pratiche d’accoglienza, sui movimenti sociali e le politiche identitarie, sui nuovi media o sull’evoluzione del lavoro nel sistema neoliberista lo dimostrano. Di sguardo dal basso (Fava 2010), insomma di etnografia, continua a esserci un gran bisogno. Ovviamente di etnografia che, come suggerisce saggiamente Matera, assuma pienamente le conseguenze della continua opera di ripensamento e decostruzione delle categorie antropologiche.
Si tratta di una strada non semplice ma l’antropologo che vorrà percorrerla, ancorché spaesato, non si troverà del tutto privo di appigli: al contrario, come scrive Matera, avrà a disposizione tanta riflessione disciplinare cui richiamarsi. Pur con i loro limiti, ad esempio, certe intuizioni della scuola diffusionista (ovviamente depurate dall’arbitrario quadro teorico generale) e, soprattutto, le etnografie micro-macro della scuola di Manchester (che trascendevano l’idea di luogo) possono far parte di quello che Hannerz (2012) ha definito «il passato che si può usare» (Matera 2017: 85-90). Inoltre, la maturità che la disciplina ha mostrato nel rilevare il coinvolgimento ermeneutico tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, la ridiscussione costante dei propri tropi e l’interesse per la restituzione testuale delle esperienze sono altri aspetti da utilizzare nell’analisi dei panorami e dei flussi globali attuali. Studiosi come Arjun Appadurai e Ulf Hannerz (o, aggiungo io, David Graeber), da questo punto di vista, hanno mostrato le potenzialità dell’antropologia nell’affrontare la polverizzazione della modernità e l’incessante movimento prodotto dalla globalizzazione economica, politica e culturale. Sì, un tal modo di lavorare, rischia di dilatare esponenzialmente il campo di osservazione portando l’etnografo fuori dal terreno classicamente inteso. Tuttavia, ciò «non comporta la fine dell’osservazione della quotidianità delle persone, dell’analisi delle microinterazioni, ma porta a considerare quei dettagli, quelle microinterazioni come parte dei molteplici mondi che li attraversano, li oltrepassano e li ricostituiscono continuamente» (Ivi: 93).
 Sprecare la più matura riflessione disciplinare per chiudersi etnograficamente in un terreno locale avulso dallo spazio globale contraddice lo sforzo della disciplina verso l’analisi della complessità. È questo, credo, il messaggio che Matera intende far passare. Più opportuno, invece, seguire con maggior vigore le tendenze che cercano di dar conto dell’interconnessione del mondo odierno: l’etnografia multi-situata, la netnografiaonline, le riflessioni sulle nozioni di habitus, performance e repertorio culturale individuale come crocevia di più «ampie cornici sociali e culturali entro cui i soggetti contemporanei possono agire (o essere agiti)» (Ivi: 159). La cultura, secondo questi orientamenti, non può più essere vista come un oggetto statico e localizzato che dirige meccanicamente la vita di individui territorializzati, bensì come uno spazio dal quale essi parlano. Uno spazio mutevole, attraversato e intersecato da altri spazi e livelli, in cui micro e macro si richiamano vicendevolmente. In tale scenario l’uomo odierno, scrive Matera riprendendo una celebre immagine lévi-straussiana, è un novello bricoleur alle prese con una cassetta degli attrezzi quanto mai varia: «la connessione tra vite locali e progetti, oggetti e idee transnazionali è la matrice delle identità globali contemporanee» (Ivi: 170).
Sprecare la più matura riflessione disciplinare per chiudersi etnograficamente in un terreno locale avulso dallo spazio globale contraddice lo sforzo della disciplina verso l’analisi della complessità. È questo, credo, il messaggio che Matera intende far passare. Più opportuno, invece, seguire con maggior vigore le tendenze che cercano di dar conto dell’interconnessione del mondo odierno: l’etnografia multi-situata, la netnografiaonline, le riflessioni sulle nozioni di habitus, performance e repertorio culturale individuale come crocevia di più «ampie cornici sociali e culturali entro cui i soggetti contemporanei possono agire (o essere agiti)» (Ivi: 159). La cultura, secondo questi orientamenti, non può più essere vista come un oggetto statico e localizzato che dirige meccanicamente la vita di individui territorializzati, bensì come uno spazio dal quale essi parlano. Uno spazio mutevole, attraversato e intersecato da altri spazi e livelli, in cui micro e macro si richiamano vicendevolmente. In tale scenario l’uomo odierno, scrive Matera riprendendo una celebre immagine lévi-straussiana, è un novello bricoleur alle prese con una cassetta degli attrezzi quanto mai varia: «la connessione tra vite locali e progetti, oggetti e idee transnazionali è la matrice delle identità globali contemporanee» (Ivi: 170).
L’antropologia dovrà, pertanto, essere in grado di leggere le dinamiche di questo bricolage (che, si badi, non equivale a un accesso paritario e generalizzato a risorse e possibilità) attingendo a tutta la sua capacità immaginativa e alla flessibilità del suo sguardo (Ivi: 171). Per vincere questa sfida e non condannarsi alla marginalità (o peggio al silenzio), l’antropologia del futuro sarà chiamata allora a seguire e, riprendendo la vicenda di Marcel Appenzzell, inseguire con pazienza le reti di comunicazione e connessione tra i gruppi umani. Non più studio della diversità culturale chiusa in un suo ipotetico spazio bensì progetto conoscitivo che, come diceva Geertz (2001), si distingua dal senso comune e dagli altri saperi per la sua carica sovversiva e la capacità di sgretolare ogni certezza. A non cambiare resterà una cosa: il “giro lungo” (Remotti 1990) sarà sempre, qualsiasi sia l’idea di «campo» che la sottenda, il tratto caratteristico dell’antropologia. Il suo valore aggiunto.
Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017
Note
[1] E poi, si chiede Matera riprendendo le amare considerazioni di Lévi-Strauss in Tristi tropici, qual è il grado di autenticità da ricercare (Matera 2017: 20)? Quanto indietro bisogna andare per trovare la «vera Lahore»? (Lévi-Strauss (1960: 40-41)
[2] Ciò, per l’appunto, è il risultato del progressivo scivolamento dell’antropologia verso il particolarismo etnografico e la conseguente attenzione rivolta alle culture rispetto alla Cultura. Tuttavia, pur recando con sé una buona dose di ambiguità, secondo Matera il concetto di «cultura» non va liquidato (come molti propongono) semmai puntellato. «Abbiamo molte ottime ragioni» – scrive l’autore – «per accettare che a) una tale «cosa» che chiamiamo «Cultura» è socialmente acquisita e organizzata […]. Possiamo anche accettare che b) è in una qualche maniera integrata, anche se il passaggio della Cultura verso l’integrità (o integrazione, in senso sistemico) è un passaggio «morbido». […] Tuttavia, non siamo (non più) tenuti ad accettare l’assunzione che è uniformemente distribuita entro le comunità, che è qualcosa di impacchettato, strettamente legato ai differenti gruppi umani, e che questi sono, normalmente, localizzati entro territori delimitati» (Matera 2017: 77). Così, «per reinserire la cultura nella teoria antropologica» (Ivi: 80), Matera si serve del concetto di creolizzazione elaborato in linguistica: «la dimensione culturale globale è […] un continuum creolo, fatto di flussi di significati culturali che sono disposti in modo molto complessi da attori molto diversi lungo scale molto variabili e gradi variabili di reificazione e di fluidità» (Ivi: 82).
[3] Per l’antropologia, scrive Matera, si pone sempre il problema della referenza. Rispetto al discorso filosofico, ad esempio, il patto con il lettore sottoscritto da ogni antropologo si basa necessariamente su una «conoscenza empirica che trae dall’esperienza (sociale) il suo fondamento» (Matera 2017: 50-51).
[4] Come sostenuto da Appadurai in un incontro tenuto a Milano lo scorso 27 Luglio, con la modernità anche l’identità si è polverizzata e siamo passati «dal concetto di individuale a quello di dividuale». Ciò può portare a disorientamento e nostalgia per tempi in cui i confini culturali apparivano più definiti: fenomeni che alimentano rivendicazioni identitarie e rigurgiti xenofobi e populisti cui l’antropologia deve prestare attenzione. Per guardare l’intervento completo dell’antropologo indiano si veda il sito: http://www.meetthemediaguru.org/lecture/lecture-arjun-appadurai/
Riferimenti bibliografici
Appadurai A., 2005, Sicuri da morire. La violenza nell’epoca della globalizzazione, Meltemi, Roma.
Asad T. (a cura di), 1973, Anthropology and the Colonial Encounter, Ithaca Press, London.
Asad T., 2009, Il terrorismo suicida. Una chiave per comprenderne le ragioni, Raffaello Cortina, Milano.
Clifford J., 1993, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura, arte nel XX secolo, Bollati Boringhieri, Torino.
Clifford J., 2001, Strade: viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino.
Clifford J., Marcus G. E. (a cura di), 1996, Scrivere le culture, Meltemi, Milano.
de Certeau M., 2005, La scrittura dell’altro, Raffaello Cortina, Milano.
De Martino E., 2000, La fine del mondo, Einaudi, Torino.
Fabian J., 2001, Il tempo e gli altri, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli.
Fabietti U., 2008, Il destino della «cultura» nel «traffico delle culture», in Matera V. (a cura di), Il concetto di cultura nelle scienze sociali contemporanee, Utet, Torino: 37-46.
Fardon R., 1990, Localizing Strategies. Regional Traditions of Ethnographyic Writings, Smithsonian Institution Press, Washington.
Fava F., 2010, Lavoro nero allo Zen, in Vignato S. (a cura di), 2010, Soggetti a lavoro. Per un’etnografia della soggettività nel lavoro, Utet, Torino: 19-35.
Fischer M., Marcus G., 1998, Antropologia come critica culturale, Meltemi, Roma.
Hannerz U., 2012, Il mondo dell’antropologia, a cura di D’Agostino G. e Matera V., Il Mulino, Bologna.
Geertz C., 1987, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna.
Geertz C., 1990, Opere e vite. L’antropologo come autore, Il Mulino, Bologna.
Geertz C., 2000, Gli usi della diversità, in Borofsky R. (a cura di), L’antropologia culturale oggi, Meltemi, Roma: 546-560.
Geertz C., 2001, Anti-Anti Relativismo, in Geertz C., 2001, Antropologia e filosofia, Il Mulino, Bologna: 57-83.
Gupta A., Ferguson J., (a cura di), 1997, Culture, Power, Place. Explorations in Critical Anthropology, Duke University Press, Durham & London.
Inglese D., 2016, L’antropologia in Guerra. Il caso Human Terrain System, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 18
Lévi-Strauss C., 1960, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano.
Miceli S., 2004, Parole in gioco. Saperi e sapori dell’antropologia post-geertziana, in Archivio Antropologico Mediterraneo, n. 5/7: 35-46.
Perec G., 1984, La vita istruzioni per l’uso, Rizzoli, Milano.
Remotti F., 1990, Noi primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Bollati Boringhieri, Torino.
Remotti F., 2014, Per un’antropologia inattuale, Eléuthera, Milano.
_______________________________________________________________________________
Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.
________________________________________________________________








