«Il signore parte?» chiese. «Sì» rispose Phileas Fogg. «Andiamo a fare il giro del mondo». Passepartout, con gli occhi sbarrati, le palpebre e le sopracciglia alzate, le braccia aperte e il corpo afflosciato, mostrava tutti i segni della meraviglia spinta fino allo sbalordimento. «In ottanta giorni» rispose il signor Fogg. «Per cui non abbiamo un istante da perdere».
La fermezza dell’eccentrico Phileas Fogg fa da contraltare allo sbalordimento dell’ingenuo e vivace domestico Passepartout, chiamato a seguire il suo padrone nella più grandiosa delle missioni: Il giro del mondo in ottanta giorni, raccontato nell’omonimo capolavoro di Jules Verne.
Simile conflitto emozionale si presta alla perfezione a introdurre questo contributo, che intende ragionare sul viaggio e su quanto – pratico e meno – lo concerne, a partire da un recente lavoro di Giovanni Messina edito da Angelo Pontecorboli e presentato da Giulia de Spuches, About the journey. Stasis, chiasmus and interruptions A geography essay (Firenze 2022), su cui tornerò regolarmente. Prima, mi preme sottolineare un aspetto in particolare della natura del viaggio, fatto di ogni cultura: quello di avere un peso diverso per ciascuno degli abitanti del mondo. Questo rende opportuno investirlo, da specialisti, di quel ruolo chiarificatore che, dentro i mondi culturali e fra essi, si attribuisce ai fenomeni in grado di accomunarli come di distinguerli, consentendo di spiegarne la sfuggente complessità e financo di arrischiarsi nella proposta di una regola. O, almeno, di porsi delle domande pertinenti.
Per tentare una lettura critica dell’idea di viaggio e delle sue implicazioni, insomma, bisogna anzitutto chiarire cosa esso non rappresenti: un fatto eminentemente fisico. Viaggiare costituisce infatti una contingenza individuale e mentale, prima che collettiva e materiale, ovvero rigenerante o logorante come accettato dall’immaginario occidentale moderno. Se esso diventa normalità nella memoria collettiva è proprio per la sua capacità di implicare altro oltre la dimensione materiale e corporea. La sua binomia è, a ben vedere, giustificata: si tratta della pratica umana in assoluto più in grado di incrinare, revisionare e capovolgere gli orizzonti di senso definiti e le consuetudini personali e culturali, soggiogando il concetto più permeante che l’ominazione ci consenta di pensare: lo spazio, l’al di là di noi stessi.
Ed è l’incognita spaziale che, per prima nella vicenda umana, alimenta il senso (e i sensi) del viaggio, osservabile come il più paradossale dei concetti geografici: l’unico a non ammettere quello, decisamente più “antropologico”, di confine, o quantomeno a consentirci di superarlo senza eccessivi patemi [1]. Si tenga presente, ad esempio, quanto oggi si viaggi enormemente più di prima e in infiniti modi, ma allo stesso tempo si accetti, nel proprio bagaglio esperienziale e conoscitivo, un indeterminato numero di trincee e limiti plurimi, che media e palinsesti virtuali riescono a prospettare nei modi pervasivi della perenne disponibilità digitale tale da compromettere l’irripetibilità dell’esperienza.
 Generalmente, sebbene il punto di vista (colto) occidentale lo concepisca come un’esperienza ricreativa, più o meno limitatamente accessibile e solitamente edificante, non per tutti il viaggio inaugura il momento della sospensione benefica com’è accolto. Oggi, mentre scrivo, soprattutto nel dibattito pubblico il viaggio è la tragedia dell’abbandono forzato della propria terra natia per il mare minaccioso [2] – viatico verso porti sicuri ma altri, verso la speranza, che unisce ciò che la terra divide [3] – come anche la fuga da una guerra che dilania le carni, le persone, l’identità, i popoli. Cosa rappresenta poi la morte, per tante culture antiche e moderne, e forse anche per noi tutti, se non un viaggio, quello sovrasensibile per antonomasia, verso un ignoto che specialmente nelle strutture religiose del pensiero si scopre salvifico perché proiettabile oltre la consunzione corporea e l’acredine sociale di un mondo che comunque ci vede scomparire per sempre? E nell’ambito della modernità non è forse nel gergo giovanile di tante realtà italiane che, nel lessico, incontriamo il “viaggio” come esperienza di amplificazione sensoriale conseguente all’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, e dunque nuovamente come proiezione dell’individuo in una dimensione altra da sé, nefasta a posteriori?
Generalmente, sebbene il punto di vista (colto) occidentale lo concepisca come un’esperienza ricreativa, più o meno limitatamente accessibile e solitamente edificante, non per tutti il viaggio inaugura il momento della sospensione benefica com’è accolto. Oggi, mentre scrivo, soprattutto nel dibattito pubblico il viaggio è la tragedia dell’abbandono forzato della propria terra natia per il mare minaccioso [2] – viatico verso porti sicuri ma altri, verso la speranza, che unisce ciò che la terra divide [3] – come anche la fuga da una guerra che dilania le carni, le persone, l’identità, i popoli. Cosa rappresenta poi la morte, per tante culture antiche e moderne, e forse anche per noi tutti, se non un viaggio, quello sovrasensibile per antonomasia, verso un ignoto che specialmente nelle strutture religiose del pensiero si scopre salvifico perché proiettabile oltre la consunzione corporea e l’acredine sociale di un mondo che comunque ci vede scomparire per sempre? E nell’ambito della modernità non è forse nel gergo giovanile di tante realtà italiane che, nel lessico, incontriamo il “viaggio” come esperienza di amplificazione sensoriale conseguente all’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, e dunque nuovamente come proiezione dell’individuo in una dimensione altra da sé, nefasta a posteriori?
In ogni caso, è chiaro che al concetto sia attribuibile l’idea di rottura, scollamento e cambiamento, poiché l’altrove «lo si incontra uscendo dal proprio sguardo, osservando il mondo con gli occhi degli altri» [4] e acquisendo un nuovo modo di osservare la realtà. Scartare e interrompere per accogliere e avanzare è l’invito del viaggio e il punto d’incontro dei principi che reca, fondanti una contraddizione di cui il geografo Giovanni Messina propone una lettura originale e inedita. Nel suo About the journey. Stasis, chiasmus and interruptions, il viaggio diviene un “dispositivo tripartito” (tripartite system) che si fonda su un processo scandito da tre momenti conoscitivi: quello dell’origine o della stasi, del pensare e concepire l’esperienza del viaggio, che con la sua carica di attesa e vigile predisposizione prelude all’attivazione fisica vera e propria; quello dell’innesco o del cominciamento, fase che attiva il viaggio nella sua materialità sensoriale di connessione dell’uomo ai luoghi, che ri-significa; infine, in sua funzione, quello dell’esperienza, ovvero della produzione semantica, volta a tradurre il fatto empirico in elemento del vissuto, «della e nella memoria».
Sulla scorta gnoseologica della New Cultural Geography, simile ripartizione – che Messina suggerisce per scandagliare il viaggio in quanto struttura multiforme del pensiero, prima che dell’esperienza stessa – sembra inserirsi alla perfezione nell’economia della ricerca dell’altrove, prima pensato che vissuto dall’uomo e caro alla “prima” antropologia. Il viaggio, che sorge precedentemente al suo “atto d’innesco”, si avvia infatti con l’esigenza dell’utile, raggiunto soltanto col superamento dello stupore per il tramite del governo delle sensazioni, spesso avverse, che una nuova geografia impone all’estraneo, al forestiero; implica, soprattutto, quei “processi cognitivi fondanti” che abbiamo nostri nello scrutare l’alterità.
Sono approdato alle ragioni dell’antropologia dagli studi geografici, certo non per caso. Ricordo, in particolare, che un’opera su tutte ha rivestito un ruolo cruciale per la mia comprensione dell’oggetto geografico: Vi piace la geografia? di Armand Frémont [5]. Fra le sue righe, prende corpo uno dei più efficaci contributi all’esigenza di chiarire cosa rappresenti la geografia e cosa sia in grado di insegnare, a dispetto di tante insufficienti e approssimative politiche didattiche (soprattutto italiane). In tal senso, è il concetto di spazio vissuto, formulato dal grande geografo francese, a fungere da efficace connettore fra due discipline complementari come geografia e antropologia, scrutanti l’Uomo nella sua distribuzione organizzativa e meccanica sociale. L’espace vecu, ovvero quello «degli individui di cui si appropriano, con i loro percorsi, le loro percezioni, le loro rappresentazioni, i loro segni, le loro pulsioni e passioni» [6] , è una figura concettuale che getta un ulteriore, solido ponte per ragionare sulla complessità dei quadri umani nei loro aspetti ontologicamente processuali. Non deve certo stupire come una modernità tanto superficiale, frammentata e astratta possa così facilmente fraintendere una materia che insegni a pensare e considerare paesaggi di senso articolati e in divenire.
La nascita dell’antropologia, dal canto suo, assume una posizione duplice ma non ambigua per l’epoca: pensare l’uomo è una chiave epistemica e farlo “distanti” un’altra, che poteva stravolgere il significato della ricerca e che risentiva ancora di una carica politica e imperialista [7]. Premessa e strumento alle origini della disciplina è dunque il viaggio; prima coloniale e autocratico, teso a fagocitare spazi, uomini e ricchezze, poi prudentemente critico e volto alla conoscenza del diverso, del “selvaggio”, ancorché utile a giustificare un predominio culturale acquisito con la forza e commentato nei salotti della terra natia. Il viaggio trova così il suo innesco prima come frattura e poi come conciliazione riparatrice alle origini della storia della disciplina [8].
Il senso dell’offesa e dello scontro sintetico, a ben vedere, ritorna nelle pagine di Giovanni Messina, che nota come la mitologia racconti quanto sia la spedizione militare a fondare l’epica costitutiva della civiltà occidentale, riconoscendo all’approccio letterario, fin dalla Grecia antica, un ruolo didascalico di ampio respiro. «La tensione della guerra che pulsa come il fato» rischiara il momento della stasi, dell’«attesa come potenza, come precondizione tumultuosamente statica all’agire nello spazio e attraverso il tempo», ed accende nel combattente un doppio senso dell’ignoto: quello dell’altrove geografico e quello dell’incertezza e della precarietà della propria vita, che la guerra strappa via e non restituisce. Al contrario, si cita come altrove benefico la Terra Promessa agognata dagli Israeliti per ragioni di fede, e del cui mitico viaggio racconta il Libro dell’Esodo.
Dal punto di vista epistemologico, insomma, viaggiare si presenta come un concetto implicito in forza all’antropologia, che se ne serve dapprincipio per le sue peregrinazioni alla ricerca dell’Altro primitivo ed esotico e le cui cosmogonie ottiene spesso di fondare. L’osservazione diretta, partecipante, inserisce il viaggio nell’alveo ermeneutico della scienza moderna, strappandolo agli equilibri di potere anglofoni e facendone a sua volta un ambiente interpretativo per l’etnografo. Dopo E. Tylor (1832-1917) e sir J. Frazer (1854-1942), primi grandi etnologi a riconoscere un ruolo non banale ai “diversi” [9], sarà Franz Boas (1858-1942) – in aperta polemica con le generalizzazioni evoluzioniste dei suoi predecessori [10] – a disvelare la specificità dei numerosi e diversi gruppi umani, aprendo l’antropologia, oltreché alla vera e propria ricerca sul campo, a proficui dialoghi con altre discipline come psicologia e linguistica.
Spetterà però alle generazioni ad esso successive, prima con Kroeber e Malinowski poi con Margaret Mead e Lévi-Strauss (fra gli altri), produrre i più formidabili contributi per la sistemazione del perimetro della disciplina, che ora confronta tendenze e paradigmi, definisce continuità e separazioni scandagliando puntigliosamente le culture come scritture di modi di vita e raccontando la diversità di un mondo postcoloniale che diviene globale. Così scriverà proprio Claude Lévi-Strauss (1908-2009):
«La fine di una civiltà, il principio di un’altra, il nostro mondo che all’improvviso scopriva di esser diventato troppo piccolo per gli uomini che lo abitano, tutte queste verità mi sono state rese più evidenti, non tanto dalle cifre, dalle statistiche o dalle rivoluzioni, quanto dalla risposta avuta al telefono, qualche settimana fa, mentre accarezzavo l’idea – 15 anni dopo quei primi viaggi – di ritrovare la mia giovinezza visitando nuovamente il Brasile: in ogni caso, mi dissero, avrei dovuto prenotare il posto quattro mesi prima!» [11].
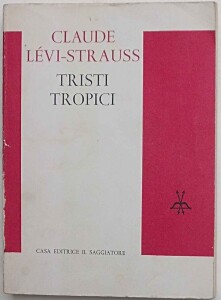 È lui a dirci meglio della multiformità del viaggiare con la sua penetrante capacità analitica ed esplicativa, malgrado più forte sia il ricordo, in tanti saggi sulla materia, del solo celebre «Odio i viaggi e gli esploratori [...]», in apertura di Tristi Tropici (1955), pietra miliare e tra le opere fondative dell’antropologia moderna. Nelle righe poco sopra, tratte dal libro, è difficile non scorgere, come nota già Marco Aime, una vera e propria preconizzazione della modernità globalizzata, nella quale il viaggio, che «si inscrive simultaneamente nello spazio, nel tempo e nelle gerarchie sociali» [12], muta al mutare degli orizzonti collettivi, che sembrano fatalmente tendere ad una “umanità della monocultura”, di massa, nella quale il viaggio rischia di divenire, da baluardo della ricerca della diversità, espediente rigenerativo per sentirsi a casa ma altrove, come oggi accade.
È lui a dirci meglio della multiformità del viaggiare con la sua penetrante capacità analitica ed esplicativa, malgrado più forte sia il ricordo, in tanti saggi sulla materia, del solo celebre «Odio i viaggi e gli esploratori [...]», in apertura di Tristi Tropici (1955), pietra miliare e tra le opere fondative dell’antropologia moderna. Nelle righe poco sopra, tratte dal libro, è difficile non scorgere, come nota già Marco Aime, una vera e propria preconizzazione della modernità globalizzata, nella quale il viaggio, che «si inscrive simultaneamente nello spazio, nel tempo e nelle gerarchie sociali» [12], muta al mutare degli orizzonti collettivi, che sembrano fatalmente tendere ad una “umanità della monocultura”, di massa, nella quale il viaggio rischia di divenire, da baluardo della ricerca della diversità, espediente rigenerativo per sentirsi a casa ma altrove, come oggi accade.
D’altra parte, nelle stesse righe, Lévi-Strauss ebbe modo di alludere alla “fine dei viaggi”, dove questi – avendo già inaugurato la pratica antropologica – si apprestano a perdere la loro originaria carica di avventura empirica nel mondo sconosciuto per abbracciare quella, più frenetica e alienante, dell’evasione fine a sé stessa e del consumo, la cui declinazione più discussa resta quella turistica. Nel viaggio, scoprendo le culture, realizziamo l’unicità di quella cui apparteniamo in un’esperienza che è insieme omogenea e cadenzata, e ci prestiamo ad una vicenda metaforicamente esemplificata da G. Messina con la figura retorica del chiasmo, rappresentando «l’incrocio a χ di binari che mettono a sistema due territorialità, di origine e di destinazione, con le rispettive comunità. Nella sua dimensione di connettore, il viaggio è dunque il perno di un sistema relazionale complesso che trova esito, fra gli altri, nelle dinamiche del contatto culturale».
Nuovamente, però, una torsione paradossale sembra agitare il nostro discorso, e la linearità del viaggio quale sequenza organica di differenti predisposizioni alla sintesi di senso pone un problema: quello di un’esperienza mancante, di un «chiasmo imperfetto, incompleto, determinato dagli approdi mancati, dai respingimenti, dai naufragi dei migranti, dall’attardarsi delle retoriche e delle narrative o […] da ragioni sanitarie». L’armonica unità del viaggio può quindi venire minata dai dualismi ideologici o dalle fenomenologie di ordine globale, quali quelle che ancora attraversiamo mentre scrivo, e confermarsi come una possibilità che nell’accomunare gli individui ottiene di separarli, distinguerli e addirittura punirli. Per questo ultimo caso si pensi, ad esempio, alle forme di sradicamento forzato come il viaggio sospensivo degli esili o quello, decisamente più agghiacciante, delle deportazioni novecentesche, chiasmi della storia.
Nel presente recente, quello dei dibattiti che hanno infiammato l’opinione pubblica particolarmente nell’ultimo triennio, il carattere di sospensione del viaggio si ritrova così declinato, alternativamente, ora nella nave carica di migranti cui è impedito l’accesso, nei porti sicuri, per motivi politici (quando non ideologici), e ora nelle navi-quarantena costrette nel limbo della prossimità costiera per via della precarietà sanitaria a bordo. «Chiami imperfetti», ricorda Messina.
Rispetto alla modernità in cui siamo immersi, che regolarmente ci chiama a nuove considerazioni e nuovi modi di intendere ciò che ci circonda, sembra che un aspetto paradossale possa (finalmente) riguardare la stessa pratica antropologica: quella del viaggio negato, dove la sua esperienza, ascrivibile ad un perfezionamento della pratica etnografica e delle prime acquisizioni sull’Altro, risulta ridimensionata e limitata dalla forte esigenza di concentrarsi su campi di ricerca di estrema prossimità, come quelli locali, dei propri luoghi abitati o del “giardino di casa” e, su tutti, dei palinsesti digitali, a portata prensile, nei quali prendono forma, oltre a inediti modi di erogazione dei servizi, nuove comunità e quindi nuove pratiche di relazione e produzione sociale.
Ciò di cui parlo si riferisce – direttamente sullo sfondo ad una nuova concettualità geografica – agli stravolgimenti subiti dalla stessa idea di spazio, che frequentiamo e “aggrediamo” in forme sempre più frequentemente inedite e non di rado insostenibili. Oggi, soprattutto, assume nuove sfumature una riconfigurazione dei quadri di vita “storici” e consueti che, secondo Luigi Marfè, «ha finito per dematerializzare i confini tra le culture: si può andare dall’altra parte del mondo e rimanere entro i limiti rassicuranti delle proprie abitudini, visitare le periferie delle grandi metropoli europee e inoltrarsi in paesaggi letteralmente inesplorati»[13]. Questo, se è principalmente attribuibile al fatto che sapere geografico e sapere culturale abbiano oramai restituito una relativamente robusta conoscenza del mondo, non può non ricollegarsi direttamente alle immagini che del mondo si hanno e facilmente si producono e riproducono nonché alle loro possibilità comunicative e di incidenza nella costruzione e trasformazione degli immaginari costituiti (aspetto non di poco conto).
L’uomo, insomma, è diventato ipertelligente. Ottiene sempre più facilmente e velocemente di accedere a spazi ‘altri’, apparentemente astratti perché cibernetici e digitali, puramente visuali ma non per questo sovrasensibili, anzi. Il paesaggio sensoriale virtuale, che ora esclude il solo olfatto, è implementato da programmi e sistemi che ne amplificano e perfezionano la portata estetico-visiva, sonora e tattile, regalando esperienze non più uniche e finite, tramandabili e gestibili dalla memoria, ma replicabili, non individuali e ultra-accessibili. Queste aree d’azione, quando ad esempio commisurate all’esigenza di portare a compimento un’operazione burocratica, si configurano inoltre come effimere intercapedini tra spazio pubblico e spazio privato per le quali Silvano Tagliagambe ha coniato la definizione di spazio intermedio, nuova dimensione di “intimità” fra le due sfere nella quale risultano rinegoziate le stesse idee di identità e socialità di ciascuno [14].
La riproducibilità del viaggio, ottenuta mediante sistemi come Google Maps o simili, si confonde così con il suo senso originario: la possibilità di conoscere e di superare un limite viene sostituita dalla seduzione del poter fare e dell’uso del dispositivo, sempre più accessorio glamour e la cui capacità strumentale appare ormai secondaria [15]. D’altra parte, allo smartphone si accorda la funzione di personale inter-mediario necessario per saggiare l’esperienza del viaggio moderno, che solo dopo una accorta manipolazione estetica (anche ottenuta mediante i cosiddetti “filtri”) può riversare le sue espressioni audiovisive nell’ecosistema mediale e fungere da “pegno” interattivo.
D’altra parte, nota nuovamente Marfè, la circolazione delle immagini «è strettamente connessa con l’impoverimento culturale dei luoghi: diventando discorso, trasformandosi in testo, il viaggio entra in una dimensione dell’immaginario che può giungere a rimodellarlo profondamente, a sottrargli realtà, a mutarlo in oggetto» [16]. La fisicità delle esperienze appare nuovamente compromessa, e un nuovo meccanismo di dematerializzazione sembra giustificare il sopravvento di ciò che il filosofo sudcoreano Byung-chul Han concepisce come non-cose, ovvero elementi di una realtà osservata come cosmo puramente immaginifico in cui oggetti, fatti e attitudini, svuotati di senso e contenuto materico, sono individuati dalla rappresentazione di sé stessi e contribuiscono a plasmare, attraverso canali di comunicazione e intelligenze artificiali, un’esistenza effimera, apatica e priva di mondo, dove la patina che li cela diventa sufficiente per la loro perpetuazione [17].
È ancora il saggio di Giovanni Messina a proporre una chiave interpretativa che sembra gettare ulteriore luce su questo passo. L’attenzione dell’autore verso la componente letteraria torna ancora utile per precisare quegli “elementi binominali” che nella figura del chiasmo, come detto, illustra le contraddizioni e la polisemia del viaggiare. Richiamandosi alla filosofia di Merleau-Ponty, il testo commenta e si sofferma sulla relazione tra identità e alterità ed interno ed esterno, che dell’escatologia dell’altrove costituiscono i due principali assi interpretativi. In particolar modo, sono interno ed esterno a sembrare oggi trasfigurati nell’immediatezza di un dentro e fuori digitale che nei click inserisce letteralmente l’individuo nel nuovo spazio-palinsesto di cui già conosce limiti, estremi concettuali, codici d’accesso e caratteri semiotici. Interno ed esterno, primordiali fautori schematici di interpretazione culturale e delle differenze fra le comunità umane nello spazio geografico, perdono la loro carica di condizioni sociali di appartenenza ed esclusione, strenuamente negoziate anche nelle spedizioni etnografiche, per divenire asettiche operazioni di produzione interattiva che remoti gestori della comunicazione rendono traducibile in introito economico [18].
Da quando la nostra specie ha imparato a viaggiare, ha dovuto fare regolarmente i conti con l’idea della diversità e dello scontro tra popoli, che ne è letale traduzione e che ancora crediamo, in un domani prossimo, di potere spegnere definitivamente, sebbene le sue maglie sembrino invece tendere alla dilatazione. Abbiamo così scoperto i confini, e chiesto alla geografia di fornirci i macro-strumenti interpretativi per pensare spazi sempre più vasti. È stata la geografia, prima di ogni altro insieme metodologico, a renderci globali e a consentirci di ripercorrere le nostre rotte, ponti sulla lontananza, ora fissate sulle carte che da secoli conserviamo con cura.
A tal proposito, è al viaggio che si è chiesto di misurare il mondo prima nella necessità del sostentamento e degli spazi vitali e, oggi, più frequentemente attraverso le forme culturali del lavoro e dello svago ricreativo. A conti fatti, risulta puntuale l’immagine strutturale che della sua pluralità ha potuto restituire il contributo di Giovanni Messina. Nel viaggio, appunto, riconosce metaforicamente la figura retorica del chiasmo per spiegare l’incerto equilibrio fra i suoi momenti salienti – come l’innesco, il cominciamento materiale – soprattutto rispetto alle variabili che lo rendono imperfetto e inconcluso compromettendone l’esito edificante ed incrinandone il nesso principale fra i suoi frangenti: l’esperienza accrescitiva. L’imperfezione del viaggio-chiasmo si può sostanziare, ad esempio, nelle navi cui, oggi, è negato un approdo sicuro, come in tante altre vicende della storia recente e meno.
Le attese, gli auspici, le funzioni del viaggio fanno anche i conti con una mutata concezione dello spazio, cui non è estranea l’iper-tecnologizzazione che predispone per noi mondi nuovi e in continuo fermento. La smisurata dilatazione è stata da un lato corroborata e dall’altro controllata e inibita dalle infinite possibilità della comunicazione a distanza, che nell’annullare gli spazi fisici rende disponibile un universo astratto e multimediale dove ciò che si trova dall’altro capo del mondo è distante un click. Il quale ultimo è intrinsecamente transculturale e a-spaziale.
Un paradosso che vizia la moderna idea di viaggio è relativo alla contrazione delle visioni territoriali consuete, che nei palinsesti digitali dà vita ad un fenomeno che non mi sembra improprio definire proliferazione dell’altrove, in cui la diversità è costantemente ri-prodotta da schemi, algoritmi, micro-comunità e codici d’accesso che tendono a scartare, rendere innocui, alienare ed escludere con subdola facilità, non di rado trasferendo nel mondo digital classificazioni e linguaggi discriminatori già operanti nella realtà sociale; il tutto secondo un processo permanente [19].
La costante ontologica del viaggio e dell’uso dello spazio sembra dunque l’identità, col suo denso e problematico portato, ed è questo il terreno nel quale, a mio avviso, sia l’antropologia che la geografia che una loro convergenza devono situarsi per pensare e ripensare il presente in maniera congrua; anche laddove, sempre più spesso, luoghi nuovi e diversi, incalzati proprio dal mercato del viaggio, si attivano per inscenare sé stessi ed operare una contraffazione delle proprie culture di riferimento, inventando e barattando genuinità e tradizione, ma scordandosi di abitare.
Cosa sia oggi l’altrove, insomma, è lungi dall’essere chiarito, mentre sembra urgente considerare un approccio di prossimità che investa i territori nei quali esistiamo e si dedichi alla comprensione del cambiamento che ci coinvolge da vicino ed è destinato a mutare il nostro modo di utilizzare lo spazio e di farlo socialmente. Se l’Antropocene suggerisce velocità, arbitrarietà (anche morale) e una certa varietà di idee di progresso, agli specialisti tocca l’improbo compito di suggerirne le condizioni e valutarne l’impatto; per questo, sarebbe opportuno cominciare dal respiro contraddittorio di cui il viaggiare – chiasmo nell’esistenza – si fa oggi portatore nel suo costante rimodulare i rapporti tra le comunità in un mondo mai così ristretto e così interattivo.
Dialoghi Mediterranei, n.61, maggio 2023
Note
[1] Aime M., Papotti D., Confini. Realtà e invenzioni, EGA Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2023
[2] Della stessa autrice della prefazione del saggio si segnala de Spuches G., Confin(at)i mediterranei e afroamericani. Una performance geografica sulla disumanizzazione in Memorie Geografiche 18/2020: 161-167
[3] https://journals.openedition.org/aam/6438
[4] Marfè L., Il racconto di viaggio e la “retorica dell’alterità” in Marfè L. (a cura di), Sulle strade del viaggio. Nuovi orizzonti tra letteratura e antropologia, Mimesis Edizioni, Milano, 2012: 55 – 65
[5] Frémont A., Gavinelli D. (a cura di), Vi piace la geografia?, Carocci Editore, Roma, 2007
[6] ibidem
[7] La nascita dell’antropologia culturale è strettamente intrecciata all’avventura coloniale dell’impero britannico, in cui muovono i primi passi proprio Frazer e Tylor, e alla nascente società statunitense, inizialmente orientata verso la “questione interna” dei pellerossa e probabilmente la prima a manifestare un’attenzione di tipo scientifico verso le società “altre”. Pionieri della scuola antropologica statunitense possono considerarsi Lewis Henry Morgan (1818-1881) e Henry Schoolcraft (1793-1864).
[8] A ben vedere, lo stesso Lévi-Strauss definirà l’antropologia, in misura largamente provocatoria, “scienza del rimorso”.
[9] Al primo è riferibile l’opera Primitive culture (1871), mentre al secondo Il ramo d’oro (1915).
[10] L’evoluzionismo è la cornice paradigmatica all’interno della quale si mossero i primi antropologi inglesi e statunitensi, che poterono d’altra parte trarvi gli strumenti teorici per indagini etnologiche ed antropologiche basate su ampie comparazioni. «Gli antropologi evoluzionisti di fine Ottocento sostenevano che tutte le culture umane dovessero seguire necessariamente una e una sola sequenza di sviluppo, tale sequenza va dallo stadio selvaggio a quello della civiltà. Alcune società si sarebbero “sviluppate” prima, altre sarebbero rimaste attardate su livelli evolutivi inferiori. Gli evoluzionisti, sulla base di questa idea semplicistica e convinti che il livello di sviluppo massimo fosse rappresentato dalla civiltà europea, contribuirono a giustificare la posizione dominante di quest’ultima sulle popolazioni colonizzate.» (Treccani)
[11] Lévi-Strauss C., Tristi Tropici, Il Saggiatore, Milano, 1960: 19
[12] https://www.youtube.com/watch?v=S4Os2lSFFVk
[13] Marfè L, cit: 19
[14] Tagliagambe S., Lo spazio intermedio. Rete, individuo, comunità, Università Bocconi Editore, Milano, 2008
[15] Si pensi a come la funzione della chiamata abbia progressivamente perso terreno a vantaggio delle più immediate possibilità di scambio della messaggistica istantanea (WhatsApp, Telegram, ecc.)
[16] Marfè L., cit: 21
[17] Han B., Le non-cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale, Einaudi, Torino, 2022. Dello stesso autore si segnala Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete, Einaudi, Torino, 2023.
[18] Simili forme mercificatorie confluiscono nel concetto di marketing digitale, ovvero la sfera del marketing che utilizza internet e tecnologie che vi si basino – come computer, smartphones e altri media e dispositivi digitali – per promuovere (e vendere) prodotti e servizi.
[19] È necessario chiarire come, nell’ultimo triennio, dimensioni eccezionali e quasi autonome abbiano rappresentato, in tal senso, lo stato di crisi inauguratosi con l’epidemia del 2020 e quello rappresentato dall’invasione russa, che ci ha investiti indirettamente. Lo spazio mediatico di pandemia e guerra, ad esempio, è un formidabile laboratorio di produzione semantica, alterazione percettiva e separazione sociale. Cfr. Turco A., Epimedia. Informazione e comunicazione nello spazio pandemico, UNICOPLI, Milano, 2021 e Geopolitica, informazione e comunicazione nella crisi russo-ucraina. La guerra, la pace, l’analisi scientifica, i media, UNICOPLI, Milano, 2022.
_____________________________________________________________
Nicolò Atzori, consegue una laurea triennale in Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) con una tesi in Geografia e Cartografia IGM e una magistrale in Storia e Società (ind. medievistico) con una tesi in Antropologia culturale, presso l’Università di Cagliari, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Altresì, è diplomato presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 2017 lavora, per conto di CoopCulture, come operatore museale e guida turistica presso il Museo Villa Abbas e il sito archeologico di Santa Anastasia di Sardara (SU), luoghi dei quali, fra le altre cose, cura la comunicazione e, nel primo caso, gli aspetti museografici. Sta frequentando il master di Antropologia Museale e dell’Arte della Bicocca.
______________________________________________________________











