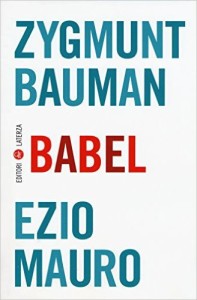Certe formule lessicali posseggono la icastica precisione di cogliere e rapprendere lo spirito del tempo, lo Zeitgeist, di illuminarne cioè il grumo oscuro e profondo, di ricapitolarne il senso complessivo. Così è stato per “L’uomo ad una dimensione”, definizione che Herbert Marcuse e la Scuola di Francoforte utilizzarono per indicare i primi processi di omologazione e di alienazione imposti dalla civiltà industriale avanzata. Così è stato per “Il secolo breve”, espressione adottata dallo storico inglese Hobsbwan che confinò il Novecento entro le fallimentari e rovinose esperienze del nazionalismo, del comunismo e del capitalismo, stretto, circoscritto e dissolto tra lo scoppio della prima guerra mondiale e la caduta del muro di Berlino. Così è infine per “La modernità liquida”, titolo di un’opera del 2000 di Zygmunt Bauman, diventata splendida invenzione metaforica, penetrata nel linguaggio comune, per descrivere e identificare il tempo incerto in cui viviamo, la precarietà e vulnerabilità della nostra condizione contemporanea.
Liquido non è soltanto il tempo ma anche lo spazio, dal momento che sono state cancellate le distanze e le differenze tra il lontano e il vicino, tra il pubblico e il privato. La mobilità è la cifra in cui sembra coagularsi l’odierna esperienza umana, l’insieme delle erratiche fluttuazioni degli individui e delle società. Liquida è anche l’identità, che può cambiare di sesso, di pelle, di religione, di professione. Abitiamo la vita come se pattinassimo su uno strato di ghiaccio oltremodo sottile e si salva – per usare l’immagine di Ralph Waldo – chi è abbastanza veloce da non rischiare di romperne la fragile superficie. Alla stupefacente velocità di un segnale elettronico si muove il mondo che ci circonda, si consuma e si rende obsolescente ogni legame e ogni forma durevole di relazione e di appartenenza. Con l’implosione del tempo nella galassia delle comunicazioni, la globalizzazione, che è qualcosa di più della colonizzazione e qualcosa di diverso dal vecchio imperialismo, rende reciprocamente contigui tutti luoghi della terra. Alla apparente rimozione di tutte le barriere fisiche e al fenomeno dell’interdipendenza e dell’interconnessione universale si accompagnano la balcanizzazione politica del globo, la formazione di nuove stratificazioni sociali, la messa in crisi dei sistemi di sovranità democratica.
Nel furore compulsivo del consumismo si celebrano e si dissipano i desideri agiti non da bisogni concreti ma da forze oscure, volatili ed effimere, per cui paradossalmente solo il desiderio è desiderabile, e non tanto il suo soddisfacimento. Lo stesso potere – liberato dai vincoli e dai confini della territorialità – è sdrucciolevole, plastico, mutevole, incorporeo, liquido appunto. Liquefatte le certezze in ipotesi, le verità in ambivalenze, la realtà in virtualità, caduta la rigida e rassicurante opposizione tra l’essenza della cosa e la sua rappresentazione, la mappa logico-conoscitiva che ci orientava si decentra, si destruttura, si decompone. Se elementi di disordine irrompono laddove regnava l’ordine, è possibile si producano spaesamento, insicurezza, incertezza, vulnerabilità. Gli stranieri sono per statuto ontologico coloro che con la loro stessa presenza insidiano le frontiere della sicurezza e minacciano la maestà dell’ordine. Le paure tipicamente urbane, elette a fabbriche dell’intolleranza e dell’odio sociale, generano nuovi Panopticon, nuove e più scaltrite tecniche di protezione, di controllo, di sorveglianza.
Questo, in grande sintesi, il complesso quadro tematico e problematico su cui il grande studioso di origine polacca, Zygmunt Bauman, ha con rigore e sistematicità impegnato la sua acuta analisi critica, ragionando, da più di mezzo secolo ormai, intorno alle più rilevanti questioni sociali e culturali della contemporaneità. La generazione di giovani antropologi cresciuta negli anni Settanta nelle università italiane si è in gran parte svezzata, confrontata e maturata sulle pagine della sua prima pubblicazione edita in Italia nel 1976 da Il Mulino, col titolo Cultura come prassi, un’opera fondamentale sia sul piano epistemologico che metodologico, una sorta di breviario che ha aperto la strada alla prospettiva strutturalista degli studi e alla ricerca scientifica dei tratti e dei caratteri invarianti nelle culture intese come sistemi aperti e dinamici. «La cultura è un coltello il cui lato tagliente è continuamente premuto contro il futuro». Così scriveva allora l’antropologo che, nonostante le severe argomentazioni contro l’ordine politico e sociale della modernità, ha sempre guardato con fiducia gramsciana alle potenzialità creative e liberatorie della cultura e dell’uomo in quanto agente di scelte e responsabilità. Da sociologo fu tra i primi a capire che “società”, il termine basico del vocabolario sociologico, era destinato a essere sostituito da “rete”.
A questo Grande Vecchio, che fra pochi giorni compirà novant’anni e non cessa di dare il suo prezioso contributo al dibattito pubblico, la comunità scientifica deve moltissimo, in primo luogo forse quella immaginazione sociologica di cui scriveva Charles Wright Mills, la creazione cioè di potenti metafore, di felici immagini linguistiche, come quella appunto che definisce il passaggio cruciale della cosiddetta modernità dalla fase hardware a quella software. Autore di una sterminata produzione di libri, Bauman continua ad esercitare con generosità il suo magistero, eminentemente etico prima ancora che intellettuale, e sembra in questi ultimi anni voler destinare il suo insegnamento alla divulgazione delle sue riflessioni attraverso conversazioni e interviste. L’ultima è contenuta nel libro, scritto in collaborazione con il giornalista Ezio Mauro, direttore di Repubblica, Babel (Laterza 2015).
Attento osservatore dei fatti di cronaca, lo studioso riesce a trarre dal quotidiano e caotico svolgersi evenemenziale degli accadimenti le traiettorie del tempo lungo, i cambiamenti che attraversiamo e di cui abbiamo una cognizione ancora confusa, quel presente in movimento destinato a diventare futuro. Il fattore umano resta pur sempre al centro delle sue illuminanti escursioni nei paesaggi surreali della Babele che abitiamo, quella soggettività o agentività indisciplinata e resistente a tutte le verità scientifiche, a tutte le derive autoritarie contemporanee. Nel denso dialogo con il giornalista che descrive scenari a tratti apocalittici fino al punto da temere che «finirà per sciogliersi anche il pensiero che pensa il mondo liquido», il vecchio antropologo sembra avere il compito di ribadirne con la sua autorevolezza le ragioni ma anche di stemperarne con la sua saggezza le possibili fughe profetiche e pessimistiche. «Ogni nuovo inizio – scrive nel prologo del libro – preannuncia nuovi rischi, ma allo stesso tempo propone nuove opportunità. Nessuno degli inizi è definitivo e irrevocabile». La verità è che ogni tramonto, in fondo, prepara l’alba di mondi nuovi, l’epifania di nuovi equilibri. Il disordine inintelligibile in cui siamo oggi sospesi, impigliati come insetti nelle ragnatele che noi stessi abbiamo tessuto, per rievocare l’immagine geertziana, è condizione che rende gli individui vulnerabili e le società atomizzate ingovernabili. Ma nessuno dei due, né Bauman né Mauro, è così ingenuo da pensare che la fine del proprio mondo coincida con la fine del mondo tout court.
La conversazione che gravita intorno alla crisi si snoda e si dirama fondamentalmente lungo tre percorsi, che pur intrecciandosi interessano rispettivamente la sfera politica, le dinamiche sociali e gli sviluppi culturali. Venuto meno il concetto di pubblico nell’ipertrofia del privato che ha colonizzato ogni spazio mediatico – «una lacuna democratica, la cui portata non riusciamo ancora a calcolare» – i cittadini non fanno politica ma la ricevono, non la partecipano ma la affidano, consumando tutta la dimensione civica nella mera espressione del voto. Da qui la distorsione dei poteri e della natura stessa della democrazia, fondata su un consenso banalizzato in audience, su leader trasformati in performer, su una politica ridotta ad evento, su un confronto di idee degenerato in scontro tra personalità. «Nella rete fittissima di connessioni che attraversa il nostro mondo abbiamo smarrito quel vecchissimo filo d’Arianna che collega il singolo al plurale, l’individuale al collettivo, casa nostra alla vita degli altri, tutto questo alla politica». Dentro uno Stato che ha perso riferimenti e radicamenti territoriali, essendo ormai sovranazionale il capitale finanziario che «viaggia leggero con un semplice bagaglio a mano» e regge l’economia su scala globale, i cittadini non sono più lavoratori ma semplici consumatori, e il patto che prima legava in un rapporto di interdipendenza produttori e imprenditori si è definitivamente spezzato, fino al punto che è lecito dubitare del valore d’uso di una politica che non è più in grado di incidere sulla vita quotidiana degli individui.
Zygmunt Bauman individua nella contraddizione tra fissità e mobilità la chiave di volta della mutazione contemporanea, la faglia che ha prodotto le nuove disuguaglianze, il punto di non ritorno che determina e fa diversi i modi di agire, di sentire, di pensare. Il movimento è la cifra del nostro tempo acrono, del qui e ora, la condizione che investe non solo gli uomini nel loro nomadismo turistico o migratorio, ma anche ogni aspetto della cultura e della vita, di una «quotidianità vissuta come dentro un nastro di Moebius», in un perenne scorrere e fluttuare che genera un modo diverso di stare al mondo. La dimensione liquida dunque ci attraversa, intride i nostri pensieri, permea i nostri rapporti, e immersi nelle acque confortevoli e scintillanti delle nuove tecnologie «stiamo diventando degli affluenti del grande flusso totale. Le nostre culture sembrano versarsi nello stesso fiume, ridotte a immissari, trascinate a confondersi o a numerarsi, diventando tributarie».
Proprio perché il dialogo mette a confronto un autorevole antropologo con un non meno autorevole rappresentante del mondo dell’informazione, le pagine forse più interessanti del libro sono quelle che riguardano le questioni della comunicazione nell’età dei social network. I profondi mutamenti introdotti dalla rete, che è «una replica elettronica della comunità recintata, chiusa da muri concreti, in difesa dal mondo esterno», hanno prodotto un densissimo pulviscolo informativo che finisce col far prevalere il segno sul senso. «Se ieri – afferma Ezio Mauro – il medium era il messaggio, oggi il medium può fare a meno del messaggio. I ragazzi si scambiano col cellulare segnali vuoti per salutare, sollecitare, confermare, e l’impulso riassume definitivamente la parola e il vuoto, sostituendoli». Attraverso facebook e tweet il web è diventato il luogo delle espressioni fàtiche, dove tutto è contemporaneo e ubiquo, dove la connessione surroga la partecipazione e la connettività prende il posto della collettività, e tutto sembra favorire quella amatorializzazione di massa delle forme espressive un tempo riservate ai professionisti della comunicazione.
L’assolutismo della delega alla tecnica può degenerare nell’autismo elettronico di cui ha scritto Castells, quando nel mondo online cerchiamo rifugio dal trambusto e dalle solitudini della vita offline. I due universi con i loro diversi codici sono partecipati simultaneamente e, a volte, interscambiati, confusamente mescolati. Le stesse identità finiscono con l’essere liquidamente commutabili nella libertà illimitata e incontrollata della rete, nel gioco polivalente del multitasking, nel mercato straripante di app e gadget. Non sappiamo se la qualità ideale dell’identità più desiderata sia la biodegradabilità, come ipotizza Bauman in un altro suo scritto, ma è certo che le opzioni disponibili non sono fondate su valori durevoli, autorevoli e non negoziabili. La sovraesposizione pubblica, ovvero l’autoesposizione quale prova dell’esistenza sociale, trasforma i social network in campi di sorveglianza volontaria, in spazi privilegiati di una vera e propria “società della confessione”. È questo uno dei passaggi cruciali della conversazione destinato ad approfondire gli aspetti politici di una pratica che fa credere alle nuove generazioni facebook che cliccare su una petizione vale come atto politico in sé autosufficiente. Ma se è vero che – come ha scritto Morozov – «i tweet non rovesciano i governi, solo i popoli lo fanno», le tecnologie non sono altro che «attrezzi senza manico». E noi siamo il manico, con le nostre responsabilità e le nostre determinazioni.
Nella ricognizione dei fenomeni mediatici e degli usi e degli abusi della rete, Bauman non tralascia di considerare le questioni connesse al potere che può esercitare azioni di censura online, di propaganda e di controllo della sfera privata degli individui attraverso l’intrattenimento e la seduzione. «Con l’uso della forza, le persone possono essere costrette a fare ciò che altrimenti preferirebbero non fare. Con l’uso del denaro, le persone possono essere indotte a fare ciò che di per sé non farebbero se non fossero corrotti. Con l’uso della seduzione, le persone possono essere convinte a fare qualcosa per il semplice piacere di farlo». Pur nella liquidità dei mezzi e delle strategie comunicative, il regime del nuovo Panopticon strappa dati strettamente personali e penetra capillarmente nella vita quotidiana di ciascuno di noi per le vie attraenti ed infinite dei social media. Non il rigore coercitivo delle norme ma il fascino irresistibile dei desideri alimenta e sostiene i meccanismi della sorveglianza, dal momento che si rendono disponibili automaticamente e volontariamente le informazioni più segrete della nostra privacy mentre usiamo il telefonino, facciamo acquisti con le carte di credito, navighiamo su Internet.
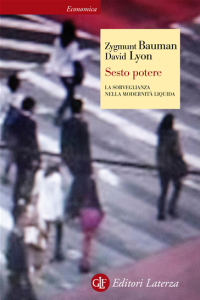 Che nel mondo digitale si possano monitorare i consumi, sorvegliare le condotte e orientare le scelte politiche con la complicità degli stessi utenti, è ampiamente documentato in un altro libro che Bauman ha scritto in forma di conversazione con il sociologo David Lyon, allievo in gioventù di McLuhan, dal titolo Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida (Laterza 2014). Ridotti i droni di nuova generazione a piccoli volatili che sorvolano invisibili i cieli delle nostre esistenze, «nessuno saprà mai per certo se o quando un colibrì si poserà sul suo davanzale», nessuno sfugge a questo moderno “occhio di Dio”, pervasivo e sfuggente che spia i nostri gusti, le nostre abitudini e perfino i nostri pensieri, accessibili e disponibili in ogni momento della giornata. Le transazioni che operiamo, le informazioni che assumiano e contestualmente rilasciamo sono esse stesse strumenti di controllo, dispositivi di sicurezza la cui ambivalenza è riconducibile a quella “microfisica del potere” descritta da Foucault, che identificò per primo nel modello del Panopticon, ideato dal filosofo inglese Jeremy Bentham, il paradigma delle società moderne. Oggi, però, sostiene Bauman, «blanditi dal consumismo e spaventati dalla nuova libertà dei capi di sparire nel nulla insieme ai posti di lavoro, i subalterni sono talmente addestrati a svolgere il ruolo di sorveglianti di se stessi da rendere superflue le torrette di osservazione dello schema di Bentham e Foucault».
Che nel mondo digitale si possano monitorare i consumi, sorvegliare le condotte e orientare le scelte politiche con la complicità degli stessi utenti, è ampiamente documentato in un altro libro che Bauman ha scritto in forma di conversazione con il sociologo David Lyon, allievo in gioventù di McLuhan, dal titolo Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida (Laterza 2014). Ridotti i droni di nuova generazione a piccoli volatili che sorvolano invisibili i cieli delle nostre esistenze, «nessuno saprà mai per certo se o quando un colibrì si poserà sul suo davanzale», nessuno sfugge a questo moderno “occhio di Dio”, pervasivo e sfuggente che spia i nostri gusti, le nostre abitudini e perfino i nostri pensieri, accessibili e disponibili in ogni momento della giornata. Le transazioni che operiamo, le informazioni che assumiano e contestualmente rilasciamo sono esse stesse strumenti di controllo, dispositivi di sicurezza la cui ambivalenza è riconducibile a quella “microfisica del potere” descritta da Foucault, che identificò per primo nel modello del Panopticon, ideato dal filosofo inglese Jeremy Bentham, il paradigma delle società moderne. Oggi, però, sostiene Bauman, «blanditi dal consumismo e spaventati dalla nuova libertà dei capi di sparire nel nulla insieme ai posti di lavoro, i subalterni sono talmente addestrati a svolgere il ruolo di sorveglianti di se stessi da rendere superflue le torrette di osservazione dello schema di Bentham e Foucault».
La strategia del Panopticon contemporaneo sviluppa la sua azione su due fondamentali direttrici, tende cioè a confinare “dentro” e a escludere “fuori”. Così è per tutti i soggetti non conformati al sistema del marketing e del consumo. Così è per i migranti, trattenuti nei campi profughi e nello stesso tempo esclusi come corpi estranei dal resto dell’umanità, clandestini la cui prossimità basta a destabilizzare e disorientare individui e collettività. Nella modernità liquida, attraversata dalle endemiche paure urbane, dalla precarietà economica e dalle insicurezze esistenziali, i migranti diventano scandalose e inquietanti presenze, walking dystopias, distopie che camminano. Le tecnologie di controllo, funzionali a tenerli a distanza e a renderli invisibili, sembrano affrancare le nostre condotte e le nostre coscienze dai vincoli morali e dalle responsabilità civili. Se è vero che la paura è incubatrice di altre paure, il bisogno di protezione diventa fattore motivante della sorveglianza e la ricerca sicuritaria – che moltiplica videocamere e serrature blindate, software per il riconoscimento facciale e macchine per scannerizzare il corpo, dall’impronta digitale alla scansione dell’iride – genera e riproduce paradossalmente moti e sentimenti di insicurezza. Un cortocircuito rovinoso e perverso.
 Le vicende di Wikileaks e di Snowden hanno ampiamente dimostrato quali esiti può avere una politica che espropria le “nude vite” mentre rende volontaria la servitù ed entusiastica la sottomissione alle tecnologie digitali vissuta come avanzamento di libertà. A fronte di queste pratiche che in nome della sicurezza sacrificano la privacy disprezzata come un feticcio del passato, Zigmunt Bauman auspica una “etica della nuova sorveglianza”, la riappropriazione di un più ragionevole equilibro tra i principi cardini della convivenza, tra libertà e sicurezza, in una prospettiva democratica che illumini il disordine babelico del nostro tempo.
Le vicende di Wikileaks e di Snowden hanno ampiamente dimostrato quali esiti può avere una politica che espropria le “nude vite” mentre rende volontaria la servitù ed entusiastica la sottomissione alle tecnologie digitali vissuta come avanzamento di libertà. A fronte di queste pratiche che in nome della sicurezza sacrificano la privacy disprezzata come un feticcio del passato, Zigmunt Bauman auspica una “etica della nuova sorveglianza”, la riappropriazione di un più ragionevole equilibro tra i principi cardini della convivenza, tra libertà e sicurezza, in una prospettiva democratica che illumini il disordine babelico del nostro tempo.
Non si scrivono libri come questi se non si coltiva una qualche fiducia nell’opinione pubblica, una speranza nell’uomo e nelle sue potenzialità di riscatto e di emancipazione. La stessa speranza era di Gramsci quando scriveva: «La sfida della modernità è vivere senza illusioni e senza diventare disilluso». Quella illusione che l’uomo non può perdere senza perdere la sua umanità. Quella stessa speranza che fa dire, in conclusione, al grande interprete dello spirito della nostra modernità: «Gli esseri umani sono una specie endemicamente trasgressiva e non può fare a meno di esserlo, avendo ricevuto la grazia – o la maledizione – di un linguaggio che comprende la particella “no” (ossia la possibilità di negare o confutare l’esistente) e il tempo futuro (ossia la capacità di farsi spingere dalla visione di una realtà che “per ora” non esiste ma “in futuro” potrebbe esistere). Per un uomo come l’homo sapiens, capace di scegliere, trascendere e trasgredire, non esiste una situazione che si possa totalmente e veramente riassumere nel “tutto è perduto”». L’immortalità della speranza dischiude un orizzonte di luce sul cupo scenario del presente.
Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015
_______________________________________________________________________________
Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia.
________________________________________________________________