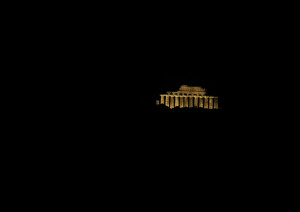Ha ragione Nino Giaramidaro che si chiede a che punto è la notte oramai fonda, replicando quell’oscuro biblico interrogativo posto dal profeta Isaia alla misteriosa sentinella che forse sta lì da sempre a vegliare sulle mura delle nostre coscienze. E l’eco infinita di quella voce giunge fino a noi. A che punto è la notte, ci chiediamo, davanti agli abissi della guerra, ai naufragi delle cento Cutro, alle morti degli innocenti, a quei bambini – cinquanta, cento? – rimasti intrappolati con le madri nel buio delle stive a far da zavorra per tenere in equilibrio quella fragile e precaria imbarcazione colata a picco nelle acque del mare Egeo. Nemmeno un bambino fra i 104 superstiti.
A che punto è la notte che sembra non finire mai se la politica è diventata “necropolitica”, un sistema scientifico di concertazione europea che stabilisce i confini tra salvati e sommersi, tra garantiti e scartati. Tra umano e non umano. Un potere attento alla gestione dei “flussi” e al loro respingimento e non alla protezione delle vite delle persone, alla tutela dei loro diritti. Una ragione di Stato che avalla le deportazioni e i regimi dispotici dei cosiddetti “Paesi terzi sicuri” pur di difendere la sovranità dei privilegi, i sacri confini minacciati dalle orde dei poveri cristi che annegano sotto le nostre coste, a un passo dalle nostre case sicure, sotto i nostri sguardi sempre più smarriti, distratti o rassegnati.
A che punto è la notte che non conosce spiragli di luce e sprofonda nella muta collettiva indifferenza se davanti al genocidio impunemente consumato nel Mediterraneo, a fronte del quotidiano stillicidio di morti per naufragio la cronaca si trattiene a stento un solo giorno per naufragare anch’essa nell’oblio o forse nella vergogna. A che servono infatti i princìpi umanitari universali, le leggi scolpite nelle Costituzioni e nelle Convenzioni internazionali, le faticose conquiste della civiltà del diritto e della solidarietà se a prevalere sono sempre gli interessi tribali delle nazioni, le vecchie trincee innalzate da quelle “comunità immaginate” che una retorica di enfasi e omissioni ha inventato sui tragici miti del sangue, della stirpe e del suolo?
Questa rivista non può tacere né declinare le responsabilità che ognuno di noi si assume rispetto all’aberrante assuefazione del “lasciar morire”, a questo paradigma silenzioso e velenoso che penetrato nelle vene delle nostre giornate ci fa compartecipare ad una morte politicamente amministrata e pubblicamente somministrata come naturale e ineluttabile, ci fa accettare le gerarchie tra gruppi umani e tra le vite delle persone sulla base di categorie dichiaratamente etnorazziali. Ne aveva scritto sul numero precedente Giovanni Cordova. Ne scrive in questo Luca Ramello, rovesciando la prospettiva e dando la parola ad alcuni dei sopravvissuti alle intercettazioni violente della Guardia Costiera tunisina, per i quali la contiguità dei concetti di vita e di morte è strettamente associata ai valori della libertà e dell’uguaglianza. «Viviamo in una prigione. Cos’è la libertà? Attraversare o morire», confessa K., ventitreenne che vive a Sfax, dopo aver tentato la traversata tre volte, esser sopravvissuto ad un naufragio e in attesa di imbarcarsi su una nuova carretta.
Alla Tunisia – questo piccolo Paese del Mediterraneo, oggi piegato da una grave crisi economica e da un regime sempre più autoritario e per questo al centro di strategie geopolitiche internazionali – Dialoghi Mediterranei ha deciso di destinare uno spazio permanente di riflessione, una speciale attenzione per approfondire la conoscenza di quel che accade ma anche di quel che si rappresenta, delle dinamiche sociali e dell’immaginario popolare, delle relazioni storiche e culturali con l’Italia e degli aspetti più interessanti e meno noti. Cercheremo di leggere la cronaca per capire la genesi e gli snodi delle migrazioni ma soprattutto per osservare più da vicino i contesti e la vita della popolazione nelle forme pubbliche e private, nelle dimensioni generazionali e nei risvolti antropologici. Sarà un contributo a ricostruire quel ponte o quella rete di legami plurisecolari che paranoie securitarie e torsioni politiche hanno rinnegato e spezzato. Sarà un modo per tentare di risarcire memorie, di ricostituire percorsi e approdi, di riconnettere i fili della densa trama di mobilità e diaspore, di ininterrotti e umani contatti, esperienze molteplici di quella storia di lunga durata che ha operato come un pendolo perennemente oscillante tra le due rive del Mediterraneo. Sarà anche l’occasione per ospitare i punti di vista, le voci e le contro-narrazioni di studiosi e colleghi tunisini, per inaugurare un più sistematico rapporto di collaborazione e scambi culturali.
In questo numero Ahmed Somai, italianista e traduttore tunisino, racconta le vicende della traduzione in arabo presso l’editore Finzi delle Fiabe italiane di Italo Calvino, ne ricorda le assonanze con le sue letture infantili de Le mille e una notte, le somiglianze tra le letterature orali e popolari. Barbara Teresi, dal canto suo, traduttrice dall’arabo all’italiano, ribadisce le sotterranee risonanze mediterranee tra le due culture, mentre chiarisce esemplarmente che tradurre è pur sempre una questione di sguardo, «un’arte performativa, è interpretare, alla stregua dei musicisti, una melodia composta da qualcun altro, suonare con i propri strumenti e la propria sensibilità una partitura altrui». Dell’eredità dello storico plurilinguismo presente nelle politiche e pratiche della Tunisia di oggi scrive Clelia Farina, che indaga sulle tendenze delle nuove generazioni e sulle sperimentazioni sui social. E di uno straordinario metissage di stili tra Art Nouveau, Arabisance, Art Déco e Liberty è documento lo studio di Rosy Candiani, che ci conduce per le strade di Tunisi e ci fa scoprire un patrimonio artistico e architettonico poco conosciuto, quello delle facciate delle case costruite dagli italiani tra la fine dell’800 e gli anni trenta del ‘900, decorate con ornamentazioni in stucco e gesso.
Mentre Roberta Marin dà conto degli sviluppi dell’arte moderna e contemporanea in Tunisia, passando in rassegna alcuni degli artisti più rappresentativi che nella loro produzione si muovono tra tradizione e innovazione, Antonino Cangemi recensisce un romanzo di Elena Nicolai che fa del Paese nordafricano il paesaggio narrativo di un brillante e originale intreccio intertestuale e Aldo Nicosia, dal canto suo, rievoca il periodo di permanenza a Tunisi quando ai primi di luglio del 1988 iniziò il suo apprendistato di arabista presso l’Institut Bourguiba ed ebbe modo di scoprire quanto restava tra le rovine de La Goulette della presenza dei siciliani insediati in quel quartiere già dalla fine dell’800.
La Tunisia, dunque, è indagata sotto i diversi aspetti culturali ma nel dossier l’incerta e instabile transizione democratica del Paese dopo il tramonto della Primavera è al centro di non pochi contributi, esiti di ricerche sul campo e di osservazioni critiche sulle evoluzioni politiche, economiche e sociali in atto. Così Chiara Sebastiani che denuncia il complesso fenomeno del razzismo degli europei nei confronti degli immigrati tunisini e dei tunisini rispetto ai profughi neri subsahariani. E commenta il tentativo di «fare delle relazioni Italia-Tunisia il fulcro delle relazioni Europa-Africa» come l’ennesima strumentale pratica di stipulare accordi con i dittatori pur di affermare i propri interessi nazionali. Così Enzo Pace che nell’attenta analisi del contesto politico tunisino ci aiuta a comprendere il ruolo di Rachid Ghannouchi, leader del partito di Ennahda, nella cui storia personale – scrive – «si riflettono tutte le contraddizioni non solo del suo Paese, ma anche di tutto il mondo arabo-musulmano dalla fine del colonialismo a oggi e, dunque, anche dei complessi rapporti che gli Stati della riva nord del Mediterraneo hanno intrattenuto con quelli della riva sud». Così Elena Nicolai che sottolinea l’eccezione tunisina, la cosiddetta tunisianité, soprattutto nelle implicazioni legislative e giuridiche dell’ordinamento in materia di migrazione come nel destino rivoluzionario e nella sua parabola. Così, infine, Giada Frana che accanto agli affanni della vita quotidiana in bilico tra la morsa dell’inflazione e la spinta all’emigrazione descrive le esperienze di resistenza dei giovani che provano a progettare un qualche futuro nel loro Paese.
Questo numero che presenta un ampio panorama di scritti riprende il dibattito sulle riviste, sulla loro capacità di penetrazione nel discorso pubblico e sul loro complessivo stato di salute. Si sta sviluppando un interessante confronto tra esperienze e posizioni specifiche diverse e tuttavia convergenti sulla necessità di un tavolo di condivisione e di coordinamento per ragionare sulle strategie da adottare per affrontare, per esempio, le sfide potenzialmente offerte dalle tecnologie digitali e dalle opportunità dell’open access. Comune è il convincimento che le riviste sono i luoghi elettivi per la circolazione e connessione delle idee, delle ricerche, dei progetti. Spazi ibridi e dialogici, di contaminazione tra pratiche e saperi ai confini delle mura universitarie, «con gli stivali – scrivono Mara Benadusi e Stefania Pontrandolfo, rispettivamente direttrice e caporedattrice del semestrale Antropologia Pubblica – rocambolescamente infilati nelle due staffe: tra dentro e fuori l’accademia». Contro l’arido specialismo autoreferenziale di certa saggistica, lontana dalla dimensione pubblica e funzionale soltanto alla costruzione di una carriera universitaria, Antonello Ricci, direttore di Voci, auspica quella «intensa dialogicità» che ispirò Lombardi Satriani fondatore della rivista e fermamente convinto che «una scienza che parli solo a se stessa sia una scienza incestuosa, troppo dominata dall’ansia di difendere privilegi accademici». Tanto più che l’antropologia è scienza per definizione aperta agli sconfinamenti e «gli antropologi – annota Eugenio Zito, del comitato di redazione di Antropologia Medica – hanno imparato a lavorare negli interstizi, spesso al confine tra mondi differenti (e gli antropologi medici, per la peculiarità dei loro interessi, forse ancora di più); da tempo sono impegnati nel coinvolgere comunità e gruppi rispetto a questioni e argomenti centrali nei dibattiti contemporanei».
Se questa apertura all’interdisciplinarità – ovvero alla cosiddetta “consilienza” che ibrida modelli teorico-metodologici provenienti da campi di conoscenza diversi – appare il generale orientamento emerso da più di un intervento, come non convenire con Alberto Baldi, direttore del semestrale EtnoAntropologia, «sulle opportunità di concepire contributi non solo scritti ma anche iconografici da organizzare non secondo criteri spesso aleatori, ma maggiormente cogenti e strutturati, in dialogo e non in subordine alla parola scritta»? Una esigenza oggi sempre più avvertita e praticabile stante le enormi potenzialità della tecnologia digitale che consente l’attivazione di link, Qr code, documenti filmati e navigazioni ipertestuali. E da un processo di rinnovamento formale e di riorganizzazione editoriale che corrisponde alle evoluzioni suggerite dal movimento dell’open science è nata venti anni fa Mediterranea. Studi e ricerche sul Mediterraneo antico, una rivista che, nel solco della prestigiosa tradizione scientifica in ambito storico-archeologico, si conferma fedele – come scrive Marco Arizzo della redazione – ad «una rigorosa specializzazione, premessa fondamentale e garanzia di solidità di ogni vero studio multi-disciplinare».
In questo orizzonte eclettico e accogliente le riviste restano preziosi spazi di apprendistato per i giovani studiosi ansiosi di dare visibilità alle proprie indagini, aspirano ad essere agili strumenti di lettura critica dei più svariati temi della contemporaneità, possono essere laboratori culturali a forte radicamento territoriale e tendenzialmente impegnati a rovesciare il rapporto centro-periferia. In un’ottica interculturale e interdisciplinare si muove con intelligente equilibrio tra linguaggio scientifico e divulgativo la rivista Africa e Mediterraneo, attenta da trent’anni a decostruire «la visione pregiudiziale di chi vede l’Africa come “provincia” e “periferia” di quello che un tempo veniva chiamato “Primo Mondo”», come annotano Sandra Federici e Enrica Picarelli.
Della provincia – ma non del provincialismo – è espressione tra le più creative e rappresentative il trimestrale Il Grandevetro di cui Giovanni Commare della redazione racconta da testimone la storia di mezzo secolo di vita intellettuale e di significativa presenza nell’area toscana del Medio Valdarno, un sodalizio che ha conservato nel tempo l’impegno politico dentro un’anima irriverente, «libertaria e anarchica». Scaturisce dalla volontà di un gruppo di giovani amici il semestrale Pequod, un’avventura editoriale progettata a Vizzini nel catanese appena tre anni fa, che porta nel nome ispirato alla celebre nave-baleniera del romanzo Moby Dick l’idea di navigare tra le onde della conoscenza, tra letteratura e filosofia e “varia umanità”. Ne descrive vicende e obiettivi il caporedattore Enrico Palma ed è incoraggiante pensare che ci siano ancora giovani che per passione intellettuale scelgano l’impervia forma novecentesca della rivista piuttosto che quella più facile e accessibile del blog. Al Novecento ci riconduce infine Aldo Gerbino che ci ricorda “l’inutilità” e “la nobiltà” delle antiche riviste letterarie e si augura ci sia un futuro, pur nella dittatura degli algoritmi e nelle insidie dell’Intelligenza Artificiale, per il destino delle parole, senza le quali «si perde una di quelle forme in cui l’uomo esiste».
Il dibattito sulle riviste non finisce qui, crediamo possa svilupparsi nei prossimi numeri, nella consapevolezza che il sapere, qualunque sia l’attribuzione disciplinare, resta «strettamente ancorato a un fare e a un darsi nello spazio pubblico», come affermano i redattori di Antropologia Pubblica e come Dialoghi Mediterranei da più di dieci anni tenta di mettere in pratica. Tanto più oggi che la rivista ha ottenuto il riconoscimento scientifico da parte dell’Anvur e può offrire ai collaboratori la facoltà di avvalersi dei crediti acquisiti da utilizzare ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Nelle nostre pagine continueranno a trovare accoglienza anche quei contributi meno corrispondenti ai format canonici e ai modelli di scrittura convenzionali e tuttavia ritenuti scientificamente adeguati e pertanto legittimati alla pubblicazione. Perché, come ha scritto Fabio Dei nel numero precedente, «accanto a un sistema di riviste scientifiche globalmente standardizzato, è opportuno e utile che si mantengano iniziative meno formalizzate, nelle quali la “conversazione” disciplinare e il confronto delle idee possano più liberamente fluire. Anzi, i due processi sono forse complementari – aggiungeva – facce della stessa medaglia: più la componente “ufficiale” si ingessa, più vi sono stimoli a creare qualcosa di diverso – di “deanvurizzato”, se vogliamo dir così». Da qui, da queste parole, vogliamo continuare a discutere e a confrontarci con le redazioni di riviste di fascia A e con quelle che più liberamente si muovono in quell’area franca, negli interstizi o nei margini, dove s’infrangono le cornici disciplinari e, a volte, si rigenerano le idee e si aprono nuovi scenari.
In questo numero il lettore può davvero trovare, nella straordinaria ricchezza di scritti, stimolanti opportunità per riflettere su questioni di attualità, per appassionarsi ad incursioni letterarie e artistiche, per recuperare memorie storiche. Per ricordare figure come quella di Don Lorenzo Milani, per esempio, su cui ragionano studiosi dalle diverse competenze: Marina Castiglione linguista, Vincenzo Guarrasi antropologo, Leo Di Simone teologo, e tre docenti in servizio presso istituti scolastici, Salvina Chetta, Valeria Dell’Orzo e Tommaso lo Monte. Dai loro scritti affiora il profilo di una personalità complessa e profetica, un esemplare maestro di vita e di umanità, un educatore “controvento” di cui oggi, nel centenario della nascita e nell’Italia piegata e disorientata, rimpiangiamo l’assenza. La scuola e l’istruzione restano temi privilegiati della rivista dal momento che sentiamo nostro e urgente l’interrogativo di Franco Lorenzoni: «Come educare allo stare al mondo e al convivere tra diversi in un tempo in cui si diffondono a impressionante velocità sempre nuovi veleni?».
Di altre figure luminose come quella di Scotellaro, ricordato da Pietro Clemente con una ampia e intensa testimonianza che ne attualizza l’eredità, e delle altre numerose sollecitazioni alla lettura disseminate in questo numero – dal rap alle novene, dal maestro Giacomo Puccini all’etnomusicologo Andreas Bentzon, dalla Napoli della Marina storica a quella di Ozpetek e Sorrentino fino a quella dello scudetto, dal rito del matrimonio al potere del patriarcato, dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni a quello delle Erbe Palustri di Villanova, dal culto delle pietre in Calabria a quello del Crocifisso a Mazzarino in Sicilia, dal paesaggio in un contado toscano del ‘500 all’Oasi di Tagiura nella Tripolitania italiana degli anni venti del ‘900, dalle voci delle donne siciliane antifasciste che scrivono subito dopo la fine del conflitto al deputato comunista per rappresentare le loro istanze a quelle dei giovani figli di immigrati a Bologna che testimoniano le loro vite, le loro aspirazioni in un Paese che non riconosce loro il diritto alla cittadinanza – si dispiega un universo di storie, di idee e di esperienze, si snodano percorsi che s’incrociano, fili che s’intrecciano, memorie e culture che s’incontrano, si riconoscono, dialogano.
Come le splendide immagini dell’album che chiude il numero e mette insieme l’anonimato degli spazi aeroportuali e gli scorci mediterranei di Alessandria d’Egitto e Beirut; le maschere dei Diavoli di Prizzi, i fuochi di San Sebastiano di Palazzolo Acreide, le corse dei Ceri di Gubbio e la spettacolare festa delle Aquile in Mongolia; le suggestioni della via Appia e lo squallore delle case in Albania; e i preziosi appunti, infine, per comporre un piccolo inedito affresco del Novecento femminile siciliano. Se è vero che la fotografia è scrittura che racconta non il mondo ma il nostro sguardo sul mondo, specchio non della vita ma della memoria della vita, materia e sentimento del tempo consumato, testimonianza che mostra senza pretendere di dimostrare, i nostri autori ci aiutano – nel flusso indistinto e travolgente delle immagini di oggi – a liberare gli occhi dall’effimero e rutilante velame mediatico e a fermare qualche fotogramma che parli ancora all’uomo e dell’uomo: «figure di uomini e non hommes par la figure», direbbe Antonino Buttitta.
Sulla fotografia e sul suo rapporto con la scrittura Stefano Montes continua anche in questo numero ad accompagnarci nel fascinoso gioco delle sue escursioni antropologiche. «Pensare per immagini – scrive – è uno dei modi salienti di essere nel mondo». Di queste fotografie abbiamo infatti bisogno come pietre d’inciampo, come epifanie, come parole che rompono i silenzi, lampi che illuminano e separano le cose dall’ombra delle cose. Qualcosa che aiuta a ripensare e riorganizzare la grammatica delle nostre percezioni, l’alfabeto dei nostri discorsi. Guardare al di là del vedere e pensare prima di credere non sono paradigmi verbali e fattuali scindibili. Sono consustanziali. Eppure, ha affermato di recente in un’intervista lo scrittore Daniel Pennac, «guardiamo la gente annegare nel Mediterraneo e intanto continuiamo a parlare dei nostri valori democratici». Un clamoroso ossimoro in cui sembra implodere la nostra cecità davanti al naufragio della nostra stessa umanità.
A che punto è la notte, dunque, se non riusciamo a guardare quel che accade davanti a noi e dentro di noi? Se non riusciamo a pensare ed accettare l’esistenza di forme di umanità diverse da quelle che ci somigliano, se non c’è spazio per gli altri, per l’universalità dell’uomo nella sua complessità e varietà di vite e di culture, per l’idea stessa di appartenenza ad un destino comune del genere umano?
A che punto è la notte? È ancora fonda.
Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023