di Valeria Dell’Orzo
L’avvento di quella spasmodica corsa produttiva che si sintetizza nella espressione tempi moderni ha travolto e ribaltato la realtà originaria del produrre e con questa tutto il quotidiano dei singoli produttori e degli imprenditori; ha investito il fare nei processi lavorativi dove non c’è più il tempo dell’unicità, della riflessione, del gusto del singolo manufatto e del piacere di riscoprire se stessi nell’artefatto a cui si è dato vita o che si è scelto di acquistare.
L’annichilimento, frutto dell’appiattirsi diffuso del poliedrico sull’uniforme fissità della produzione seriale, ha per lungo tempo sopito l’estro creativo e imprenditoriale del singolo artigiano, il gusto artistico di dar forma fisica al proprio pensiero. Le strutture progettuali, esecutive e creative sembrano mortificate dalla corsa all’omologazione e dalla perdita di una identità manifatturiera, densa della storia personale, dei legami e dei simboli delle proprie origini. Eppure oggi, forse proprio come estrema reazione all’annullamento dell’umanità che regge le dinamiche del produrre, nascono realtà di interessante recupero, segnate della bellezza della riscoperta, spinte dalla voglia di ripescare se stessi da quella massa generata dalla globalizzazione.
Vivere un luogo, farne parte, tessere la naturale rete di rapporti umani, porta in sé un agire, la volontà, purtroppo spesso soffocata dalle evidenze esterne, di dar vita a qualcosa, di fare del proprio quotidiano una voce attiva e creativa, l’aspirazione a infondere qualcosa di personale entro la realtà sociale che ci circonda.
Può così accadere che una parte dell’imprenditoria moderna lasci alle proprie spalle la freddezza dei meccanicismi produttivi e torni con la piena bellezza dell’umanità al fare artistico e manuale, riscopra il gusto antico del plasmare, del forgiare, dell’utilizzare materiali, forme, colori e trame della propria cultura d’origine, scavi lungo le proprie radici per portarne alla luce i valori simbolici e sociali e farne miscela insolubile col quotidiano e il locale circostante.
Non sono pochi gli esempi di imprenditori, ristoratori e artigiani, che tornano nelle botteghe, che riportano a galla quelle conoscenze dimenticate dal pressare dei tempi produttivi, omologati e ripetitivi. È in questo spaccato che si inserisce un settore apparentemente nuovo, ma dalla dimenticata storia secolare, dello sviluppo di progetti e attività produttive ad opera di gente venuta da lontano, dei migranti e più frequentemente dei loro figli, giovani che portano in sé il patrimonio conoscitivo esitato da continui scambi tra sistemi e culture.
 Quando dentro il mondo rampante e violento dell’economia si fa spazio non solo un imprenditore immigrato ma perfino una donna straniera che tenta e intraprende un’attività produttiva in forma autonoma, l’operazione della imprenditoria femminile migrante si vela di invisibilità agli occhi esclusivisti e androcentrici del sistema di mercato, scivola nella disattenzione generale, lontana dal circuito competitivo. Paradossalmente, oltre alla validità del progetto in sé, è proprio la mancata aggressione competitiva, questa sorta di nicchia sottratta al regime e sottovalutata dal sistema generale, che protegge di fatto la crescita di nuovi progetti e lascia libere, perché ritenute erroneamente irrilevanti, le nuove spinte di una società che muta, si arricchisce, pur non rendendosi conto, troppe volte, del potenziale sommerso dalle logiche di sopraffazione e marginalizzazione.
Quando dentro il mondo rampante e violento dell’economia si fa spazio non solo un imprenditore immigrato ma perfino una donna straniera che tenta e intraprende un’attività produttiva in forma autonoma, l’operazione della imprenditoria femminile migrante si vela di invisibilità agli occhi esclusivisti e androcentrici del sistema di mercato, scivola nella disattenzione generale, lontana dal circuito competitivo. Paradossalmente, oltre alla validità del progetto in sé, è proprio la mancata aggressione competitiva, questa sorta di nicchia sottratta al regime e sottovalutata dal sistema generale, che protegge di fatto la crescita di nuovi progetti e lascia libere, perché ritenute erroneamente irrilevanti, le nuove spinte di una società che muta, si arricchisce, pur non rendendosi conto, troppe volte, del potenziale sommerso dalle logiche di sopraffazione e marginalizzazione.
È l’apparire non competitive, non adeguate al sistema globalizzato dell’arricchimento sfrenato, che permette a piccole e intelligenti realtà di creare un proprio canale, di dar forma a progetti che affondano le basi nell’humus della cultura tradizionale e promuovono la contaminazione e lo scambio, la mescolanza e l’innovazione.
In questo contesto di multietnica effervescenza creativa, la Sicilia si mostra particolarmente feconda. Molte sono infatti le esperienze nel settore della ristorazione che offrono non solo la possibilità della fruizione di piatti esotici, ma contribuiscono di fatto a promuovere la partecipazione a un progetto di conoscenza e di scambio, la mise en place di un tavolo di comunicazione che passa dal gusto per giungere all’interazione, al contatto, alla conoscenza.
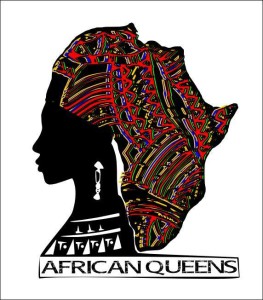 Fra le tante realtà troviamo quella di Mamma Africa, Abibata Konate, arrivata in Italia nel 1994 dalla Costa d’Avorio, che all’Albergheria ha dato il via a uno spazio che è difficile definire un mero ristorante etnico, è piuttosto un luogo dove cibo condiviso − piatti gustosi e “della nostalgia”, come li definiscono gli avventori migranti, ricreati qui come nei Paesi di origine grazie alla storica varietà di mercanzie offerte dal mercato di Ballarò [1], per dar loro quel proustiano ricordo che ciascuno lega alla propria infanzia − e progetti di assistenza locale e internazionale si fondono in uno scenario di crescita comune, di impegno sociale, di reciprocità, esperienze che vanno oltre la mera ristorazione: di fatto, la sua attività fa da ponte tra la cultura del produrre e quella dell’accoglienza.
Fra le tante realtà troviamo quella di Mamma Africa, Abibata Konate, arrivata in Italia nel 1994 dalla Costa d’Avorio, che all’Albergheria ha dato il via a uno spazio che è difficile definire un mero ristorante etnico, è piuttosto un luogo dove cibo condiviso − piatti gustosi e “della nostalgia”, come li definiscono gli avventori migranti, ricreati qui come nei Paesi di origine grazie alla storica varietà di mercanzie offerte dal mercato di Ballarò [1], per dar loro quel proustiano ricordo che ciascuno lega alla propria infanzia − e progetti di assistenza locale e internazionale si fondono in uno scenario di crescita comune, di impegno sociale, di reciprocità, esperienze che vanno oltre la mera ristorazione: di fatto, la sua attività fa da ponte tra la cultura del produrre e quella dell’accoglienza.
Il lavoro di Abibata, iniziato per ricreare qui un po’ di quella vita quotidiana che aveva lasciato nella terra d’origine, per fare delle proprie competenze un mestiere, e per aiutare i tanti migranti meno fortunati di lei, si è gradualmente trasformato in una piccola impresa della ristorazione, ha esteso questo intento assistenziale a chi, straniero o locale, si trovasse nella condizione di aver bisogno di un pasto caldo, consumato in un contesto di familiare cortesia, di sano ristoro che sarebbe riduttivo considerare solo materiale, e ha dato vita a un’organizzazione, una onlus [2] che opera a cavallo tra l’Italia e il Burkina Faso, Paese di origine del marito, volta a promuovere l’istruzione e ad alimentare fonti di sussistenza attraverso la realizzazione di laboratori professionali e la coltivazione del più tipico simbolo delle campagne siciliane, il ficodindia, forte, adatto al clima torrido delle arse campagne nostrane e utilizzato, nella cultura contadina, in ogni sua parte.
Differente, ma ugualmente interessante, è invece il progetto di due giovani palermitane, ascrivibili secondo gli schematismi giuridici tra i migranti di seconda generazione, ma più semplicemente figlie della inedita cultura, tanto negata quanto ricca e diffusa, che si sviluppa tra le origini familiari e il quotidiano locale del quale hanno sempre fatto parte. Anche quella di Aissetou Jaith e Adjo Cuccia è un’attività che fa della mescolanza un punto di forza troppe volte ciecamente ignorato dalle logiche ottuse dell’esclusione. Adjo è originaria del Togo ed è stata adottata da una famiglia palermitana quando aveva nove anni. Per arrotondare fa pure la baby sitter ed è iscritta a Scienze della comunicazione. Aissetou, nata a Palermo da genitori del Gambia, insegna anche danza. Entrambe hanno fatto apprendistato nella pratica sartoriale e si sono distinte nelle fiere artigianali locali.
 La realtà di African Queens [3], questo è il nome che le due creative imprenditrici hanno dato alla loro linea sartoriale, che, partendo dai colori, dalle trame, dai disegni dei tessuti africani, dà vita a una moda di foggia prevalentemente occidentale, arricchita dall’ibridazione visiva e concettuale con l’immagine più colorata dell’Africa, abiti e accessori assunti a bandiera di una terra, da cui, bandite frontiere e distanze, si dispiega un tripudio di vitalità cromatica, di ricchezza estetica e di densità simboliche Le stoffe provengono dal Ghana, dalla Costa d’Avorio e dal Senegal. I prodotti finiti sono accessori e capi di abbigliamento non solo femminile.
La realtà di African Queens [3], questo è il nome che le due creative imprenditrici hanno dato alla loro linea sartoriale, che, partendo dai colori, dalle trame, dai disegni dei tessuti africani, dà vita a una moda di foggia prevalentemente occidentale, arricchita dall’ibridazione visiva e concettuale con l’immagine più colorata dell’Africa, abiti e accessori assunti a bandiera di una terra, da cui, bandite frontiere e distanze, si dispiega un tripudio di vitalità cromatica, di ricchezza estetica e di densità simboliche Le stoffe provengono dal Ghana, dalla Costa d’Avorio e dal Senegal. I prodotti finiti sono accessori e capi di abbigliamento non solo femminile.
Le due donne creative che portano avanti questo progetto hanno scelto di agire concretamente nel tessuto locale, iniziando anche loro a muovere i primi passi sul fertile suolo dell’Albergheria, muovendo dal circuito delle conoscenze locali, per avviare il processo di visibilità necessaria a diffondere l’esperienza imprenditoriale che, oltre a essere un’attività commerciale, si presenta come volontà di affermazione, come varco nella barriera dell’esclusione sociale.
 Rivolgendosi a questo primo mercato aperto e variegato hanno, infatti, dato forma a una originale ibridazione sartoriale che promuove la mescolanza culturale, sociale e economica, ma che in realtà rappresenta un interessante messaggio di riscatto e di emancipazione, una reazione di largo respiro a tutte le esclusioni perpetrate nella realtà di ogni giorno, siano esse dovute alla provenienza, al colore della pelle, alla taglia che, per difetto o per eccesso, si posiziona al di fuori dagli asfittici standard estetici convenzionalmente accettati, all’età, troppo giovane o troppo vecchia per le vestali del sistema.
Rivolgendosi a questo primo mercato aperto e variegato hanno, infatti, dato forma a una originale ibridazione sartoriale che promuove la mescolanza culturale, sociale e economica, ma che in realtà rappresenta un interessante messaggio di riscatto e di emancipazione, una reazione di largo respiro a tutte le esclusioni perpetrate nella realtà di ogni giorno, siano esse dovute alla provenienza, al colore della pelle, alla taglia che, per difetto o per eccesso, si posiziona al di fuori dagli asfittici standard estetici convenzionalmente accettati, all’età, troppo giovane o troppo vecchia per le vestali del sistema.
L’immagine dell’imprenditoria femminile migrante che si delinea dall’osservazione dei singoli fenomeni, mostra da una parte una realtà sommerca che resiste e sopravvive alla politica dell’odio sociale ed etnico, sottraendosi alla concorrenza dell’egemonia maschile del mercato globalizzato; dall’altra è volta ad arricchire e rinnovare l’economia locale, attraverso la naturale rete dei traffici commerciali e le indotte connessioni sociali. Ma ancor più importante è l’apporto culturale che queste esperienze produttive sorte ed inventate dal basso, frutto di felici commistioni e dell’incontro di sensibilità, stili di vita e storie diverse, offrono all’Occidente quale antidoto ai pervasivi processi di omologazione.
Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018
Note
[1] Secondo quanto riportato da Muhammad Ibn Jubayr, viaggiatore, storico e letterato andaluso, che visitò Palermo nel 1184, quando ancora la realtà musulmana era ancora solida tra i nuovi assetti normanni, Ballarò, storico mercato dell’Albergheria, deve probabilmente il suo nome al villaggio di mercanti dediti alla vendita di prodotti locali ma anche di spezie, cibi, frutti, tessuti e artefatti provenienti dal mondo islamico al di là del Mediterraneo. Bahlara,sorto intorno alla porta di mare Bab- al- Bahar, appena fuori Palermo, spostava nei pressi del Kemonia la sua attività di vendita dando origine al mercato tutt’ora esistente e ancora imbevuto dell’iniziale spirito di mescolanza.
[2] Il cui sito è ancora in fase di creazione: http://www.mammaafricaonlus.org/index.html.
[3] Sito: http://www.africanqueens.it/
_______________________________________________________________________________
Valeria Dell’Orzo, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e in Antropologia culturale e Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha indirizzato le sue ricerche all’osservazione e allo studio delle società contemporanee e, in particolare, del fenomeno delle migrazioni e delle diaspore, senza mai perdere di vista l’intersecarsi dei piani sincronici e diacronici nell’analisi dei fatti sociali e culturali e nella ricognizione delle dinamiche urbane.
________________________________________________________________









