di Nicolò Atzori
Revanscismo digitale
Sono sardo, convintamente. L’essere tale è quella che mi sembra una condizione felicemente in grado di rendere eccepibile il mio sentirmi un abitante del mondo. La Sardegna mi appartiene nella misura in cui io appartengo a lei: sono sardo perché il mio stare in questo mondo riflette l’idea che nutro di una terra che osservo e percepisco dirigere i miei modi di fare, dire e sentire; lo sono perché cosciente della sua posizione nella storia e in questo entropico presente.
La storia, appunto, colei che tutto muove e tutto puote, è l’incolpevole mandante del mio odio verso una certa Sardegna: non già quella che abito, che vivo a palmo a palmo e che si manifesta ai miei occhi e al mio bisogno di comprensione in tutta la compattezza della sua problematicità, bensì quella risultante da descrizioni, narrazioni e mitizzazioni limitanti, edificate da e per un certo gusto nazionale e un generale morboso bisogno di “vero”, “autentico”, “genuino”, “primordiale”. Insomma, esotico.
Una proiezione della Sardegna, in sostanza, che si è fatta strada lentamente, nel corso dei decenni, a partire forse dai primi grandi interventi sulla Costa Smeralda, all’inizio dei Sessanta, quando ha cominciato a sgretolarsi l’idea (fallace) di un’isola storicamente incorrotta e ora finalmente e una volta per tutte alla portata del nuovo che avanza, degli stimoli esterni, del progresso per i sardi e per chi li ama. Un progresso gretto, sbiadito, autoreferenziale. Per contro, una contraddittoria visione (una fra le tante che informano il senso comune sardo) esige che, proprio in funzione di quei trascorsi irrispettosi della bellezza dei litorali e della vita simbiotica dei loro abitanti, si proceda a squarciare simile patina di corruzione (estetico-fisica), sconfessando tali abietti modelli per disvelare, invece, ciò ch’è sostanza dell’ethos sardo: le sue tradizioni, la fierezza della sua gente, la grande capacità d’arrangiarsi, l’impossibilità d’arrendersi. Stereotipi che, a poco a poco, si sono cristallizzati, quali virtù, nell’immaginario collettivo di una larga parte di società per divenire gli arpioni di un revisionismo da tastiera [1] il quale si propone di discutere le acquisizioni della ricerca suggerendo scenari indimostrati e indimostrabili in cui si esalta una civiltà nuragica fatta di giganti e guerrieri imbattibili [2] e ingiungendo agli addetti ai lavori di tacere in quanto complici della damnatio memoriae ordita dalla scienza ufficiale. Questa avrebbe voluto celare una verità alternativa che, emersa con l’archeologia, avrebbe poi occultata. Una diatriba insanabile o da liquidarsi come sfida impari fra esperti buoni contro ignoranti cattivi? Sia mai, gli immaginari collettivi sono ben altra cosa: ne vanno analizzate tutte le sfaccettature.
Il meccanismo utilizzato in questa impasse è generalmente quello che non mi sembra improprio definire guerra logica (di logoramento) e si riferisce principalmente al periodo preistorico: con l’ausilio di suggestioni astratte ma prodotte da supposizioni che agiscono sul piano del ragionare induttivo (“siccome…e quindi…”) [3], si procede a confutare ciò che risulta stridere con la causa dell’affermazione intellettuale del predominio della Civiltà Sarda; ad esempio, l’assenza di una scrittura organica, imputata alla cancellazione sistematica delle sue prove e la cui esistenza sarebbe motivata da quella, nel resto del bacino mediterraneo, di culture già ampiamente strutturate dal punto di vista espressivo e comunicativo [4].
Aggiungo io, visto che di provocazioni si parla: si aveva davvero bisogno della scrittura, in età nuragica? Quali linee essenziali seguiva lo scambio interpersonale, comunitario e fra gruppi diversi (dunque anche commerciale) nell’impalcatura culturale dei secoli dell’età del Bronzo (e poi di quella del Ferro) isolana? Si ricorreva, peraltro, per quel che ne sappiamo, ai segni ponderali [5]. In questo caso, mi sembra che proprio il fascino pop della storia – giocato sulle modulazioni di una società ebbra di scientismo – abbia mietuto le sue vittime, imponendo di considerare primitive e, ancor più, tristemente arretrate le civiltà prive di scrittura, termine culturale spartiacque nella cronologia convenzionale [6]. Eppure esistono gli antropologi, in grado di fare i conti con simili meccaniche già da un bel po’, e gli stessi detrattori dovrebbero rifuggire certe approssimazioni, se predicano onestà e verità.
Da un lato, insomma, sembrerebbe in atto una sorta di attacco al potere intellettuale rappresentato dalla ricerca ufficiale (accademica), accusata (non certo in maniera totalmente infondata) di superbia e presunzione quando non di una razionale opera di cancellazione del passato glorioso della Sardegna megalitica; trama, questa, tessuta da non meglio individuabili gruppi di potere che agirebbero per screditare, appunto, la Vera Storia a discapito di una sua versione semplificata o ipercomplicata (a seconda della convenienza), trincerata dietro una criminosa mistificazione e generalmente irrigidita nelle asettiche posizioni dovute alle troppo rigorose metodologie della ricerca (il mantra è: le tesi ufficiali fanno i salti mortali per celare la verità, che sarebbe a portata di mano).
Dall’altro lato, invece, sembra potersi osservare come proprio la supponente riluttanza al confronto degli occupanti gli uffici dipartimentali e i consorzi di ricerca contribuisca ad allontanare profani e addetti ai lavori, acuendo l’asprezza del dibattito col risultato di stendere, fra le controparti, uno spazio d’azione sterminato impiegabile in modi plurimi e da svariati tipi di interessati o “appassionati”, liberi di arricchire lo spettro delle tesi, delle antitesi, delle suggestioni, delle invenzioni [7]. La mancanza più cocente, a mio avviso, è anzitutto quella di una linea intellettuale – non accademica – che sarebbe forse in grado di fungere da raccordo o addirittura arbitro di questa aspra contesa, magari smussando velleità e consentendo a posizioni indiscutibilmente inconciliabili, un dialogo finalizzato alla sintesi di nuovi significati improntati alla crescita civile. Penso nostalgicamente e utopisticamente alla tradizione letteraria sarda, in grado di esprimere figure del calibro di Deledda, Atzeni, Satta, Dessì e di produrre – da profani della metodologia disciplinare – visioni di una Sardegna palpabile, concreta, senza artifizi (salvo, ovviamente, rari casi stilistici, ché anche l’occhio vuole la sua parte).
In secondo luogo, si osserva la progressiva inibizione della dimensione pubblica del confronto: dell’iniziativa comunitaria, dell’incontro tra istanze della ricerca e nuove convinzioni ma anche luoghi o relitti del senso comune [8]. È un errore che in buona parte muove, a mio avviso, dalla demonizzazione “positivistica” dei folklorismi che ha troppo facilmente pervaso gli ambienti del professionismo culturale sia pubblico che privato, per certi versi animati da una fascinazione catartica molto simile a quella di chi li osteggia e che oggi ha prodotto i suoi esiti in riferimento a ben più stringenti contingenze anche di ordine globale.
Eppure mi sembra che l’opera di Gramsci e quella, fra gli altri, di Cirese dopo di lui siano state ampiamente in grado di dare conto della fulgida complessità della cultura popolare, della sua produzione espressiva (rituale, simbolica e pratica) e del suo potere semantico per la definizione degli immaginari moderni, dai quali non siamo certo in grado di astrarre [9]. E invece dell’idea di folklore resistono oggi sfumature romantiche e fiabesche, opportunamente investite di magia dall’imbonitore di turno, che nel caso sardo ha spesso l’abito buono del decisore pubblico, quasi per procura chiamato a vendere più che a migliorare la qualità del vivere di coloro dei quali fa le veci (e migliorare la di loro capacità d’acquisto, per restare nel lessico economico) [10].
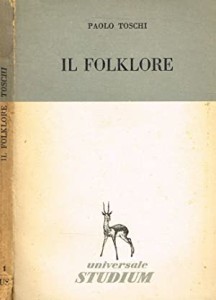 Contro ogni ingiusta, superficiale e faziosa idea di folklore, dove questo è qualificato nei termini del pittoresco, dell’antiquato e dell’arretrato, mi sembra opportuno riproporre una definizione desueta formulata da Paolo Toschi, secondo il quale esso «si rivela come la manifestazione di una perenne forza spirituale dei gruppi associati, la quale crea, conserva e tramanda quelle forme di vita pratica estetica e morale che ai gruppi stessi sono necessarie e congeniali, mentre rinnova o elimina via via quelle che sono morte e superate»[11].
Contro ogni ingiusta, superficiale e faziosa idea di folklore, dove questo è qualificato nei termini del pittoresco, dell’antiquato e dell’arretrato, mi sembra opportuno riproporre una definizione desueta formulata da Paolo Toschi, secondo il quale esso «si rivela come la manifestazione di una perenne forza spirituale dei gruppi associati, la quale crea, conserva e tramanda quelle forme di vita pratica estetica e morale che ai gruppi stessi sono necessarie e congeniali, mentre rinnova o elimina via via quelle che sono morte e superate»[11].
Insomma, il terreno del dibattito intorno alla cultura sarda e ai suoi statuti (storici, soprattutto) parrebbe, oggi, terra di nessuno, senza vincitori né vinti – Sardegna a parte, fra gli ultimi – ma anche senza una linea comunicativa o di coscienza comune; questo, perlomeno, a riferirsi alla sua dimensione pubblica nella fisicità e matericità dello scambio interpersonale, visto che la normalizzazione dei più retorici sforzi mediatici di divulgazione o informazione “scientifica” corre velocissima nell’ipertesto cibernetico e fra i gangli dei new media, oramai assurti a sacche di significati liofilizzati e pronti per l’uso, tendenze semiotiche da secondare acriticamente per non venire inghiottiti nell’oblìo della non-presenza virtuale (equivalente, per alcuni segmenti sociali, alla privazione di una identità) e vari ed eventuali escamotage per tonificare la propria vivacità intellettuale e mostrarsi intimamente parte degli innamorati ed edotti in materia di Sardegna. Quella costruita (anche dall’informazione), almeno.
Già, perché oggi parliamo di una Sardegna debitamente assemblata e infiocchettata, dove i tasselli utilizzati si riferiscono a precisi aspetti della storia, del costume e della tradizione che si assumono come tratti essenziali dell’identità sarda e ben poco, invero, hanno a che fare col tenore della più o meno remota vicenda umana nell’Isola, comprovato (fino a prova contraria) da centinaia di studi e migliaia di ore di ricerca spese. Innegabilmente (e come potrebbe essere altrimenti), certa politica ha contribuito in maniera robusta alla sistemazione di un paesaggio semantico definitosi a partire da una precisa selezione di fatti storici e rapidamente assurto a bacino di esempi virtuosi per giustificare una nuova stagione di autonomia istituzionale, che si richiama a momenti nei quali la Sardegna sarebbe stata assolutamente padrona del suo destino.
Accantoniamo momentaneamente la preistoria nuragica: è all’età di mezzo che si chiede più spesso di certificare la gloria passata, passepartout per quella futura ma in un presente che non sembra affatto disposto a concedere troppi margini. Su tutte, quella di Mariano IV e di sua figlia Eleonora d’Arborea sono le figure del Medioevo sardo che meglio racchiudono e impersonano gli slanci dei “nostalgici” di una Sardegna indipendente e temibile, che col primo vide, negli anni Settanta del Trecento, il giudicato d’Arborea [12] raggiungere la sua massima espansione e controllare la quasi totalità del suolo isolano [13]. Ancora più “politicizzato” risulta il personaggio di sua figlia Eleonora, salita sul trono giudicale arborense nel 1383 in virtù delle disposizioni dettate da suo nonno Ugone II (padre di Mariano), secondo le quali le donne potevano succedere al trono in mancanza di eredi maschi [14]. La giudicessa, sì, è una che di mistificazione ne ha patita fin troppa, bistrattato com’è stato il suo reale ruolo storico da chi la vedrebbe assurgere a “eroina della storia sarda” in grado di combattere da sola contro il bieco invasore aragonese e difendere con le unghie e con i denti il suo regno.
Proviamo a fare chiarezza. Eleonora fu prima di tutto una donna del suo tempo, esattamente come uomo del suo tempo fu suo padre Mariano, senza dubbio in grado di trasmetterle i rudimenti dell’ars politica, di insegnarle i codici comportamentali e comunicativi convenienti a corte e fuori di essa e, in lei come nei suoi fratelli, di instillare i princìpi per i quali battersi in nome del lignaggio e tenuto conto delle condizioni sociali, economiche e territoriali del suo giudicato. Ed Eleonora si dimostrò di certo un personaggio estremamente intelligente e in linea con quanto imposto dalle contingenze della fase, sebbene salita al trono – e qui risiede, forse, la straordinarietà della sua figura – nel momento probabilmente più difficile per la storia dell’Isola.
La sua lucidità e capacità di comprensione dei problemi condussero infatti la giudicessa, anzitutto, alla produzione di una nuova stesura corretta e aggiornata della Carta de Logu arborense, importante codice legislativo emanato da Mariano IV in una data non precisabile e da Eleonora promulgato – con opportune integrazioni – tra la fine degli anni Ottanta e i primissimi anni Novanta del Trecento [15]. Secondariamente, se in un primo momento ella parve intenzionata a proseguire la politica vigorosa inaugurata da suo padre, fu ancora la sua lungimiranza – compresa la gravità della situazione – a farle assumere un atteggiamento conciliante verso la Corona, animata dalla volontà di «pacificare la situazione interna del giudicato e tra questo e i territori annessi, di rafforzare il partito della «pace» – espressione delle forze sociali tradizionali – contro il partito della «libertà» – espressione dei ceti urbani emergenti», all’indomani della morte di Pietro il Cerimonioso (1387).
Effettivamente, solo la viltà della corona aragonese, che trattenne in ostaggio suo marito Brancaleone Doria, inviato in Spagna come intermediario per intavolare le trattative, costrinse Eleonora – non senza iniziali resistenze – a cedere alle richieste del sovrano Giovanni I Il Cacciatore firmando la Pace del 1388. La grandezza di Eleonora, dunque, stette di certo nella sua capacità politica, che la portò dapprima a sconfessare la linea autoritaria e dannosa del fratello Ugone III, e secondariamente a servirsi in maniera opportuna degli organismi e dei funzionari in forza al giudicato, che, da inesperta, la seppero inizialmente coadiuvare e supportare nella prassi di esercizio del potere [16].
Insomma, una acritica – ed errata – sopravvalutazione di questa figura apostrofata come “eroina” sembra fare capo all’esigenza di alcuni di riferirsi in termini lusinghieri ad un personaggio femminile, ringalluzzendo certe frange più bisognose di totem che di idee e così costruendo una narrazione pronta a subentrare in soccorso delle istanze – spesso forzate – e delle posizioni che un simile attivismo rivendica [17].
“Mariano IV primo indipendentista” e “Eleonora d’Arborea prima femminista”, allora, diventano slogan facilmente udibili. In momenti come questi mi sovviene con facilità un breve passo di Marc Bloch: «Robespierristi, antirobespierristi, noi vi chiediamo grazia: per pietà, diteci, semplicemente, chi fu Robespierre» [18]. Fosse facile.
L’esaltazione morbosa e forsennata della propria terra d’origine, però, beneficia di non poche sollecitazioni provenienti dalle visioni consolidate proposte dal palinsesto mediatico nazionale che, per il tramite del teleschermo, veicola i suoi peggiori esiti narrativi, prontamente giustificati dalla platea, adducendo ragioni promozionali, di “visibilità” (altro termine mistico) e, ovvio, di pubblicità. Il titolo della recente puntata di un noto format, quasi a canzonare, fu Sardegna, l’isola che c’è, quantunque il suo contenuto raccontasse una terra a tratti disabitata, gremita di fate e giganti, simbologie apotropaiche, guerrieri ed eroi, vecchi ultracentenari e misteri irrisolti, magie e suggestione; oltre, ovviamente, al mare, ma qui si sbaglia raramente [19]. Peccato che la Sardegna sia, pressoché ovunque, tremendamente concreta nella sua problematicità, e bisognosa di una abbondante iniezione di lucido pragmatismo per fuoriuscire da questa sorta di incantesimo inibitore della sua generale capacità introspettiva. Noi sardi, insomma, abbiamo evidenti problemi di comunicazione, comunicabilità e, quel che è forse alla base, interpreti. Su tutto, a me pare, abbiamo una paura tremenda del vuoto.
 Pane e formaggio e altre cose di Sardegna
Pane e formaggio e altre cose di Sardegna
Così il titolo dello splendido saggio di Giulio Angioni (1939-2017) chiama in causa due degli alimenti più scontati della dieta sarda. L’antropologo di Guasila vi analizza, con la sua consueta profondità, lo stato di salute di un’isola che nel rapporto coi suoi apparati tradizionali individua una puntuale cartina di tornasole. Mi ritrovo così nelle parole del giornalista bittese Natalino Piras, che, nella sua bella recensione del volume comparsa sul Messaggero nel 2003, ne individua una implicita avvertenza, cara invero alla consueta postura dell’Angioni antropologo: «attento, attenti, a non subirle le trasformazioni. Non subire le trasformazioni ma comprenderle è anche valutare il fatto che l’abbondanza di oggi è in qualche maniera frutto della scarsità di risorse di ieri» [20]. E questo prudente atteggiamento è quello di chi, vivendo da specialista e abitante le dinamiche isolane, scorge in quella che chiamiamo tradizione un bagaglio semantico di importanza capitale per lo stare al mondo dei sardi, che per questo devono vigilare sulla sua integrità.
Sul solco della tradizione, però, si gioca il secondo grande piano di confronto in materia di comunicazione e comunicabilità delle cose di Sardegna, che spesso assume l’aggettivo “tipico” quale password d’accesso al dibattito. Sotto la spinta del gusto etnico-identitario recente, ad esempio, si verifica una risemantizzazione di arti più o meno popolari e tradizionali come quelle legate alla ceramica, alla piccola metallurgia e al legno – e così via – che vengono interessate da una torsione merceologica dei loro beni e prodotti, i quali solo alla luce delle esigenze della progettualità (se va bene) turistica acquistano valore economico divenendo merci e confluendo sotto la generica categoria di artigianato artistico [21]. La perdita della funzionalità tecnica, insomma, evolve in acquisizione di valore economico. Il problema maggiore, nota Angioni, è rappresentato dal fatto che simili pratiche reificatorie siano riuscite «con successo a fingere, per esempio, che la Sardegna sia stata e continui a essere un luogo di produzione e di uso dei ‘tappeti’, che invece non risultano mai usati in tempi storici nelle case sarde del popolo, se non in chiesa e forse nelle case aristocratiche, e più scarsamente rispetto ad altri luoghi mediterranei e vicino-orientali, molto diversamente da come induce a pensare l’uso di espressioni come ‘il tappeto sardo’» che invece, osserva ancora l’antropologo, «era più normalmente coperta da letto, da tavola, da cassapanca, al massimo arazzo non principalmente ornamentale» (Angioni, 2011: 311). In poche parole, si tratta di uno dei casi esemplari dell’invenzione della tradizione già teorizzata da Hobsbawm [22]. E così via.
Il pratico e il materiale, però, non hanno affatto bisogno del fiabesco o di una folklorizzazione a tutti i costi, essenzialmente volta alla loro de-funzionalizzazione, bensì di una rieducazione a viverli, conoscerli e acquisirne rudimenti, sfumature e contorni la cui rarefazione ha inizio almeno nei decenni centrali del secolo scorso; quando, più precisamente, si cominciano a scorgere i primi segnali di una decostruzione della cultura contadina e, generalmente, della inibizione dell’attitudine antropologica dei sardi (come quasi ovunque nella Penisola, sia chiaro) a rintracciare nel saper fare delle norme di reciprocità e di vita comunitaria che, sfaldatesi, hanno proiettato gli abitanti dell’Isola in una sorta di limbo caleidoscopico ma culturalmente di complicata definizione, facilmente in grado di spaventare i meno temprati. Sarebbe approssimativo ammettere che il brusco sfacelo della cultura contadina – forse la misura della koinè sarda moderna – non abbia avuto alcuna incidenza nella costruzione di un paesaggio politico e speculativo, quindi comunicativo, così…compulsivo.
Ed è circa un quarantennio fa, nella fase a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, che «l’idea di modernità comincia a farsi meno monolitica e più articolata, recuperando quanto era stato frettolosamente abbandonato nel corso dei processi di industrializzazione e di inurbamento delle masse rurali nel secondo dopoguerra», come ha osservato da Pietro Clemente [23]. Si “scopre” l’attenzione verso il patrimonio culturale, cambia l’idea di futuro, e l’antropologia stessa amplia lo spettro delle sue prerogative epistemologiche: l’Altro, adesso, è più vicino: sulla porta di casa. Eppure, in Sardegna, una linea decisionale precisa e convinta in direzione dei luoghi e delle loro specificità, anche in grado di offrire alternative di vita locale [24] ai giovanissimi che fuggivano a gambe levate, stenta ad affermarsi. Un morbo atavico.
Va registrato, infatti, come quelli che chiamiamo territori abbiano storicamente goduto di un interesse abbastanza approssimativo e maldestro da parte delle istituzioni, spesso inadatte a stimare e soppesare le vicende strutturali di ordine sociale, economico, particolarmente giovanile, ecc. Negligenza che, in questo particolare momento, appare svilupparsi a tutto vantaggio di interventi improntati alla realizzazione di sontuose vetrine nazionali dove la parola d’ordine è la spettacolarizzazione della cultura popolare, scimmiottata nei più beceri modi, o l’esibizione di slogan ormai logori dove l’allusione si rifà sempre e comunque, ineluttabilmente, a un corpus di virtù peculiari dei sardi e invero frutto dell’inflazionamento della tradizione e di una concezione puramente estetico-contemplativa del patrimonio culturale (quando non bucolica, come nel caso di quello ambientale), cui spesso si sommano considerazioni sulla “purezza genetica” [25].
Fra gli esiti dell’ambigua linea politica regionale, così, si annovera la genesi di tendenze che, nelle aree interne, si concretano nell’organizzazione di manifestazioni di promozione delle tradizioni locali e del panorama enogastronomico – oramai “brandizzatesi” – il cui retrogusto è quello di un grande supermercato del nonluogo [26], se tale può dirsi il luogo-merce anche nell’entroterra (e credo di sì). Esito anche dell’erronea convinzione secondo la quale la tanto decantata “ricchezza della Sardegna” si possa auto-convertire e declinare in valore sociale ed economico senza sollecitazioni esogene oltre a quelle, auto-indotte, delle comunità, prive però di un piano sistemico.
No, non ho assolutamente nulla contro la “valorizzazione”, ma ritengo che il concetto sia portatore di ben più ampi significati rispetto a quelli esibiti. La valorizzazione, da queste parti, si confonde spesso con l’apertura di nuovi siti archeologici, mentre il senso è ben più ampio: essa comporta, a me pare, una effettiva messa in valore delle specificità e delle possibilità locali solo nell’ottica in cui possa primi definirsi un panorama di consapevolezze nel quale comunità, istituzioni e associazioni si preoccupino, per 365 giorni all’anno, di produrre benessere a tutti i livelli, attingendo al palinsesto patrimoniale materiale e immateriale: con quest’ultimo riferendoci a saperi, pratiche e conoscenze implicite (spesso artigianali) in grado, se apprese e messe in opera, di rendere i luoghi vivaci e pulsanti e così rieducare, per via diretta, alla comprensione dell’ethos di appartenenza, coi suoi vizi, le sue virtù e i margini di crescita.
In quella che chiamiamo tradizione, infatti, così bene indagata da De Martino, Cirese, Angioni, Bravo ecc., confluiscono ed emergono quei tratti silenti della koiné sarda, espressione della stratificazione etnica che conferisce la statura di ponte fra i popoli all’isola di Sardegna, i cui paesaggi umani tracciano le linee di un percorso culturale peculiare che, dai primi vagiti in età neolitica, ha manifestato tendenze insediative, tecniche, rituali e politiche assolutamente singolari e, per certi versi, straordinarie nel vasto ed eterogeneo mondo occidentale. Ma in linea, io penso, con la qualità del tutto multiforme in cui è possibile immergersi dalle spiagge del “grande mare”.
I sardi, insomma, non lo fanno meglio o peggio: lo fanno a modo loro, come ovunque nel mondo e in tutte le epoche; lo fanno, certo, ben consci di abitare una realtà unica a suo modo, che non cambierebbero con nessun’altra, anche coi suoi problemi eterni e apparentemente insormontabili. Ma la soglia del nostro amore verso questa terra è soggetta ad aumentare se solo contribuissimo, già individualmente e con maggior presenza, a meglio comprenderne i meccanismi che diamo magari per scontati, favorendo la loro corretta e ordinata conoscenza e comunicabilità e costruendo, così, un piccolo mondo, il nostro, nel quale sia davvero possibile cambiare e riemergere da un indistinto e asfissiante marasma cervellotico che non solo non rende giustizia alla nostra complessità, ma ne sbiadisce gli infiniti, bellissimi, colori. Perché non saremo mai più di quanto comprenderemo, a qualsiasi livello e su qualsiasi piano. E perché siamo sardi, certo, ma sulla faccia della terra.
Dialoghi Mediterranei, n. 56, luglio 2022
Note
[1] Non già da intendersi nella negativa accezione comune, ma in quanto la tastiera è effettivamente lo strumento principale del dibattito
[2]https://www.cagliaripad.it/564094/il-comandante-dellesercito-del-faraone-ramses-si-chiamava-serramanna/
[3] Per questo motivo facilmente producibili e adattabili, generalmente mutuate da atteggiamenti socio-psico-mentali e motori impliciti e definitisi in tempi relativamente molto recenti (come nell’ambito delle conoscenze ambientali, della toponomastica e della geomorfologia immanenti alla cultura contadina) e applicate, per induzione, alle fasi più remote della storia umana
[4] Rispetto alle tesi più eclatanti che coinvolgono la Sardegna d’età remota, si segnala il mito di Atlantide, su cui i contributi editoriali si sprecano: https://www.lastampa.it/cultura/2016/08/23/news/la-mitica-atlantide-la-sardegna-basta-guardarla-dall-alto-1.34824190/
[5] file:///C:/Users/nicol/Downloads/4805-Articolo-16900-1-10-20210618.pdf
[6] Si accetta generalmente che la scrittura della lingua, ampiamente successiva alla rappresentazione grafica dei numeri, sia una introduzione sumera ascrivibile quindi all’area mesopotamica del III millennio a.C., come riportato in Cantarella E., Guidorizzi G., Il lungo presente. Dalla preistoria a Giulio Cesare, Einaudi Torino, 2015: 28.
[7] Nell’ecosistema Facebook spopolano, ad esempio, i gruppi di fantarcheologia.
[8] Ciò per cui gli etnografi, in parte, si spendono.
[9] Cfr. Bravo G. La complessità della tradizione. Festa, museo e ricerca antropologica, Franco Angeli Ed., Milano, 2005.
[10]https://www.lanuovasardegna.it/regione/2019/12/02/news/all-artigiano-in-fiera-anche-il-folclore-dell-isola-1.38046359
[11] Toschi P., Folklore, Touring Club Torino 1966: 22
[12] I giudicati furono delle entità statuali indipendenti che risultano formate in Sardegna almeno dal IX sec. a.C. Essi dividevano in quattro l’isola e, nel contesto internazionale del Medioevo si contraddistinguevano per la modernità della loro organizzazione amministrativa.
[13] È certo, al netto di tutto, che Mariano sia stato una figura di importanza capitale nella storia sarda, poiché «diede respiro internazionale alla contestazione arborense, stabilendo alleanze matrimoniali a tutto campo nel Mediterraneo occidentale: con i settori dell’aristocrazia catalana in conflitto con la monarchia, con i visconti di Narbona, con una delle famiglie prefettizie romane e nell’isola con l’inquieto Brancaleone Doria», arrivando persino ad ottenere credito presso la riottosa corte pontificia (Anatra B., La Sardegna aragonese: istituzioni e società in Storia della Sardegna dalle origini al Settecento, Laterza Bari 2006: 153).
[14] Oliva A. M., La successione dinastica femminile nei troni giudicali sardi, in “Miscellanea di studi medievali sardo-catalani”, CNR, Roma, 1981: 29.
[15] https://www.filologiasarda.eu//pubblicazioni/pdf/carta_de_logu/intro.pdf
[16] https://www.treccani.it/enciclopedia/eleonora-d-arborea_%28Dizionario-Biografico%29/
[17] https://www.unadonnalgiorno.it/eleonora-darborea/
[18] Bloch M., Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi, Torino 1998, 2009: 105
[19] La puntata successiva fu, invece, di altissimo profilo divulgativo, in linea col suo canone: possibile che la consulenza scientifica isolana interpellata per la realizzazione della puntata non sia stata in grado di fare meglio? Viene il dubbio che piaccia vedersi in un certo modo: https://www.raiplay.it/video/2022/04/Ulisse-il-piacere-della-scoperta-Sardegna-isola-che-c-e-19cf7fe9-492b-4dcf-b90d-52b41c2461b6.html
[20] http://www.regione.sardegna.it/messaggero/2003_giugno_21.pdf
[21] Fare, dire, sentire, Il Maestrale Nuoro 2011: 310-311
[22] Hobsbawm E., Ranger T. (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino 1983.
[23]De Rossi A., Mascino L., Patrimonio in Manifesto per riabitare l’Italia, Donzelli, Roma 2020: 177
[24] La Sardegna non è propriamente a misura di futuro, per gli under 35.
[25] In questo caso, acquisizioni accreditate sono state strumentalizzate facilmente: https://www.lanuovasardegna.it/regione/2018/05/04/news/dna-l-italiano-non-esiste-l-unico-puro-e-il-sardo-1.16793528
https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/il-dna-dei-sardi-svela-lorigine-genetica-di-un-popolo-antichissimo.
[26] Temporaneo, ad essere precisi: l’evento ha solitamente una durata di uno o due giorni.
_____________________________________________________________
Nicolò Atzori, consegue una laurea triennale in Beni Culturali (indirizzo storico-artistico) con una tesi in Geografia e Cartografia IGM e una magistrale in Storia e Società (ind. medievistico) con una tesi in Antropologia culturale, presso l’Università di Cagliari, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Altresì, è diplomato presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 2017 lavora, per conto di CoopCulture, come operatore museale e guida turistica presso il Museo Villa Abbas e il sito archeologico di Santa Anastasia di Sardara (SU), luoghi dei quali, fra le altre cose, cura la comunicazione e, nel primo caso, gli aspetti museografici.
______________________________________________________________












