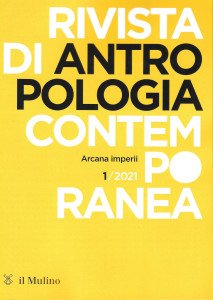«Ciò non è permesso, ma se insisti con la forza, fa’ ciò che vuoi. Per il re non c’è legge scritta» (Vita di Alessandro il Macedone, 2001: 170)
Presentazione
Cosa c’è di più contemporaneo e, al tempo stesso, inattuale del potere? Esso pare pervadere ogni aspetto della nostra vita, e mai come negli ultimi tre anni è stato al centro del dibattito pubblico. La pandemia da Covid-19 ci ha fatto entrare a stretto contatto con il potere delle istituzioni, dello Stato, di enti internazionali come il WHO; un contatto che a molti è sembrato sgradito, eccessivo, finanche pericoloso. Sono numerosi i cittadini, gli intellettuali e i ricercatori che guardano con sospetto alle biopolitiche delle nostre istituzioni, temendo di venire schiacciati dalle strategie del potere, lasciati inermi ad una mera nuda vita preda di un sistema capitalista intrinsecamente oppressivo.
È notevole quanto radicalmente si sia diffuso questo lessico nella produzione scientifica degli scienziati sociali, nel tentativo di molti di scoprire i meccanismi del potere, le leggi non scritte che definiscono l’autorità nella nostra società: gli arcana imperii del nostro tempo, assolutamente contemporanei, eppure capaci di trascendere i singoli eventi storici.
È questo il termine desueto scelto come titolo per il nuovo numero della “Rivista di Antropologia Contemporanea”. Ciascuno dei sei saggi che compongono questo terzo volume mette diversamente a fuoco il tema della “cratofobia”. Tale termine, coniato da Piero Vereni che è anche il curatore del numero, non definisce un atteggiamento culturale sui generis, bensì uno specifico approccio e posizionamento dei ricercatori sociali rispetto al potere. In particolare, esso viene visto come intrinsecamente malvagio, finalizzato solo alla conservazione e alla riproduzione di se stesso, e pressoché inattaccabile nelle sue strutture.
 In sostanza, nella cratofobia la genealogia, la funzione e il funzionamento del potere coincidono. Per il ricercatore la condizione morale di un potere così (in)definito – e in particolare la sua espressione per eccellenza: lo Stato – è inaccettabile per principio, e non lascia spazio alcuno per negoziazioni o compromessi con esso. Anzi, diventa suo preciso compito svelare le verità segrete del potere – gli arcana imperii, appunto – di cui la realtà culturale non è altro che una copertura.
In sostanza, nella cratofobia la genealogia, la funzione e il funzionamento del potere coincidono. Per il ricercatore la condizione morale di un potere così (in)definito – e in particolare la sua espressione per eccellenza: lo Stato – è inaccettabile per principio, e non lascia spazio alcuno per negoziazioni o compromessi con esso. Anzi, diventa suo preciso compito svelare le verità segrete del potere – gli arcana imperii, appunto – di cui la realtà culturale non è altro che una copertura.
“Arcana imperii” è un titolo piuttosto particolare, che personalmente mi ha rievocato alcune considerazioni di Roberto Calasso ne La rovina di Kasch (1983). In un passaggio densissimo, egli ricollega queste regole segrete all’idea e all’origine della sovranità (regale e statale) europea:
«Chi ti ha fatto conte?». Aldeberto risponde: «Chi ti ha fatto re?». Allusione prematura alla singolare intimità, da sempre, di Talleyrand con gli arcana imperii. Il punto pericoloso, per ogni sovranità, è la sua origine. Aldeberto toccava quel punto con insolenza, e con ciò si dimostrava sovrano. Quanto al segreto della sovranità, vi allude il motto dei conti di Périgord: «Re que Diou», «Null’altro che Dio» (diversa interpretazione, ma alla fine convergente: «Nessun altro re che Dio»). La sovranità può essere attaccata riconducendola all’origine, ma la sovranità vince la sua ordalia quando rifiuta di render conto, se non a qualcosa («Diou») su cui nessuno può contare» (Calasso 1983: 81).
In un brevissimo capitolo della stessa opera troviamo, prendendo a prestito il termine di Jan Assmann, una sorta di cratogonia: «In origine il potere era diffuso in un luogo, aura e miasma. Poi si raccolse in Melchisedech, sacerdote e re. Poi si divise fra un sacerdote e un re. Poi si raccolse in un re. Poi si divise fra un re e una legge. Poi si raccolse nella legge. Poi la legge si divise in molte regole. Poi le regole si diffusero in ogni luogo» (Calasso 1983: 82). Dispersione e concentrazione: il potere non è mai qualcosa di stabile, ma una continua oscillazione tra questi due poli, di mano in mano, di soggetto in soggetto. Come trasformare il potere in autorità, ossia come rendere legittimo il potere in questi passaggi è un problema che accompagna la teoria politica e giuridica.
 Lo vediamo bene in Arcana imperii, opera pressoché dimenticata del giurista Pietro De Francisci (1970). Successore di Alfredo Rocco come Ministro di Grazia e Giustizia, e di Gentile come direttore dell’Istituto fascista di cultura, personalità di spicco del governo mussoliniano, De Francisci è un personaggio difficile da inquadrare e ancor più problematico da ricordare. Per l’autore, che nei primi tre volumi esplora le forme politiche dell’antichità, il fondamento va cercato nell’esigenza di imporre un ordine, che in quanto tale si presta a tipizzazioni; criticando gli idealtipi weberiani della legittimazione (tradizionale, razionale, carismatica), egli individua due forme astratte di autorità: quella del ductus, fondato su un’autorità personale riconosciuta dal gruppo sociale; quella dell’ordinamento, in cui potere del singolo è emanazione di ordine preesistente. La prima forma costituisce una fase primitiva, che precede la seconda o che, al contrario (ma in fin dei conti è lo stesso), da essa si genera durante una crisi. Questa dinamica occulta del potere, questi processi costanti che danno concretezza al diritto, sono ciò che De Francisci riconosce come arcana imperii; il lettore capirà da sé come questa prospettiva fosse profondamente legata alle vicissitudini storiche del tempo. L’opera segna anche un passaggio importante nelle riflessioni del giurista, aprendo una fase dedicata all’analisi dei contenuti spirituali, in cui il potere diventa fatto ideologico, valorizzando la auctoritas principis.
Lo vediamo bene in Arcana imperii, opera pressoché dimenticata del giurista Pietro De Francisci (1970). Successore di Alfredo Rocco come Ministro di Grazia e Giustizia, e di Gentile come direttore dell’Istituto fascista di cultura, personalità di spicco del governo mussoliniano, De Francisci è un personaggio difficile da inquadrare e ancor più problematico da ricordare. Per l’autore, che nei primi tre volumi esplora le forme politiche dell’antichità, il fondamento va cercato nell’esigenza di imporre un ordine, che in quanto tale si presta a tipizzazioni; criticando gli idealtipi weberiani della legittimazione (tradizionale, razionale, carismatica), egli individua due forme astratte di autorità: quella del ductus, fondato su un’autorità personale riconosciuta dal gruppo sociale; quella dell’ordinamento, in cui potere del singolo è emanazione di ordine preesistente. La prima forma costituisce una fase primitiva, che precede la seconda o che, al contrario (ma in fin dei conti è lo stesso), da essa si genera durante una crisi. Questa dinamica occulta del potere, questi processi costanti che danno concretezza al diritto, sono ciò che De Francisci riconosce come arcana imperii; il lettore capirà da sé come questa prospettiva fosse profondamente legata alle vicissitudini storiche del tempo. L’opera segna anche un passaggio importante nelle riflessioni del giurista, aprendo una fase dedicata all’analisi dei contenuti spirituali, in cui il potere diventa fatto ideologico, valorizzando la auctoritas principis.
Non c’è dubbio che gli arcana imperii affascinino: lo dimostrano i moltissimi autori che si sono cimentanti nel disvelamento delle leggi del potere. A volte, però, questa esigenza è motivata dalla paura e dal sospetto. Dietro ogni teoria della cospirazione, infatti, c’è il terrore del potere, il che rende ogni complottismo una forma paranoide della cratofobia. Lo vediamo all’opera in quella sorta di ur-teoria del complotto che è QAnon, che nell’assalto a Capitol Hill ha ricevuto la sua consacrazione, e che nel Covid-19 ha trovato un vettore per diffondersi nel mondo (Martellozzo 2021). Questo movimento si differenzia dalla stragrande maggioranza dei complottismi precedenti proprio per la direzione della paranoia: il pericolo non proviene dall’esterno, da un’alterità minacciosa che si infiltra nella comunità per prenderne il controllo; la minaccia viene dall’alto, da chi ha già il potere e governa nell’ombra, come il Deep State. Qui la paura degli arcana imperii nasce dal vuoto che si cela dietro al segreto del trono, e che in quanto vuoto può essere incommensurabile e tremendo. Come osservava Eco, «un segreto vuoto si erge minaccioso e non può essere né svelato né contestato, e proprio per questo diventa strumento di potere» (Eco 2015).
Quanto possa essere eloquente un’assenza lo mostra bene il settimo saggio di questo numero della rivista: un contributo che non c’è, un testo di Vereni sul “lancio delle monetine” a Craxi, nel 1993. O meglio, riguardante la bagarre nata intorno a quel testo, dove il professore suggeriva di portare fino in fondo il regicidio – che di questo si trattava – nei confronti di Craxi. Tanto grave, secondo alcune personalità della nostra politica, da meritare un’apposita interrogazione parlamentare. Lasciando da parte l’aspetto ridicolo della vicenda – per quanto sintomatico di una certa temperie culturale – vediamo in che modo un contributo mancante può aver influenzato questo numero. Nel suo editoriale, Fabio Dei ricostruisce à rebours il saggio assente, dando contezza ai lettori non solo del suo contenuto, ma delle vicende intorno alla sua mancata pubblicazione; essa infatti solleva «importanti problemi sui limiti dell’analisi etnografica e antropologica – su quello che si può dire o non si può dire nell’analisi delle dinamiche del “potere”, specie quando in gioco sono gli stessi contesti di vita sociale della ricercatrice o del ricercatore».
La mia posizione liminale, come recensore di una rivista a cui ho contribuito, mi permette di condividere con il lettore certi retroscena della ricerca che normalmente restano relegati all’aneddotica. Quando ancora pensavo a come strutturare il testo dell’articolo, seppi delle interrogazioni parlamentari riguardo all’affaire Vereni, e potei leggere le tanto citate “provocazioni” sul regicidio di Craxi. Le trovai un bel esempio di attacco satirico alla nascente politica populista, e soprattutto interessanti per la capacità di adattare una categoria classica come quella del “regicidio rituale” al contesto contemporaneo. Decisi quindi di dedicare una sezione del mio scritto al caso Moro, riflettendo sulla dimensione simbolica del suo rapimento e del suo assassinio, e sul drammatico gioco – uso volontariamente questo termine – di potere e legittimazione tra Governo italiano, partiti politici e Brigate rosse. Anche se successivamente abbandonai questa linea d’analisi, preferendole una riflessione più specifica sul regicidio, ne rimane comunque un’eco nel testo, come un riverbero silente a quel saggio mancante di Vereni.
Penso che, in fondo, la decisione dell’autore e della Redazione di rinunciare alla pubblicazione di quel testo non vada letta come una sconfitta di fronte allo strapotere della politica e dell’editoria, né come un gesto meschino. Anzitutto perché la sua assenza, come abbiamo detto, è tutt’altro che silenziosa; ma soprattutto perché in questo modo si è evitato di ricadere in quell’atteggiamento cratofobico che questo numero di RAC vuole analizzare criticamente. Non ci si è prestati al gioco dello scandalo, della proliferazione mediatica, della polarizzazione intransigente tra schieramenti ideologici che caratterizza l’arena pubblica contemporanea, e che discende dell’atteggiamento aggressivo e populista che Vereni stesso ha criticato nel suo scritto su Craxi. «L’intera vicenda – commenta Dei – deve semmai esser letta nell’ottica di contingenti strategie di potere locale, riguardanti il mondo giornalistico, politico e accademico, strategie che si ammantano di grandi principi per sostenere interessi molto più piccoli e squallidi».
Ripartiamo proprio da Dei, che insieme a Palumbo e Graeber è tra gli autori a cui Vereni, nel suo saggio introduttivo, si riferisce per circoscrivere la cratofobia, e più in generale la prospettiva del theoretically correct nell’analisi antropologica del potere. Fabio Dei aveva già sollevato alcune critiche rispetto all’adozione entusiasta di alcune “svolte” dell’antropologia statunitense, originariamente come tentativo di adeguamento a nuovi ambienti intellettuali e accademici influenzati dalla Theory dei post-strutturalisti francesi (Dei 2020: 363). Foucault, de Certeau, Agamben diventano riferimenti assoluti, usati dai ricercatori per esplicitare il proprio posizionamento nei confronti del potere istituzionale, prendendo le parti dei deboli e degli oppressi. Questo per Vereni segna un fortissimo limite epistemologico: «la societas, dunque, questo inevitabile processo di integrazione di volontà distinte, non viene mai vista nel suo farsi e può essere solo, dentro la logica cratofobica, respinta come un incubo orrifico o negata in un’inane utopia impensabile». Tale semplificazione radicale del potere ha come effetto una sorta di “fatalismo politico”, per cui diventa impensabile cambiare il sistema senza diventare attivisti e militanti, e che al contempo dona prestigio morale per la sola opposizione ideologica a quel sistema oppressivo.
Su questo aspetto Dei è tagliente: «da qui l’odierna emarginazione dalla sfera pubblica delle discipline egemonizzate dalla Theory. Non perché troppo eversive e temute dal Potere, come a molti piacerebbe pensare, ma perché autoreferenziali e grandiosamente distaccate dal buon senso» (Dei 2017: 12). Non riprenderemo la presentazione fatta da Vereni ai saggi del volume; ci limiteremo, prima di delinearli nei loro aspetti principali, a ricordare le tre domande che orientano l’intero numero: qual è il ruolo della dimensione simbolica nei processi rigidamente deterministici delle politiche cratofobiche? L’anarchia può diventare pienamente un oggetto di studio antropologico, o in fondo rimane “solo” un progetto politico cui aderire? Come, infine, si trasformano i concetti di autorità e sovranità nei contesti cratofobici?
A quest’ultima domanda risponde bene il saggio di Adriano Favole, dedicato alla curiosa assenza – e altrettanto curiosa rivendicazione – del concetto di sovranità in antropologia e le sue trasformazioni nei contesti post-coloniali e indigeni nei territori europei d’oltremare. L’autore, affatto nuovo a queste tematiche (Favole 2020), comincia ripercorrendo, quasi genealogicamente, la trattazione inter-disciplinare della sovranità negli ultimi trent’anni. In questo senso, negli anni Novanta Favole individua una decisa svolta in antropologia verso la cratofobia, che avviene incorporando il pensiero di autori come Foucault e Agamben per una lettura sospettosa – quando non irrimediabilmente negativa – del potere e dello Stato. Tale postura teorica ha due controindicazioni: un indebito, quanto superficiale, appiattimento di tutta l’antropologia precedente su posizioni cripto-colonialiste; una graduale reificazione a-storica della categoria di “Stato”. Al contrario, essa ha uno sviluppo storico articolato ed eterogeneo, che trova nel Congresso di Vienna uno dei suoi momenti fondamentali. In quell’occasione, Calasso riconosce la capacità di M. de Talleyrand di imporre la propria teoria della legittimità, come reazione alle conquiste napoleoniche, per riformulare l’equazione dello Stato moderno.
Eppure proprio le conquiste, come ricorda Favole, sono state il mezzo con cui gli Europei hanno acquisito la loro sovranità nelle Americhe, in Africa e nel Pacifico a dispetto delle popolazioni indigene. La conquista occulta necessariamente l’origine del potere, dato che “c’è sempre un autoctono conculcato” (Calasso 1983: 58) che viene dis-conosciuto. Oggi però la comunità indigena si muove in modo doppiamente problematico rispetto al modello “assolutista” della sovranità europea, negando anzitutto le premesse di “unicità” e elaborando al contrario forme multiple di sovranità condivise. Favole sottolinea l’importanza delle esperienze di decolonizzazione, tutt’ora in corso nei territori europei d’oltremare, per un’elaborazione originale dei temi del potere, che attinge alla ricchezza del pensiero indigeno. Citando Jean-Marie Tjibaou, storica figura dell’attivismo kanak nella Nuova Caledonia, egli mostra come l’indipendenza dalla madrepatria francese non debba essere necessariamente intesa come una rottura totale, bensì come la facoltà di scegliere autonomamente le reti di inter-dipendenza. Vedremo come la creazione di queste reti, sebbene sotto un’altra forma, ritorni come proposta anche nel saggio conclusivo di Bell e Pei. Un atteggiamento cratofiliaco, di apertura e negoziazione con il potere, sta già permettendo la formazione di nuove sovranità, come in Polinesia, in cui la questione ambientale viene affrontata coinvolgendo poteri indigeni con attività nazionali e internazionali di protezione della biodiversità.
Queste convivenze sono certamente difficili da realizzare, specie quando riguardano organismi internazionali e comunità di milioni di persone; ma anche su una scala minore, esse non perdono nulla della loro complessità, come evidenzia il saggio di Chiara Cacciotti. Nel suo articolo, l’antropologa romana esplora l’esperienza di Action, storico movimento di lotta per la casa nella Capitale, e del suo passaggio da un’intransigente cratofobia verso le istituzioni statali, a un’inusitata apertura a un potere più divino: la Città del Vaticano, nella figura dell’elemosiniere apostolico, mons. Krajewski. Definire “divino” il potere della Chiesa non è un mero gioco di parole di chi scrive, ma richiama uno specifico assunto teorico di Cacciotti, che nella propria analisi si rifà alla distinzione tra potere sacro e divino proposta da Graeber e Sahlins (2019). Assumendo la religione come sorgente del potere, i due antropologi distinguono un potere sacro – dai tratti negativi e da tenere separato rispetto all’ordine profano – da un potere divino, più ambiguo, capace di agire al di fuori dell’ordine legale. Declinato nel caso di Action, le istituzioni statali (Ministeri, Comune di Roma) incarnano un potere sacro da cui storicamente il movimento tiene le distanze, adottando una chiusura cratofobica; al contrario, il progressivo “allacciamento” di Action con il mondo cattolico, culminato nell’intervento dell’elemosiniere nel 2019, sancisce una visione cratofiliaca nei confronti di un potere divino, capace di agire al di là della legge.
In effetti, questo è precisamente quanto accaduto nella palazzina occupata Santa Croce/Spin Time Labs, che nel maggio 2019 si vede privata della corrente elettrica, lasciando decine di famiglie al buio e preannunciando un possibile fallimento dell’occupazione. Dopo infruttuosi tentativi di mediazione con le autorità della Capitale, l’elemosiniere del Papa interviene riallacciando personalmente i contatti, trasgredendo consapevolmente l’ordine legale dello Stato italiano forte della sua immunità. L’occupazione a questo punto si sposta, e dalla palazzina esce nella piazza, impedendo agli operai di staccare nuovamente il contatore, ma soprattutto portando nella strada – letteralmente nell’arena pubblica – le ragioni di Action e degli inquilini che occupano Santa Croce. Tra questi c’è anche la nostra autrice, che nel suo saggio propone non solo una riflessione teorica sul graduale passaggio verso posizioni cratofiliache del movimento, bensì un dettagliato spaccato della quotidianità, delle tensioni interne, delle tante vite con cui ha convissuto. Il suo posizionamento è tanto più complesso perché quello delle occupazioni abusive è un tema quasi esclusivamente trattato attraverso prospettive cratofobiche; con la sua etnografia, Cacciotti ci parla dell’apertura verso un certo potere da parte di movimenti per il diritto alla casa, e nel contempo ci mostra come sia possibile per un antropologo adottare una prospettiva non theoretically correct e che al tempo stesso non induca in utopismi di mera solidarietà.
Con il saggio precedente il mio contributo condivide la ripresa metodica delle riflessioni di Graeber e Sahlins, ma in un contesto completamente diverso: quello del Sud Sudan. La più giovane nazione al mondo, nata nel 2011 con un referendum popolare che ne ha sancito l’indipendenza dal Sudan, ha dimostrato nel modo più drammatico l’inefficacia della mera adozione di una forma statale nei processi di decolonizzazione, come già ricordava Favole nel suo articolo. Dal 2013 questo Paese è stato attraversato da una lunga serie di conflitti civili, a loro volta alimentati dalla complessa rete di interdipendenze che lega il Sud Sudan al mondo; in questo senso, il Sud Sudan costituisce un formidabile laboratorio geopolitico, e può suonare per certi versi paradossale che al suo interno persista un regno in cui da secoli è prevista l’uccisione rituale del sovrano. Il regicidio del re Shilluk è stato infatti, fin dagli albori dell’antropologia, l’occasione per un lungo dibattito sulla regalità e la natura del potere, che da Evans-Pritchard giunge fino a Graeber. La deposizione del 34° sovrano, Kwongo Dak Padiet, nel bel mezzo della guerra civile sud-sudanese, e soprattutto la sua capacità di riprendere il trono, dimostrano che questa figura è ben lungi dall’essere un fossile culturale di epoche antiche; al contrario, il carisma e le abilità diplomatiche di questo re l’hanno reso un attore di primo piano negli accordi di pace e nei negoziati tra fazioni belligeranti.
Anche la sua deposizione, benché motivata da questioni di assoluta attualità, ha continuato a rispondere a certe forme “classiche” di rimozione del sovrano. Con buona pace di Evans-Pritchard, nel regno Shilluk il regicidio è una pratica tutt’altro che simbolica, e che non deve – né può – essere ridotta a un calcolo machiavellico. Al contrario, essa obbedisce all’imperativo di mantenere il potere divino nelle migliori mani possibili; anzi, nel miglior corpo possibile. La cerimonia di installazione e consacrazione del sovrano Shilluk mobilita l’intera comunità e coinvolge tutto il territorio del regno. Essa, come osserva Calasso, «costringe a ricapitolare la storia dalle origini, finché da essa si sprigioni la minuscola gemma che è l’atto nuovo, protetto e sostenuto da tutti i precedenti» (Calasso 1983: 241).
Il regicidio e il periodo di interregno che ne segue, tradizionalmente interpretati dagli antropologi come momenti di disordine sociale, costituiscono al contrario un esercizio di violenza e competitività che assicura la scelta non di un re, ma del migliore sovrano possibile. Durante il Condominio britannico del Sudan questo sistema fu cooptato dal governo coloniale, creando una rotazione periodica della carica regale tra tre lignaggi attraverso cui si cercò di irregimentare razionalmente la trasmissione del potere. Oggi, Kwongo Dak Padiet ha saputo recuperare quella dimensione carismatica, coniugandola con una serie di performance morali che hanno creato consenso pubblico attorno alla sua figura; in altri termini una legittimazione performativa, risultato di una relazione dinamica tra il sovrano e il suo popolo, un mutuo riconoscimento del diritto a governare e a essere governati.
 Tornando al regicidio, è interessante ricordare che questa pratica ha un fondamento “divino” proprio in Europa, dato che la sua prima teorizzazione si trova nel De rege et regis institutione del gesuita Juan de Mariana, per coincidenza pubblicato solo pochi anni dopo l’assassinio del re Enrico III da parte del domenicano Jacques Clément. Certo, il regicidio non è mai stato oggetto di nessuna delle diverse teologie politiche della Chiesa cattolica, indagate da Giovanni Salmeri all’interno del proprio saggio. Un altro passaggio da La rovina di Kasch ci sembra ideale per chiosare questo quinto articolo: «come si scindano la auctoritas e la potestas, come si alleino e si scontrino, come si subordinino l’una all’altra […] tutto questo è in primo luogo una sequenza di glosse teologiche» (Calasso 1983: 80). In sostanza, Salmeri analizza il ruolo delle teologie politiche nel definire le continue oscillazioni all’interno della Chiesa tra una sacralizzazione del potere e un suo rifiuto totale, fino alla posizione del cattolicesimo contemporaneo, che anziché definire il potere stabilisce in che modo avere a che fare con esso.
Tornando al regicidio, è interessante ricordare che questa pratica ha un fondamento “divino” proprio in Europa, dato che la sua prima teorizzazione si trova nel De rege et regis institutione del gesuita Juan de Mariana, per coincidenza pubblicato solo pochi anni dopo l’assassinio del re Enrico III da parte del domenicano Jacques Clément. Certo, il regicidio non è mai stato oggetto di nessuna delle diverse teologie politiche della Chiesa cattolica, indagate da Giovanni Salmeri all’interno del proprio saggio. Un altro passaggio da La rovina di Kasch ci sembra ideale per chiosare questo quinto articolo: «come si scindano la auctoritas e la potestas, come si alleino e si scontrino, come si subordinino l’una all’altra […] tutto questo è in primo luogo una sequenza di glosse teologiche» (Calasso 1983: 80). In sostanza, Salmeri analizza il ruolo delle teologie politiche nel definire le continue oscillazioni all’interno della Chiesa tra una sacralizzazione del potere e un suo rifiuto totale, fino alla posizione del cattolicesimo contemporaneo, che anziché definire il potere stabilisce in che modo avere a che fare con esso.
Il percorso scelto dall’autore ha come tappe il dibattito tra Schmitt e Peterson, la teologia politica di Metz, e ovviamente la teologia della liberazione nel Sud America. Da quest’ultima, o per meglio dire dal suo tramonto, Salmeri si sofferma sul contributo di François Daguet intorno a quella che chiama una “teologia della secolarizzazione”. In questo frangente, la Chiesa arretra sia dalla scena pubblica che dal politico, inteso come conduzione dello Stato, rinunciando inoltre a influenzare gli orientamenti esistenziali degli individui. D’altro canto, ciò non significa affatto che la Chiesa abbia troncato i suoi rapporti con il potere; la forte enfasi sul laicato, ad esempio, rende possibile mantenere un impegno politico, di presidiare l’arena pubblica con i valori del cattolicesimo, senza coinvolgere le gerarchie ecclesiastiche.
La parte finale del saggio è dedicata all’attuale papato di Francesco, analizzandone le narrazioni nell’ottica di quello che, pare, essere un avvicinamento al mondo profano secolarizzato. Tuttavia Salmeri evidenzia bene come queste retoriche muovano sempre dal medesimo sostrato ideologico tradizionale della Chiesa:
«Che ora l’attenzione sia puntata non più (puta caso) sulla morale sessuale ma sulla morale ecologica non toglierebbe infatti che la dinamica sarebbe in fondo molto simile: attingere cioè a un patrimonio largamente comune di eticità, le cui radici sono individuate in uno strato umano anteriore a quello confessionale, e sulle quali quindi può esserci l’accordo di tutti gli esseri umani che, per riprendere la celebre argomentazione di Tommaso d’Aquino, possono sì rifiutare l’autorità del Nuovo Testamento, possono sì rifiutare anche quella dell’Antico, ma almeno a quella della ragione devono assentire».
E però questo aggancio rischia di essere inefficace, dato che proprio le categorie di “ragione”, “natura” e “Uomo” hanno ormai perso quella dimensione universalista grazie alla decostruzione operata dalle scienze umane e sociali.
Chiude la rivista un saggio (tradotto) di Daniel Bell e Wang Pei, che senza dubbio è il più “scandaloso” della raccolta rispetto alle posizioni della Theory. I due autori si domandano, infatti, se sia possibile immaginare oggi una sorta di “giusta gerarchia” tra Stati, prendendo ispirazione dalle teorie politiche degli antichi imperi indiani e cinesi; in altre parole, una rielaborazione conservativa di strutture gerarchiche del passato per adattarle al contesto internazionale contemporaneo. Bell e Pei muovono il loro discorso da due premesse: anzitutto, l’attuale sistema di relazioni egualitarie tra Stati è una finzione ipocrita, perché ci sono chiaramente nazioni capaci di influenzare – politicamente, economicamente, militarmente – altri Stati anche in seno a organismi “paritari” come l’ONU; fin qui, un sostenitore del theoretically correct non avrebbe nulla da obiettare, anzi. Ma è il secondo assunto a rappresentare un problema: gli autori sostengono che le relazioni ineguali tra Stati non sono intrinsecamente ingiuste, e viceversa l’uguaglianza non implica necessariamente giustizia. A partire da ciò, Bell e Pei provano a rintracciare delle forme moralmente giustificate di gerarchia tra Stati, trovando esempi validi nelle teorie dell’ordine globale gerarchico presenti nel pensiero politico indiano e cinese.
 Dopo aver considerato il modello degli Stati mandala elaborato da Kautilya, filosofo e uomo di Stato del nascente impero Maurya (322 a.C. – 184 a.C.), concentrano la loro attenzione sul contesto cinese e sulle teorie politiche (e antropologiche) di Xunzi. Considerato tra i fondatori del confucianesimo e dell’ideologia politica che ne è derivata, Xunzi pone il rituale al centro delle relazioni non solo tra Stati, ma anche all’interno della società. Il rituale va considerato come una pratica sociale non-coercitiva e adattabile, che ordina la partecipazione dei singoli attraverso forme gerarchiche. Nella sua storia l’impero cinese impiegherà i rituali sia per gestire le relazioni con altre potenze, sia per articolare il proprio sistema tributario, gestendolo attraverso pratiche di reciprocità tra comunità politiche gerarchizzate.
Dopo aver considerato il modello degli Stati mandala elaborato da Kautilya, filosofo e uomo di Stato del nascente impero Maurya (322 a.C. – 184 a.C.), concentrano la loro attenzione sul contesto cinese e sulle teorie politiche (e antropologiche) di Xunzi. Considerato tra i fondatori del confucianesimo e dell’ideologia politica che ne è derivata, Xunzi pone il rituale al centro delle relazioni non solo tra Stati, ma anche all’interno della società. Il rituale va considerato come una pratica sociale non-coercitiva e adattabile, che ordina la partecipazione dei singoli attraverso forme gerarchiche. Nella sua storia l’impero cinese impiegherà i rituali sia per gestire le relazioni con altre potenze, sia per articolare il proprio sistema tributario, gestendolo attraverso pratiche di reciprocità tra comunità politiche gerarchizzate.
Pur ammettendo il divario tra ideale e realtà, i due autori cercano di adattare quest’ultimo sistema di tributi al contesto contemporaneo, immaginando un sistema gerarchizzato nell’Asia orientale in cui la Cina rappresenta il fulcro. Certo, Bell e Pei sono consapevoli che sancire, anche simbolicamente, status di inferiorità o superiorità tra Stati è incompatibile con l’ideale egualitario; un sostenitore della Theory definirebbe questo sistema come il coronamento della decennale strategia cinese di soft power. Ma lasciando da parte queste letture cratofobiche, mi domando quanto possa essere d’accordo una realtà come Taiwan, che nasce in opposizione alla sovranità cinese, e che difficilmente potrebbe riconoscere lo Stato confinante come autorità sovrana.
Ad ogni modo, nonostante le perplessità, sono d’accordo con Vereni quando sostiene che quest’ultimo articolo propone delle prospettive «particolarmente stimolanti perché sono elaborate davvero out of the box della politologia come si studia nelle scienze sociali accademicamente più riconoscibili»; inoltre, esse hanno il pregio di “scandalizzarci”, cioè di farci comprendere quanto radicate siano in noi certi assunti cratofobici. Cratofilia e cratofobia, vale la pena ricordarlo, sono gradienti che probabilmente riguardano quasi ognuno di noi, come atteggiamenti che abbiamo interiorizzato in modo più o meno consapevole e che ritroviamo riflessi nella nostra produzione scientifica e culturale.
Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022
Riferimenti bibliografici
Bell, Daniel A., Pei, Wang, 2021, “La giusta gerarchia tra gli stati ovvero il bisogno di reciprocità”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 131-160.
Cacciotti, Chiara, 2021, “Aprire è potere. Note sul passaggio dalla cratofobia alla cratofilia di un movimento di lotta per la casa romano, Action”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 63-86.
Calasso, Roberto, 1983, La rovina di Kasch, Milano, Adelphi.
Dei, Fabio, 2017, “Di Stato si muore? Per una critica dell’antropologia critica”, in F. Dei e C. Di Pasquale (a cura di), Stato, violenza, libertà, Roma, Donzelli: 9-49.
Dei, Fabio, 2020, “Oltre il campo. Etnografia, teoria e scrittura nella tradizione antropologica”, in V. Matera (a cura di), Storia dell’etnografia. Autori, teorie, pratiche, Roma: Carocci: 345-368.
Dei, Fabio, 2021, “Editoriale”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 5-7.
De Francisci, Pietro, 1970, Arcana imperii, 3 voll. (ed. or. 1947-48), Roma, Bulzoni.
Eco, Umberto, 2015, “Conclusioni sul complotto. Da Popper a Dan Brown”, Lectio Magistralis presso l’Università di Torino, 10 giugno 2015, https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=278419 [controllato 09/02/22].
Favole, Adriano (a cura di), 2020, L’Europa d’Oltremare, Milano, Raffaello Cortina.
Favole, Adriano, 2021, “Sovranità. L’antropologia politica, le prospettive indigene, l’Europa d’Oltremare”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 35-62.
Franco, Carlo (a cura di), 2001, Vita di Alessandro il Macedone, Palermo, Sellerio.
Graeber, David, Sahlins, Marshall, 2019, Il potere dei re, Milano, Raffaello Cortina.
Martellozzo, Nicola, 2021, “Il carisma del re deposto. Reinventare il potere tradizionale nel conflitto sud-sudanese”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 87-110.
Martellozzo, Nicola, 2022, “Profezie e folQlore. Il ritorno di Kennedy nella narrazione complottista di Qanon”, Dialoghi Mediterranei 53, gennaio 2022, http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/profezie-e-folqlore-il-ritorno-di-kennedy-nella-narrazione-complottista-di-qanon/ [controllato 09/02/22].
Matera, Vincenzo (a cura di), 2020, Storia dell’etnografia. Autori, teorie, pratiche, Roma, Carocci.
Salmeri, Giovanni, 2021, “Fine della teologia politica? Due storie parallele”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 111-130.
Vereni, Piero, 2021, “Arcana imperii e le semplificazioni radicali del reale. Una introduzione”, Rivista di Antropologia Contemporanea 1: 9-34.
______________________________________________________________
Nicola Martellozzo, dottorando presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali (Università di Torino), negli ultimi due anni ha partecipato come relatore ai principali convegni nazionali di settore (SIAM 2018; SIAC 2018, 2019; SIAA-ANPIA 2018). Con l’associazione Officina Mentis conduce un ciclo di seminari su Ernesto de Martino in collaborazione con l’Università di Bologna. Ha condotto periodi di ricerca etnografica nel Sud e Centro Italia, e continua tuttora una ricerca pluriennale sulle “Corse a vuoto” di Ronciglione (VT).
______________________________________________________________