di Aldo Aledda
Uno degli ultimi sviluppi della guerra in corso in Ucraina è dato dal blocco russo all’uscita dai porti del mar Nero delle navi che trasportano il grano del Paese aggredito in tutto il mondo. Si comprometterebbe così la produzione alimentare soprattutto di diversi Paesi del sud Asia e dell’Africa, innescando, di conseguenza, una crisi che porterà – si narra – alla fame e alla totale povertà le relative popolazioni che, per conseguenza, non troveranno di meglio che emigrare in luoghi migliori della terra.
Tutto ciò, pare, con l’intento di maggiorare il valore del grano russo da esportazione. Con l’avvertimento “amichevole” mandatoci dal Cremlino: state attenti Paesi europei, soprattutto quelli con le coste nel Mediterraneo, che sostenete l’Ucraina, che sarete invasi da flussi migratori non meno di come lo fu l’Est Europa a seguito della crisi siriana.
Quest’ultimo allarme, a parte essere cavalcato strumentalmente dal forte partito putiniano in Italia che punta alla risalita di qualche punto nei sondaggi sostenendo la pace a oltranza, si lega anche a una corrente sotterranea che a più riprese riaffiora nelle analisi delle forze politiche più conservatrici che oggi sono in prima fila nel proclamare la pace a vantaggio della pancia più piena degli italian first, ossia il timore dei flussi migratori. Ma l’aspetto più preoccupante della vicenda è che la relazione guerra, povertà, emigrazione ha trovato spazio nei commenti sia pure affrettati, oltre che in politici autorevoli presi dal panico (come la Ministra dell’interno che sarebbe competente a gestire questo genere di problemi), anche nelle colonne dei giornali e nei palinsesti televisivi da parte di tanti opinionisti italiani, ciascuno sia pure ispirato dalle sue personali preferenze ideologiche: prepariamoci a sigillare ancora di più le frontiere per contenere le ondate o, all’opposto, non esitiamo a salvare e ad accogliere più umanamente chi approda nelle nostre coste.
La verità è che la relazione tra povertà ed emigrazione è stata da tempo esplorata e, si può dire, anche scientificamente stabilita in modo definitivo, nel senso che la decisione di abbandonare un contesto economico sfavorevole non sta in capo ai soggetti economicamente più deboli, ossia i “poveri”, ma in quelli che si trovano a uno stadio ulteriore a quello della mera indigenza. Tutto il resto è, come dicono gli americani, scienza da tabloid. Infatti, ciò oltretutto sarebbe in contrasto con un recente sondaggio internazionale del Gallup, che mi è già capitato di segnalare in questa rivista, per cui il 4% della popolazione mondiale vorrebbe spostarsi in un altro Paese e, se ciò fosse consentito, secondo studi economici specifici, la ricchezza mondiale raddoppierebbe.
Appare chiaro che perché questo effetto avvenga i soggetti che emigrano devono essere provvisti o di un’esperienza di lavoro o di una formazione di base che consenta alle loro capacità di esprimersi a un livello tale da rendere possibile questo salto di qualità e di quantità. Ma che cosa induce tanti osservatori, a parte gli interessi di bottega, a continuare a credere nella relazione povertà/emigrazione come nelle teorie vuoto/pieno o nei pull factors? Probabilmente sono le apparenze di un fenomeno che dà la sensazione prima facie a molti osservatori e commentatori di trovare nella figura del migrante una sorta di ultimo della terra, giacché anche da come si presenta combinato nell’abbigliamento sembra, appunto, un “morto di fame”.
Incominciamo da quest’ultima impressione che è la più facile da fugare. In Italia la raffigurazione degli emigranti, poveri, malvestiti, con la classica valigia di cartone è lo stereotipo che ci hanno consegnato le immagini e le illustrazioni dell’Ottocento e primo Novecento in cui i flussi migratori erano in atto, situazioni potentemente fissate anche dalla pittura italiana a cavallo dei due secoli, segnatamente da Giovanni Fattori e la sua scuola. In realtà si trattava dell’abbigliamento frugale e quotidiano delle persone comuni che vivevano nei villaggi, da cui proveniva la massa dei migranti e la valigia di cartone era il bagaglio di chiunque non appartenesse alla classe alta abituata a spostarsi con bauli e borse di pelle con relativi servitori (una quantità limitata di migranti ma che pure vi fu).
La verità è che i disagi conosciuti in nave dai migranti, dalle malattie ai contagi, alla fame, qualche volta perfino ai naufragi, fino alle difficoltà che incontrarono molti a essere ammessi nel Paese di accoglienza e a essere ospitati in baracche oppure a essere rimandati indietro con la prima nave in partenza – tutte traversie che non mancarono di attirare le attenzioni degli scrittori più aperti socialmente, come un Edmondo De Amicis, e che costituirono anche oggetto di interrogazioni nel regio Parlamento italiano – orbene tutte queste erano solo la conseguenza di una condizione temporanea che in qualche modo si sapeva dovesse segnare chi lasciava la propria terra.
 L’accostamento che è stato fatto del disagio attuale con le esperienze passate dell’emigrazione italiana, così potentemente contenuta nel racconto deamicisiano Dagli Appennini alle Ande e spesso fatto anche da chi stende queste note, non fa apparire quella troppo distante dalla condizione in cui oggi si trova chi abbandona l’Africa e il Medio Oriente diretto in Italia.
L’accostamento che è stato fatto del disagio attuale con le esperienze passate dell’emigrazione italiana, così potentemente contenuta nel racconto deamicisiano Dagli Appennini alle Ande e spesso fatto anche da chi stende queste note, non fa apparire quella troppo distante dalla condizione in cui oggi si trova chi abbandona l’Africa e il Medio Oriente diretto in Italia.
Supponiamo, in quest’ultimo caso, che uno esca dal Mali e che come tutti i migranti abbia come prima meta un centro di smistamento dell’Algeria prima di mettersi nelle mani degli scafisti alla ricerca di un passaggio in Europa. Sicuramente in queste traversie egli conoscerà momenti drammatici che gli imporranno elevati esborsi di somme accanto a ricatti, violenze e torture, al termine delle quali, chi riesce ad approdare vivo nelle coste della Sicilia o della Calabria, si troverà comunque ad avere perso tutto, dai soldi messi insieme in famiglia per recarsi in Europa, agli indumenti, ai documenti personali, e dovrà affidare la sua sorte solo alla benevolenza di chi lo ho tratto in salvo, ma non potrà evitare di essere incluso quasi a colpo d’occhio nella categoria degli ultimi della terra.
Questo discorso si lega a quello della povertà come causa dell’emigrazione giacché fu questo aspetto a colpire i primi osservatori del fenomeno anche in Italia. Tuttavia, le cose storicamente hanno funzionato in un altro modo, soprattutto nel senso che se ci poteva essere una povertà individuale che faceva capo al singolo migrante, ce ne era una meno acuta in ambito familiare che serviva a supportare la sua volontà e le sue effettive capacità di sopravvivere in un contesto alieno. L’emigrazione italiana verso gli Stati Uniti – avverte la storica italo-americana Donna Gabaccia – avvenne quasi del tutto attraverso le catene migratorie familiari e con biglietti totalmente prepagati. La stessa cosa accadde in America Latina, in cui peraltro i primi flussi dei genovesi e dei piemontesi provenienti dal Regno di Sardegna stabilitisi nelle foci del Rio della Plata, come battistrada dell’espansione commerciale di Casa Savoia, furono seguiti dalla parte relativamente più ricca dell’Italia, ossia il resto del Nord, dalla Lombardia al Veneto. Che ciò impegnasse finanziariamente la famiglia e la parentela è confermato anche dalla canzoncina in voga allora in Italia: “Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar…”.
 Chi era povero, insomma, non si muoveva dal suo paese, come ho cercato di dimostrare nell’ultimo libro su un caso di studio come quello dell’emigrazione sarda (Sardi in fuga in Italia e dall’Italia (2022), osservando che la Sardegna partecipò con appena 130 mila persone ai grandi flussi migratori italiani otto-novecenteschi poiché versava nella povertà più assoluta, mentre ne scaricò quasi 700 mila (su una popolazione di neanche un milione e mezzo di abitanti) nel secondo dopoguerra quando incominciò il suo decollo economico. D’altro canto, come ho appena premesso, anche la grande emigrazione italiana fu inaugurata dai flussi dal Nord Italia nel momento in cui questa parte del Paese incominciava a sentire gli effetti dell’industrializzazione, con il passaggio a una agricoltura più razionale, e solo alla fine dell’Ottocento e i primi del Novecento si ebbero le uscite massicce da un Mezzogiorno che economicamente incominciava a tirare fuori la testa.
Chi era povero, insomma, non si muoveva dal suo paese, come ho cercato di dimostrare nell’ultimo libro su un caso di studio come quello dell’emigrazione sarda (Sardi in fuga in Italia e dall’Italia (2022), osservando che la Sardegna partecipò con appena 130 mila persone ai grandi flussi migratori italiani otto-novecenteschi poiché versava nella povertà più assoluta, mentre ne scaricò quasi 700 mila (su una popolazione di neanche un milione e mezzo di abitanti) nel secondo dopoguerra quando incominciò il suo decollo economico. D’altro canto, come ho appena premesso, anche la grande emigrazione italiana fu inaugurata dai flussi dal Nord Italia nel momento in cui questa parte del Paese incominciava a sentire gli effetti dell’industrializzazione, con il passaggio a una agricoltura più razionale, e solo alla fine dell’Ottocento e i primi del Novecento si ebbero le uscite massicce da un Mezzogiorno che economicamente incominciava a tirare fuori la testa.
Possiamo osservare il fenomeno anche sul fronte degli arrivi, ritenendo verosimile che se gli Stati Uniti divennero la più grande potenza economica al mondo già agli inizi del Novecento e altri Paesi dell’America Latina, come l’Argentina – che all’inizio del secolo scorso era la decima potenza mondiale – o il Venezuela – che conobbe alcune parentesi di discreto sviluppo grazie alla risorsa petrolifera – in qualche modo li seguirono, ciò non sarebbe avvenuto se si fosse riversata in questa parte del pianeta solo quella massa povera e incolta che vorrebbe un certo romanticismo migratorio.
Probabilmente a spingere parte degli europei verso il Nuovo Mondo e a rendere meno influente la condizione economica più che la povertà fu la creazione degli Stati nazionali in Europa le cui costruzioni, per avere senso e sviluppare un certo tipo di orgoglio, dovevano perseguire omogeneità linguistiche, culturali e religiose, espellendo quelle frange di abitanti meno disponibili a queste conversioni, ma il più delle volte anche quelli più professionalmente attrezzati. Pensiamo ai Padri Pellegrini che cercavano nuovi territori perché ritenevano il suolo inglese ormai non più “riformabile” dal punto di vista religioso, ma anche agli ugonotti che, dopo la revoca dell’Editto di Nantes nel 1685 da parte di Luigi XIV, si riversarono in massa negli Stati americani rappresentati da un folto numero di artigiani e di commercianti francesi di La Rochelle, contribuendo decisamente, con gli altri emigrati europei, al decollo economico del Nuovo Mondo.
Che anche nell’emigrazione degli italiani, soprattutto nel Meridione vi fosse stato stata una non piena accettazione della nuova costruzione statale che imponeva la piemontesizzazione di tutto il Paese (poi, che non si trattasse solo di un problema economico è dimostrato che contro l’abbandono delle campagne e il conseguente l’espatrio dei braccianti si opponeva con forza il partito degli agrari fortemente radicato nel Parlamento italiano), è confermato anche dal pensiero di Francesco Saverio Nitti, meridionalista, politico, Presidente del consiglio del Regno e poi della Repubblica, che non vedeva altra alternativa per chi stava nel Meridione se non essere “o briganti o migranti” anche come risultato di un fenomeno che nel Meridione poggiava sull’idea coltivata, per esempio, dal patriota anarchico Carlo Pisacane che, su citazione dello stesso Nitti, diceva: «Credo che il reggimento costituzionale del Piemonte sia più dannoso all’Italia che la tirannide di Ferdinando II».
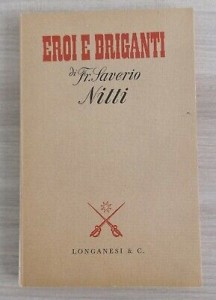 Gli italiani, in effetti, ultima realtà nazionale in Europa in ordine di tempo giunsero solo dopo l’Unità d’Italia nel Nuovo Mondo e trovarono il terreno già lavorato dai primi insediamenti europei: dagli inglesi, che avevano reciso con la rivoluzione americana il cordone ombelicale con la patria, ai tedeschi che, dopo la formazione della nazione tedesca e poi l’avvento del nazismo, emigrarono in massa in Usa (tanto che oggi costituiscono il primo gruppo etnico per appartenenza nazionale), quindi irlandesi ed europei dell’est che con gli altri divennero i protagonisti nella corsa all’american West negli spazi messi a disposizione del governo ai coloni che vi arrivavano per primi, con l’Homestead Act del 1863, in cui gli italiani giungendo relativamente in ritardo si dovettero accontentare di ciò che restava.
Gli italiani, in effetti, ultima realtà nazionale in Europa in ordine di tempo giunsero solo dopo l’Unità d’Italia nel Nuovo Mondo e trovarono il terreno già lavorato dai primi insediamenti europei: dagli inglesi, che avevano reciso con la rivoluzione americana il cordone ombelicale con la patria, ai tedeschi che, dopo la formazione della nazione tedesca e poi l’avvento del nazismo, emigrarono in massa in Usa (tanto che oggi costituiscono il primo gruppo etnico per appartenenza nazionale), quindi irlandesi ed europei dell’est che con gli altri divennero i protagonisti nella corsa all’american West negli spazi messi a disposizione del governo ai coloni che vi arrivavano per primi, con l’Homestead Act del 1863, in cui gli italiani giungendo relativamente in ritardo si dovettero accontentare di ciò che restava.
Insomma, voglio dire, nulla nasce dal nulla e non bisogna confondere la povertà assoluta, data il più delle volte dalla mancanza momentanea di cibo, con la ricerca di maggiori opportunità, il miglioramento e, perché no, anche la fortuna. Ed è quanto accade oggi in cui possiamo dire che, da un lato, sia in atto una immigrazione subita da parte di tutti in Paesi, compresi quelli emergenti, che è costituita da soggetti non particolarmente qualificati e un’altra ricercata, quella dei cervelli e delle professionalità alla cui attrazione sono impegnati un po’ tutti.
Dalle sacche più profonde della povertà mondiale, o magari solo dal disagio, proviene, è vero, l’emigrazione africana e mediorientale in Italia e in Europa, per tornare al tema principale, da un continente come quello africano che, tuttavia, sta registrando tra le più prodigiose, sia pur lente, crescite al mondo del Pil, il 16,6% nel 2019 con variazioni che vanno dal 6% della Nigeria al 34,3% della Tunisia (sebbene tutti i Paesi siano caratterizzati da un indebitamento pubblico quasi insostenibile). Stephen Smith, un giornalista e ricercatore francese che ha risieduto a lungo in Africa e oggi è docente universitario, in un libro tradotto in italiano Fuga in Europa. La giovane Africa per il Vecchio Continente (2018), è molto netto sull’argomento: dall’Africa emigra in Europa la classe media, quella che ritiene, anche per ragioni climatiche, insopportabile il continente africano ma dispone nel contempo delle risorse necessarie per affrontare l’avventura migratoria, a fronte delle classi alte che stando abbastanza bene dove si trovano non hanno ragione di muoversi e i veri poveri che sono troppo occupati a mettere insieme il pranzo e la cena per potere pensare a emigrare o tutt’al più cercano di raggiungere un Paese vicino. Inoltre, avverte il ricercatore francese a proposito delle proposte che circolano anche ad alti livelli in Europa di realizzare un piano Marshall per l’Africa: attenti che se il continente africano crescerà, a prescindere dal contributo che darà ai cambiamenti climatici, ciò avverrà a vantaggio della classe media che si svilupperà ancora di più, ma non desiderando rimanere in Africa raddoppierà il numero di coloro che oggi emigrano in Europa.
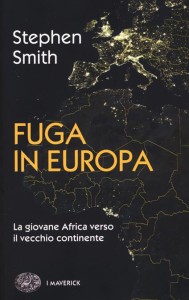 Quindi, i poveri africani che vorrebbero abbandonare il loro Paese hanno solo la scelta di recarsi in quello confinante. Mi sono già occupato di questo problema in questa stessa rivista segnalando studi e inchieste giornalistiche che mostrano come gli Stati africani, adottando prassi e istituti europei di controllo dei flussi migratori, siano divenuti più selettivi di quelli nel fare entrare cittadini del medesimo continente e, per certi versi, ancora più prevenuti nei loro confronti per effetto della nomea che si sarebbero fatti molti di loro in Europa come malviventi, turbolenti, mendicanti e sottrattori del lavoro dei residenti nel timore che si comportino nello stesso modo anche da loro. Cronache e studi, oltre che testimonianze facilmente accessibili a chi si occupa di questi problemi, hanno dimostrato che per gli africani emigrare presuppone un investimento non alla portata di tutte le famiglie. Anche perché quei cinque/seimila dollari che costerà il trasferimento e che si raccolgono, come fu per gli italiani che dovevano emigrare, tra i diversi componenti del nucleo familiare allargato, ci si aspetta si tramutino nel tempo in costanti e regolari rimesse a favore di chi è rimasto in patria, un’operazione che, per i Paesi più poveri, nel suo ammontare supera il sostegno finanziario della Banca Mondiale.
Quindi, i poveri africani che vorrebbero abbandonare il loro Paese hanno solo la scelta di recarsi in quello confinante. Mi sono già occupato di questo problema in questa stessa rivista segnalando studi e inchieste giornalistiche che mostrano come gli Stati africani, adottando prassi e istituti europei di controllo dei flussi migratori, siano divenuti più selettivi di quelli nel fare entrare cittadini del medesimo continente e, per certi versi, ancora più prevenuti nei loro confronti per effetto della nomea che si sarebbero fatti molti di loro in Europa come malviventi, turbolenti, mendicanti e sottrattori del lavoro dei residenti nel timore che si comportino nello stesso modo anche da loro. Cronache e studi, oltre che testimonianze facilmente accessibili a chi si occupa di questi problemi, hanno dimostrato che per gli africani emigrare presuppone un investimento non alla portata di tutte le famiglie. Anche perché quei cinque/seimila dollari che costerà il trasferimento e che si raccolgono, come fu per gli italiani che dovevano emigrare, tra i diversi componenti del nucleo familiare allargato, ci si aspetta si tramutino nel tempo in costanti e regolari rimesse a favore di chi è rimasto in patria, un’operazione che, per i Paesi più poveri, nel suo ammontare supera il sostegno finanziario della Banca Mondiale.
A fronte di tutto ciò sta la realtà di un continente europeo più in generale e di quella italiana in particolare che presenta il più elevato indice di invecchiamento, cui si può rimediare solo immettendo rapidamente nel sistema produttivo forze giovani, un problema che solo l’arrivo di stranieri può risolvere, e non certo le illusorie politiche di sostegno familiare, che anche se fossero efficaci non potrebbero dare frutti prima due decenni.
In tutto ciò chiaramente la povertà non c’entra, se non come problema di fondo che esige altre soluzioni. La carestia e la fame provocheranno in Africa non migranti, ma stragi di esseri umani non solo per la mancanza di grano e le malattie, ma per la lotta di ciò che rimane da mangiare, aggravata dalla condotta dei governi locali ancora più autoritaria e l’infiltrazione sempre più forte delle organizzazioni terroristiche. Ossia tutti problemi che in un modo o nell’altro toccheranno anche la Fortezza Europa. Ecco perché occorrerà continuare a guardare. Ma nel modo giusto, senza trincerarsi dietro slogan elettorali o analisi superficiali.
Dialoghi Mediterranei, n.56, luglio 2022
_____________________________________________________________
Aldo Aledda, studioso dell’emigrazione italiana con un’ampia esperienza istituzionale (coordinamento regioni italiane e cabina di regia della prima conferenza Stato-regioni e Province Autonome -CGIE), attualmente è Coordinatore del Comitato 11 ottobre d’Iniziativa per gli italiani nel mondo. Il suo ultimo libro sull’argomento è Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche (Angeli, 2016). Da attento analista del fenomeno sportivo ha pubblicato numerosi saggi e una decina di libri (tra cui Sport. Storia politica e sociale e Sport in Usa. Dal big Game al big Business, finalisti premio Bancarella e vincitori Premio letterario CONI); ha insegnato Storia all’Isef di Cagliari e nelle facoltà di Scienze motorie a Cagliari, Roma e Mar del Plata in Argentina.
______________________________________________________________








