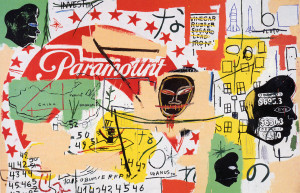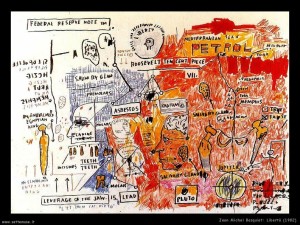di Gabriella D’Agostino
Comincerò da una ovvietà, ossia da quel fenomeno di globalizzazione indicato come una delle caratteristiche, se non la principale, del nostro tempo. Questo processo, tuttavia, lungi dall’avere un esito scontato nel senso della omogeneizzazione (dei costumi, dei sistemi di valori, ecc.), ha invece giocato un ruolo non marginale nel cosiddetto processo di “tribalizzazione del mondo” che ha visto intensificare la “produzione” di sentimenti nazionalistici e l’ostentazione di rivendicazioni identitarie. Da qui, per fare solo un esempio, la posizione di quanti come Ch. Taylor, avevano visto nel multiculturalismo una possibile concreta risposta a un progetto politico di “valorizzazione” delle cosiddette differenze etniche nei limiti dei principi universalistici (Taylor 1993). Come proponeva Michel Wieviorka (1994), una possibile soluzione sarebbe quella di una mediazione instabile tra il polo dell’individualismo e dei valori universalistici, il cui scopo è l’accesso alla cittadinanza e all’eguaglianza sociale e politica, e il polo del “communitarisme”, fondato sulle solidarietà tessute dalla storia e dalle tradizioni, mediazione che porterebbe a un métissage creativo.
La storia dell’umanità, tuttavia, si caratterizza come movimento di uomini che nel reciproco contatto (caratterizzato come scontro o come incontro, a questo livello non importa) hanno sempre dato vita a métissages creativi. La questione non è dunque una novità che intende porsi come risolutiva di una condizione inedita, o come soluzione possibile, ma di rileggere la storia e la dinamica dei contatti servendosi di categorie diverse da quelle utilizzate in questi ultimi decenni. Tra queste, la categoria dell’identità è, a mio avviso, tra le più infruttuose quando non perniciose perché reifica e rende statica una dimensione che, se proprio si vuole prendere in considerazione, si presenta piuttosto come processo, e la cui “natura” è dunque relazionale, storica, revocabile, situata, ecc.
Da sempre, insomma, gli uomini sono in cammino e le culture hanno camminato sui loro piedi. «Che cosa accadrebbe – si è chiesto James Clifford (1999) – se il viaggio, liberato dai suoi lacci, venisse vissuto come il complesso, pervasivo spettro dell’esperienza umana? Pratiche di spostamento potrebbero allora apparire come costitutive dei significati culturali, e non già un loro mero trasferimento e allargamento. Per esempio, non sarebbe più possibile celebrare, o deplorare, gli effetti culturali dell’espansionismo europeo in termini di una semplice diffusione verso l’esterno della civiltà, dell’industria, della scienza o del capitale. La regione che chiamiamo ‘Europa’ è stata infatti costantemente rimodellata e attraversata da influenze originatesi al di là delle sue frontiere» (Clifford 1999: 11). Il processo di interazione tra le culture – continua Clifford – «non è forse rilevante, in varia misura, per qualsiasi ambito di fenomeni, locale, nazionale o regionale che sia? Praticamente ovunque si volga lo sguardo, si scorgono all’opera processi umani di movimento e d’incontro complessi e di antica data. I centri culturali, le regioni e i territori precisamente delimitati non esistono prima dei contatti, ma di essi si nutrono, appropriandosene e disciplinando gli incessanti movimenti delle persone e delle cose» (Clifford 1999: 11-12).
Di fatto, «la ricerca di tradizioni pure e di differenze culturali nette» si è fondata su presupposti errati proprio per il fatto che «l’interscambio delle culture è la regola, e lo è da lungo tempo» (Clifford 1999: 13). Le ragioni di questa modalità di rappresentare le cose sono molteplici, e non tutte nobili. Altri, molto meglio di me, hanno riflettuto a lungo su questi temi e hanno fornito contributi illuminanti. In questa sede mi limito a un solo esempio, In an Antique Land Amitav Ghosh: «riattraversando di continuo i sottili confini che separano l’oggi da secoli apparentemente remoti, con in mano soltanto un frammento di lettera scritta da un mercante arabo del XII secolo, […] si mette alla ricerca di un ignoto schiavo indiano di cui non conosce neppure il nome, e che tuttavia gli appare come una chiave per intendere e raccontare una Storia fatta di tante storie, diaspore e guerre, tradizioni e incontri, rotture e sparizioni». Il libro di Ghosh è un illuminante esempio della relazione tra locale e globale, «due piccoli villaggi egiziani non lontani dal Cairo, e l’universo medievale, lungo le rotte mercantili che dal Maghreb all’Egitto, attraverso il deserto e l’Oceano, portano in India», passando per la Sicilia e la Spagna. Quel “locale” diventa luogo di «straordinario apprendistato linguistico e umano», e quel “globale” a esso si nutre e si alimenta.
Zygmunt Bauman, in una bella Intervista sull’identità (2003) racconta di quando ricevette la laurea honoris causa dall’Università di Praga. È costume di questa istituzione far suonare l’inno nazionale del Paese di appartenenza del “neolaureato” e Bauman si trovò in imbarazzo nel dover indicare il proprio. Ebreo polacco di nascita, avendo dovuto abbandonare la Polonia si era recato in Gran Bretagna di cui, successivamente, aveva assunto la cittadinanza. Con le sue parole: «Non avevo intenzione di passare per un inglese e né i miei colleghi né i miei studenti hanno mai avuto il minimo dubbio che fossi uno straniero, un polacco per essere esatti. Questo tacito gentlemen’s agreement ha impedito ai nostri rapporti di guastarsi: al contrario, li ha resi onesti, tranquilli e nel complesso sereni ed amichevoli. Avrei dovuto quindi far suonare l’inno polacco? Ma anche questa scelta non aveva molto fondamento: trent’anni e passa prima della cerimonia di Praga ero stato privato della cittadinanza polacca […]. La mia esclusione era stata ufficiale, avviata e confermata da quel potere che aveva la facoltà di distinguere il ‘dentro’ dal ‘fuori’, chi apparteneva da chi no: pertanto, il diritto all’inno nazionale polacco non mi competeva più». La soluzione viene trovata chiedendo che fosse suonato l’inno europeo: «La nostra decisione, dice Bauman, […] era al tempo stesso “inclusiva” e “esclusiva”. Alludeva a un’entità che includeva i due punti di riferimento alternativi della mia identità, ma contemporaneamente annullava, come meno rilevanti o irrilevanti, le differenze tra di essi e perciò anche una possibile “scissione di identità”. Rimuoveva la questione di una identità definita in termini di nazionalità, quel tipo di identità che mi era stata resa inaccessibile» (Bauman 2003: 4-5) [1].
Osserva infatti Bauman che l’idea di identità, e di “identità nazionale” in particolare, «non è un parto ‘naturale’ dell’esperienza umana, non emerge da questa esperienza come un lapalissiano ‘fatto concreto’. È un’idea introdotta a forza nella Lebenswelt degli uomini e delle donne moderni, e arrivata come una finzione. Si è congelata in un ‘fatto’, un ‘elemento dato’, proprio perché era stata una finzione e perché si era allargato un divario, dolorosamente percepito, tra ciò che quell’idea implicava, insinuava, suggeriva, e lo status quo ante […]. L’idea di ‘identità’ è nata dalla crisi dell’appartenenza e dallo sforzo che essa ha innescato per colmare il divario tra ‘ciò che dovrebbe essere’ e ‘ciò che è’, ed elevare la realtà ai parametri fissati dall’idea, per rifare la realtà a somiglianza dell’idea» (Bauman 2003: 19). È significativo, in questo senso, che cosa accadde in occasione di un censimento condotto in Polonia poco prima della Seconda Guerra mondiale. Gli addetti al censimento dovevano dar conto del senso di appartenenza, in termini di nazionalità, dei singoli individui censiti. In circa un milione di casi, tuttavia, i rilevatori non riuscirono a ottenere risposta a questo quesito, semplicemente per il fatto che gli intervistati non capivano il significato di parole come “nazione”, o espressioni come “avere una nazionalità”. Il senso di appartenenza si dichiarava a partire da uno specifico luogo, delimitato dall’esperienza che gli individui ne avevano: “siamo locali”, “siamo di questo posto”, “siamo di qui” e i rilevatori furono costretti ad «aggiungere la voce ‘locale’ alla lista ufficiale delle nazionalità» (Bauman 2003: 16).
Due sono, fondamentalmente, i tipi di “comunità” «cui le identità fanno riferimento come entità che le definiscono»: «comunità di vita e destino i cui membri (secondo la formula di Sigfried Kracauer) ‘vivono insieme in attaccamento indissolubile’, e comunità ‘saldate insieme unicamente da idee o vari principi’». È la negazione del primo (nelle forme più o meno drammatiche che la storia ci ha fatto conoscere, e ognuno ci metta dentro gli esempi che preferisce!) che suscita, alimenta e sostiene l’altro. «La questione dell’identità – osserva Bauman – sorge solo quando si viene a contatto con ‘comunità’ della seconda categoria, e solo perché sono molteplici le idee che creano e tengono insieme le ‘comunità saldate insieme da idee’ con cui si viene a contatto nel nostro polimorfo mondo culturale. È proprio perché ci sono tante idee e principi attorno a cui crescono ‘comunità di credenti’ che si devono fare paragoni, fare scelte, farle ripetutamente, rivedere le scelte fatte in altre occasioni, cercare di conciliare esigenze contradditorie e spesso incompatibili […]. Si diventa consapevoli che ‘l’appartenenza’ e ‘l’identità’ non sono scolpite nella roccia, non sono assicurate da una garanzia a vita, che sono in larga misura negoziabili e revocabili; e che i fattori cruciali per entrambe sono le proprie decisioni, i passi che si intraprendono, il modo in cui si agisce e la determinazione a tener fede a tutto ciò» (Bauman 2003: 16).
Amartya Sen (premio Nobel 1998 per l’Economia), in un libro dal titolo significativo, Identità e violenza (2006), va persino oltre. Scrive Sen: «Un senso di identità può essere fonte non sempli- cemente di orgoglio e felicità, ma anche di forza e sicurezza nei propri mezzi. Non sorprende che il concetto di identità incontri tanta ammirazione, dal popolare invito ad amare il prossimo alle raffinate teorie del capitale sociale e della autodefinizione comunitaria. […] Eppure l’identità può anche uccidere, uccidere con trasporto» (Sen 2006: 3; corsivo mio). Sen ci ricorda come il senso di solidarietà all’interno del gruppo, sulla base di condivisione identitaria, se da un lato, in termini di “capitale sociale”, rende la vita migliore e dunque si configura come una risorsa, come un capitale appunto, dall’altro può rendere maggiore la distanza da altri gruppi in termini di percezione, può cioè agire come dispositivo per enfatizzare la differenza e la divergenza. Lo stesso movimento cioè che unisce gli individui ne esclude altri e non di rado “senza appello”: «la calamità dell’esclusione può andare a braccetto con la benedizione dell’inclusione» (Sen 2006: 4) [2]. La realtà contemporanea ancora una volta offre decine di esempi in questo senso e ancora una volta invito a scegliere quello più convincente.
Da Jean-Loup Amselle (1990; Amselle, M’Bokolo 1999) e da altri studiosi che prima di lui avevano posto le basi per decostruire il concetto di identità etnica (Mercier 1968; Barth 1969) abbiamo imparato a quale tipo di “ragione” abbia risposto la partizione del continente africano da parte delle amministrazioni coloniali. E abbiamo imparato che il discretum, risultato appunto della “ragione coloniale”, interveniva su un continuum, su una “catena di società”, su una realtà fluida che poteva comporsi e ricomporsi a seconda delle circostanze. Sappiamo come il colonialismo abbia determinato la configurazione e le strutture di potere del presente e quale responsabilità esso abbia nei conflitti che hanno martoriato il territorio africano come altre aree. Porre l’enfasi sulla dimensione identitaria dei gruppi umani, aggettivandola in senso etnico (o etnico-territoriale), rischia di farci precipitare di nuovo verso una logica classificatoria (poco importa se, sempre più spesso, non imposta dall’alto ma rivendicata dal basso, almeno in apparenza) che finisce con il creare nuove strutture di potere. Le categorie non sono mai oggettive, neutrali, disinteressate, tanto meno le categorie sociali. La loro ragion d’essere risponde comunque a una volontà di dominio, di assoggettamento, di controllo dell’altro. Le rivendicazioni identitarie, non di rado, al di là del discorso di cui si rivestono, si accompagnano a una rivendicazione del diritto di accedere a determinate (e limitate) risorse economiche, e in modo esclusivo proprio perché si tratta di risorse limitate
La riflessione di Amartya Sen, prima richiamata, non va nel senso di una obliterazione dell’invocazione di una identità ma piuttosto verso l’idea che una «identità bellicosa può essere contrastata dal potere delle identità concorrenti». Tutti gli esseri umani possiedono molte identità simultaneamente. Oggi più che mai è forse possibile rendersi conto, in modo netto, dei processi di “stratificazione identitaria” in cui gli individui, e le comunità cui essi danno forma, sono coinvolti. Le nostre città in modo evidente – ma in realtà qualunque agglomerato di individui la cui possibilità di contatto con il resto del mondo grazie alle tecnologie di comunicazione di massa (tv satellitare, internet) fa saltare le tradizionali dicotomie centro/periferia, locale/globale – sono attraversate e investite da processi tali per cui «gli spazi appaiono indefiniti e molteplici, i tempi dei ‘radicamenti’ irregolari e fluttuanti» (Callari Galli 2004: 24).
Come scrive Appadurai (1996): «appena le forze innovative provenienti da diverse metropoli sono portate all’interno di nuove società, esse tendono, in un modo o nell’altro, a subire un processo di indigenizzazione: questo è vero della musica come degli stili abitativi, dei procedimenti scientifici come del terrorismo, degli spettacoli come delle norme costituzionali. In poche parole, le singole culture possono riprodursi o ricostruire le loro specificità sottoponendo le forme culturali transnazionali ad un processo di indigenizzazione» (cit. in Callari Galli 2004: 25). In questo senso, si è parlato di “istituzionalizzazione globale della vita mondiale” e di “localizzazione della globalità” come di processi contemporanei. Da un lato, dunque, a una deterritorializzazione dei prodotti culturali si accompagna una loro riterritorializzazione. L’invito sempre più insistente riguarda pertanto il fatto di non considerare locale e globale come dimensioni oppositive ma di «immaginare un incessante processo di deterritorializzazione che investe tanto il processo di globalizzazione quanto le forme che assume il localismo» (Callari Galli 2004: 26).
Come ha scritto Michel Foucault: «lo spazio, nella nostra contemporaneità, ci si offre sotto forma di relazioni di dislocazione», e esso ha sostituito la nozione di tempo storico come fulcro dell’organizzazione politica e culturale propria del XIX secolo (sviluppo/sottosviluppo, progresso/tradizione): non più una grande storia che si sviluppa nel tempo ma una «rete che incrocia dei punti e intreccia la sua matassa» (Foucault 1994: 13). In questo senso, forse, dobbiamo ripensare ai territori come reti che incrociano dei punti, e alle identità degli individui che vi abitano come a “matasse” da dipanare. Dobbiamo, in sostanza, ripensare alla relazione noi/gli altri in termini diversi perché il confine oggi, forse, non si segna in termini collettivi ma individuali: il plurale cede il posto al singolare.
La questione della “natura umana”, del ‘Chi siamo?’ deve essere intesa allora come una domanda politica, e la risposta non può contemplare il riferimento alla questione metafisica della natura umana: ‘che cosa distingue la nostra specie dalle altre?’. Questa domanda infatti si è sempre configurata a partire dalla definizione della relazione umano/animale ma il primo dei termini ha sempre incluso un Noi ontologicamente contrapposto a gli Altri. Pur in assenza di una esplicita e consapevole riflessione in questo senso, al livello più generale, si tratta di quell’attitudine etnocentrica che caratterizza qualunque gruppo umano, di qualunque tempo e di qualunque luogo, in relazione a una alterità rispetto a cui e grazie a cui il gruppo si marca come tale. Sappiamo bene infatti che quando la questione della natura umana è stata posta in termini metafisici e l’idea che ne è scaturita è stata utilizzata come criterio per ‘oggettivare’ alcune credenze, ossia come fondamento filosofico universale di un determinato sistema di valori presentato appunto come aderente “alla natura delle cose”, le conseguenze sono state drammatiche. Questa idea della natura umana è il perno di ogni forma di colonialismo (passato e presente).
Di fronte alla diversità due sono state, fondamentalmente, le vie perseguite dai veri detentori della natura umana [3]: o l’assimilazione – l’altro condivide le caratteristiche della natura umana, le eventuali deviazioni si possono correggere – (per es.: Colombo, Las Casas); oppure la sottomissione o l’eliminazione (l’altro non condivide le caratteristiche della natura umana, dunque è una mostruosità irrecuperabile (cfr. D’Agostino 2000). Chiunque sarà in grado di trarre esempi dal passato remoto, dal passato prossimo e dal presente.
La domanda a cui dovremmo cercare una risposta potrebbe, allora, essere posta in questi termini: come possiamo ricercare un ideale unificante che ci trasformi da una massa indistinta di individui in un gruppo di individui distinguibili, uniti tuttavia da obiettivi comuni. La nozione di ‘oggettività’ dovrebbe essere sostituita con quella di ‘solidarietà’ per lavorare alla costruzione di un mondo complesso e interrelato, simile più a un «bazar kuweitiano che non a un club per gentiluomini inglesi», come direbbe Clifford Geertz.
Tendere verso e non invece assumere una particolare forma di questa tensione come la “maniera di vivere ideale”, forse potrebbe costituire il nocciolo della questione. Ogni modo di vivere storico ha dei difetti e «dichiarare senz’altro perfetto un qualsiasi modo di vivere significa violare una massima che dovrebbe governare la ricerca della verità in ogni campo della vita: non ostruite il cammino dell’indagine» (Putnam 1995: 194). Per esempio: individuare nella democrazia un “valore universale” presuppone che ci si intenda sul significato di “valore universale”. La questione non dovrebbe essere posta in modo astratto ma essere l’esito di un ragionamento di questo tipo: è possibile trovare delle obiezioni al fatto di considerare la democrazia un valore o, che è lo stesso, è possibile «stabilire se in ogni parte del mondo gli uomini possano avere ragioni» sufficienti per considerarla tale? (Sen 2004: 67). E questo al di là del fatto che l’esercizio concreto di questa forma di governo possa lasciare a volte perplessi proprio in nome della difesa di quei principi su cui essa si fonda. Il problema allora, per riprendere Putnam, non è quello di dover scegliere entro un insieme di modi di vita ottimali già definito e determinato: è che non conosciamo un modo di vivere veramente ottimale.
In questa situazione, abbiamo una sola scelta: cercare di riformare i modi di vita che già abbiamo, per migliorarli, e tentare modi nuovi se crediamo che siano migliori; ma questi tentativi non devono essere fatti a spese del diritto degli altri di tentare per conto loro. «Non c’è niente di ingiusto nella scelta di chi decide di mantenersi fedele a un modo di vivere tradizionale per cercare di renderlo migliore, il più giusto, il più appagante possibile – finché quella persona non cerca di imporre quel modo di vivere a tutti gli altri. Questo è un ideale democratico, ovviamente; e però […] esso non deriva solo dall’idea di democrazia ma, a un livello più fondamentale, anche dal riconoscere che una verità degna di questo nome deve essere orientata al mondo e assoggettarsi alla discussione pubblica» (Putnam 1995: 194; corsivo mio).
Dialoghi Mediterranei, n.16, novembre 2015
(*) Testo letto in occasione della giornata di studio sul tema “Politiche di integrazione e meticciato: l’Università incontra Cécil Kienge”, Palermo, Steri, Sala Magna, 25 giugno 2013.
Note
[1 ] Sulla questione della cittadinanza e il processo di naturalizzazione cfr. nota 3.
[2] Riconoscere questo comporta anche lo sforzo di «comprendere quale ruolo giochi la scelta nel determinare il peso e la persuasività di identità specifiche, che sono inevitabilmente diverse» (Sen 2006: 6). I comunitaristi ritengono l’identità comunitaria un fatto “naturale”, predeterminato, che non richiede una scelta ma solo la constatazione di un dato, una presa d’atto. Tuttavia, anche in presenza dell’articolazione sociale più “semplice”, l’appartenenza ai gruppi diversi di cui il sociale si compone (maschi/femmine/gay, giovani/anziani, sposati/celibi/nubili, per fare solo qualche esempio), pesa diversamente. C’è sempre la possibilità di scegliere, fermo restando il fatto che la scelta si compie sempre all’interno del “limite di budget” cui l’individuo deve adeguarsi. Non troppo diversamente, considerarsi francese, italiano, messicano, afroamericano, ebreo, arabo, musulmano implica che si abbia consapevolezza del peso che quella identità ha, rispetto alle altre affiliazioni cui contestualmente si è riconducibili (Sen 2006: 6-7).
[3] La questione della “natura umana” ricompare curiosamente in quel processo formale che si chiama “naturalizzazione”, e mostra una contraddizione che non so sia stata rilevata. Il termine è mutuato dall’ambito biologico dove sta a indicare l’adattamento di specie animali e vegetali ad ambienti diversi da quelli originari, con conseguente modifica di determinati caratteri in risposta alle diverse condizioni. Per gli esseri umani, nell’ambito del diritto, il termine indica l’ottenimento della cittadinanza da parte di uno straniero. La condizione giuridica, culturale per definizione, l’essere ‘straniero’ rispetto all’essere ‘cittadino’, nel dispositivo della naturalizzazione viene assimilata a un processo biologico, naturale appunto. Contraddittoriamente, da un lato si presuppone una nozione identitaria forte (l’essere italiani, francesi, americani, ecc.), dunque una costellazione di tratti identitari culturalmente definiti che sia incontrovertibile (lingua, costumi, ecc.), formale, dall’altro si presuppone che lo stesso non sia per il soggetto interessato al processo, che dunque si caratterizza per tratti identitari revocabili. Più in generale, come abbiamo imparato da Van Gennep (1909) e dalle procedure di antropopoiesi messe in atto dalle diverse comunità di tutti i tempi e di tutti i luoghi, studiate dagli antropologi (cfr., per esempio, Calame, Kilani 1999; Remotti 1996), il processo di costruzione di un individuo segue un percorso che va dalla natura alla cultura, mentre per fare di uno straniero un cittadino il percorso sembra andare dalla cultura alla natura, ostentando come naturali i nuovi tratti da assumere, che sono appunto culturali.
Interessante è, in questo senso, il caso della cosiddetta “piccola naturalizzazione”. Si tratta di una versione ridotta del riconoscimento di certi diritti civili agli “indigeni africani” nella colonia eritrea. Nel Disegno di codice civile per la preparazione dell’Ordinamento della Colonia Eritrea (1903), venivano distinte due categorie: i cittadini e gli stranieri, i soggetti e gli assimilati. Sulla base del grado di “civiltà” erano considerati stranieri tutti gli individui appartenenti alla civiltà europea o a essa riconducibile, mentre i “soggetti” erano tutti i nativi e coloro a questi assimilabili, date certe condizioni. Indigeni e assimilati potevano ottenere appunto la “piccola naturalizzazione”, in via del tutto eccezionale e come una sorta di premio per coloro che facevano parte della “vera e autentica aristocrazia indigena”. In ogni caso si trattava di una condizione giuridica personale e non trasmissibile (Sòrgoni 1994: 93-95). Così un giurista commentava questa condizione: «La naturalità concessa all’indigeno non è che una vernice che potrà forse servire a dargli un po’ di lustro presso i suoi antichi compagni di tribù ma non certo a trasformarlo in cittadino […] poiché lo scopo nostro non deve essere quello di creare dei cittadini italiani» (cit. in Sòrgoni 1994: 95). In questo caso dunque il percorso si compie solo parzialmente, perché la natura del nativo è resistente al processo di incivilimento radicale e dunque questa sua natura, inferiore, ostacola il processo di naturalizzazione, di acquisizione di una natura superiore. Si tratta di una ulteriore declinazione della tesi, prospettata come fatto naturale incontestabile, che esistono individui superiori per natura appunto, e altri inferiori per natura.
Riferimenti bibliografici
Amselle J.-L.1990, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot.
Amselle J.-L., M’Bokolo E. 1999, Au cœur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte.
Appadurai A. 1996, «Sovereignty without territoriality. Notes for a Post national Geography”, in P. Yaeger (ed.), The Geography of Identity, Ann Arbor, Mich., University of Michigan Press.
Balslev A. N., Rorty R. 2001, Noi e loro. Dialogo sulla diversità culturale, Trad. e cura di S. Morini, Milano, Il Saggiatore.
Barth F. 1996 (éd.), Ethnic groups and boundaries. The Social Organisation of Culture Difference, Bergen-Oslo, Universitet Forlaget, London, George Allen & Unwin.
Bauman Z. 2003, Intervista sull’identità, a cura di Benedetto Vecchi, Roma-Bari, Laterza.
Calame C., Kilani M. 1999 (éds.), La fabrication de l’humain dans les cultures et en anthropologie, Lausanne, Payot.
Callari Galli M. 2004, «Cultura e contemporaneità. Nuovi scenari per un concetto compromesso», Rassegna italiana di Sociologia, anno 45, n. 1 (Pensare la cultura): 21-36.
D’Agostino G. 2000, “Un lungo viaggio”, in G. Cocchiara, L’eterno selvaggio, n. ed. a cura di G. D’Agostino, Palermo, Sellerio: 9-30.
Foucault M. 1994, Eterotopia. Luoghi e non luoghi metropolitani, in Millepiani, Milano, Mimesis: 9-22.
Mercier P. 1968, Tradition, changement, histoire, les « Somba » du Dahomey septentrional, Paris, Anthropos.
Morini S. 2001, “Introduzione”, in Baslev A.N., Rorty R. 2001: 9-30.
Popper K. 1973, La società aperta e i suoi nemici, trad. it., Roma, Armando.
Putnam H. 1995, Pragmatism and Relativism: Universal Values and Traditional Ways of Life, in Words and Life, Cambridge MA, Cambridge University Press.
Remotti F. 1999 (a cura di), Forme di umanità. Progetti incompleti e cantieri sempre aperti, Torino, Paravia Scriptorium.
Sen A. 2004, La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un’invenzione dell’Occidente, trad. it., Milano, Mondadori.
2006, Identità e violenza, trad. it., Roma-Bari, Laterza.
Sòrgoni B. 1998, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941), Napoli, Liguori.
Taylor Ch. 1994, Multiculturalisme: différence et démocratie, Paris, Aubier.
Van Gennep A. 1909, Les rites de passage, Paris, Nourry.
Wieviorka M. 1994, La démocratie à l’épreuve: nationalisme, populisme, ethnicité, Paris, La Découverte.
_______________________________________________________________________________
Gabriella D’Agostino, docente di Antropologia culturale nell’Università di Palermo, è direttore responsabile del semestrale di scienze umane, Archivio Antropologico Mediterraneo, e direttore scientifico della rassegna cinematografica, Sole Luna. Un ponte tra le culture. Ha pubblicato con Sellerio, Da vicino e da lontano. Uomini e cose di Sicilia (2002), con Flaccovio, Forme del tempo. Introduzione a un immaginario popolare (2008). Tra i suoi lavori più recenti: Histories de vie, témoignages, autobiographies de terrain, con M. Kilani e S. Montes (Lit Verlag, 2010), la curatela dell’edizione italiana del libro di T. Todorov, Una vita da passatore. Conversazione con C. Portevin (Sellerio 2010), Altre storie. Memoria dell’Italia in Eritrea (Archetipolibri 2012), nonché la Prefazione e la curatela dell’edizione italiana (con V. Matera), in R. H. Robbins, Antropologia. Un approccio per problemi (Utet 2009, 2a ed. 2015).
________________________________________________________________________________