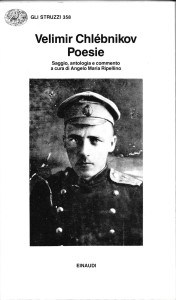Marina Cvetaeva è il terzo, dopo Chlebnikov e Mandel’štam, dei poeti russi di cui Angelo Maria Ripellino avrebbe voluto occuparsi «personalmente» quando la Collezione di poesia Einaudi, la mitica ‘bianca’, dovuta peraltro a una sua idea, cominciò, sullo scorcio del 1963, a prender corpo [1]. La scelta non era fortuita. Nella sua Poesia russa del Novecento (Guanda 1954; Feltrinelli 1960) Ripellino aveva dato della Cvetaeva una valutazione nettamente più alta di quella del suo predecessore Renato Poggioli (che nel saggio preposto a Il fiore del verso russo, uscito da Einaudi nel 1949, l’aveva inserita tra i ‘minori’), ed era oggi confortato da nuove edizioni, come la monacense di Lebedinyj stan (1957) o il corpus moscovita Izbrannoe (1961), venute a rilanciarne il nome.
Come sappiamo, Ripellino non ha fatto in tempo a lasciarci un suo Mandel’štam, una sua Cvetaeva: ci ha solo lasciato un sovrumano Chlebnikov [2], che accresce il nostro rimpianto per gli esclusi. A escludere la Cvetaeva concorse, nel 1967, l’apparizione dell’antologia curata per Rizzoli da Pietro Zveteremich, fumo negli occhi per chi anelava a giungere per primo, segnare la strada. Trovandosi a parlarne [3], Ripellino si pronunziò in via preliminare sulla traduzione, con uno scatto esegetico che prefigura, non senza un’ombra di rammarico, la sua possibile prova:
«Benemerita impresa! Versione cauta, paziente, fedele. Ma, scusatemi, dov’è la Cvetàeva? Un fragore di oceano in tempesta è divenuto sciacquio da trovarobe, l’urlato s’è fatto modulazione da camera. So bene quanto sia duro trasporre questo tessuto vocale, in cui le parole si attraggono ed urtano per parentela fonetica, spezzandosi in stridule schegge, questo tessuto malato di un’infrenabile iperemia di assonanze, – questa trama affannosa di frasi a squarciagola, scagliate alla cieca, a precipizio. Eppure qualcosa di più si poteva ottenere con aggiustamenti ed astuzie, tentando nella nostra lingua consimili rinterzi e viluppi acustici, evitando le vane inversioni, lavorando (accanitamente) di lessico.
Ma al traduttore è mancato il coraggio della manovra e del giuoco, il gusto del vocabolo acerbo e dissueto, la voglia di condividere sino in fondo questo martirio verbale. E perciò la sua versione senza follia va presa come un’interlineare, nient’altro. Ossia come un’ombra scialba del linguaggio frenetico della Cvetàeva, di quell’asfissia del linguaggio, malmenato e strozzato, ridotto a monosillabi, a gridi, a deflagrazioni, – di quell’Alta Raucedine, sgrigliolìo di parole sfiancate e contratte, che si reggono insieme, come una turba di invalidi e di sbandati, mediante trattini e rimandi fonetici, che guizzano per i versi come micce».
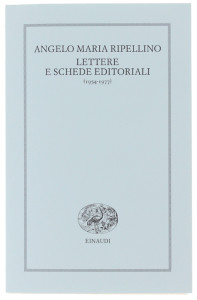 Il prosieguo del ‘pezzo’ − una miniera di folgoranti intuizioni, di catene di immagini che valgono più di laboriose formule critiche − mostra che Ripellino aveva visto bene, ben misurato il peso del poeta. Ne fa fede, per limitarci all’Italia, una fortuna editoriale che dura ormai da mezzo secolo, e che ci ha reso disponibile una quota significativa dell’immenso lascito cvetaveiano. E non è un caso che vi abbiano notevolmente contribuito due allieve di Ripellino: Serena Vitale, con una decina di volumi, e Caterina Graziadei, che, dopo la magnifica traduzione del poema L’accalappiatopi (ed. e/o 1983 e 2017), presenta ora, per i tipi di Nottetempo, la prima integrale (con testo a fronte) del ciclo Lebedinyj stan (Il Campo dei cigni).
Il prosieguo del ‘pezzo’ − una miniera di folgoranti intuizioni, di catene di immagini che valgono più di laboriose formule critiche − mostra che Ripellino aveva visto bene, ben misurato il peso del poeta. Ne fa fede, per limitarci all’Italia, una fortuna editoriale che dura ormai da mezzo secolo, e che ci ha reso disponibile una quota significativa dell’immenso lascito cvetaveiano. E non è un caso che vi abbiano notevolmente contribuito due allieve di Ripellino: Serena Vitale, con una decina di volumi, e Caterina Graziadei, che, dopo la magnifica traduzione del poema L’accalappiatopi (ed. e/o 1983 e 2017), presenta ora, per i tipi di Nottetempo, la prima integrale (con testo a fronte) del ciclo Lebedinyj stan (Il Campo dei cigni).
L’opera − affidata, come ricorda la curatrice, dalla stessa Cvetaeva all’Università di Ginevra prima del suo rientro in Unione Sovietica nel 1939, e apparsa, come si è anticipato, a Monaco nel 1957 − è una ansimante ‘diretta’ dell’immane rivolgimento che dal Febbraio porta all’Ottobre, e quindi alla sanguinosa guerra civile e alla vittoria comunista: un percorso scandito dalle date in calce alle poesie, che si estendono dal 2 marzo 1917 al 31 dicembre 1920.
Ai tempi convulsi Marina va incontro con la sua endemica «voluttà della mischia e dell’abisso», e da «eterno contrario» (così ancora Ripellino). Come sempre si ritrova dalla ‘parte sbagliata’, avversaria dei ‘rossi’; e il suo isolamento è presto aggravato dall’assenza del marito, Sergej Efron (che dopo l’insurrezione bolscevica si unisce all’esercito volontario dei ‘bianchi’), e dalla necessità di provvedere, nel trambusto e nella carestia, alle due figliolette Alja e Irina. Li cito perché nel diario ha gran parte la sollecitudine, tutta femminile, per i loro destini. A partire dalla poesia inaugurale, datata 18 gennaio 1918 (l’unica a eludere l’ordine rigorosamente cronologico della serie), che commemora in cadenze epiche l’avvio di Sergej al fronte: «Sulla tua daga hai inciso: Marina − | levandoti in difesa della Patria». Sergej riappare nei trepidi versi del 12 maggio 1918 («Non so se è vivo o non è vivo | chi mi è più caro del cuore, | chi mi è più caro del figlio […] Se l’incontrerai – dimmelo»), nella ‘lettera’ del novembre 1919 («Vuoi sapere come scorrono i giorni | miei nel paese delle offese?»), nel disperato appello dell’ottobre 1920: «di te, mia vertigine, | parlo, rispondi!» Quanto alle bambine, Irina, che morirà d’inedia a meno di tre anni, è evocata in due poesie del 26 agosto 1918 («Trinità, proteggi l’erede | di gioie imperiture»; «crescerà splendida – la mia bimba»), Alja, colta in due momenti di condiviso cammino («Giovane una, l’altra di quattro anni: | tu ed io – lungo la Moscova»; «Madre e figlia andiamo – due viandanti»), si presta anche a una dolce iconografia:
La camiciola intessuta d’argento
serra il petto tempestato di stelle!
La testa – un caschetto fiorito
d’argento cesellato.
Gli occhi – due laghi di steppa,
due Divine rivelazioni –
sul volto di un rosa velato
da Guerra e Ispirazione.
Ad Alja si può prendere a emblema della raccolta, per il modo in cui la dimensione privata e affettiva si intreccia indissolubilmente alla Storia, includendo il richiamo al padre, «anche lui Angelo e Guerriero», e la preghiera per «la nostra Armata». La scelta di campo e l’impegno solennemente sancito in chiusa ai versi del novembre 1920 («Bianco cimento, hai trovato il tuo annalista!») rendono queste poesie, scrive Ripellino, «quasi lamenti, per l’“accampamento dei cigni”, l’esercito bianco, destinato a perire». La testimonianza di Marina, anche se ad occhi ben aperti, oltrepassa infatti la mera cronaca vivendola quasi come già trascorsa e associandovi remoti eventi della storia russa: Gengis Khan e l’Orda d’oro, Griška Otrep’ev, Napoleone, i falsi Dimitrij. Marina Mniszech, Sten’ka Razin, Pugačëv. L’annalista, per usare una bella triade di Caterina Graziadei (in Postfazione), è in uno «cantore medioevale, voce guerriera e lamento di coro greco», avverte nel presente il rintocco dei Secoli, l’unisono dei Lutti e delle Imprese. Così vediamo scorrere, come fotogrammi di una pellicola dimenticata in archivi polverosi, «colore di cenere e sabbia, − | le truppe della rivoluzione», gli «occhi chiari» dello Zar deposto, il principe Alessio, «l’agnello di Càrskoe Selò», la «Mosca del sottosuolo», Kerenskij, «il giovane dittatore, | pari a un turbine ardente», le «sciabole sguainate» degli Junker caduti a Nižnij, la razzia a un «fondaco di vini», il generale cosacco Kornilov, la «santa legione della Guardia Bianca», il Cremlino «precluso al popolo», il «sacro cuore di Aleksandr Blok», i «giorni funesti dell’Ottobre», fino all’amaro e glorioso «Buon Anno» agli sconfitti, ai «guerrieri armati di bisaccia», che sigilla il libro.
 Nella sua Postfazione la Graziadei (che alla ‘incandescenza’ della Cvetaeva, al suo fondo magico e visionario ha consacrato pagine prestigiose)[4] illustra autorevolmente la «varietà di temi, ritmi, lessico» che alimenta il fuoco di queste liriche (restituito per quanto possibile, e certo con strenuo agonismo, nella traduzione), registrandone insieme le costanti: il basso continuo della tradizione epica (il Cantare della schiera di Igor’, il Lamento sulla disfatta della terra russa), il tratto infantile e fiabesco, la «vocazione conativa», il gioco dei contrasti cromatici, il gusto delle simmetrie e delle ripetizioni, il frequente ricorso all’allitterazione e all’assonanza, l’insistenza sulle ‘figure etimologiche’, la sintassi nominale e l’ellissi che reclamano, direbbe Pizzuto, la compartecipazione attiva del lettore.
Nella sua Postfazione la Graziadei (che alla ‘incandescenza’ della Cvetaeva, al suo fondo magico e visionario ha consacrato pagine prestigiose)[4] illustra autorevolmente la «varietà di temi, ritmi, lessico» che alimenta il fuoco di queste liriche (restituito per quanto possibile, e certo con strenuo agonismo, nella traduzione), registrandone insieme le costanti: il basso continuo della tradizione epica (il Cantare della schiera di Igor’, il Lamento sulla disfatta della terra russa), il tratto infantile e fiabesco, la «vocazione conativa», il gioco dei contrasti cromatici, il gusto delle simmetrie e delle ripetizioni, il frequente ricorso all’allitterazione e all’assonanza, l’insistenza sulle ‘figure etimologiche’, la sintassi nominale e l’ellissi che reclamano, direbbe Pizzuto, la compartecipazione attiva del lettore.
Da tutta questa dovizia, e con l’orecchio difettivo di chi non sa il russo, sia lecito trascegliere alcune perle che sembrano felicemente superare le arcigne barriere della lingua: la litania, in antifrasi, sulla giustizia divina che «macera l’erba, | prosciuga i fiumi, | tormenta gli storpi, || invia ladro e serpe, | moria e carestia, | onta e fetore, | tuono e gragnola»; l’epicedio per Aleksej Aleksandrovič Stachovič, il maestro di etichetta e di postura morto suicida nel febbraio 1919, in cui «ancora alitava il Secolo Diciotto»; i versi da pari a pari, da sovrana a sovrano, ‘scagliati’ a Pietro il Grande, progenitore del Disastro; e l’impagabile autoritratto del 20 settembre 1920: «C’è nella mia figura – fermezza di ufficiale, | c’è nel mio petto – onore di ufficiale. | Ogni tormento indomita affronto: | io che resisto come un soldato!»[5].
Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
Note
[1] Vd. Angelo Maria Ripellino, Lettere e schede editoriali (1954-1977), a cura di Antonio Pane, introduzione di Alessandro Fo, Torino, Einaudi, 2018: 69-70.
[2] Poesie di Chlébnikov. Saggio, antologia, commento, Torino, Einaudi, 1968.
[3] Vd. Il cigno abbandonato, «L’Espresso», 19 marzo 1967: 22.
[4] L’origine orfico rituale della poesia in Marina Cvetaeva, in Caterina Graziadei, Il gladiatore morente. Saggi di poesia russa, Fiesole, Cadmo («Esedra»), 2000: 213-267.
______________________________________________________________
Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999).
_______________________________________________________________