Anche se sono trascorsi più di venticinque anni, ricordo bene l’entusiasmo con cui Alessandro Fo prese a comunicarmi la sua scoperta di un poeta quasi sconosciuto (e dal nome, pensai, decisamente impoetico): Enzo Mazza, che aveva consacrato migliaia di testi alla memoria del figlio primogenito (scomparso, non ancora sedicenne, in un incidente), consegnandoli in parte a nove, meravigliose edizioni fuori commercio, destinate a un mannello di amici ed estimatori [1].
La mia curiosità fu parzialmente soddisfatta, nel settembre 1996, dall’arrivo di Uno di questi giorni [2], l’antologia che lo stesso Mazza aveva tratto, come scrive nella Nota, da «diciotto tra folte, brevi e meno brevi raccolte poetiche», e che era occupata, per metà delle sue 160 pagine, dalle Poesie per Fabio, a loro volta esigua selezione dei nove, per me ormai leggendari incunaboli.
La lettura non tradì le attese. La voce di Mazza era di una grana speciale. Limpida, pacata, sincera fino al martirio, caparbiamente fedele ai suoi temi, e semplicemente inaudita appunto nelle Poesie per Fabio. Fui subito spinto a scriverne, e da quella modesta recensione [3] venne una sobria corrispondenza che il poeta onorò da par suo con lettere in versi (o versi in forma di lettere) che parlano della malinconica vita di un vecchio, di residue letture, di viaggi sognati, di rimembranze fra cui trascelgo, a beneficio dei futuri biografi, il passaggio sul servizio militare (che rinvia a Due ricordi di Lecce, impresso nel remoto libro d’esordio) [4]: «io che correvo | nel Millenovecentoquarantotto | sulla spiaggia di Lecce, | ventiquattrenne allievo | ufficiale, abilissimo nel leggere | Foscolo ed altri di nascosto, | magari con un peso sulle spalle».
Feci anche in tempo, prima che il mio amico ‘da lontano’ fosse travolto da una progressiva e perniciosa perdita della memoria, a parlare del suo successivo e terzultimo libretto, L’oscuro lembo [5], e persino a incontrarlo (un’unica, memorabile volta) nel suo casale di Dolciano, presso Chiusi (dove, dopo il terribile lutto, si era confinato, lasciando Roma e l’insegnamento), quando un gruppo di studenti capitanati, ça va sans dire, da Alessandro Fo volle festeggiarne il settantasettesimo compleanno stampandogli ‘a tradimento’ la raccolta inedita Senza saperlo [6].
A vent’anni dal quel genetliaco e a quattro dalla morte di Enzo (7 febbraio 2017), Alessandro Fo corona il suo apostolato aggiungendo ai pionieristici studi che ne avevano reso calda e cospicua testimonianza [7] un’impresa editoriale che sarebbe piaciuta al mai troppo rimpianto Vanni Scheiwiller: il varo dei due splendidi volumi – chiamati non a caso a inaugurare, sotto la direzione dello stesso Fo, di Giuseppe Grattacaso e Matteo Pelliti, la combattiva collana «I Paralleli» del meritorio editore senese Betti – che riuniscono, intorno al’intero ‘ciclo per Fabio’, il trittico che ne costituisce in qualche modo la premessa, e le raccolte che lo seguirono, a concludere ‘in bellezza’ una straordinaria vicenda poetica e umana.
Curato da Alessandro Fo, Daniela Gentile e Claudio Vela, Il canzoniere per Fabio e altre poesie vuol essere dunque il prototipo dei ‘Meridiani degli Esclusi’, concepiti per riparare torti di un’industria editoriale sempre più stretta a bilanci e ricavi, sempre più aliena da una vera missione culturale; e di un Meridiano, ossia di un’edizione di riferimento, ha tutti i numeri: un fervido e ben temperato saggio introduttivo, una ricca sezione di Note biografiche sull’autore e su alcuni suoi destinatari, un’accurata Bibliografia, un meticoloso Indice, e un’attrattiva Appendice (l’arioso racconto di Alice Borgna sulla quasi incredibile circolazione in ambito ospedaliero, lenimento per «genitori interrotti», di gualcite fotocopie delle poesie per Fabio).
Da questo imprescindibile corpus – che giustamente privilegia, come indica il titolo, il ‘ciclo per Fabio’, definito da Fo «un’impresa poetica di cui da tempo si era perso l’eguale» (p.12) – resta giocoforza esclusa una quota non irrisoria della produzione poetica di Mazza, la teoria di introvabili prove che vi conducono, e cui ho avuto agevole accesso grazie alla sollecitudine di Gianluca Mazza, il figlio ‘salvato’. Ho potuto così accertare che la poesia di Mazza prevede un’assorta contemplazione del mondo, configura un itinerario di conoscenza che non teme di attraversare il dolore, l’angustia delle cose, e sembra idealmente aver principio nella prima delle tre quartine di un rivelatore Addio a Saba («Qui ho voluto morire con la mia fiaba, | rifarmi un viso più scialbo e distratto, | qui dove il verso metteva ali d’un tratto, | dove prendevo confidenza con Saba) [8]: una scelta di campo, un passaggio alla ‘serietà della vita’, confermato nella filza di Poesie per un amore (penso in particolare alla chiusa, stupenda, «è simile al destino che mi crolla | la tua cenere scossa») [9] o in Ultime ore a Siena, con l’implacabile incipit «Non mi aspetto più nulla dal tuo cielo» [10].
Ed ho poi rilevato i prodromi della vocazione ‘monografica’ che dominerà il ‘Canzoniere per Fabio’. Le trentanove poesie anepigrafe (e senza numero di pagina) di I vecchi e il vino (apparso nel 1953 e verosimilmente ispirato al «soggiorno di un anno nel Veneto, ad Asolo») [11] rovistano senza requie i residui di un amore ormai guasto e l’inerzia di una sonnolenta provincia, i paesi «disertati dai giovani», il placido microcosmo che preannuncia una rassegnata senilità: «D’improvviso | mi immagino dipinto in un domani | come in un quadro, vecchio anch’io tra vecchi, | su uno sfondo di cenci e di casette; | anch’io nella mia spira d’ozio, come | in un’ebbra agonia, senza tristezza».
Questa tendenza alla riflessione insistita sul medesimo oggetto, interamente adagiata sull’endecasillabo ‘naturale’ e ‘antico’ inscindibile dalla poesia di Mazza, si conferma nella prova successiva, Una stagione [12], in specie nelle diciotto poesie della prima parte (Diario), dove le raccolte cogitazioni su una vita sospesa si curvano sui «cari colli | toscani» [13] e sull’«estate di Val d’Orcia» [14], mentre nelle quattro poesie di La famiglia un «saccheggiatore di rimorsi»[15] torna alla casa avita per denunciare colpe, vere o immaginarie, verso gli affetti più cari, in cerca di un’eterea espiazione: «Potessi, ora entrerei | nel tacito vestibolo | come la spira d’un ricordo, senza | turbarne il sonno, e abbraccerei l’infanzia | e padre e madre, intenerito, vinto» [16].
Ciò che è stato, libretto che arriva al termine della breve ma feconda esperienza della rivista «Marsia» (condivisa con Manlio Barberito, Luigi de Nardis, Alessandro Dommarco e Ariodante Marianni [17], presenta una voce ormai ben definita: meditativa, incline a un’introspezione condotta fino alla più severa autoanalisi (come quella che nel copioso Autoritratto investe «La mia vita che affilo come lama | e si è fatta rigagnolo da fiume», o «la mia poca saggezza, il mio fittizio | distacco dalla sete di rinascere | quando mostro d’attorno un viso calmo | e un debole sorriso di rinunzia | fingo per abitudine») [18], al colloquio a distanza con persone privilegiate (Mi restano altri giorni, Intorno a un punto), agli interrogativi metafisici che raggiungeranno il ‘Canzoniere per Fabio’: «Cosa c’è tra il regno delle ombre | e noi, come s’invola | il respiro, la forza, la speranza?» [19].
L’impegno nella redazione di «Marsia» sembra meglio riflettersi, cinque anni più tardi, nei 70 epigrammi [20], indirizzati in gran parte a figure e fenomeni della ‘società letteraria’. Qui Mazza rivela un’inedita vena di polemista, attesa a una acuminata brevità che sa aprirsi a slanci genuinamente lirici («Una sera alle Giubbe Rosse | tacquero i pappagalli | al silenzio di Pintor»; «eroe municipale, poeta non castrato, | vivido, nel balzo, come i delfini»; «fiutavi la morte come un raro tabacco») [21], e che rimarrà uno dei segni distintivi della sua poesia.
Appena un anno dopo, Gli inediti di Magalotti offrono due altre importanti novità, anch’esse gravide di futuro. La prima riguarda la costituzione del nido familiare, palesata dalla presenza del nome della moglie (Elena Panicucci, sposata nel 1962) nella sezione Non lei, ma la sua trasparenza, che ripercorre l’agonia e la morte di sua madre Marina, e implicita nel serto I sogni di Cortona (ad esempio nell’invocazione «Tu mi darai la forza di mutarmi») [22]. La seconda sono i quattordici Sonetti con dedica, che sperimentano una forma eletta, confermando insieme (come si vede anche nei versi liberi dedicati a Lamberto e a Luigi De Nardis) la preferenza per il dialogo quasi privato, rivolto a una cerchia esclusiva, sia pur quella, familiare quanto problematica, evocata in Per il mio compleanno: «Non regalatemi il solito libro | con parole d’augurio. | Tacete, rivedendomi diverso, | la fronte più solcata, | le dita più bruciate. | Non vi ferisca il mio silenzio. | Pochi chilometri, | eppure vengo da lontano, | col passo del profugo | da paesi senza bandiera» [23].
 La prima parte di Il canzoniere di Fabio e altre poesie si distende dal 1967 di L’acqua e il vento al 1982 di L’invisibile. Tra questi termini Mazza dà alle stampe altri due libri da considerare. Uno di questi giorni [24] si segnala per la predominanza di testi articolati su compatti blocchi strofici di varia misura (ivi compresi due sonetti senza rime) che mostrano un persistente interesse verso la forma chiusa, per il rivelatorio affondo sui poeti che «cedono alla congiura tecnologica studiandosi di indossare acconce tute mimetiche» [25], e soprattutto per le poesie che, in una sorta di oscura antiveggenza, saggiano una cauta interlocuzione con amici scomparsi: i «ripetuti contatti con ombre e reliquie» [26] devoluti alla sequenza L’amico morto (Paolo Redi, il «redivivo» [27] che sarà ancora ricordato in Senza saperlo), a Più delle voci e Per un anniversario. Ma l’intera silloge è percorsa da un affranto allarme, dislocato nei «bambini volati via | con i fumi e gli umori del bosco» [28], nel «lembo di terra che non sembra terra | ma un aldilà senza dolore» [29], nel «giustiziere appostato | sagacemente dietro la sua nuca» [30], nelle «Stagioni ipocondriache» e nel «putrido fondale dove tutto s’arresta» [31], trovando la formulazione forse più suggestiva nella poesia epilogale del Quadernetto senese: «Sotto la Croce del travaglio | hai nascosto il bulbo della giovinezza | o negli occhi spauriti della civetta d’agosto | che non fa dormire?» [32].
La prima parte di Il canzoniere di Fabio e altre poesie si distende dal 1967 di L’acqua e il vento al 1982 di L’invisibile. Tra questi termini Mazza dà alle stampe altri due libri da considerare. Uno di questi giorni [24] si segnala per la predominanza di testi articolati su compatti blocchi strofici di varia misura (ivi compresi due sonetti senza rime) che mostrano un persistente interesse verso la forma chiusa, per il rivelatorio affondo sui poeti che «cedono alla congiura tecnologica studiandosi di indossare acconce tute mimetiche» [25], e soprattutto per le poesie che, in una sorta di oscura antiveggenza, saggiano una cauta interlocuzione con amici scomparsi: i «ripetuti contatti con ombre e reliquie» [26] devoluti alla sequenza L’amico morto (Paolo Redi, il «redivivo» [27] che sarà ancora ricordato in Senza saperlo), a Più delle voci e Per un anniversario. Ma l’intera silloge è percorsa da un affranto allarme, dislocato nei «bambini volati via | con i fumi e gli umori del bosco» [28], nel «lembo di terra che non sembra terra | ma un aldilà senza dolore» [29], nel «giustiziere appostato | sagacemente dietro la sua nuca» [30], nelle «Stagioni ipocondriache» e nel «putrido fondale dove tutto s’arresta» [31], trovando la formulazione forse più suggestiva nella poesia epilogale del Quadernetto senese: «Sotto la Croce del travaglio | hai nascosto il bulbo della giovinezza | o negli occhi spauriti della civetta d’agosto | che non fa dormire?» [32].
Come si legge nella Nota che lo correda, Poeti [33] vuol essere un seguito dei 70 epigrammi, un’altra tappa della ricerca «coscientemente riduttiva dell’espressione poetica», e come il suo antesignano è in prevalenza rivolto all’ambiente artistico-letterario che Mazza frequentava (o di cui aveva contezza), in particolare ai poeti che ne presidiano la zona centrale (al cui centro spiccano le cinque poesie in memoria di Pasolini e le sei per Vittorio Bodini), e anche qui a volte inclinando a un registro più schiettamente lirico (quello, ad esempio, adibito in Rivedendo Alfonso Gatto). Insieme a esiti folgoranti come Poeta minimo («Affondi tra myricae | infinitesimali. | Così curi i tuoi mali | e sei felice»)[34] o A certi poeti («Di gruppo in gruppo, il vostro piede | lascerà un’orma? | Ad ogni costo e in ogni forma | vorreste precorrere il tempo | che inesorabilmente vi precede»)[35], vi si distinguono la virulente Odicina al’Italia («Quasi sempre titubante | sul da farsi, ma pronta | a gettarti sull’anarchico | ballerino») [36], e l’autoaccusa di A F. («so di essere solo | una firma illeggibile nei tuoi quaderni, | un segno opaco di paternità») [37], che anticipa una invariante del ‘Canzoniere per Fabio’.
Ma il cruccio del padre inane già si sporgeva nella raccolta che saluta i primi passi del primogenito e che ora apre il Canzoniere di Fabio e altre poesie. Anche se il tono di L’acqua e il vento (libretto apparso nel maggio 1967, quando il figlio, cui è dedicato, non aveva ancora compiuto i due anni) è cautamente festevole o quantomeno fiducioso, colpisce, alla luce di quel che seguì, il «rimango | al di qua della soglia, ti rispondo | con un impeto muto, dal fondo | prosciugato del cuore» (n. 15), doppiato dal «Batti alla porta, | ma non t’apro» (n. 23): spia di un disagio, quasi di una preventiva colpevolezza in attesa della sua pena. L’esito è, comunque, fra i più felici. Qui Mazza si giova del suo tirocinio da epigrammista costruendo, con versi perlopiù brevi, piccole strutture, insieme solidali e leggere, che delicatamente racchiudono il plesso di gaudio e timore, il contrastato mood che lo invade, il suo perpetuo oscillare tra il «Sono tuo padre, non sono | l’uomo di prima, non suono | a porte sconosciute […] vedo nell’anticamera buia | la tua testa dolcissima | emergere dal caos | dei giocattoli, splendere | sulla cima del tronco | come una causa prima»» (n. 21) e il «mi sento | come te, per assurdo, | indifeso. La vita | è mutata, è febbrile | per causa tua, nelle ore | più silenziose, e non so | reggerne il peso» (n. 31), tra l’avara euforia per il miracolo di una nuova vita e lo sconforto che allaga il finale della poesia conclusiva: «Bruci | d’ansia e ti lascio | alle tue impervie strade, | come l’animale che d’un tratto | cessa d’essere padre» (n. 33). La studiata grazia di questi Lieder – dove si ammira l’accorta pulizia della lingua, la giustezza del ritmo, l’eleganza degli enjambement, i raffinati effetti fonici (come la rima-calembour «alibi/abili» della n. 3, o l’assonanza remota «libro/cibo» della n. 4) – ha il suo vertice nell’icona che custodisce insieme al bambino il titolo stesso (e il senso) dell’opera (n. 8):
La mamma che t’avvolge
nella fiamma dei capelli
e assicura agli anelli
la rete del lettino,
non sa che la tua anima
somiglia all’acqua,
né che al vento somiglia
il tuo destino.
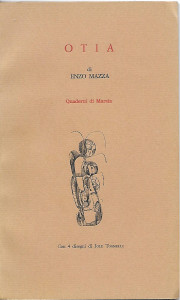 Otia segna, a un decennio da L’acqua e il vento, il ritorno al rifugio familiare. Anche se la nota che lo sigilla dà al titolo una connotazione tutt’altro che positiva (certificando «l’impossibilità di scalfire o modificare l’assetto delle cose: ozio come assenza e sconfitta […] una sorta di alienante vacanza, abbarbicata al tema della famiglia e del contrapporsi, al suo interno, delle figure che la compongono»), il libretto vuol recuperare («in certo modo, anche per l’uguale numero dei componimenti»), sebbene in tempi mutati, il clima di quella raccolta ‘aurorale’ (di cui conserva l’elegante veste grafica dei Quaderni di Marsia e i raffinati disegni di Jole Tognelli). Di un’altra storia parla subito la poesia posta a epigrafe, che sembra ispirarsi alla straziante morte di Pasolini: «Ma guarda, se mai lo hai visto, | il luogo dove ci avventuriamo, | queste sabbie senza un’anima | che si pieghi sul corpo esanime | dietro il cespuglio più tristo». E continua a parlarne, amara e perplessa, la prima poesia: «Guardo, mi chiedo che cosa | sanno i figli di me, se solo | attraverso le loro immagini | ho amato ciò che restava. | Chiedo a te come reggono | i tristi umori, le dure | parole, quanto lontano | mi vedono, se il peso | reggerò del loro giudizio». Ad imporsi, ora, è la ‘terra desolata’ che muove alla derelizione caproniana del «Noi come siamo soli | sul nostro pezzetto | di terra» (n. 14), al «Tutto già, dove vado, | è palude, grigiore | a perdita d’occhio» (n. 31), fino a «l’angoscia di chiudersi | per non capire, per dire | basta alla vita» (n. 20). Prevale insomma l’inquietudine, il senso di una minaccia imminente (riassunta nei «turbati segni» della poesia terminale), se non di una scontata sconfitta («quale | pallida voglia di esistere | potevo nutrire, se tutto | avevo già consumato?» – n. 24) che toglie aria all’idillio cui pure si anela: «Dove corrono i piedi | leggeri dei miei figli | sull’arenile sinuoso, | infinito, non posso | essere anch’io, se non spezzato | dall’affanno, a premerne | le impronte fuggitive» (n. 26). Ma il cimento dei contrari trova un luminoso equilibrio nella ripresa del motivo dei «bambini volati via» (enunciato, come si è visto, in Uno di questi giorni): «Posatasi d’incanto | dietro le dune, un’astronave | li rapirà nella galassia | dei loro giochi. Passeranno | a volo sul mio guanciale | da un altro cielo, puntandomi | misteriosi fucili. | Solo un urto soave | mi parrà la ferita» (n. 27).
Otia segna, a un decennio da L’acqua e il vento, il ritorno al rifugio familiare. Anche se la nota che lo sigilla dà al titolo una connotazione tutt’altro che positiva (certificando «l’impossibilità di scalfire o modificare l’assetto delle cose: ozio come assenza e sconfitta […] una sorta di alienante vacanza, abbarbicata al tema della famiglia e del contrapporsi, al suo interno, delle figure che la compongono»), il libretto vuol recuperare («in certo modo, anche per l’uguale numero dei componimenti»), sebbene in tempi mutati, il clima di quella raccolta ‘aurorale’ (di cui conserva l’elegante veste grafica dei Quaderni di Marsia e i raffinati disegni di Jole Tognelli). Di un’altra storia parla subito la poesia posta a epigrafe, che sembra ispirarsi alla straziante morte di Pasolini: «Ma guarda, se mai lo hai visto, | il luogo dove ci avventuriamo, | queste sabbie senza un’anima | che si pieghi sul corpo esanime | dietro il cespuglio più tristo». E continua a parlarne, amara e perplessa, la prima poesia: «Guardo, mi chiedo che cosa | sanno i figli di me, se solo | attraverso le loro immagini | ho amato ciò che restava. | Chiedo a te come reggono | i tristi umori, le dure | parole, quanto lontano | mi vedono, se il peso | reggerò del loro giudizio». Ad imporsi, ora, è la ‘terra desolata’ che muove alla derelizione caproniana del «Noi come siamo soli | sul nostro pezzetto | di terra» (n. 14), al «Tutto già, dove vado, | è palude, grigiore | a perdita d’occhio» (n. 31), fino a «l’angoscia di chiudersi | per non capire, per dire | basta alla vita» (n. 20). Prevale insomma l’inquietudine, il senso di una minaccia imminente (riassunta nei «turbati segni» della poesia terminale), se non di una scontata sconfitta («quale | pallida voglia di esistere | potevo nutrire, se tutto | avevo già consumato?» – n. 24) che toglie aria all’idillio cui pure si anela: «Dove corrono i piedi | leggeri dei miei figli | sull’arenile sinuoso, | infinito, non posso | essere anch’io, se non spezzato | dall’affanno, a premerne | le impronte fuggitive» (n. 26). Ma il cimento dei contrari trova un luminoso equilibrio nella ripresa del motivo dei «bambini volati via» (enunciato, come si è visto, in Uno di questi giorni): «Posatasi d’incanto | dietro le dune, un’astronave | li rapirà nella galassia | dei loro giochi. Passeranno | a volo sul mio guanciale | da un altro cielo, puntandomi | misteriosi fucili. | Solo un urto soave | mi parrà la ferita» (n. 27).
L’invisibile appare nel 1982, l’anno che segue la morte di Fabio, ma l’effettiva stesura è fatta risalire, nella nota che lo licenzia, al 1980 [38]: il tema «del nucleo familiare e dell’amore paterno» lo riconduce a L’acqua e il vento e a Otia, con cui è chiamato a formare «una sorta di trittico». Oltre a far corpo con queste due raccolte (ripetendone il numero di componimenti e di nuovo avvalendosi dei disegni di Jole Tognelli), la plaquette ripropone la temperie ‘monografica’ che contrassegnava I vecchi e il vino e che si diramerà, oltre che nel ‘Canzoniere per Fabio’, in vari libretti successivi. Qui il ‘pensiero dominante’ (che nasce, come confessa l’autore, da un’idea «non più che scherzosa: preparare una serie di epitaffi per la mia lapide») si distribuisce, sempre con l’agile concisione propria del «trittico», fra l’autoepitaffio, il silenzioso dialogo con i familiari superstiti e i variegati rovelli sulla condizione della morte. E se nelle pseudo iscrizioni funerarie (per tutte, quella, classicamente atteggiata, di IV: «Amico, se ti conduce | qui gentilezza, sposta | quel tanto la lampada | che il barlume non mi angosci | col ricordo della vostra | luce») si avverte l’iniziale ‘divertimento’, per il resto il gioco si fa più serio. L’aggirarsi intorno a chi non può vederti stabilisce già la situazione primaria del ‘Canzoniere per Fabio’ (come in XXVI: «Non giureresti ch’io non sia sul limite, | nel buio del giardino, per sorprendervi | intorno alla tovaglia impoverita | dalla mia assenza, e cogliere di voi | sulla parete in luce | come le misteriose proiezioni | di tre rami spezzati»; o in XXVIII: «tacito | più del vago ricordo che risuscito | nel cuore invulnerabile dei figli, | erro tra voi invisibile, | attento a non turbarvi, nel vapore | che le scodelle esalano»), laddove la meditazione sulla morte prefigura abissali profondità (il capogiro del «Salgo, forse ignaro | di cadere, o precipito salendo» di VIII) e geometrie ultraterrene, da paradiso dantesco: «Per noi l’immateriale | spessore è il solo porfido | che i gradi del sussistere divide | in segmenti di cui non vi è concetto» (XV); «Sappi che un centro non esiste ed è | in ogni punto che ordina la mente. | Ed anche voi, movendovi pur fermi, | fate infiniti centri d’ogni punto» (XXI).
 Questa lunga storia ci dice che l’uomo sospinto, suo malgrado, sulle orme del figlio scomparso è un poeta nel pieno dominio dei suoi mezzi espressivi, dell’arte acquisita in un trentennio di oculatissime prove, di scelte ben meditate. Così, quel che all’inizio aveva concepito solo come «testimonianza d’un inesauribile dolore» [39], il lugubre «Ripetermi è come avvolgermi | più volte nel sudario» di Nella calante oscurità (p. 271), diventa negli anni, quasi senza volerlo, un grande edificio, una reggia mirabilmente sorretta da quell’unica pietra. Come scrive Alessandro Fo, «il cammino, pur se monotematico, spalanca attorno a quella sorta di monomania l’intero mondo e lo risistema in quella prospettiva, riscrivendolo dagli astri fino alla ultima f» (p. 12).
Questa lunga storia ci dice che l’uomo sospinto, suo malgrado, sulle orme del figlio scomparso è un poeta nel pieno dominio dei suoi mezzi espressivi, dell’arte acquisita in un trentennio di oculatissime prove, di scelte ben meditate. Così, quel che all’inizio aveva concepito solo come «testimonianza d’un inesauribile dolore» [39], il lugubre «Ripetermi è come avvolgermi | più volte nel sudario» di Nella calante oscurità (p. 271), diventa negli anni, quasi senza volerlo, un grande edificio, una reggia mirabilmente sorretta da quell’unica pietra. Come scrive Alessandro Fo, «il cammino, pur se monotematico, spalanca attorno a quella sorta di monomania l’intero mondo e lo risistema in quella prospettiva, riscrivendolo dagli astri fino alla ultima f» (p. 12).
Considerando le nove raccolte [40] come un organismo unitario, quel che primamente colpisce è la «miriade di segni delicati e ostinati»[41] che vi sono sparsi, a cominciare da quelli volti a ricostituire la sembianza amata: se ne diventa quasi avidi, e si salutano ad ogni apparizione. Difficile dimenticare l’«astratta | rosa che le tue efelidi colorano» (p. 113), il «roseo riflesso, efelide, sorriso | tenero a me, come ultimo congedo» (p. 145), «i colori | pastello del tuo viso» (p. 147), le «tue efelidi | scomparse» (p. 306); «Quel piccolo neo, quel neo sulla guancia» (p. 257); «il rosso dei capelli» (p. 306), il «sogno più d’una tua ciocca | che ti rosseggi sulla fronte intatta» (p. 117), lo struggente «Vorrei imprimere in me l’ultima fiamma | dei tuoi capelli» (p. 106); le «falcate» (p. 112), «l’irraggiungibile andatura» (p. 192), i «lunghi passi» (p. 382), «l’apertura del tuo passo» (p. 426). Difficile dimenticare l’immagine che li condensa, il «fiore virgiliano | su cui passò il gran carro» (p. 260), replicato nella «prima | giovinezza racchiusa in un esametro | virgiliano, languente | come un fiore sul ciglio d’una strada» (p. 371).
La riscrittura del cosmo comporta il riesame di ogni suo dettaglio: «Strano che le inezie sopravanzino | perfino gli astri» (p. 435); «cerco | solo inezie che abbiano | un senso enorme» (p. 132). Ogni cosa, anche la più infima, è chiamata a concorrervi: «alle minuzie | chino lo sguardo» (p. 411); «torno alle minuzie» (p. 201); «ciò che vado scrivendo non potendo | che esser fatto che di piccolezze» (p. 555); «trattengo | inezie nella mente» (p. 406); «le presenti | inezie» (p. 367). Se Ripellino si flagella nel «vecchietto benpensante», nell’«arcisapiente melenso» che «fruga perdute felicità fra i detriti» [42], il superfluo è per il padre orbato il tramite della «manovra ontologica» di cui acutamente discorre Alessandro Fo: «Mazza registra puntuale, pedante, la sistematica inesistenza di Fabio, e con il medesimo gesto di questa registrazione gli fonda un’esistenza nuova, sì che da allora in poi irrevocabilmente egli è e sarà nel sassolino, nell’anello della catenella, nel muschio, nel terriccio, in ogni dove» (p. 29).
Questo caparbio catalogo di briciole («io frugo il fondo | d’ogni cassetto, cerco un segno | o un tramite che illumini l’assenza» – p. 118) è l’àncora del vertiginoso viaggio la cui scorta sarà il goethiano Gesang Der Geister Über Den Wassern richiamato nell’appunto premesso a L’acqua e il vento, che riecheggia in La penombra e i riflessi («La tua assenza è la morte, un tuo riflesso | nell’acqua il luccichio della speranza» – p. 115; «avverto l’anima tua nel tremolio dell’acqua» – p. 116; «le punte | delle tue dita che dal muro staccano | il tuo viso, lo affondano nell’acqua» – p. 133) e nello spirito «che canta nella grande | vertigine, nella schiumante | cascata» di La calante oscurità (p. 273). Un viaggio che rovescia le prospettive e sconvolge i significati, inducendo ossimori vitali («Inutili | le scale, se altezza | è profondità» – p. 188; «Ma come puoi | cadere così in alto» – p. 217; «Così sono caduto risalendo» – p. 306; «Ero nell’ultima vettura | e che fosse la prima mi pareva. | Era davanti la motrice, o in coda, | e in senso inverso procedeva?» – p. 256) o il paradosso di «una forza | di movimento che rinasce | dall’immobilità» (p. 464), «l’immobilità | pur illusoria» (p. 471), quella che «nasconde lo spostarsi d’un sistema di mondi» (p. 224), e che si affida a due simboli precipui. Il primo è il «filo» che ne orienta il labirintico percorso, pegno di un rapporto ‘possimpossibile’, sempre in bilico, che può indurre prossimità e distacco, disperazione e speranza («siamo | vicini all’altro capo | del filo» – p. 295; «se un tratto | brevissimo di filo ci divide?» – p. 494; «corre siderali | distanze il filo indissolubile | si aggomitola | e si dipana. L’altro | capo tu reggi» – p. 403; «rischioso, pericolante filo | sospeso tra il sì e il no» – p. 500; «lume, unico ricordo | che è il nostro filo – noi | alle due estremità | così lontane da confondersi | in un unico cielo» – p. 277), e che prende talvolta la forma di un favoloso talismano: «tutto preso da un filo d’oro» (p. 364); «Tocco perle | che scivolano, rimbalzano dal filo» (p. 431); «Forse aggomitolare il poco filo | della tua vita, la dolcezza berne» (p. 110). L’altro è l’«anello» (precorso dal «misterioso anello» di L’invisibile, il cerchio di moscerini in cui lo scomparso aveva asilo – p. 97), promessa di un legame indissolubile, e garanzia di un qualche approdo: «ancora sacri | gli anelli della propria storia | preclusa a interpreti beffardi» (p. 249); «Perché si ricongiungano | gli anelli, né fuggevole | l’amore sia, non devo | temere un lapis che mi espunga?» (p. 301); «Non si compie | il giro degli anelli in cui m’inscrivo | che un altro inizia d’altri anelli, dentro | un vortice di oscurità guidato | dal magnetismo d’una arcana bussola» (p. 98); «anelli di catena che via via | si saldano. Uno all’altro ti rimanda, | ed è infinito intreccio, | reiterata rima, scala | spirale, che sali | fino a che non ti dà | vertigine l’altezza» (p. 205); «anelli di pensieri che sollevino | anche per poco a un’altra luce» (p. 234).
Avvinto a «fili | che non cedono» (p. 109), a «pensieri | cuciti dal tuo filo inesorabile» (p. 127), murato nella ‘missione’ che si è imposto, fermo al suo «Sto. Di qui non fuggo» (p. 198), il poeta ferito resta pienamente consapevole della sua anomalia, ed è talora indotto a chiederne venia: «Li ho scritti per dolore, | solo per me, senza | speranza, non per accorto | disegno» (pp. 273-274); «il mio | è un inutile scialo» (p. 240). Sorprende la lucidità con cui ne valuta i risultati, pronta al giudizio impietoso e all’autodenigrazione, ma capace anche di intravederne il tesoro: «Me ne sono accorto: | ho messo con freddezza | la poesia alla porta, | l’ho calpestata, morta | sapendola, distolto | dalla nuova bruttezza | del verso, in me contorto | e zoppo, aspro d’una asprezza | difficilmente immaginabile» (p. 201); «Mai un’ars potrebb’essere | questa, rovinoso | scoscendimento, fangoso | rigagnolo, una esse | giallastra, dall’alto» (p. 201); «Ciò che dicevo | con timbro puro ha un suono rauco» (p. 282); «la poesia non ha più quasi forma» (p. 365); «poesia | sconsacrata, blasfema, senza centro» (p. 374); «Mi chiedo a volte (quanti analoghi | inizi), come | nella ossessiva | ripetitività | siano infiniti i temi» (p. 240) . E commuove la pietas che ne molce il delirio: «lascio cadere l’uso del linguaggio | non avendo più sillabe da unire» (p. 107); «reggo | solo la vecchia penna | che tra le dita mi duole, | e muto limo correggo | periture parole» (p. 257); «Chi era? Non ha avuto | fama. Non era che uno sconosciuto» (p. 289); «fra noi rimarranno | queste rime (come un tempo | erano dette), ammesso | che lo siano, così | disarticolate e grame» (p. 362); «Il travaglio che dura | da anni, il tornar sopra | ciò che ho scritto in principio | o appena ieri, il bruciare, il salvare | frammenti, accumulandoli» (p. 410); «Per te avrai visto i miei sei mesti libri, | i semi che ogni tanto vi germogliano» (p. 423); «Ancora un piccolo | sonetto in una barca | fatta di carta | che cola a picco» (p. 178) «tutto ciò che ho scritto | su di te, lucidissimo, paziente | cesellatore, un anno dopo l’altro […] che scrive ancora | e forse, fino all’ultimo, di te | scriverà col medesimo abbandono | dei primi giorni» (p. 427).
 La figura forse più intensa di questa «ossessiva | ripetitività» (incisa nel «cane | che un osso leviga e scarnisce | ossessivamente, senza scopo» – p. 209) è il mutarsi del padre in jacoponico ‘figlio del figlio’, quando il custode diviene un custodito, il maestro un allievo, il forte un debole in cerca di aiuto, il vivo un morto e il morto un vivo: «Non trovo | l’interruttore e la tua spalla è guida | alla mano che annaspa verso il lume» (p. 116); «Tu a liberarmi dall’ingombro | della paura, solo tu m’insegni» (p. 147); «io cattivo maestro, tu sapiente» (p. 183); «Da te mi deriva il mesto | sorriso, l’affabile | gesto. Eri tu ad insegnarmi | cose impensabili, nato | da poco, cresciuto | con la rapidità di cui soffro | ancora. Così forte, accanto, | ti ho avuto, che non so | non aspettarmi un tuo soffio» (p. 197); «E tu, bambino, mi terrai | per mano, e mai la stretta | allenterai, nemmeno per giocare» (p. 209); «A te, malfermo, | vorrei appoggiarmi, essere riamato, | io, misteriosamente abbandonato» (p. 268); «Camminami davanti, a fianco, dietro, | non perdermi d’occhio» (p. 430); «Per quanto ho da vivere, avrai | al risveglio il mio primo pensiero. | E, se morrò nel sonno, sarai tu | a discendere, a prendermi | sotto le ascelle. E chi | per le caviglie mi solleverà?» (p. 371). L’indicibile tenerezza del ‘novissimo stato’ rifulge un una poesia di Ultimi frammenti (n. 106, p. 419), la cui concisa perfezione sembra includere, quasi inavvertibile, incorporato senza sforzo nel contesto, un rimando al «sì che m’ha fatto per molti anni macro» di Paradiso, XXV, 3:
La figura forse più intensa di questa «ossessiva | ripetitività» (incisa nel «cane | che un osso leviga e scarnisce | ossessivamente, senza scopo» – p. 209) è il mutarsi del padre in jacoponico ‘figlio del figlio’, quando il custode diviene un custodito, il maestro un allievo, il forte un debole in cerca di aiuto, il vivo un morto e il morto un vivo: «Non trovo | l’interruttore e la tua spalla è guida | alla mano che annaspa verso il lume» (p. 116); «Tu a liberarmi dall’ingombro | della paura, solo tu m’insegni» (p. 147); «io cattivo maestro, tu sapiente» (p. 183); «Da te mi deriva il mesto | sorriso, l’affabile | gesto. Eri tu ad insegnarmi | cose impensabili, nato | da poco, cresciuto | con la rapidità di cui soffro | ancora. Così forte, accanto, | ti ho avuto, che non so | non aspettarmi un tuo soffio» (p. 197); «E tu, bambino, mi terrai | per mano, e mai la stretta | allenterai, nemmeno per giocare» (p. 209); «A te, malfermo, | vorrei appoggiarmi, essere riamato, | io, misteriosamente abbandonato» (p. 268); «Camminami davanti, a fianco, dietro, | non perdermi d’occhio» (p. 430); «Per quanto ho da vivere, avrai | al risveglio il mio primo pensiero. | E, se morrò nel sonno, sarai tu | a discendere, a prendermi | sotto le ascelle. E chi | per le caviglie mi solleverà?» (p. 371). L’indicibile tenerezza del ‘novissimo stato’ rifulge un una poesia di Ultimi frammenti (n. 106, p. 419), la cui concisa perfezione sembra includere, quasi inavvertibile, incorporato senza sforzo nel contesto, un rimando al «sì che m’ha fatto per molti anni macro» di Paradiso, XXV, 3:
Se hai caro che ti venga accanto,
fammi posto (d’un dito
mi basta lo spessore).
A questo fine sono dimagrito.
Comunque sia, la modalità allusiva è sempre adibita con naturalezza, per spontanea adesione a una voce fraterna, in genere attingendo ai nostri classici. Altri celebri passi danteschi risuonano ad esempio in versi come «e riposato della lunga via» (p. 238), «Oh, riposarsi della lunga via» (p. 301), «oscuro | poeta già finito | sul muro della terra» (p. 153), «Io sono uno che ricorda e pensa» (p. 202), «il messagger che porta ulivo» (p. 459), per non dire del petrarchesco «il credere per morte essere scarco» (p. 399), dei leopardiani «lucciole | appo le siepi» (p. 203) e «la noia è il tutto» (p. 241), della «Primavera non viene danzando» (p. 223), che ribalta la corriva filastrocca di Angiolo Silvio Novaro, del joyciano «incubo da cui so di non svegliarmi» (p. 115).
«Piangere sugli oggetti è così umano | che senza pianto non rivedo | tre chiavi in un anello, un orologio, | uno sdrucito portafoglio: il poco | che torna a un padre in forma di reliquia» (p. 113). Il breve giro di questa lirica di Poesie per Fabio annuncia la fioritura di virgiliane lacrime che annovera le «suole silenziose» (p. 120), «il cuoio del pallone | calciato in alto, atteso come un astro | sull’erba» (p. 129), le «suole di gomma» (p. 132), la «scodella» (p. 135), la «racchetta» (p. 136), la «logora corda d’altalena» (p. 137), la «cesta dei balocchi» (p. 138), la «giacca d’antilope» (p. 145), le agende» (p. 265), la «borsa dei tuoi libri» (p. 303), la «sdraio rossa» (p. 449), e che andrà a toccare le «fotografie ingrandite del tuo viso» (p. 126), «i ritratti | che fermano una crescita» (p. 136), il «giallo d’una vecchia | fotografia» (p. 304), la «dolcissima fotografia | che mi prostra» (p. 395), avendo culmine nella «posa immobile | sullo sfondo del lago di Zurigo» di L’oscuro lembo (n. XII), che ha ispirato la sublime fantasia del figlio-cigno: «vederne l’alto collo | incurvarsi sul lago di Zurigo» (p. 426).
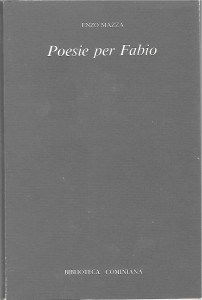 Non meno umano è il pianto versato nelle ricorrenze del naufragio – del «momento in cui sollevo | il citofono in fondo al corridoio | e da una voce sconosciuta apprendo | apprendo che mi visita la morte» (p. 314), fluttuante in una marea di 120 endecasillabi senza punteggiatura che costituisce un unicum nella poesia di Mazza –, a partire dall’arreso sgomento di Poesie per Fabio: «non reggo | la vita da una notte di settembre» (p. 106). Anche qui la coazione si afferma senza ripetersi, generando una rosa di vivide varianti: «ed è settembre vuota vigna, vuota | voliera, acqua di pozzo | a cui non bere» (p. 119); «già muore ottobre e tutto s’è compiuto» (p. 124); «Presto, a settembre, calerà la scure | sui miei ricordi e l’illusorio viaggio | sconfinerà nel tuo per aver tregua» (p. 140); «Che vuoi che oda? Un solo, secco | colpo, l’ultimo settembre, | un tuo gemito: eccomi | come sono, inerti le membra» (p. 298); «Come catastrofe, assai prima, | ogni settembre mi si annuncia, | e ciascun anno muta la pronuncia | del verbo, dai cunicoli alla cima» (p. 311); «Sono così stanco che la morte | è l’unica, costante apparizione | – o giorni o giorni o giorni –, corte | o lunghissime ore | se mi concentro o mi disperdo, come | sempre a settembre, gemito e tremore» (p. 357); «Settembre, il frutto che mi cade ai piedi | è uno dei tanti segni a cui | trasalisco, fermatosi oggi il tempo» (p. 361); «quel settembre in cui vidi | sparecchiata la tavola in un lampo, | nudo il salotto, pallide le lampade, | due ombre soccorrevoli di amici | che ti amavano. O Dio, com’è rimasta | crocifissa la vita a quegli istanti» (pp. 427-428). E veramente commuove, di là da ogni mero merito estetico, il compianto di tutto un evo: «Di queste povere cose, di poveri | versi che si ripetono a settembre, | non dubito, come l’essere vivo | non mi dà turbamento» (p. 429); «Qua, sospirando | senza un sospiro, ricordo | che di anno in anno, sempre | la medesima sera di settembre, | sedendo a cena solo, | ma senza toccar cibo, muto | aspettando, che fosse | quella l’ultima cena mi pareva, | silenziosa e inodore, | vuoto il tuo posto, presentendo | che lì non ti saresti più seduto» (p. 468).
Non meno umano è il pianto versato nelle ricorrenze del naufragio – del «momento in cui sollevo | il citofono in fondo al corridoio | e da una voce sconosciuta apprendo | apprendo che mi visita la morte» (p. 314), fluttuante in una marea di 120 endecasillabi senza punteggiatura che costituisce un unicum nella poesia di Mazza –, a partire dall’arreso sgomento di Poesie per Fabio: «non reggo | la vita da una notte di settembre» (p. 106). Anche qui la coazione si afferma senza ripetersi, generando una rosa di vivide varianti: «ed è settembre vuota vigna, vuota | voliera, acqua di pozzo | a cui non bere» (p. 119); «già muore ottobre e tutto s’è compiuto» (p. 124); «Presto, a settembre, calerà la scure | sui miei ricordi e l’illusorio viaggio | sconfinerà nel tuo per aver tregua» (p. 140); «Che vuoi che oda? Un solo, secco | colpo, l’ultimo settembre, | un tuo gemito: eccomi | come sono, inerti le membra» (p. 298); «Come catastrofe, assai prima, | ogni settembre mi si annuncia, | e ciascun anno muta la pronuncia | del verbo, dai cunicoli alla cima» (p. 311); «Sono così stanco che la morte | è l’unica, costante apparizione | – o giorni o giorni o giorni –, corte | o lunghissime ore | se mi concentro o mi disperdo, come | sempre a settembre, gemito e tremore» (p. 357); «Settembre, il frutto che mi cade ai piedi | è uno dei tanti segni a cui | trasalisco, fermatosi oggi il tempo» (p. 361); «quel settembre in cui vidi | sparecchiata la tavola in un lampo, | nudo il salotto, pallide le lampade, | due ombre soccorrevoli di amici | che ti amavano. O Dio, com’è rimasta | crocifissa la vita a quegli istanti» (pp. 427-428). E veramente commuove, di là da ogni mero merito estetico, il compianto di tutto un evo: «Di queste povere cose, di poveri | versi che si ripetono a settembre, | non dubito, come l’essere vivo | non mi dà turbamento» (p. 429); «Qua, sospirando | senza un sospiro, ricordo | che di anno in anno, sempre | la medesima sera di settembre, | sedendo a cena solo, | ma senza toccar cibo, muto | aspettando, che fosse | quella l’ultima cena mi pareva, | silenziosa e inodore, | vuoto il tuo posto, presentendo | che lì non ti saresti più seduto» (p. 468).
Ma il culto di reliquie e anniversari è solo uno degli innumeri modi (il più comune, anche se la convenzione vi è volta in ansioso canto) della desiderata reviviscenza. Proprio perché in nessun luogo, il figlio deve essere dappertutto: «Mai di cercarti nello spazio | sarò pago» (p. 190). Se L’acqua e il vento vedeva Fabio infante «levare gli occhi | alle dita che vibrano | come ali di farfalla» (n. 14), lui volato via, «un biancore improvviso di farfalla» (p. 120) farà presto a diventarne un indizio, quasi un senhal: «Fuggi, cieca | farfalla. Nel tralucere di un’ala | forse è mio figlio» (p. 132). Un indizio che muove persino a nostalgia, a richiamare «la farfalla a cui, | nel minuscolo palpito, mi parve | congiungersi il tuo volo» (p. 138), a ritrovarla nella misteriosa «àtropo che s’invola | e sale, o risale, l’opaco | spazio, l’opaco | tempo congiunti, ed oltre, dove | anima non si duole» (p. 326), quando non a dettare una trasognata metamorfosi: «ed anche qui, | ognuna in forma di farfalla, volano | scompaiono ritornano le tue | due sillabe ora mute, | screziate, agili ali» (p. 475). Un indizio che si riverbera ancora, sulle ali di un’altra suggestione dantesca (Purgatorio, X, 125), nella poesia incipitaria di L’oscuro lembo: «Allora | mi appoggerà la testa sulla spalla | o, di là d’ogni tempo, | brucerò d’ansia, lui | assunto nell’angelica farfalla» (p. 532).
Oltre che in questa forma emblematica il figlio fluttuerà in altre forme, per dirla con Saba, leggere e vaganti. Sarà «falda di fuoco del camino» (p. 119), «favilla» (p. 144), «torcia che accendi» (p. 284), «luce che va e viene» (p. 146), «un astro o un suo frammento» (p. 261), «l’angolo d’azzurro | dove t’incieli» (p. 122), «soffi | d’aria o vaghi fremiti | d’ali chiuse ed aperte» (p. 150), «cigolio lontano» (p. 142). Sarà poi «corda | tesa, giammai sfiorata dalle mie | dita vinte da un tremito» (p. 176), presenza che «si rivela, si nasconde» (p. 160), per farsi oroscopo nel «lui ripiegato | come un foglietto in cui tutto | del suo destino era scritto» (p. 150). Si mostrerà «per un istante immisurabile» (p. 433), e giungerà ad imprimere un’angosciosa lastra (Ultimi frammenti, n. 59, p. 403):
Sempre l’idea d’un viso
fuggevole, fissato
un attimo, diviso
da me da un vetro sigillato;
uno tra mille, e la paura
di perderlo, già in moto la vettura.
 L’interrogazione delle cose si accompagna alla strenua ricerca di un ‘contatto’, configurato dal «Ma te soltanto penso, ho te davanti | e chiamo sottovoce, fino a scorgerti | tra ombre andare, ed improvvisi gorghi | di luce, cancellarti oltre le piante» (p. 106). Tentativi che tradiscono la natura affabile, tutt’altro che solipsistica, della poesia di Mazza, e sono ora sperimentati in ogni concepibile verso, pur nella cognizione dell’azzardo: «l’illusione che si va infoltendo, | e poi fugge da me, d’un tuo sussurro» (p. 139). Il «colloquio muto» (p. 308) darà voce al rimpianto di quel che non è stato («L’ultimo lunedì volevo dirti | qualcosa di non detto» – p. 118; «come vorrei | lodarlo o, con amore, | rimproverarlo» – p. 204) e all’inverosimile appello («Puoi chiamarmi al mio numero, | o a un altro con qualsiasi prefisso» – p. 221; «devi chiamarmi più forte | se vuoi che ti risponda» – p. 165), all’istanza capziosa («ti chiederò di fingere di aprire | l’acqua del bagno, di sottrarmi | una lametta, un ultimo profumo» – pp. 127-128) e alla più tenera supplica («Leggimi, figlio, in filigrana, | consumami fra le tue dita | fino alla più sottile trasparenza» – p. 128; «Dimmi come posso chiamarti, | se con le tue due sillabe | o in altro modo» – p. 148; «batti con lievi nocche | all’uscio» – p. 185), sino a concedersi una velata replica («Babbo, | mi dice, trovami | nella profondità» – p. 156), un trepido premio: «La voce non è più la stessa, | leggermente incrinata, | ma che lo sia, del timbro | inconfondibile a me sembra, | e posso allora riascoltare, | senza vederti, una tua | confessione sommessa, | la più vera di quante abbia ascoltato» (p. 413). La desolata dolcezza, la malinconiosa magia di questa conversazione silente dilaga in una lirica di Nella calante oscurità (n. 80, p. 265):
L’interrogazione delle cose si accompagna alla strenua ricerca di un ‘contatto’, configurato dal «Ma te soltanto penso, ho te davanti | e chiamo sottovoce, fino a scorgerti | tra ombre andare, ed improvvisi gorghi | di luce, cancellarti oltre le piante» (p. 106). Tentativi che tradiscono la natura affabile, tutt’altro che solipsistica, della poesia di Mazza, e sono ora sperimentati in ogni concepibile verso, pur nella cognizione dell’azzardo: «l’illusione che si va infoltendo, | e poi fugge da me, d’un tuo sussurro» (p. 139). Il «colloquio muto» (p. 308) darà voce al rimpianto di quel che non è stato («L’ultimo lunedì volevo dirti | qualcosa di non detto» – p. 118; «come vorrei | lodarlo o, con amore, | rimproverarlo» – p. 204) e all’inverosimile appello («Puoi chiamarmi al mio numero, | o a un altro con qualsiasi prefisso» – p. 221; «devi chiamarmi più forte | se vuoi che ti risponda» – p. 165), all’istanza capziosa («ti chiederò di fingere di aprire | l’acqua del bagno, di sottrarmi | una lametta, un ultimo profumo» – pp. 127-128) e alla più tenera supplica («Leggimi, figlio, in filigrana, | consumami fra le tue dita | fino alla più sottile trasparenza» – p. 128; «Dimmi come posso chiamarti, | se con le tue due sillabe | o in altro modo» – p. 148; «batti con lievi nocche | all’uscio» – p. 185), sino a concedersi una velata replica («Babbo, | mi dice, trovami | nella profondità» – p. 156), un trepido premio: «La voce non è più la stessa, | leggermente incrinata, | ma che lo sia, del timbro | inconfondibile a me sembra, | e posso allora riascoltare, | senza vederti, una tua | confessione sommessa, | la più vera di quante abbia ascoltato» (p. 413). La desolata dolcezza, la malinconiosa magia di questa conversazione silente dilaga in una lirica di Nella calante oscurità (n. 80, p. 265):
Non muoverti, ma fammi
un ilare segnale
come uno schiocco di dita,
non potendo altro suono
emettere, o muovendoti pianissimo
muovimi intorno l’aria
notturna, in modo che una pagina
da sé si volti e n’abbia
io dolce meraviglia.
Il ‘Canzoniere per Fabio’ è questa «dolce meraviglia». La sua prodigiosa tenuta risiede in una incredulità che si fa fede, è ‘l’albero del niente’ chiamato al miracolo delle foglie e dei frutti: non più l’«albero gigante | alla cui ombra non avrò ricetto» cui il figlio era stato prematuramente associato [43], ma il grande albero generato dal vuoto, la frondosa quercia della ‘disperata speranza’: «il cuore, immenso album segreto | della tua vita in divenire», dischiuso nell’ultimo dei Frammenti postumi (p. 477).
La terza parte del Canzoniere per Fabio e altre poesie documenta l’ultima fase della milizia poetica di Enzo Mazza, avviata da Per i sedici anni di Gianluca (1990), tardivo ‘risarcimento’ al figlio indenne (festeggiato proprio nel compleanno che felicemente scavalca l’infausto quindicesimo del figlio ‘interrotto’, come dichiara l’incipit del primo dei nove sonetti che lo compongono: «Ora hai l’età che lui non ha raggiunto») che trova diretta espressione nelle terzine finali del quarto («L’occaso è una carezza al cuore, al petto, | e d’inespresso amore solo avvampo | in un sogno che a te mi veda stretto») e del quinto («Ma non turbarti: vi amo entrambi, sono | stanco di confrontarvi: non aveva | altra speranza il cuore che il perdono»), mentre l’ottavo si fa carico di un lucido quanto spietato bilancio: «Abbasso il capo: so che ti rattrista | ancor oggi, dal tempo dei trastulli, | la mia sola presenza, che mi annulla | ai tuoi occhi qualcosa d’intravisto || dietro di me, ch’io stesso non discerno. | Né, forse, hai torto. L’umiltà collima | con la superbia, l’incontrarsi alterno, || ovunque si produca, delle rime. | Ancora io le ricerco, ed è l’inferno | a guidarmi la mano più di prima».
Ugualmente ‘monografici’ sono i tre successivi libretti in memoria di amici da poco scomparsi (12 poesie per Bruno Carnevali – 1990; Versi a Marinka – 1993; 12 poesie per Alceste Angelini – 1995), mentre ventinove poesie estravaganti trovano asilo, come Postille inedite, nell’autoantologia Uno di questi giorni (1994). Più che da un intento celebrativo o testimoniale, il trittico è mosso dal desiderio di proseguire il fervido dialogo interrotto dalla morte, restaura la consuetudine del mutuo ascolto. Nel primo dei testi per Bruno Carnevali leggiamo: «se mi presti orecchio | per gentilezza e antico affetto, | e se puoi le parole d’un amico | incredulo e ferito | ricevere da lungi ed emendare | per virtù di sapienza e rarefatta, | limpida, inalienabile memoria». Nel secondo: «Fin dai tempi dell’Achmàtova | parlavamo di Dante, anche di Dio». Nel terzo: «Ma le forze | mi abbandonavano, e il coraggio, | ahi, di sollecitarti una risposta». Nel quarto: «Parlavamo di libri, | naturalmente, anche d’iniziative | tipografiche». Nel sesto: «Questo non so, ché alcun valore | non hanno le domande che ti pongo». E nell’ultimo: «Addio. Non posso | chiamarti più, non c’è alcun modo | di eludere il silenzio». Ma la nota più fonda di questo irrisolto colloquio si leva nella chiusa del quinto: «Così, Bruno, nel pallido recinto | che, disparendo lascia | dietro di sé una vita, | ti ho conosciuto e, tristemente | (ora consentimi l’avverbio), amato».
Quasi lasse di un unico poemetto, le ventuno poesie per Marinka (in cui affiora per tre volte il nome della comune amica Jole Tognelli, commemorata in Postille inedite) danno invece vita a un torneo di sguardi che ha il suo apice nei testi allogati al centro della raccolta. Nell’uno campeggia quello di Marinka, introdotto da «quell’indimenticabile | azzurro dei tuoi occhi» della poesia proemiale e qui reso eterno da un perentorio «no» (p. 500):
Gli occhi di chi
li ha chiusi, si dimenticano appena
scompaiono le epigrafi e i cipressi,
scende e ogni cosa ingoia
la nebbia del tempo, ma i tuoi
a cui corrispondeva
la dolce piega del sorriso, no.
Nell’altro quello del poeta si ferma, finemente ecfrastico, sulle cangianze delle sue creazioni artistiche (pp. 499-500):
Pochi hanno in arte la mano leggera,
e tu l’avevi, frantumando,
ricomponendo un mondo, indovinandone
i luoghi acconci, case e prati
fioriti, neve a chiazze, omini
formicolanti nei costumi
d’origine, fondali sghembi, intenso
movimento sospeso, strana sorta
di cronistoria affaccendata e assorta
in un suo sovrasenso.
 Il ventaglio di versi per il grecista Alceste Angelini («l’amico fraterno e generoso di quest’ultimi decenni» rammemorato nella notizia che li accompagna) rimpiange insieme il maestro, il modello inarrivabile: «Pari alla tua non era la mia mente, | albero scheletrito il mio sapere, | protratta insania, colpa d’infinite | ore perdute in vani passatempi. | Ma tu indulgevi, sopravvalutavi | la mia pochezza, amico incoercibile» (n. V). Il sodalizio è ripercorso fra gli echi di autori condivisi (i danteschi «velame che non ti nasconde», «cotanto senno», «aer perso», i «licheni» e il «pianissimo» di Sbarbaro, le «ombre virgiliane», il «ritrattino» di Leopardi, «il romito studiolo del Petrarca» e il suo «Già su per l’Alpi neva d’ogni giorno»), in scene della memoria (per tutte, quella che nella poesia incipitaria risale dal mesto convegno con il morente alle escursioni dei «bei tempi», «per le vie | ripide su San Biagio, fuori porta, | e negli ultimi anni, invece, piane | a Sarteano, verso le piscine, | tranne la salitina al bar | della piazzetta. Là | stavamo per un po’ seduti, esposti | a un lieve moto di ventilazione»), in soavi congetture di vita oltremondana («Forse seimila miglia | di lontano, in altezza | giammai così vertiginosa | immaginabile quaggiù, si è mosso | stuolo di amici ad incontrarti, ognuno | puro intelletto e ognuno | non so se con diversa o pari | intensità di luce» – n. 2), per chiudersi nel rammarico di una separazione senza rimedio: «di te notizie | terrene non ho più, non potrò averne (n. XI); «non so più nulla | adesso, quasi un cataclisma | a dividerci silenziosamente | fosse avvenuto» (n. XII).
Il ventaglio di versi per il grecista Alceste Angelini («l’amico fraterno e generoso di quest’ultimi decenni» rammemorato nella notizia che li accompagna) rimpiange insieme il maestro, il modello inarrivabile: «Pari alla tua non era la mia mente, | albero scheletrito il mio sapere, | protratta insania, colpa d’infinite | ore perdute in vani passatempi. | Ma tu indulgevi, sopravvalutavi | la mia pochezza, amico incoercibile» (n. V). Il sodalizio è ripercorso fra gli echi di autori condivisi (i danteschi «velame che non ti nasconde», «cotanto senno», «aer perso», i «licheni» e il «pianissimo» di Sbarbaro, le «ombre virgiliane», il «ritrattino» di Leopardi, «il romito studiolo del Petrarca» e il suo «Già su per l’Alpi neva d’ogni giorno»), in scene della memoria (per tutte, quella che nella poesia incipitaria risale dal mesto convegno con il morente alle escursioni dei «bei tempi», «per le vie | ripide su San Biagio, fuori porta, | e negli ultimi anni, invece, piane | a Sarteano, verso le piscine, | tranne la salitina al bar | della piazzetta. Là | stavamo per un po’ seduti, esposti | a un lieve moto di ventilazione»), in soavi congetture di vita oltremondana («Forse seimila miglia | di lontano, in altezza | giammai così vertiginosa | immaginabile quaggiù, si è mosso | stuolo di amici ad incontrarti, ognuno | puro intelletto e ognuno | non so se con diversa o pari | intensità di luce» – n. 2), per chiudersi nel rammarico di una separazione senza rimedio: «di te notizie | terrene non ho più, non potrò averne (n. XI); «non so più nulla | adesso, quasi un cataclisma | a dividerci silenziosamente | fosse avvenuto» (n. XII).
Più che a questi libretti cronologicamente contigui (cui tuttavia rimanda l’epicedio A Jole, tre mesi dopo, con il suo impagabile «discensore»), le Postille inedite si avvicinano alle raccoltine di ‘fine carriera’, che registrano l’arrivo di una relativa pace interiore, di una certa serenità, portando un più libero e mosso procedere, una svagata leggerezza spesso appesa al rapido graffio dell’epigramma, inciso sull’invito che le conclude: «Lasciate la lapide bianca. | La mia natura era pigra. | Leggere anche una sola epigrafe | a volte stanca». È il tempo dei consuntivi, il tempo che più facilmente chiama al ricordo (qui rivolto a vecchi anni di scuola e alle figure dei genitori), che, sotto la «malinconia | d’uno stato che si adegua alla polvere» (n. 13), induce reiterate domande sulla morte, ma anche autorizza sognanti, aeree fantasie, come quella che ancora incrocia il figlio (n. 19):
Quando sarai bien vieille
non ricorderai nulla
o a certi versi miei
dondolerai la culla,
come avessero preso
la forma d’un bambino,
d’un Peter Pan, sorpreso
a uscire dal camino.
Certo il tuo non volava
sopra la casa in tondo,
semmai ci domandava
com’era fatto il mondo.
È lui, ora, a precederci
nel mare dell’ignoto.
Ma Dio? Dobbiamo crederci
o preferire il vuoto?
Questa condizione permane nelle due susseguenti raccolte. L’oscuro lembo è il diario di un vecchio che accarezza i propri giorni con l’allegra mestizia di chi sa di averne distillato tutto il fiele, che si sofferma sui piccoli fatti della sua povera vita con la derelitta stupefazione di un «superstite d’un secolo perverso» (n. III), che annota impassibile i segni della decadenza e della malattia: «Nulla | stringono le mie scarne braccia ed anche | mi si offusca e mi cade dalla mente | ciò che sapevo» (n. XXVI). Uno zibaldone che accoglie ancora memorie remote, come quella, tenace, del padre, «la bontà incarnata», «candido, privo di rancori, | impulsivo, sebbene sottomesso | a lei, mia madre, che per sé teneva | i biscotti più buoni» (n. VII), della «donna impareggiabile», oggi «sofferente, smagrita» (n. XXX), dei giovanili «vecchi di Monfumo» (n. XXI), dell’amico fiorentino in cui sembra di riconoscere Paolo Redi (n. XIX):
Pallido e scarno,
ti rivedo seduto
sulla spalletta dell’Arno,
poco loquace, anzi muto.
Non c’è un piccolo cinema nei pressi
in cui sparire, come facevamo
una volta? Non siamo, in fondo,
sempre gli stessi?
 Una pratica di scrittura che convoca sparsamente il «difficile incedere di Sbarbaro» (n. XX), «il sax di Charlie Parker» (n. X), «L’Egitto, Cuba, il Messico, le Antille» (n. XVIII), le «rondini infallibili, nei voli | primaverili a ritrovare i nidi | deserti sotto questo tetto» (n. III), il «plaid che me disteso copre» (n. XI), i danteschi «amici | morti e ancor vivi, non diversi | da quelli a cui | i naviganti han detto addio» (n. XVI), e dà ancora luogo alla visione del «crollo ripetuto da una macchina | da presa all’infinito» (n. XII), al vano anelito: «Tendo alla fine le braccia, | nessuno immobile | sul letto immaginandomi | mentre le tendo. Non può tutto | un semplice pensiero, come può | accadere nel sogno l’impossibile?» (n. VI). Un esercizio che si piega, con mossa metaletteraria già indirizzata ai versi «astrusi, brutti, di retrodatata | fattura» di Postille inedite (n. 14), a contenere sé stesso: «il quadernetto quadrettato, | la punta fine che mi aiuta | gli ultimi anni a vincere, talvolta | a eludere l’attesa | che la stanzetta non mi veda più» (n. XXII); «la cameretta | dove dormo e riempio quadernetti»; «le paginette dei Frammenti postumi | col nome e il titolo in azzurro» (n. V).
Una pratica di scrittura che convoca sparsamente il «difficile incedere di Sbarbaro» (n. XX), «il sax di Charlie Parker» (n. X), «L’Egitto, Cuba, il Messico, le Antille» (n. XVIII), le «rondini infallibili, nei voli | primaverili a ritrovare i nidi | deserti sotto questo tetto» (n. III), il «plaid che me disteso copre» (n. XI), i danteschi «amici | morti e ancor vivi, non diversi | da quelli a cui | i naviganti han detto addio» (n. XVI), e dà ancora luogo alla visione del «crollo ripetuto da una macchina | da presa all’infinito» (n. XII), al vano anelito: «Tendo alla fine le braccia, | nessuno immobile | sul letto immaginandomi | mentre le tendo. Non può tutto | un semplice pensiero, come può | accadere nel sogno l’impossibile?» (n. VI). Un esercizio che si piega, con mossa metaletteraria già indirizzata ai versi «astrusi, brutti, di retrodatata | fattura» di Postille inedite (n. 14), a contenere sé stesso: «il quadernetto quadrettato, | la punta fine che mi aiuta | gli ultimi anni a vincere, talvolta | a eludere l’attesa | che la stanzetta non mi veda più» (n. XXII); «la cameretta | dove dormo e riempio quadernetti»; «le paginette dei Frammenti postumi | col nome e il titolo in azzurro» (n. V).
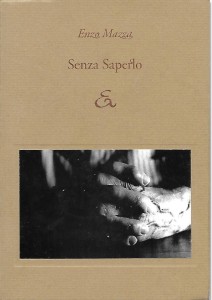 Questo clima di indulgente autoironia raggiunge, vien giusto da dire, il suo climax nelle trentotto brevi poesie di Senza saperlo. Un esito registrato dallo stesso autore («Mi escono dalla penna deliziose | poesie d’una fantastica allegrezza») nel distico iniziale di A ritroso, che ‘ritrova’ un antico episodio con la madre («Questo accadde | a Milano, all’incirca nel ventotto | del secolo trascorso»), e più volte ribadito, a partire dall’esordio di In corsivo («Vedete come biascico | – mi scuserete – le parole. Sono più morto che vivo»), che coinvolge i suoi nuovi amici, i «ragazzi» di Vene, la poesia che fa da epigrafe al libricino, e proseguendo con Congedo («Esamino | i miei poveri versi di recluso. | Quasi più niente attrae lo sguardo. | Metto il muso a me stesso. Senza angoscia»), Fa lo stesso («Sarò da museo delle cere»), Mi mancano… («Non per il semplice fatto | di avere scritto tanto | mi sento stanco, ma per i desolati contenuti»), Piccolezze («Non superano quelle | di certe collinette le mie altezze, | ciò che vado scrivendo non potendo | non esser fatto che di piccolezze»). Una nuova libertà che si esercita su evenienze del quotidiano (Fa lo stesso, Quando…, Quanto all’età…, Da qui a Volterra, Un vecchierello, Iniezioni), sulla vita dei familiari (La camera oscura, Lei, Mio figlio, Ancora lei, Un mio diritto, E io?), sul pensiero incombente dell’addio (Lugubre…, Commiato, In basso, Il pozzo, I cipressi, Vibrando, Le automobili nere, Apatia, Ad una certa età, Senza saperlo, Senz’aria, Eclissi), e che chiama spesso in causa le amicizie adunate nella poesia epilogale, Intercielo: «Spero in un intercielo, ossia | tra un cielo e l’altro un cielo in cui | si raccolgono i perduti amici». Ecco allora, su piste dantesche, All’amico Bino («vorrei che tu sotto le tue | meravigliose, uniche mura | continuassi a passare in bicicletta»), Valeri («Quanto ancora mi dolgo | che tu non mi abbia letto | Le cimetièr marin | di Valéry), A P. («Paolo, se mi senti | mi basta. Non rispondermi»); ecco la dichiarazione di poetica di Per pochi amici («Avete, avremo | una lapide, fiori, ben lontani | dalla cultura di massa. | Però continueremo a stare, | finalmente concordi, tutti insieme | tra le ingiallite pagine di marsia»); ecco il perfetto epigramma per un obliato, inobliabile maestro (Noventa, p. 552):
Questo clima di indulgente autoironia raggiunge, vien giusto da dire, il suo climax nelle trentotto brevi poesie di Senza saperlo. Un esito registrato dallo stesso autore («Mi escono dalla penna deliziose | poesie d’una fantastica allegrezza») nel distico iniziale di A ritroso, che ‘ritrova’ un antico episodio con la madre («Questo accadde | a Milano, all’incirca nel ventotto | del secolo trascorso»), e più volte ribadito, a partire dall’esordio di In corsivo («Vedete come biascico | – mi scuserete – le parole. Sono più morto che vivo»), che coinvolge i suoi nuovi amici, i «ragazzi» di Vene, la poesia che fa da epigrafe al libricino, e proseguendo con Congedo («Esamino | i miei poveri versi di recluso. | Quasi più niente attrae lo sguardo. | Metto il muso a me stesso. Senza angoscia»), Fa lo stesso («Sarò da museo delle cere»), Mi mancano… («Non per il semplice fatto | di avere scritto tanto | mi sento stanco, ma per i desolati contenuti»), Piccolezze («Non superano quelle | di certe collinette le mie altezze, | ciò che vado scrivendo non potendo | non esser fatto che di piccolezze»). Una nuova libertà che si esercita su evenienze del quotidiano (Fa lo stesso, Quando…, Quanto all’età…, Da qui a Volterra, Un vecchierello, Iniezioni), sulla vita dei familiari (La camera oscura, Lei, Mio figlio, Ancora lei, Un mio diritto, E io?), sul pensiero incombente dell’addio (Lugubre…, Commiato, In basso, Il pozzo, I cipressi, Vibrando, Le automobili nere, Apatia, Ad una certa età, Senza saperlo, Senz’aria, Eclissi), e che chiama spesso in causa le amicizie adunate nella poesia epilogale, Intercielo: «Spero in un intercielo, ossia | tra un cielo e l’altro un cielo in cui | si raccolgono i perduti amici». Ecco allora, su piste dantesche, All’amico Bino («vorrei che tu sotto le tue | meravigliose, uniche mura | continuassi a passare in bicicletta»), Valeri («Quanto ancora mi dolgo | che tu non mi abbia letto | Le cimetièr marin | di Valéry), A P. («Paolo, se mi senti | mi basta. Non rispondermi»); ecco la dichiarazione di poetica di Per pochi amici («Avete, avremo | una lapide, fiori, ben lontani | dalla cultura di massa. | Però continueremo a stare, | finalmente concordi, tutti insieme | tra le ingiallite pagine di marsia»); ecco il perfetto epigramma per un obliato, inobliabile maestro (Noventa, p. 552):
Avrò la voce quasi spenta,
ma a chi ha memoria raccomanderò
di chiudere con me
quel volume di Giacomo Noventa.
Una vaga speranza («Ultimo mio libretto, | davvero l’ultimo», assicura la poesia posta in epigrafe) rappresenta la prosecuzione e insieme l’esaurirsi di questa inattesa primavera, già minata dai sintomi del male che i versi continuano a registrare: «sonnecchio modulando versi | che mi fuggono subito di mente» (n. I); «Ahimè, la ruggine dei vecchi | arriva anche alla testa, la distrugge» (n. X); «A notte fonda resto | su tre cuscini | stranamente assonnato» (n. XIV); «Vivo a metà, cullato | dal ritmo blando della sonnolenza» (n. XVI); «Perdo improvvisamente la memoria» (n. XXIII); «Mi addormento | solo, in poltrona, cedimento insolito, | anche proficuo se, riaprendo gli occhi, | sorrido ingenuamente, come | da una vaga speranza attraversato» (n. XXXIV). Ma questo crepuscolare dormiveglia, percorso dal ricorrente pensiero della morte, non impedisce il proseguimento dei ‘muti colloqui’, si apprende a residui barlumi di vita. Tornano così i più cari ricordi: il padre «che, giovane, conobbe | la guerra di trincea sul Monte Grappa» (n. XI); il «viale | tacito, senza macchine, bellissimo, | a pochi passi dalla rosseggiante fortezza» (n. XVII); la «Venezia | bluastra» e il «Collegio relegato a Sant’Elena» (n. XX); la madre, «Emma di nome, | pittrice, ritrattista, che illustrò | perfino Dante» (n. XXIII); di nuovo il padre «clemente, dolce | con me, con le sorelle, senza mai | metterci fretta. Non si lamentò | se non tenendo alta la radio | nel semibuio della sua stanzetta» (n. XXXII). Tornano gli amici scomparsi: Paolo Redi («La più debole voce | che possa essere udita era la tua» – n. III); Giovanni Grazzini, il Vanni onorato da una ghirlanda di poesie (nn. VII, VIII, IX, XXXVII); Alceste Angiolini («Presto mi farò vivo senza vita. | Riprenderemo, come | a Siena e a Sarteano, | a discorrere insieme del Petrarca» – n. XVIII); Leonardo Sciascia («Scruto in me stesso, ancora piango | di non essere andato a Racalmuto | che all’inferno non è, dove Leonardo | pare cammini stando fermo» – n. XXI); «i superstiti amici | a me più cari, tutti giovani, | giovanissimi», che gli hanno appena offerto Senza saperlo. E c’è ancora tempo per la più vieta commozione: «Mi vengono le lacrime apprendendo | che una bambina è morta tra le fiamme | d’una baracca» (n. VI); «Ho sognato quel bimbo di tre anni | trucidato lassù, nella casetta | in Val d’Aosta» (n. X). C’è ancora spazio, sapendosi «l’ultima ruota del carro» (n. XXXIV), per semisorridenti spigolature che toccano Montale (n. VIII), Sbarbaro (n. XXVI), Joyce (n. XXXIII), Pascal (n. XXXVIII), Nietzsche (XLI), Tommaseo (n. XLIII).
Compiuta la maratona, «l’ultima ruota del carro», il poeta quasi programmaticamente minore e clandestino, guadagna un’altra luce. Nelle primissime battute del suo studio introduttivo Alessandro Fo ne proclama senza indugi la statura: «è venuto il momento di accorgersi che è vissuto nell’Italia del Novecento e primo Duemila un grande poeta» (p. 7). Questa quanto mai impegnativa asserzione si riconduce all’«orbita di una lirica senza cadute: autenticità contro artefazione, politezza formale senza futili oscurità, coincidere di dolore e di poesia come timido antidoto a un inesorabile veleno» (p. 8); riconosce «la sempre inesausta novità delle realizzazioni, il rigoglio della vena che fluisce da una vulnerazione tanto profonda e insanabile» (p. 8), vede una poesia «tersa, pura, sincera, solenne senza essere pomposa, di rarefatta raffinatissima eleganza e sempre motivata, senza superfluità né lo sforzo verso il poetico» (p. 10).
Queste valutazioni sono sostenute da una agguerrita analisi ‘tecnica’ cui non si potrà far a meno di ricorrere: «L’autore nutre una vocazione per endecasillabi e settenari, che tratta con un’ampia gamma di sapienze prosodico-metriche. Sa per esempio amministrare all’occorrenza un gioco di iati per istituire pause di stacco e di silenzio. Ma spesso rinuncia volontariamente a movenze liriche; insabbia quegli stessi endecasillabi, che gli si presentano spontanei, in spezzature arbitrarie, quasi a nasconderli, così come nasconde i confini di terzine e quartine in una delle sue forme predilette, il sonetto. Talora si ha l’impressione che Mazza tratti questi monconi di endecasillabi, destinati a compiersi nel corpo di un verso successivo, come kola lirici di strutture più complesse sfuggite alle previsioni della manualistica» (p. 25). In forza di tali referti, che contemplano, tra l’altro, la perspicua osservazione che «in 33 poesie per Fabio, nella raccolta cioè scritta nel decennale della morte, è la quartina che reca il numero dieci a portare tutto il peso della struttura, a fare da perno alla raccolta» (p. 26), Fo può parlare di un «lavoro di ingegneria della parola» adempiuto «con una ‘naturalezza’ che brucia e cancella ogni possibile residuo di fatica» (p. 27), rilevandovi la «passione per parole dal peso sillabico rilevante, come i superlativi in -issimo, le dilatate falde di avverbi in -mente e di corposi aggettivi in -bile, nonché le molte forme di gerundio: ne vengono volute ampie e solenni, prese in effetti di stasi o ritardo, ingombri armonici di rilievo plastico» (p. 27).
Una simile «vocazione», che si è tentati di accostare al «Quod temptabam dicere versus erat», di ovidiana memoria (Tristia, IV, X, 269), si manifesta in varie altre guise. Si scorge, ad esempio, lo si è detto, un certo gusto per la ‘rima calembour’: «Non sai cos’è un alibi, | cos’è l’odio, l’accidia, | l’insidia del buio. | Niente ti fa velo. | Hai dita appena abili | a reggerti sul tuo | somarello di pelo (L’acqua e il vento, n. 3); «Penso | ai fanciulli di Pascoli, Zvanî, | soli, impauriti, ed anche al sogno | d’uno dei miei fanciulli, che svanì» (In fondo al corridoio, n. 98); «Estraneo al numero degli anni, Lui, | l’eternità medesima, al di sopra | del dolore, contempla, si nasconde, | non si mostra che a tempo | scaduto, quando i giochi fatui | di cui l’esistere s’intesse | irrevocabilmente ha spento il fato» (12 poesie per Bruno Carnevali, n. XI). Si notano estrosi giochi fonici, come quelli sulla terminazione in «ono» («Quando si arriva dove sono | arrivato, e non c’è suono | che non chiami altro suono, | quasi un tuono» – In fondo al corridoio, n. 25), in «amo» («Tu viaggi, io viaggio. Consumiamo | carburante, sprechiamo | gasolio, non conosciamo | risparmio. Ci amiamo | da lontano. Parlandoci, siamo | le solite due foglie. Ruotiamo | con l’universo, ci diamo | vicendevolmente una mano. | Com’è flessibile il ramo | su cui ci appollaiamo, | timidi uccelli, lontano | il senso della vita. Rinunciamo | alla vita, e viviamo» – Nella calante oscurità, n. 6), sulla radice «pass» («Passano aerei e uccelli | di passo. Anche il dolore | si attenuerà fino a passare, dice, | fermandosi, un amico di passaggio» – Ultimi frammenti, n. 43), sulle rime-assonanze in «ersi»/«essi» (In fondo al corridoio, n. 74):
Sempre, su un’orma, versi
a piccole onde, persi
nel buio di sommersi
ricordi, echi sommessi
nei boschi, negli stessi
luoghi che non attraversi
da tempo. Ancora ti avessi
accanto! Nei casi avversi
o lieti, sai com’è dolce essere
in due, per mano tenersi.
E si apprezza la temperie ‘provenzale’ della poesia battuta, a contrappunto con «tavola», sulla significativa parola-rima «tempo» («Mi alzo da tavola anzitempo, | perché, tanto, la tavola d’un tempo | è sparecchiata, e opprime il tempo | a tavola, non come in altro tempo» – Gemito e tremore, n. 76), o il similsonetto di L’albero del niente (n. 30), in cui i primi sette versi rimano (o assonano) con i secondi sette:
Nella coppa di vetro
consumerà l’olio rimasto
la piccola fiammella,
come una vita breve
i giorni contati,
le ore d’allegria
tristemente fugaci.
Io, nel tetro
gioco ad incastro
che la mente suggella,
vorrei un più lieve
peso da reggere, alati
sensi che siano
prossimi a ciò che mi taci.
 Nel ‘Canzoniere per Fabio’ si incontra sei volte il desueto «duolo» invece del comune «dolore» (che vi ha quaranta occorrenze): «anime bianche incatenate a un duolo» (p. 107); «mi sommerge il duolo» (p. 110); «altri nascono gravidi di duolo» (p. 114); «strappo il duolo» (p. 115); «emergere dal lungo duolo» (p. 298); «Sorvoli alto le stigmate del duolo» (p. 446). Anche se l’opzione può in questi frangenti esser fortuita (motivata, mettiamo, da esigenze prosodiche o di colore verbale), vi si potrebbe anche vedere il contrassegno di una lingua che tende naturalmente verso l’alto, aspira alla dignità formale dei nostri classici. Si prendano, ad esempio, le due terzine conclusive del sonetto VI di Altri sonetti, in Poesie per Fabio (p. 146): «Piango e mi asciugo gli occhi, sono schiavo | e liberto, rinnego, accetto, dubito | di me, sordo alle cose che più amavo» || Mio figlio è luce che va e viene, porge | il suo mistero aprendosi a un connubio | di cui l’anima solo si può accorgere». Qui le «parole quotidiane, ma elette, politissime» di cui scrive Fo (p. 24) disegnano le ambasce del soggetto lirico, adottando lo statuto ‘ossimorico’ di molti sonetti petrarcheschi. Ma non si parli di tardo epigonismo o anacronistica imitazione. Come Giovanni Della Casa (o come Giorgio Caproni, o come Andrea Zanzotto), Mazza reinventa il modello investendolo del suo vissuto, del più bruciante ‘qui e ora’. L’impiego di parole e forme tramandate è insieme sorgivo e fortemente cercato: è l’elezione del campo che corrisponde alle sue corde.
Nel ‘Canzoniere per Fabio’ si incontra sei volte il desueto «duolo» invece del comune «dolore» (che vi ha quaranta occorrenze): «anime bianche incatenate a un duolo» (p. 107); «mi sommerge il duolo» (p. 110); «altri nascono gravidi di duolo» (p. 114); «strappo il duolo» (p. 115); «emergere dal lungo duolo» (p. 298); «Sorvoli alto le stigmate del duolo» (p. 446). Anche se l’opzione può in questi frangenti esser fortuita (motivata, mettiamo, da esigenze prosodiche o di colore verbale), vi si potrebbe anche vedere il contrassegno di una lingua che tende naturalmente verso l’alto, aspira alla dignità formale dei nostri classici. Si prendano, ad esempio, le due terzine conclusive del sonetto VI di Altri sonetti, in Poesie per Fabio (p. 146): «Piango e mi asciugo gli occhi, sono schiavo | e liberto, rinnego, accetto, dubito | di me, sordo alle cose che più amavo» || Mio figlio è luce che va e viene, porge | il suo mistero aprendosi a un connubio | di cui l’anima solo si può accorgere». Qui le «parole quotidiane, ma elette, politissime» di cui scrive Fo (p. 24) disegnano le ambasce del soggetto lirico, adottando lo statuto ‘ossimorico’ di molti sonetti petrarcheschi. Ma non si parli di tardo epigonismo o anacronistica imitazione. Come Giovanni Della Casa (o come Giorgio Caproni, o come Andrea Zanzotto), Mazza reinventa il modello investendolo del suo vissuto, del più bruciante ‘qui e ora’. L’impiego di parole e forme tramandate è insieme sorgivo e fortemente cercato: è l’elezione del campo che corrisponde alle sue corde.
Un campo conquistato poco a poco. Mazza costruisce la sua voce con esasperante lentezza, un’esitazione che trova eco nei suoi versi: «la mia pigrizia sempre | rimproveratami» (p. 238); «pigro, dolente uccello d’una estinta | famiglia» (p. 279); «io pigro, | privo di volontà» (p. 399); «gli interminabili silenzi a cui | pigrizia e ritrosia allo scrivere | ti avrebbero costretto» (p. 511); «La mia pigrizia, forse, mi giocò | l’ultimo doloroso scherzo» (p. 568); «una pigrizia per me simile | a uno stato di grazia incomprensibile» (p. 576). Ma quando la sua fisionomia di poeta è ormai delineata (diciamo all’altezza delle raccolte comprese fra L’acqua e il vento e L’invisibile), l’inaccettabile morte del figlio lo induce a volgere tutto il suo controverso mestiere a un solo compito: la salvaguardia di ogni possibile traccia di una vita sommersa. La «pigrizia» diviene d’un colpo infrenabile attivismo, cammino insonne sul ciglio dell’abisso. Il poeta di presagi, premonizioni, allarmi, crolli, il lirico introspettivo e cogitabondo, filosofico e gnomico, trova nel pensiero del figlio un imprevedibile enzima di energie latenti, e la sua musa tenue, sommessa, soffiata, la sua congenita ritrosia si vota a intraprendere una minuziosa, potenzialmente infinita, cartografia del dolore, non teme di misurare, grano per grano, le sabbie della Grande Desolazione.
Il segreto del ‘Canzoniere per Fabio’ (e, si può dire, di tutta la poesia di Enzo Mazza) è la sincerità senza remore, il coraggio di dire (e dirsi) tutto (un coraggio che si apprezza anche nelle cose meno riuscite, come i sessanta sonetti di Cupi divertimenti, raccolta inedita del 1984 che il figlio Gianluca mi ha gentilmente reso disponibile). Le incessanti rimuginazioni, le note a margine di una vita contumace hanno il prestigio del vero. Anche quando la poesia sembra diluirsi in grezzo taccuino, prolungato vociferio, giunge il colpo d’ala, l’immagine potente, il battesimo che la giustifica, restituendone l’intima urgenza. La sua viva fonte è una ‘moralità’ che piace accostare alla tradizione vociana, e alla voce, ferma quanto discreta, di Camillo Sbarbaro, che vi è spesso richiamata [44].
Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021
Note
[1] Trascrivo qui la mail (21 maggio 2021, h. 19,15) in cui Fo, su mia espressa richiesta, cerca di precisarne le circostanze: «io Mazza lo scoprii grazie a una recensione su “Oggi e domani” alle 33 poesie per Fabio, dicembre 1992, pp. 30-31. Lo cercai quasi subito, quindi direi che dovrei averlo conosciuto nel 1993, e avertelo fatto conoscere come poeta senz’altro prima del 1996. Lui mi mandò le Poesie per Fabio, poi pian piano le altre raccolte della serie per Fabio, poi – ma solo dopo che le avevo lette tutte ed eravamo già da molto in corrispondenza – lo andai a trovare in uno dei miei viaggi fra Siena e Roma (allora pendolavo), peraltro senza trovarlo. Penso che l’avrò incontrato di persona nel 94 o 95. In ogni caso quando uscì l’antologia lo conoscevo già da molto».
[2] Enzo Mazza, Uno di questi giorni. Poesie scelte (1954-1994), prefazione di Silvio Ramat, Città della Pieve (Pg), Biblioteca cominiana, 1996.
[3] Apparsa in «Oggi e domani», a. XXV, n. 3-4, marzo-aprile 1997: 40.
[4] Enzo Mazza, Poesie (1948-1951), Firenze, Felice Le Monnier, 1951 (il dittico alle pp. 19-20).
[5] Enzo Mazza, Chiusi, Biblioteca cominiana, 2000. La mia recensione apparve su «Oggi e domani», a. XXVIII, n. 11-12, dicembre 2000: 31.
[6] Enzo Mazza, Senza saperlo, Olmo, Arezzo, Edizioni degli Amici, 1° gennaio 2001.
[7] Mi riferisco, tralasciando vari altri occasionali contributi, a Voci della poesia italiana di fine Novecento (Nino De Vita, Paolo Ruffilli, Alceste Angelini, Enzo Mazza), in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia» dell’Università di Siena, 17, 1996: 319-354, e Poeti di un figlio perduto, in «La Rivista dei Libri» a. XI, n. 11, novembre 2001: 20-22.
[8] In Poesie (1948-1951), cit.: 21.
[9] Ivi: 32.
[10] Ivi: 48.
[11] Vd. Notizia, in Enzo Mazza, Gli inediti di Magalotti, Cittadella Veneta, Rebellato Editore, 1965: 75. Ne I vecchi e il vino (edito a Roma, presso la Società Anonima Poligrafica Italiana) i toponimi Asolo e Monfumo (sua frazione) ricorrono in complesso sette volte. Il primo informa anche il titolo Nel rivedere Asolo (in Enzo Mazza, Ciò che è stato, Roma, Quaderni di Marsia, 1960: 12)
[12] Enzo Mazza, Una stagione, Siena, Casa Editrice Maia, 1954.
[13] Ivi: 11.
[14] Ivi: 21.
[15] Ivi: 35.
[16] Ivi: 46.
[17] La citata Notizia acclusa a Gli inediti di Magalotti registra anche un assiduo lavoro, negli anni cinquanta, per il quotidiano «La Nazione», contributi, con poesie, saggi e recensioni, alle riviste «Il Ponte», «Galleria», «Poesia Nuova», «Nuova Antologia», «L’Osservatore Politico Letterario», «Letteratura», e la versione integrale dei Carmina di Catullo (apparsa da Guanda nel 1962).
[18] Ivi: 19 e 20-21.
[19] Ivi: 35.
[20] Enzo Mazza, 70 epigrammi, Caltanissetta – Roma, Sciascia, 1964.
[21] Ivi: 37, 47, 59.
[22] Gli inediti di Magalotti, cit.: 42.
[23] Ivi: 26.
[24] Enzo Mazza, Uno di questi giorni, con due incisioni di Bruno Carnevali, Roma, Quaderni di Marsia, 1973.
[25] Ivi: 61 (Nota).
[26] Ibidem.
[27] Ivi: 13 (a inizio della prima strofa del primo dei cinque momenti dell’epicedio): «Redivivo, dicevi | guardandomi con ironia (ma era stata di breve | durata la tua malattia)».
[28] Ivi: 36.
[29] Ivi: 54.
[30] Ivi: 55.
[31] Ivi: 57.
[32] Ivi: 32 (la prima delle quattro strofe).
[33] Enzo Mazza, Poeti, a cura di Bino Rebellato, Cittadella, 1980.
[34] Ivi: 37.
[35] Ivi: 39.
[36] Ivi: 12.
[37] Ivi: 32.
[38] Nella lirica XX di 33 poesie per Fabio (1987) l’autore ne evocherà il primo tentativo di stampa, effettuato proprio alle soglie di quel lutto: «Ricordi L’Invisibile? Volevo | liberarmene, ma | tra Cecina e Corneto non trovai, | in quella ferma aria d’estate, un solo | tipografo, uno disposto | a comporre le bozze di quei versi. | Volevo accelerare i tempi, | mi divorava un’ansia | febbrile, e poco dopo ne scoprii | il perché, più terribile d’ogni altro | colpo vibratomi con cieca | furia da un dio che non conosco».
[39] Nella breve notizia che accompagna le Poesie per Fabio (1987), la prima campata del ‘Canzoniere’.
[40] Poesie per Fabio, Casier (TV), Biblioteca cominiana, 1987; L’albero del niente, Città di Castello, Tibergraph Editrice, 1987; Nella calante oscurità, Città di Castello, Tibergraph Editrice, 1988; In fondo al corridoio, Città di Castello, Tibergraph Editrice, 1988; Gemito e tremore, Città della Pieve, Biblioteca cominiana, 1990; Ultimi frammenti, Città di Castello, Biblioteca cominiana, 1990; 33 poesie per Fabio, Città di Castello, Biblioteca Cominiana, 1991; L’ombra d’un sorriso, Città della Pieve, Biblioteca cominiana, 1992; Frammenti postumi, Città della Pieve, Biblioteca cominiana, 1994. Il corpus costituisce la seconda parte di Il canzoniere di Fabio e altre poesie (pp. 103- 478), da cui cito.
[41] Vd. l’introduzione di Silvio Ramat alla citata autoantologia Uno di questi giorni (p. 9).
[42] Nella poesia n. 50 di Lo splendido violino verde.
[43] Vd. Enzo Mazza, Uno di questi giorni (1973), cit.: 24.
[44] Nell’epigrafe di L’ombra d’un sorriso, in 12 poesie per Alceste Angelini (n. IV), nell’epigrafe e nella poesia n. XX di L’oscuro lembo, in Una vaga speranza (n. XXVI).
______________________________________________________________
Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999).
______________________________________________________________










