Fu circa tre anni fa, durante un convegno a Napoli, che un semiologo francese mi chiese cosa distinguesse gli antropologi dai sociologi. Come unico antropologo presente, mi presi la responsabilità di affermare che era l’etnografia, a fare la differenza. “Dunque, solo una questione di metodo”, rispose un po’ deluso il collega d’oltralpe, sostenendo che, dopotutto, anche i sociologi a volte facevano dell’etnografia, senza per questo diventare antropologi. Si tratta di un punto di vista molto diffuso, secondo il quale il metodo etnografico può essere estrapolato dalla sua disciplina d’origine e applicato come strumento in altri campi del sapere; non solo la sociologia, ma anche la psicologia sociale, la pedagogia, e perché no, la semiotica.
Tra gli insegnamenti dell’Università di Bologna ce n’è uno di etnosemiotica, peraltro molto interessante, in cui il suffisso “etno-” sta proprio per etnografia. Si può essere d’accordo o meno, ma è un dato di fatto che l’etnografia viene ormai largamente usata al di fuori della nostra disciplina. Tim Ingold si esprime con durezza nei confronti dei ricercatori sociali che fanno un simile uso dell’etnografia:
«Such a procedure, in which ethnographic appears to be a modish substitute for qualitative, offends every principle of proper, rigorous anthropological inquiry including long-term and open-ended commitment, generous attentiveness, relational depth, and sensitivity to context, and we are right to protest against it» (Ingold 2014: 384)
Sotto questo aspetto, l’antropologo scozzese è in linea con la rivendicazione mossa da Remotti nei confronti di certi “territori disciplinari” (Remotti 2014), dove la questione del metodo s’impone con forza. Non si tratta, ovviamente, di difendere a priori una sorta di “diritto d’esclusiva” che l’antropologia vanterebbe sulla ricerca etnografica. Proprio in quanto antropologi, sappiamo bene che ogni forma di sapere è cangiante, suscettibile di venire ripresa e trasformata continuamente da nuovi attori sociali. Piuttosto, si tratta di mettere a fuoco la specificità del rapporto tra antropologia ed etnografia, identificandone gli aspetti caratterizzanti. Un atteggiamento, questo, indispensabile per proteggersi dagli abusi retorici e ideologici dell’etnografia (Ingold 2014: 383), così come dall’estrapolazione acritica da parte di altre discipline.
Il volume pubblicato per Carocci, Storia dell’etnografia. Autori, teorie, pratiche (2020), si muove esattamente in questa direzione. Si tratta di un’opera collettiva, che propone diciassette diversi sguardi sull’approccio etnografico, ripercorrendone le origini, esplorandone le diramazioni e rivelandone gli aspetti più critici. Di questo libro è già uscita, pochi mesi fa, un’ottima recensione scritta da Francesca Scionti, sulle pagine dell’Archivio Antropologico Mediterraneo (n. 22, 2020). È interessante che, in questo momento di sospensione generale, si torni ad interrogarsi sulle modalità del far ricerca. Non tanto – e questo è apprezzabile – per proporre degli escamotage con cui superare l’ostacolo del lockdown, magari reinventandosi come etnografi digitali; bensì, per «riposizionare l’etnografia al centro della tradizione antropologica», sondandone potenzialità e limiti.
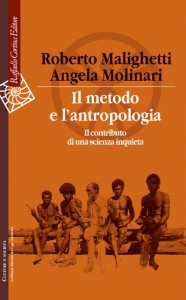 Il curatore, Vincenzo Matera, non è nuovo a questo tema, anzitutto per una questione d’esperienza: nella sua carriera ha condotto ricerche etnografiche nel Meridione d’Italia, in Indonesia, Africa Orientale e, più recentemente, a Milano. Professore ordinario in antropologia a Bologna, si è occupato spesso dei temi della memoria, dell’immaginario culturale e delle nuove forme di comunicazione, come i social media. Una costante del suo lavoro è l’attenzione alla scrittura etnografica e alle politiche della rappresentazione, che ritroviamo pienamente in quest’ultima curatela.
Il curatore, Vincenzo Matera, non è nuovo a questo tema, anzitutto per una questione d’esperienza: nella sua carriera ha condotto ricerche etnografiche nel Meridione d’Italia, in Indonesia, Africa Orientale e, più recentemente, a Milano. Professore ordinario in antropologia a Bologna, si è occupato spesso dei temi della memoria, dell’immaginario culturale e delle nuove forme di comunicazione, come i social media. Una costante del suo lavoro è l’attenzione alla scrittura etnografica e alle politiche della rappresentazione, che ritroviamo pienamente in quest’ultima curatela.
Diventa interessante far dialogare questo libro con quello, meno recente, di Roberto Malighetti e Angela Molinari (2016). I due autori si interrogavano allora sulla portata, sul valore e sulla ricaduta epistemologica dell’etnografia intesa come metodo. In sostanza, il loro volume ripercorre la storia della disciplina attraverso la lente del metodo etnografico, osservando come il sapere antropologico venga prodotto. Ciò che emerge – e che a mio avviso ritroviamo anche nel volume di Matera – è una costante oscillazione tra la necessità di possedere una metodologia e l’impossibilità di adottarne una pre-costituita, una tensione che risiede, in fondo, nelle stesse modalità della ricerca etnografica. Dal momento in cui l’antropologia prende le distanze dal metodo delle scienze naturali, impiegato durante le survey ottocentesche, la soggettività viene assunta come fondamento; per essere precisi, tutto ciò che segue costituisce il tentativo di addomesticare la soggettività del ricercatore, al fine di trasformare un’esperienza personale in sapere scientifico. Si capisce, dunque, perché la ricerca etnografica meriti e continui a meritare tutta l’attenzione degli antropologi.
Uno degli assunti cruciali del volume curato da Matera è il legame solidale tra etnografia ed elaborazione teorica (Scionti 2020), senza che con questo si voglia intendere una ethnographic theory (Ingold 2014). Pur nella difficoltà di definire l’approccio etnografico, possiamo elencare alcune caratteristiche di base: indipendentemente dal contesto e dall’oggetto di ricerca, l’etnografia è sempre contemporanea (Remotti 2014), circostanziata (Appadurai 1988) e incorporata (Malighetti & Molinari 2016: 187-247). Questi tre aspetti rimangono sullo sfondo in tutti i saggi di questo volume, elaborati da ciascun autore in modo personale, sia assumendoli in modo implicito, sia valutandone il diverso impatto sull’esperienza della ricerca. L’etnografia, e su questo Matera è chiaro fin da subito, non è un metodo; piuttosto un insieme di conoscenze operazionali e relazionali. Un sapere composito, accumulato nel tempo dagli antropologi e divenuto loro patrimonio comune, ma anche “tacito” (Polanyi 1979), raramente esplicitato sotto forma di protocolli o regole generali. Tuttavia, ciascun saggio di questo volume suggerisce che, sebbene la ricerca etnografica non sia un metodo, essa vada comunque condotta “con metodo”, se mi si concede il gioco di parole.
 Per la mia esperienza di lettore, una buona recensione, così come una buona etnografia, non deve limitarsi ad una pura descrizione. Chi recensisce, allo stesso modo dell’etnografo sul campo, deve assumersi la responsabilità del parlare per gli altri, presentando nel modo più corretto e fedele il loro pensiero, pur consapevole che, inevitabilmente, il risultato sarà tutt’altro che preciso. In linea con quanto detto, ho organizzato questa breve recensione come un percorso di lettura che si snoda tra i diciassette contributi, strutturato intorno a tre questioni focali. Anzitutto, la capacità dell’etnografia di “inflettere” (enfold) al suo interno pratiche e saperi provenienti sia dal contesto etnografico che da quello accademico. Per usare la terminologia di Ingold, la metodologia etnografica consiste in una serie di abilità (skill) applicabili all’ambiente di ricerca, e interagenti con esso. Viene poi la necessità di ricomporre le singole etnografie in un quadro analitico più ampio, contrastando il pericolo di “polverizzazione” descritto da Remotti (2014). Terzo punto, il problema della rappresentazione, ovvero la possibilità di poter/dover parlare per l’Altro. Si tratta di una rivendicazione al cuore stesso dell’antropologia, un tema peraltro già sottolineato da Scionti, ma che qui ho cercato di declinare in quanto espressione di potere.
Per la mia esperienza di lettore, una buona recensione, così come una buona etnografia, non deve limitarsi ad una pura descrizione. Chi recensisce, allo stesso modo dell’etnografo sul campo, deve assumersi la responsabilità del parlare per gli altri, presentando nel modo più corretto e fedele il loro pensiero, pur consapevole che, inevitabilmente, il risultato sarà tutt’altro che preciso. In linea con quanto detto, ho organizzato questa breve recensione come un percorso di lettura che si snoda tra i diciassette contributi, strutturato intorno a tre questioni focali. Anzitutto, la capacità dell’etnografia di “inflettere” (enfold) al suo interno pratiche e saperi provenienti sia dal contesto etnografico che da quello accademico. Per usare la terminologia di Ingold, la metodologia etnografica consiste in una serie di abilità (skill) applicabili all’ambiente di ricerca, e interagenti con esso. Viene poi la necessità di ricomporre le singole etnografie in un quadro analitico più ampio, contrastando il pericolo di “polverizzazione” descritto da Remotti (2014). Terzo punto, il problema della rappresentazione, ovvero la possibilità di poter/dover parlare per l’Altro. Si tratta di una rivendicazione al cuore stesso dell’antropologia, un tema peraltro già sottolineato da Scionti, ma che qui ho cercato di declinare in quanto espressione di potere.
La traiettoria
Accortomi dell’insoddisfazione del mio interlocutore, cercai di spiegare la differenza tra il metodo dei sociologi e l’etnografia degli antropologi paragonandoli ad un gruppo di agricoltori e di cacciatori-raccoglitori. Al di là della deformazione professionale sottesa da una simile metafora, il paragone era rivolto al diverso modo di ottenere sostentamento dall’ambiente. Lo spazio dell’agricoltura è uno spazio addomesticato e semplificato, in cui sono impiegate tecniche precise e sperimentate (es: irrigazione, aratura, semina) tese a controllare il maggior numero di fattori ambientali, al fine di ottenere una resa significativa. Il cacciatore-raccoglitore si muove al contrario in luoghi selvatici, densamente popolati, in cui i fattori ambientali sono troppo complessi da controllare, e con cui tuttavia occorre familiarizzare, imparando a conoscerli e sviluppando tecniche “su misura”, saperi specialistici, strumenti creati con materiali di quello stesso ambiente; col rischio, talvolta, di non ottenere nulla. Metafora decisamente rozza e imprecisa, ma che ho deciso di recuperare per descrivere un aspetto, a mio parere fondamentale, dell’etnografia. Consideriamo la costruzione di una freccia in questo ipotetico gruppo di cacciatori-raccoglitori: si tratta di uno strumento composito, ottenuto assemblando materiali presenti nello stesso ambiente in cui si caccia, come rami per l’asta, frammenti d’osso per la punta, e piume per l’impennata; ma non basta: occorre avere certe abilità per trasformare i singoli materiali in una freccia, e possederne altre per saperla utilizzare. Si tratta dunque di saperi contestuali e relazionali, inestricabilmente legati all’ambiente in cui vengono elaborati.

Esemplari di frecce conservate presso la collezione etnologica del Museo di Antropologia dell’Università del Missouri
Si pensi adesso al ruolo giocato nella storia dell’antropologia da certi “materiali nativi”, concetti come quello di totem, tapu o šaman. Al di là di tutti i possibili mea culpa post-coloniali, di tutte le appropriazioni coloniali, di tutti i retroscena à la Leiris, rimane il fatto che queste categorie hanno influenzato in modo determinante la disciplina. La specifica abilità dell’etnografo sta, a mio avviso, nella sua capacità di saper creare simili strumenti di ricerca attraverso l’introiezione di determinati aspetti del proprio fieldwork. Proseguendo con la metafora, le nostre azioni sul campo costituiscono ciò che Ingold chiama task, ovvero «any practical operation, carried out by a skilled agent in an environment, as part of his or her normal business of life. In other words, tasks are the constitutive acts of dwelling» (Ingold 2011: 195). Sono diversi i saggi presenti in questo volume che dimostrano una simile potenzialità insita nell’etnografia, quella cioè di inflettere al proprio interno certi aspetti del campo, sia come modalità generale di approccio all’alterità, sia come tentativo di risolvere specifiche problematiche presentate dal contesto.
Iniziamo dai due contributi di Enzo Alliegro e Gabriella D’Agostino, che hanno per giunta il merito di decostruire il mito di Malinowski, presentato ancora nella manualistica come “l’antenato totemico” della ricerca etnografica. Alliegro in particolare ci mostra una genesi alternativa per l’etnografia, concentrandosi sulle ricerche etnologiche americane condotte sotto l’egida del Bureau of American Ethnography. Per questi antropologi l’etnografia costituisce un modo per cogliere la vita culturale altrui attraverso un intenso assorbimento, per quanto parziale e temporaneo, di quelle modalità di vita. Nell’esperienza etnografica di Cushing, l’accesso all’alterità non si ottiene attraverso una mimesi completa, provando a “diventare nativi”, ma convivendo sistematicamente con loro, introiettando particolari modalità d’esistenza umana attraverso l’etnografia. Ritroviamo un simile approccio anche in Boas, nei termini di una “torsione dell’esperienza” prodotta proprio dal convivere e condividere.
Gli etnografi entrano “in corrispondenza” con gli altri, per citare la bella espressione di Ingold ripresa da Gabriella D’Agostino nel proprio saggio, nel quale incontriamo nuovamente dei ricercatori americani alle prese stavolta con originali applicazioni dell’osservazione partecipante. Ci troviamo in un periodo in cui il retaggio di Malinowski è stato ben metabolizzato, e in cui l’osservazione partecipante si è ormai imposta come principale strumento a disposizione dell’antropologo, a dispetto delle sue criticità. Nonostante ciò, l’esperienza della Scuola di Chicago mostra come l’etnografia possa venire rimodellata, combinandosi in modo originale con approcci (interazionismo simbolico) e concetti (community). La tensione tra osservazione e partecipazione viene “risolta” dai ricercatori della Scuola impiegando la propria soggettività (biografie, background, interessi) per entrare in corrispondenza con il contesto di ricerca, prima che con le singole persone.
The Hobo di Nels Anderson nasce proprio dalla capacità di questo sociologo di impiegare la propria esperienza di vagabondo per cogliere, come etnografo, quel contesto culturale. La sua storia di vita ha condizionato non solo il suo posizionamento sul campo, ma finanche la sua corporeità. Come anticipato in apertura, uno dei punti fermi dell’etnografia è proprio il suo carattere incorporato. Il saggio di Ivo Quaranta mette in luce precisamente questo aspetto, considerando il corpo sia come un filtro culturale, sia come mezzo espressivo della soggettività nel mondo, sia infine come strumento di ricerca. Non solo il corpo è incarnato nel mondo, ma questo posizionamento – inteso come una specifica configurazione dell’esistenza umana – influisce sulle possibilità d’azione nell’ambiente in cui si trova (affordance); in altre parole genere, emozioni, fisicità, abilità, sono tutti aspetti che condizionano la ricerca, in quanto predeterminano un campo di possibilità entro cui l’etnografo può muoversi e agire nel fieldwork. La dimensione incorporata dell’etnografia ne segna anche il limite, rendendo ogni ricerca inevitabilmente incompleta. Per cercare di superare questo scacco si può optare per diverse strategie, come la narrazione corale, il lavoro d’equipe o, più spesso, il ricorso a mediatori privilegiati tra il ricercatore e il fieldwork.
Una delle relazioni più importanti nell’ambito etnografico è quella tra antropologo e “informatore”, termine un po’ desueto per riferirsi ad un’ampia ed eterogenea platea di collaboratori. Nonostante venga talvolta presentata come una relazione paritaria, non lo è mai, dato che si fonda necessariamente su delle asimmetrie: di potere, di saperi, di interessi. Tuttavia, questo non esclude che il rapporto tra etnografo e “informatore” si basi sulla fiducia e il rispetto reciproco, che anzi sono condizioni fondamentali per la collaborazione. L’approccio di Griaule si fonda, di fatto, su un’esasperazione del sospetto nei confronti dell’altro; siamo ben lontani da Clara Gallini e dalla sua Intervista a Maria. In proposito, il saggio di Angela Biscaldi e Vincenzo Matera offre un’interessante retrospettiva sulle tecniche dell’inchiesta orale di Marcel Griaule. Tanto esplicite quanto disilluse, queste brevi riflessioni mettono non solo a fuoco lo statuto epistemologico dell’informatore nella nascente etnografia francese, ma sottintendono tutta una serie di tattiche, diversivi, e stratagemmi per ottenere informazioni veritiere. Per Griaule, il collaboratore indigeno tende a mentire, distorcendo una realtà che solo il lavoro “poliziesco” dell’etnografo può permettere di ricostruire. Riprendendo la metafora iniziale, la tecnica etnografica di Griaule occupa il polo estremo della modalità predatoria, in cui il ricercatore usa l’altro per ottenere informazioni. Da ciò, la problematica rappresentazione del pensiero Dogon da parte di Griaule, la cui costruzione è legata proprio a questa strategia cinica della raccolta dati.
Ben diversa è la modalità con cui Ernesto de Martino e la sua equipe hanno condotto la loro ricerca nel Meridione. Giovanni Pizza si sofferma a lungo sull’aspetto inter-disciplinare dell’etnografo napoletano, la cui eredità – specie il suo lato politico – è ripresa più volte nelle 450 pagine del volume. Per Pizza, l’approccio di de Martino alla ricerca etnografica esemplifica gli aspetti di quello che è stato definito Fieldwork Italian Style. Nel lavoro d’equipe delle famose survey degli anni Cinquanta, l’assemblaggio dei saperi durante la ricerca è già presente in nuce nello sguardo antropologico di de Martino, che è esso stesso inter-disciplinare. In questo senso, l’interdisciplinarità come capacità di inflettere altri saperi accademici rappresenta solo un caso specifico della più ampia capacità etnografica nei confronti di qualunque sapere “altro”. Negarlo significherebbe, come sostiene Ingold (2014: 386), reiterare una distinzione qualitativa tra mondo accademico e mondi “etnografabili”. Pizza rivolge la sua attenzione al particolare “focus della comprensione” che rende efficace il lavoro d’equipe, che de Martino descrive come prospettiva centrale capace d’integrare i singoli contributi, superando le differenti specializzazioni.
Questo focus è applicabile non solo al dialogo inter-disciplinare, ma anche a quello infra-disciplinare, cercando di accordare tra loro singole ricerche etnografiche altrimenti scollegate. Una possibilità, questa, che se portata all’estremo conduce a quel «rischio di polverizzazione disciplinare» da cui ci mette in guardia Remotti: «invece di elaborare punti di vista e mettere alla prova concetti e prospettive teoriche, si assiste all’uso di nozioni che balzano da uno scritto all’altro senza un tentativo serio di collaudo […] Si forma cioè una patina di superficie, sotto la quale si intravedono piuttosto nitidamente i rischi di polverizzazione, dispersione, dissoluzione» (Remotti 2014: 58-59). D’altronde, questo è il rischio che corre l’antropologia come sapere della contemporaneità, inevitabilmente calato qui, ora e con questo corpo (ivi: 93). La polverizzazione disciplinare è un problema percepito come tale solo recentemente, dato che per la maggior parte della sua storia l’antropologia si è dotata di strutture teoriche in cui (o da cui) comprendere le varie ricerche etnografiche.
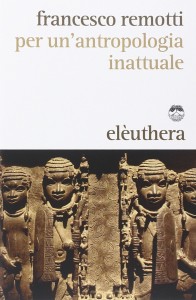 Alessandro Mancuso ricostruisce un attento spaccato su uno di questi periodi, trattando dei contrasti tra Radcliffe-Brown, Malinowki ed Evans-Pritchard intorno alla validità dei rispettivi approcci antropologici. Non si tratta dell’ennesima pagina di storiografia della disciplina, ma di una lezione importante su un momento chiave per l’elaborazione dell’etnografia come metodologia. È curioso che questo momento “genetico” per l’antropologia verta proprio sui principi organizzativi e classificatori delle strutture di parentela, cioè sulla possibilità di mettere potenzialmente in relazione qualunque contesto etnografico. Teorizzazioni di questo genere, con simili pretese universalizzanti, possono sembrarci oggi fuori luogo o frutto di aride riflessioni proiettate sulla realtà. Al contrario, il pregio di questo saggio sta nella sua capacità di evidenziare il ruolo giocato in tutto ciò dalla ricerca etnografica, che ha portato finanche lo stesso Radcliffe-Brown a scegliere intenzionalmente certi contesti per “testare” le proprie teorie. Al di là dei contrasti, intravediamo nel dibattito di questo periodo la volontà di stabilire delle interconnessioni valide, fondate sul lavoro di campo. Tornando al presente, Mancuso sottolinea paradossalmente la difficoltà di integrare un bagaglio condiviso di riferimenti teorici con una metodologia etnografica critica.
Alessandro Mancuso ricostruisce un attento spaccato su uno di questi periodi, trattando dei contrasti tra Radcliffe-Brown, Malinowki ed Evans-Pritchard intorno alla validità dei rispettivi approcci antropologici. Non si tratta dell’ennesima pagina di storiografia della disciplina, ma di una lezione importante su un momento chiave per l’elaborazione dell’etnografia come metodologia. È curioso che questo momento “genetico” per l’antropologia verta proprio sui principi organizzativi e classificatori delle strutture di parentela, cioè sulla possibilità di mettere potenzialmente in relazione qualunque contesto etnografico. Teorizzazioni di questo genere, con simili pretese universalizzanti, possono sembrarci oggi fuori luogo o frutto di aride riflessioni proiettate sulla realtà. Al contrario, il pregio di questo saggio sta nella sua capacità di evidenziare il ruolo giocato in tutto ciò dalla ricerca etnografica, che ha portato finanche lo stesso Radcliffe-Brown a scegliere intenzionalmente certi contesti per “testare” le proprie teorie. Al di là dei contrasti, intravediamo nel dibattito di questo periodo la volontà di stabilire delle interconnessioni valide, fondate sul lavoro di campo. Tornando al presente, Mancuso sottolinea paradossalmente la difficoltà di integrare un bagaglio condiviso di riferimenti teorici con una metodologia etnografica critica.
Su questo aspetto, Marco Gardini e Luca Rimoldi guardano con favore all’analisi situazionale come strumento di ricerca. Ripercorrendo le ricerche del Rhodes-Livingstone Institute, i due autori mettono bene a fuoco l’ampia portata di questa tecnica etnografica. Sebbene costituisca un’indagine puntuale su fenomeni precisi, l’analisi situazionale permette di illuminare in modo estensivo la rete soggiacente di dinamiche interconnesse; da qui, la duplice declinazione di questo strumento etnografico, come extendend case method e network analysis. La ricerca, dunque, non rimane isolata al singolo caso, ma rimanda costantemente ad un panorama di processi più ampio. Non si tratta di un ampliamento di tipo teorico, bensì contestuale, che ha condotto gli etnografi del Rhodes-Livingstone Institute verso nuove possibilità d’indagine e di riflessione, contribuendo in modo decisivo a cambiare, aumentandola, la scala d’applicazione dell’antropologia sociale.
Un problema speculare all’accordare tra loro singole ricerche nello stesso posto è quello di dare coerenza e rigore ad un’unica ricerca multi-situata. Bruno Riccio dedica il suo contributo proprio a questo tema, evidenziando tutta la complessità che si cela dietro le “circostanze” del campo, che per quanto siano sempre localizzate e contemporanee, possono essere strutturate attraverso spazi, tempi e relazioni distribuite in modo diffuso, anziché puntuale. Il viaggio è un elemento centrale per ogni etnografia, ma nell’etnografia multi-situata passa dall’essere un semplice topos narrativo (o, al più, un momento di transito verso il campo) al diventare uno strumento fondamentale per seguire e successivamente ricostruire le complesse interconnessioni di fenomeni come le rotte migratorie.
La ricerca multi-situata ha un importante momento di teorizzazione e applicazione con la cosiddetta svolta post-moderna, di cui Writing cultures può considerarsi uno dei testi più importanti. Ripercorrendo questo libro/manifesto, Alessandro Simonicca analizza una sotto-trama specifica del lavoro di George Marcus, legata a doppio filo alla sociologia weberiana. In particolare, Simonicca si sofferma sulla bounded rationality, con cui il sociologo tedesco cerca di «inserire inserti generalizzanti dentro la dimensione ideografica della storia». Dunque, di nuovo il tentativo di inquadrare casi empirici dei più disparati all’interno di una griglia interpretativa dotata di principi organizzativi. Marcus rielabora tutto questo stabilendo una relazione circolare tra campo, etnografia e teoria, proponendo un theory work che non si esaurisce nella singola ricerca, ma continua a ripetersi su scale differenti, rimandando di fatto la fine dell’etnografia. L’originale proposta di Marcus consiste nel passare da singole realtà ad una oggettivazione rigorosa delle connessioni, attraverso un movimento a spirale che man mano intercetta una dimensione etnografica sempre più ampia.
Finora ci siamo concentrati sul primo senso del termine “etnografia”, ovvero il condurre una ricerca di campo. Con i prossimi saggi ci avvicineremo di più al senso significato, quello cioè di scrivere un’etnografia. A metà tra uno e l’altro, sta il problema cui accennavamo in apertura, ovvero il poter/dover rappresentare l’alterità. La questione della rappresentatività si pone con particolare forza in antropologia, specie nel contesto contemporaneo. Un esempio interessante è quello dall’etnografia multi-specie, in cui la ricerca si situa nelle zone di contatto, frizione o rottura della classica dicotomia natura/cultura. In questa forma di etnografia, il riconoscimento della soggettività di esseri non-umani pone il problema di come si possa parlare per essi. La questione si ripropone in forma più estesa per tutta l’antropologia che, come nota Appaudari, «survives by its claim to capture other places (and other voices) through its special brand of ventriloquism. It is this claim that needs constant examination» (Appadurai 1988: 20). La questione della rappresentatività rimane comunque una questione di potere, e delle sue distribuzioni asimmetriche all’interno delle relazioni di campo (ibidem).
Ritroviamo tutto ciò nel contributo di Fabio Dei, che ritorna proprio sulla svolta post-moderna presentata da Simonicca (e in realtà, anche su svolte più recenti) con una retrospettiva critica. Pur riconoscendo il merito di autori come Marcus, Clifford e degli altri protagonisti di questa fase, la maggior criticità di Writing culture sta proprio nella pretesa di esporre i “puri fatti”, enfatizzando la ricerca come esperienza personale irriducibile e l’auto-riflessione. Le premesse di questa proposta teorica stanno nella particolare ricezione della French Theory nel contesto accademico statunitense, che focalizzò l’attenzione dei ricercatori sulle politiche identitarie; come sottolinea Dei, nel quadro europeo la questione identitaria sottendeva tutt’altro tipo di implicazioni culturale. La svolta post-moderna, nel suo tentativo di restituire una voce più autentica all’altro, si rese soggetta alle medesime “ossessioni” che imputava all’ermeneutica di Geertz. Per di più, il tentativo di annullare l’autorialità dell’etnografo a favore di un discorso corale o di storie di vita, non eliminava comunque la relazione asimmetrica tra ricercatore e “nativo”. Il rispettivo posizionamento sociale nel fieldwork continuava a rimanere intatto, dietro l’enfasi testuale.
L’approccio etnografico di Bourdieu si fonda essenzialmente su questo riconoscimento, come ci mostra il saggio di Ferdinando Fava. Il sociologo francese guarda con estremo scetticismo al linguaggio e alla dimensione dialogica tanto enfatizzata da Marcus o dai coniugi Tedlock: nell’esperienza maturata da Bourdieu nei contesti coloniali dialogo e linguaggio diventano anzi veicolo di violenza strutturale. La rappresentazione dell’altro si basa perciò sulla ricostruzione dell’agire interpersonale, combinando etnografia e analisi statistica. L’individuo epistemico, insieme di posizioni sociali e dinamiche interpersonali, viene preferito all’uomo empirico, ad una mutevole soggettività dietro la quale si celano relazioni di potere e rapporti socio-economici. Per poter parlare dell’altro, l’etnografo deve anzitutto sapersi mettere al suo posto, decentrandosi temporaneamente per cogliere quelle relazioni e quelle dinamiche che il proprio posizionamento – mai neutrale – non può comprendere. Un’operazione complessa, dai tratti insospettatamente “spirituali”, che si avvantaggia di mezzi come la fotografia, privata però di ogni “illusione di immediatezza”.
Le potenzialità rappresentative di questo mezzo espressivo, e più in generale del paradigma visuale, sono ben analizzate da Francesco Faeta, che non a caso fa riferimento al lavoro di Bourdieu e all’occasione di riflessione data dalle foto. La fotografia rappresenta una sorta di sguardo per procura bloccato nel tempo, una registrazione complessa e intenzionale non a caso usata spesso come metafora dell’etnografia (“fotografare un contesto”). Soffermandosi su questo carattere intenzionale e riflessivo, Faeta nota acutamente come l’etnografia visuale dica molto più dei nostri modi di guardare, dei processi che costruiscono culturalmente lo sguardo del ricercatore, che non della “realtà” che guardiamo; una dimensione riflessiva della visualità nella pratica etnografica, che nell’atto di guardare l’altro torna a “riguardarci” come ricercatori.
Certo, una ricerca non è fatta solo di sguardi e immagini, ma anche di parole: per i coniugi Tedlock, l’elemento dialogico costituisce il cuore del lavoro di campo. Angela Biscaldi ricostruisce i loro tentativi di elaborare le narrazioni orali come strumento fedele di (auto)rappresentazione. Ogni etnografo ha sperimentato i limiti di trascrizioni e registrazioni, che inevitabilmente finiscono per escludere tutta una serie di sfumature qualitative e contestuali. La proposta di Dennis e Barbara Tedlock mirava a reintrodurre parte di questa dimensione negata, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore autenticità nella rappresentazione dell’altro. Tuttavia, l’uso del dialogo, di modalità corali o co-autoriali per costruire una sorta di “mondo terzo” rischia, come nota giustamente Biscaldi, di restituire un’immagine irreale dei rapporti tra ricercatore e nativo, nello stesso modo in cui la fotografia dà l’illusione di cogliere una realtà oggettiva del contesto.
La scelta di dare voce o visibilità, per ritornare su questi due paradigmi sensoriali, non implica necessariamente una restituzione più autentica o una rappresentazione più aderente dell’alterità. L’autorialità dell’etnografo è ineliminabile al pari della sua corporeità, o delle sue relazioni di potere nel campo: l’etnografia non è una pratica compiuta per caso o per sbaglio, ma sottintende una precisa intenzione da parte del ricercatore, e che nello scrivere lo trasforma in autore. È importante che questa autorialità non sommerga la voce altrui, di coloro con i quali la ricerca è condotta, ma è altrettanto importante ricordare che non potremmo mai rinunciare a questa responsabilità. Tuttavia, che cosa accade quando questa pretesa di parlare per l’altro viene messa in scacco? Questi ultimi tre saggi esplorano diverse situazioni di invisibilità relativa, speculare per certi versi a quell’eccesso di visibilità di cui abbiamo parlato finora.
 Il contributo di Alice Bellagamba si sofferma sulla silenziosa assenza nel lavoro di Balandier delle forme di schiavitù in Africa. Non si tratta certo di un aspetto secondario nel contesto coloniale congolese: parte integrante delle strutture socio-economiche locali, abolita solo formalmente dal governo coloniale, la schiavitù verrà successivamente rimodulata nel sistema politico della Repubblica del Congo. Per Bellagamba, è proprio la visione progressista di Balandier, unita ad una certa immaturità della disciplina, all’origine del mancato riconoscimento del ruolo di schiavi, liberti e dei loro discendenti nell’assetto coloniale e post-coloniale. L’unica forma di rappresentazione di questi attori sociali è indiretta, comparendo per contrasto tra i vuoti delle etnografie dell’epoca. Nel contesto post-coloniale la relazione con questo retaggio storico continua ad essere problematico, un dark heritage che tuttavia rischia di mettere in ombra non solo fenomeni cruciali del passato, ma anche certe dinamiche contemporanee della post-schiavitù.
Il contributo di Alice Bellagamba si sofferma sulla silenziosa assenza nel lavoro di Balandier delle forme di schiavitù in Africa. Non si tratta certo di un aspetto secondario nel contesto coloniale congolese: parte integrante delle strutture socio-economiche locali, abolita solo formalmente dal governo coloniale, la schiavitù verrà successivamente rimodulata nel sistema politico della Repubblica del Congo. Per Bellagamba, è proprio la visione progressista di Balandier, unita ad una certa immaturità della disciplina, all’origine del mancato riconoscimento del ruolo di schiavi, liberti e dei loro discendenti nell’assetto coloniale e post-coloniale. L’unica forma di rappresentazione di questi attori sociali è indiretta, comparendo per contrasto tra i vuoti delle etnografie dell’epoca. Nel contesto post-coloniale la relazione con questo retaggio storico continua ad essere problematico, un dark heritage che tuttavia rischia di mettere in ombra non solo fenomeni cruciali del passato, ma anche certe dinamiche contemporanee della post-schiavitù.
Patrizia Resta si occupa di un’altra zona d’ombra, in cui stavolta il riconoscimento e la rappresentazione di certi attori viene impedita proprio dagli stessi e dalla problematicità del contesto. Il saggio di Resta si sofferma infatti sui sistemi di corruzione, fenomeni strettamente legati alla vita degli Stati e alle dinamiche sommerse del potere, e sulle società mafiose, colte come complesse reti transnazionali. Si tratta di questioni situati palesemente nell’extra-legalità, e pertanto particolarmente difficili da avvicinare per l’etnografo. Al netto di una metodologia di ricerca ancora impreparata per un tale confronto, Resta mette in luce tutta la problematicità dei rapporti di potere nel fieldowork: in che modo è possibile coinvolgere e rappresentare l’altro, quando questi si situa in territori extra-legali? In che misura l’etnografo può lasciarsi coinvolgere, o addirittura partecipare, in questi ambiti? Simili domande bastano a sfatare il mito che vuole il ricercatore sempre in posizione di superiorità e di vantaggio, rivelando invece la sua fragilità in certi contesti.
Continuando con le zone d’ombra della rappresentazione etnografica, Michela Fusaschi si interroga sull’assenza di un’antropologia di genere in Italia, questione che inserisce nel dibattito ben più ampio dei gender studies. L’analisi di Fusaschi non rimane limitata alla storia della disciplina, ma ricostruisce un discorso esteso alla società civile italiana comprendendo anche dinamiche extra-accademiche. Le modalità con cui, ad esempio, il pensiero femminista è giunto in Italia e con cui si è diffuso, non sono indifferenti: quasi paradossalmente, durante gli anni Sessanta è stato una parte di questo movimento che ha contribuito a rallentare, quando non marginalizzare, il costituirsi di un’antropologia di genere. Tuttavia, l’aspetto a mio avviso più interessante del saggio è l’originalità con cui le antropologhe italiane, ricercatrici come Amalia Signorelli o Clara Gallini, hanno affrontato le questioni di genere, pur esprimendo atteggiamenti diversi nei confronti del pensiero femminista.
Concludiamo questo rapido percorso con il saggio finale di Vincenzo Matera, che affronta direttamente la questione politica nell’antropologia, una dimensione a lungo rimossa. Matera dimostra come relazioni asimmetriche e squilibri di potere non siano condizioni occasionali o contingenti del campo, ma vanno al contrario riconosciute come parte integrante di ogni contesto di ricerca. L’approccio di de Martino è emblematico di questo riconoscimento, avendo introdotto strutturalmente una componente politica nella stessa etnografia, attraverso il pensiero di Gramsci. Non come un filtro interpretativo rigido, ma al contrario adattando il marxismo alla specifiche condizioni etnografiche. Fare altrimenti avrebbe significato ridurre la rappresentazione del Meridione e delle sue comunità a nient’altro che una categoria astorica, l’ennesima variabile dipendente di un’equazione socio-economica. Questa capacità di de Martino – e in realtà tratto comune del Fieldwork Italian Style – di inflettere criticamente il pensiero politico di Gramsci riconferma quella qualità specifica dell’etnografia, di costituirsi relazionalmente e contestualmente.
Complessivamente, i saggi di questo volume parlano dell’approccio etnografico nell’unico modo sensato per farlo: in modo incompleto. Ciò non significa, si badi, in modo approssimativo o superficiale, ma che l’etnografia è qualcosa che non potrà mai dirsi definitivo, mai concluso, mai completamente regolare e, in questo senso, mai davvero un metodo. L’etnografia è un progetto aperto, di cui questi diciassette autori segnano le differenti origini, possibilità e limiti del suo sviluppo. Soprattutto, è un progetto aperto all’alterità, non solo perché in dialogo con essa, ma perché da questo dialogo esce ogni volta un po’ trasformata. Compito – affatto facile – dell’antropologia il tenere viva questa dimensione creativa dell’etnografia. Con tre anni di ritardo, sarò felice di consigliare questo volume al mio amico semiologo.
Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021
Riferimenti bibliografici
Appadurai, Arjun, 1988, “Introduction: Place and Voice in Anthropological Theory”, Cultural Anthropology 3(1): 16-20.
Ingold, Tim, 2011, The perception of the environment, London/New York: Routledge.
Ingold, Tim, 2014, “That’s enough about ethnography!”, HAU: Journal of Ethnographic Theory 4(1): 383-395.
Malighetti, Roberto, Molinari, Angela, 2016, Il metodo e l’antropologia. Il contributo di una scienza inquieta, Milano: Raffaello Cortina Editore.
Matera, Vincenzo (a cura di), 2020, Storia dell’etnografia. Autori, teorie, pratiche, Roma: Carocci.
Polanyi, Michael, 1979, La conoscenza inespressa, Roma: Armando.
Remotti, Franceso, 2014, Per un’antropologia inattuale, Milano: Elèuthera.
Scionti, Francesca, 2020, “Vincenzo Matera (a cura di), Storia dell’etnografia. Autori, teorie, pratiche”, in Archivio Antropologico Mediterraneo 22(2).
______________________________________________________________
Nicola Martellozzo, dottorando presso la Scuola di Scienze Umane e Sociali (Università di Torino), negli ultimi due anni ha partecipato come relatore ai principali convegni nazionali di settore (SIAM 2018; SIAC 2018, 2019; SIAA-ANPIA 2018). Con l’associazione Officina Mentis conduce un ciclo di seminari su Ernesto de Martino in collaborazione con l’Università di Bologna. Ha condotto periodi di ricerca etnografica nel Sud e Centro Italia, e continua tuttora una ricerca pluriennale sulle “Corse a vuoto” di Ronciglione (VT).
______________________________________________________________








