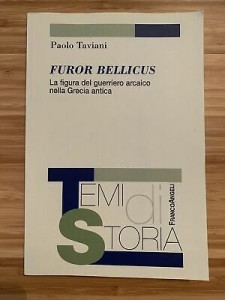di Antonello Ciccozzi
Piani narrativi in conflitto e etnocentrismi geopolitici
Raccolgo e rielaboro qui una serie di riflessioni sulle rappresentazioni della guerra in Ucraina che ho pubblicato in ambito divulgativo (mediatico e social) durante i primi tre mesi del conflitto. Il tema di fondo è quello del rischio antropologico del riemergere di una concezione dello Stato nazionale come “società guerriera” in seno alla postmodernità occidentale; questo a partire dal riaffermarsi dell’estetica etno-nazionalista moderna del morire per la patria, della difesa dell’identità, della bandiera, del confine, come corollario necessario di una poetica del fronte, di lotta armata contro l’invasore che antepone questi valori a quelli dell’esistenza individuale, della ricerca soggettiva di una buona vita.
Una questione da evidenziare subito è che alla guerra delle armi corrisponde una guerra delle narrazioni. In fondo la cosa è abbastanza ovvia, meno ovvio però è che il web ha conferito una rilevanza inedita alla guerra delle narrazioni: quello in atto in Ucraina è il primo conflitto armato che si combatte anche nel metaverso, dove internet si configura non solo come un luogo virtuale di rappresentazione delle ostilità ma anche come un campo di battaglia in cui il reale non solo si rappresenta ma si costruisce. Si costruisce attivamente in uno schieramento di parte sia richiesto che ostentato, e in una guerra del consenso alla guerra, tra la meta-tribù dei sostenitori dell’Ucraina in linea con le politiche egemoniche atlantiste, e quella degli altri, politicamente subalterni e variamente accusati di addobbare di pacifismo posticcio sentimenti filo-putiniani e anti-occidentali.
A differenza di tanti conflitti postmoderni – che dalla prima guerra in Iraq in poi sono stati raccontati con attenta parsimonia rispetto ad errori ed orrori, sangue e distruzioni – il male di questa guerra si è fatto immediatamente infodemia che per tre mesi ha monopolizzato il senso comune occidentale attraverso un bombardamento mediatico a tappeto. Dopo la pandemia Covid-19 questa guerra è diventata un “fatto sociale totale globale” (un fatto sociale che condiziona tutti gli aspetti del vivere e lo fa su una scala planetaria); e, se da un paio di settimane si assiste a un calo di copertura mediatica, le ostilità sembrano lontane dal cessare. Al momento siamo in uno scenario che forse sarebbe il caso di definire in termini di “prima guerra glocale” (ossia di conflitto globale combattuto localmente, in quanto circoscritto in Ucraina) che rischia di diventare la Terza guerra mondiale, con il rischio aggiunto e varie volte annunciato di un olocausto nucleare che avrebbe esiti apocalittici.
In questa dinamica in cui il piano rappresentazionale tende sempre più a fabbricare quello reale, nella guerra di narrazioni ciascuna posizione rivendica da entrambi i lati del fronte un monopolio assoluto di attinenza al reale, presentando il suo racconto di guerra come marchio di verità, e derubricando a costrutto propagandistico arbitrario la narrazione della controparte. Sicché, quella che da Ovest viene raccontata come un’invasione dai connotati nazisti, messa in atto dall’autocrazia russa contro la nazione ucraina sovrana e democratica, vista da Est diventa un’operazione di difesa di minoranze perseguitate da otto anni dal governo dell’Ucraina, una nazione che viene immaginata come una reincarnazione del nazismo, rea di un separatismo imperialisticamente fomentato dall’Occidente che minaccerebbe alla radice l’essenza della Russia, rendendo l’intervento militare una necessità vitale e inevitabile. Pena la perdita della libertà (coniugata in due concezioni assolutamente contrapposte) per i russi non si poteva evitare l’intervento armato contro l’Ucraina, mentre per gli ucraini non si può evitare la resistenza amata, che per gli occidentali non si può evitare di armare.
 In questo modo la guerra è diventata l’unica opzione possibile, una necessità imprescindibile che obbedisce alla strategia descritta dall’acronimo T.I.N.A. (there is no alternative). Ognuna delle due parti in causa vede nell’altra il male assoluto, e lo fa a partire dall’uso ideologico del conio retrotopico della reductio ad hitlerum del nemico. Il paragone con Hitler e il nazismo è un atto noumenico che sottende un’operazione analogica in cui gli eventi in corso vengono tradotti su un piano fenomenico dato da una realtà passata dove la storiografia ha stabilito che effettivamente bene e male, ragioni e torti, vittime e carnefici erano separati totalmente, dove è pacifico che non ci può essere nessuna posizionalità, prospetticità o relativismo, e che non vi poteva essere altra soluzione che la risposta violenta ed eliminatoria rivolta contro la violenza di un tiranno assoluto che non aveva solo mire di conquista ma perseguiva finalità eliminatorie genocidarie. Hitlerizzare il nemico definisce in tal modo un panorama assiologico dualistico del tutto manicheo che dispone al si vis pacem para bellum. Proprio questo paradossale e anche grottesco essere “ognuno l’Hitler dell’altro” è il dispositivo retorico che delinea una cornice in cui due etnocentrismi geopolitici – opposti e complementari – raccontano due versioni della realtà del tutto incompatibili, dove il “noi” è santificato e “altro” viene demonizzato, dove pare impossibile la comprensione di un piano di realtà che possa in qualche misura relativizzare ragioni e torti, comprendere e riconoscere che sono in lotta due nebulose di motivazioni emiche del tutto autocentrate e chiuse in una relazione di disconoscimento reciproco.
In questo modo la guerra è diventata l’unica opzione possibile, una necessità imprescindibile che obbedisce alla strategia descritta dall’acronimo T.I.N.A. (there is no alternative). Ognuna delle due parti in causa vede nell’altra il male assoluto, e lo fa a partire dall’uso ideologico del conio retrotopico della reductio ad hitlerum del nemico. Il paragone con Hitler e il nazismo è un atto noumenico che sottende un’operazione analogica in cui gli eventi in corso vengono tradotti su un piano fenomenico dato da una realtà passata dove la storiografia ha stabilito che effettivamente bene e male, ragioni e torti, vittime e carnefici erano separati totalmente, dove è pacifico che non ci può essere nessuna posizionalità, prospetticità o relativismo, e che non vi poteva essere altra soluzione che la risposta violenta ed eliminatoria rivolta contro la violenza di un tiranno assoluto che non aveva solo mire di conquista ma perseguiva finalità eliminatorie genocidarie. Hitlerizzare il nemico definisce in tal modo un panorama assiologico dualistico del tutto manicheo che dispone al si vis pacem para bellum. Proprio questo paradossale e anche grottesco essere “ognuno l’Hitler dell’altro” è il dispositivo retorico che delinea una cornice in cui due etnocentrismi geopolitici – opposti e complementari – raccontano due versioni della realtà del tutto incompatibili, dove il “noi” è santificato e “altro” viene demonizzato, dove pare impossibile la comprensione di un piano di realtà che possa in qualche misura relativizzare ragioni e torti, comprendere e riconoscere che sono in lotta due nebulose di motivazioni emiche del tutto autocentrate e chiuse in una relazione di disconoscimento reciproco.
Nello specifico, l’orizzonte mainstream occidentale politico e mediatico si è schierato, con gli USA e la NATO alla guida, immediatamente e in modo pressoché totale dalla parte dell’Ucraina e contro la Russia, poggiando una politica di alleanza – data dal sostegno economico e militare con un continuo invio di armi all’Ucraina – sulla narrazione del conflitto incardinata sull’unico piano dato dal solenne assioma, ripetuto ogni giorno e in ogni dove come un mantra, per cui “c’è un invaso e un invasore”. Tale visione è ben rappresentata dallo statement ufficiale della NATO [1], che racconta una conflittualità iniziata improvvisamente il 24 febbraio 2022, con un attacco del tutto immotivato della Russia contro l’Ucraina, descritta come una pacifica democrazia. Questo separa il bene e il male al 100% in piena aderenza a uno schema archetipico dualistico-manicheo che distingue nettamente le ragioni e i torti, i “buoni” (gli ucraini, e noi loro alleati) dai “cattivi” (i russi, e chi non li maledice come tali), e li declina in termini di lotta della democrazia contro la dittatura. Il tutto porta a una polarizzazione del senso comune tra uno schieramento giusto – quello a favore dell’invio di armi in Ucraina al fine di infliggere alla Russia una sconfitta umiliante – che complementarmente taccia di empietà filo-putiniana qualsiasi posizionamento di neutralità non interventista.
Questo schema di sussunzione narrativa riduce la complessità del reale sull’unico piano rappresentazionale invasi/invasori, forcludendo in tal modo una prospettiva data da altri due piani di conflittualità che vengono rifiutati, prima che per la loro attinenza al reale, per la loro vicinanza all’ottica di parte russa, all’emica del nemico: quello della pressione geopolitica tra i blocchi di potere russo e atlantista e quello delle tensioni etno-nazionaliste tra Russia e Ucraina.
Il piano della pressione geopolitica tra blocchi di potere riguarda un processo che si è iniziato a palesare nel 1991 con il distacco dell’Ucraina, insieme ad altri Stati, dall’ex blocco URSS; il tutto a partire da un patto di indipendenza basato su garanzie di neutralità e di distanza dal blocco atlantista promesse dall’Ucraina alla Russia. L’Ucraina nel 2014 rompe questo patto con un colpo di Stato e inizia ad avvicinarsi politicamente, culturalmente ed economicamente all’Occidente. Questo spostamento ha in un certo senso rigenerato la tensione geopolitica della guerra fredda tra USA e URSS, in quanto la Russia ha inteso ciò come un atto di separatismo, un’erosione di quello che considera come un suo territorio storico o almeno come una sua area di influenza (dove, di fatto, l’ingresso alla NATO in Ucraina avrebbe comportato la possibilità dell’istallazione di basi missilistiche atlantiste a 500km da Mosca). In Occidente si sapeva che tali scelte sarebbero state un azzardo, che sarebbero state interpretate in termini di aggressione; e, da Henry Kissinger in poi, vari autorevoli esperti e politici avevano avvertito in merito a tale imprudenza. Tuttora, a guerra iniziata il tema è ampiamente dibattuto, a partire dal rimprovero di papa Francesco che, senza mezzi termini, ha descritto «l’abbaiare della NATO ai confini della Russia» come una provocazione geopolitica che ha acceso la crisi attuale.
 L’altro piano, intrecciato con la questione della pressione NATO ma innervato in processi storici che durano da più di 700 anni, è quello delle tensioni etno-nazionaliste con il principale fattore di innesco attuale le violenze istituzionali contro le spinte separatiste in Donbass che dal febbraio 2014 l’Ucraina avrebbe reiteratamente perpetrato contro le minoranze russofone e russofile. Questo in una guerra ignorata se non clandestinamente sostenuta dall’Occidente, costata 4000 vittime tra i civili, e andata avanti a spregio degli accordi presi a Minsk (in cui l’Ucraina si impegnava a cessare le ostilità e a garantire maggiori autonomie alle regioni che invece ha seguitato ad attaccare). Proprio in tal senso Putin sostiene che quella che chiama come “operazione militare speciale” non sia affatto una guerra di invasione contro l’Ucraina ma una missione di difesa di minoranze etniche perseguitate, prima che di ripristino della sovranità russa, di liberazione da un separatismo prevalentemente indotto dall’Occidente che avrebbe persuaso economicamente l’Ucraina a spostarsi ad Ovest.
L’altro piano, intrecciato con la questione della pressione NATO ma innervato in processi storici che durano da più di 700 anni, è quello delle tensioni etno-nazionaliste con il principale fattore di innesco attuale le violenze istituzionali contro le spinte separatiste in Donbass che dal febbraio 2014 l’Ucraina avrebbe reiteratamente perpetrato contro le minoranze russofone e russofile. Questo in una guerra ignorata se non clandestinamente sostenuta dall’Occidente, costata 4000 vittime tra i civili, e andata avanti a spregio degli accordi presi a Minsk (in cui l’Ucraina si impegnava a cessare le ostilità e a garantire maggiori autonomie alle regioni che invece ha seguitato ad attaccare). Proprio in tal senso Putin sostiene che quella che chiama come “operazione militare speciale” non sia affatto una guerra di invasione contro l’Ucraina ma una missione di difesa di minoranze etniche perseguitate, prima che di ripristino della sovranità russa, di liberazione da un separatismo prevalentemente indotto dall’Occidente che avrebbe persuaso economicamente l’Ucraina a spostarsi ad Ovest.
Questa situazione configura una scissione e un conflitto di immaginari che si propongono come mutuamente escludenti e vengono tenuti del tutto separati dal tabù della contaminazione con il nemico, ma che forse andrebbero combinati per ricomporre la complessità reale di questo dissidio. Da un lato, la prospettiva prevalentemente atlantista e mainstream in Occidente dell’opposizione polare invasi/invasori racconta di un luminoso e pacifico processo democratico di autodeterminazione dei popoli interrotto di punto in bianco dall’aggressione russa (questo anche se, stando al Democracy index dell’Economist del 2021, l’Ucraina è un regime ibrido tra la democrazia e il regime autoritario, con vari problemi di corruzione economica e violenza politica). Dall’altro lato, la prospettiva della pressione NATO e del separatismo ucraino parla dell’Ucraina non come l’esito di un processo di autodeterminazione di un popolo ma come di una ‘nazione inventata’ da un progetto di regime change fomentato economicamente e militarmente dagli USA, di un separatismo costruito contro la Russia in una prospettiva di conflittualità imperialistica in cui Putin avrebbe reagito per difendere la sovranità russa da un’aggressione occidentale contro lo spirito della Grande Madre Russia; questo in un’idea di nazione pensata e essenzializzata come un’identità “naturale” e sacra.
Questa visione è condivisa da un fronte critico anti-atlantista e contro l’imperialismo USA, basato sull’idea che i tentativi statunitensi degli ultimi decenni (abbastanza disastrosi) di esportare le democrazie con le bombe si siano trasformati in una strategia più raffinata data dal costruire aree di influenza esportando democrazie con i dollari e difendendole quindi con le bombe in guerre di prossimità. In tal senso è utile ricordare che John Mearshmeimer, professore di Scienze Politiche all’Università di Chicago, già nel 2014 attribuiva agli USA e ai loro alleati ampie responsabilità nella crisi ucraina per aver ignorato la linea rossa di Mosca e cercato di trasformare l’Ucraina in un baluardo occidentale al confine con la Russia [2]. In questo senso l’azione militare della Russia contro l’Ucraina si configura come un atto ambivalente, tanto di aggressione quanto di difesa. Un atto di aggressione contro uno Stato sovrano, ma diventato sovrano a partire da una dinamica che dai russi è stata intesa come un’aggressione alla loro potenza, un’aggressione da cui difendersi.
Tutto lascia presagire che nel prossimo futuro ci troveremo di fronte anche a una “guerra storiografica” in cui il definire l’inizio della conflittualità armata nel 2022 o nel 2014 segnerà lo spartiacque tra due verità, una atlantista e l’altra russa (e condivisa in varia misura dalle posizioni non allineate all’atlantismo) in cui confliggono altrettanti etnocentrismi geopolitici destinati a delineare due versanti morali opposti e complementari in cui da ogni lato ci si considera nel giusto, come invasi che si difendono da un imperialismo che vuole schiacciare la propria identità nazionale, pensata su base etnica come se fosse un’essenza naturale del territorio. La prospettiva su cui oggi si riflette poco e che si è poco disposti a riconoscere è quella del relativismo geopolitico, di una possibilità di pluralità, di compresenza di piani e di verità in cui ragioni e torti non sono nettamente separati.
Questo considerando che Putin si propone come il restauratore di un orizzonte nostalgico di potenza, rivolto contro un presente in cui la Russia è un impero in crisi, perennemente introflesso nella difficoltosa conservazione della sua vastità territoriale, ossessionato dal bisogno di contenere l’epidemia di spinte etniche centrifughe che assumono forma di separatismi nazionalisti, acuiti dopo il crollo dell’URSS, in quella che si configura come una paranoia storica russa di vedere erosa la propria potenza.
Questo in contrapposizione all’imperialismo USA, estroflesso, ossia proiettato verso l’esterno in un progetto di egemonia globale fatto da decenni di “esportazioni di democrazie” rivelatesi troppo spesso fallimentari trasfigurazioni storiche delle “missioni civilizzatrici”, del “fardello dell’uomo bianco” come pretesto imperialistico-coloniale. Simili intenzioni hanno oggi portato al fronte ucraino, dove, alle spalle della Russia s’intravede sempre di più il gigante cinese; dove, a prescindere dal fatto che i popoli abbiano razionalmente scelto o siano stati persuasi a scegliere, oggettivamente la NATO negli anni ha eroso uno spazio imperiale che prima era russo. E qui va notato che quando, partendo dal proposito della difesa dell’Ucraina, l’asse atlantista dichiara che vuole sconfiggere bellicosamente, isolare politicamente e far fallire economicamente la Russia, confermiamo ai russi che una loro antica paranoia di essere aggrediti dall’Occidente non è del tutto campata in aria. In tal senso andrebbe compreso che dal punto di vista russo (e di gran parte del mondo non occidentale) i temi della democrazia e dell’autodeterminazione dei popoli sono solo una poetica che maschera la strategia imperialista degli USA, i quali vogliono imporre al mondo un assetto unipolare neoliberista e de-etnicizzato, a cui oggi i russi contrappongono una visione multipolare dove la dimensione etno-nazionalistica dell’appartenenza torna ad acquisire centralità (Dugin 2019). Probabilmente la risposta russa sottende un imperialismo di altra fattura che, come quello USA, si presenta in fattezze di liberazione; ma, di fatto, il mondo immaginato da Francis Fukuyama, pacificato nel segno del capitalismo delle democrazie neoliberali (Fukuyama 1992) appare sempre più lontano, mentre torna la profezia di Samuel Huntington sullo scontro di civiltà, che, tra l’altro, aveva individuato proprio nella questione russo-ucraina un momento di possibile crisi (Huntington 1997).
 Metafore di guerra e indottrinamento manicheo
Metafore di guerra e indottrinamento manicheo
Nel fronte rappresentazionale del conflitto si è subito aperto un mercato mediatico di “metafore a buon mercato”: l’Ucraina è la vittima del bullo, è la donna violentata dal bruto, è il conducente d’auto vittima di un pirata della strada, e via dicendo. Su questa linea è esemplare la pièce di Stefano Massini “I filosofi e il cretino” andata in onda nel corso della puntata del 5 maggio 2022 del programma Piazzapulita su La7 [3]. Qui l’attore, evocando i pensatori della Grecia classica, rimprovera in merito che se un guidatore ubriaco procura un incidente la colpa è solo e soltanto sua, e non va cercata in chi costruisce macchine veloci, in chi gli ha venduto l’alcol o in altre variabili contestuali. La metafora di Massini è implicita, non relata ad altro nella sua performance, ma il senso si capisce dalla cornice del programma televisivo che l’ha ospitata: seguendo questo conio, ripiombiamo sul mantra mainstream che viene somministrato alla popolazione spettatrice dal primo giorno di guerra: esiste solo il piano invasi/invasori, l’impatto è solo quello del 24 febbraio 2022, la colpa è solo della Russia, che è il carnefice da combattere mentre dell’Ucraina dobbiamo essere alleati fino alla fine. Chi sposta l’attenzione su altro è alleato della Russia di Putin ed empio come lui, oltre che cretino. Basta una metafora per spiegare tutto.
Ma è proprio così? Non mi pare. Le metafore che usiamo per spiegare il reale sono dispositivi retorici che semplificano, traducono, e finanche tradiscono i fenomeni sul conio dell’esempio a cui li riduciamo. L’algoritmo “la guerra è come X” non rappresenta tutta la complessità della guerra ma la semplifica in funzione della variabile X che scegliamo. Prima di tutto perché la guerra non è solo come X. La guerra non è solo una metafora, e ci vorrebbero una miriade di metafore se volessimo rappresentarla in questo modo con un minimo di esaustività, senza semplificarla secondo i nostri comodi, scegliendo la metafora X, quella Y o quella Z. Se per pensare un evento usiamo un conio unico che riguarda un evento finito in cui ragioni e torti sono separati al 100%, la rappresentazione dell’evento deriverà dalla struttura del conio, non da quella dell’evento. La guerra in corso non è in toto riducibile a un incidente, a una violenza carnale, a un atto di bullismo (dove queste metafore sono strutturalmente omologhe in quanto sostanziano situazioni dove la ragione è totalmente separata dal torto).
Che vuol dire? Che la Russia non è l’invasore? No. Vuol dire che quel piano di realtà, pur essendo ineludibile, non è il solo. E vuol dire che ridurre monocausalmente la nostra rappresentazione della realtà a quell’unico piano è un atto retorico di selezione, di sineddoche in cui evidenziamo una parte per coprire il tutto. Vuol dire che queste metafore sono utili a rappresentazioni ideologiche che rimuovono i piani disfunzionali in base a un finalismo interpretativo orientato a convincerci della sussumibilità del reale in una narrazione manichea che separa in modo netto il bene dal male (forcludendo in tal modo una serie di piani concausali che andrebbero invece intesi in una logica non esclusiva ma inclusiva). Vale a dire che in molti casi non esiste solo una causa “o” l’altra, in cui i piani di realtà si oppongono, ma che esiste una causa “e” l’altra, che i piani di realtà si combinano, sono compresenti.
La dovremmo smettere di spiegare la guerra con queste metafore di comodo usandole come punto di arrivo, come conclusione. Le metafore al limite sono punti di partenza da cui aprire riflessioni rispetto a ciò che eccede le metafore stesse, perché le metafore sono sempre un po’ vere e un po’ fasulle, rivelano e mascherano: ogni singola metafora mentre svela un piano, quello dell’intersezione tra i due fenomeni che pone in analogia, ne vela altri, quelli che eccedono da tale intersezione. Perciò bisognerebbe capire che le metafore non riflettono in toto la realtà ma sono maschere con cui mettiamo in scena il reale; e ragionare sul loro scarto, se vogliamo svelare l’eccesso osceno che sottendono.
Riprendiamo la facile metafora dell’incidente automobilistico. Se la usiamo per rappresentare l’invasione del 24 febbraio 2022 l’incidente è stato causato dalla Russia. Se la usiamo per rappresentare gli eccidi del Donbass perpetrati negli otto anni precedenti da neonazisti ucraini inquadrati regolarmente nell’esercito ai danni dei russofoni e russofili, allora l’incidente è stato causato dall’Ucraina [4]. Se la usiamo per rappresentare l’allargamento della NATO ad Est, tradendo patti contratti a partire dagli anni ’90, l’incidente allora è stato causato dalla NATO.
Poi, a differenza di un incidente d’auto che guardiamo essersi appena consumato dal ciglio di una strada, in questo caso non siamo di fronte a un processo finito ma ad un processo in divenire. E questo è un altro grande errore che rivela quanto queste metafore siano vacue, quanto queste metafore siano più utili a mistificare che a capire la realtà nella sua complessità. Se volessimo restare nell’economia di questa metafora, dovremmo renderci conto che siamo di fronte a una serie di incidenti che stanno avvenendo ora, anzi, ci siamo in mezzo, il processo è in corso.
Questi incidenti in fieri sono il rischio che la guerra si protragga, che l’Ucraina diventi un nuovo Israele (come ha detto che vorrebbe Zelensky, sic), che diventi un nuovo Vietnam, un nuovo Afghanistan, una nuova Siria o un nuovo Ruanda. C’è il rischio che la guerra porti a una guerra energetica e di risorse, che inneschi una crisi sistemica globale. C’è il rischio che il conflitto tracimi dalla dimensione glocale con cui oggi si sta combattendo una guerra mondiale per procura confinata in Ucraina. C’è il rischio che a quel punto tutto degeneri in guerra atomica e che questo porti all’olocausto nucleare, alla fine dell’umanità.
Di fronte a tutto questo sarebbe il caso di toglierci i paraocchi monocausali di metafore banalizzanti che, a ben vedere, date le circostanze sono funzionali solo a fomentare l’invasamento bellico, l’invio di armi, armi e ancora armi, in un contesto in cui tutti i contendenti vogliono solo la vittoria. Questo di fronte a un baratro dove noi abbiamo ufficiosamente deciso che la Russia deve perdere mentre la Russia ha deciso che se dovesse perdere userà l’atomica. Il rischio è che metterci i paraocchi di metafore semplicistiche che riducono tutto al piano invasi/invasori ci nasconda i pericoli che corriamo: stiamo sbattendo contro un muro e dobbiamo premere il pedale del freno mentre invece seguitiamo ad accelerare (tanto per dimostrare che le metafore si possono usare in vari modi ma l’importante è usarle come premesse per uscire da esse, non come conclusioni in cui infilare la testa come degli struzzi).
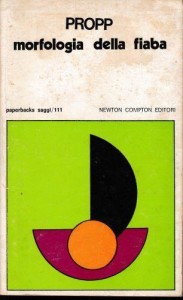 È che l’opposizione invasi/invasori funziona egregiamente come asse di produzione di consenso di massa soprattutto perché soddisfa le nostre esigenze segniche di messa in ordine semplificata del mondo in base un sistema di metà, grazie alla sua capacità di ricondurre il reale a uno schema binario che mette tutto il bene da un lato e tutto il male dall’altro, senza sbavature o contaminazioni perturbanti. È una struttura narrativa basica, che, non a caso, ritroviamo nei film classici della Disney e in tante trame hollywoodiane. Prima ancora è una struttura, come quella delle fiabe analizzate un secolo fa dal folklorista russo Vladimir Propp, i cui i ruoli di cattivi, vittime ed eroi sono nitidamente distinti (Propp 2000). Si tratta di cibo mentale facile e seduttivo con cui la nostra specie si è nutrita per la maggior parte della sua storia evolutiva, e alla cui forma massmediatica le folle sono già assuefatte.
È che l’opposizione invasi/invasori funziona egregiamente come asse di produzione di consenso di massa soprattutto perché soddisfa le nostre esigenze segniche di messa in ordine semplificata del mondo in base un sistema di metà, grazie alla sua capacità di ricondurre il reale a uno schema binario che mette tutto il bene da un lato e tutto il male dall’altro, senza sbavature o contaminazioni perturbanti. È una struttura narrativa basica, che, non a caso, ritroviamo nei film classici della Disney e in tante trame hollywoodiane. Prima ancora è una struttura, come quella delle fiabe analizzate un secolo fa dal folklorista russo Vladimir Propp, i cui i ruoli di cattivi, vittime ed eroi sono nitidamente distinti (Propp 2000). Si tratta di cibo mentale facile e seduttivo con cui la nostra specie si è nutrita per la maggior parte della sua storia evolutiva, e alla cui forma massmediatica le folle sono già assuefatte.
Una volta che il bene e il male sono reiteratamente rappresentati in modo nettamente distinto si sceglie di stare contro il cattivo e dalla parte dell’eroe e della vittima, anche e soprattutto per un riflesso pavloviano di identificazione narcisistica. Tutto questo soddisfa necessità emozionali elementari e crea in tal modo una certa dipendenza cognitiva che ci induce a eliminare percettivamente le dissonanze da questo schema. È un prodotto che funziona in termini di economia mediatica ma che può generare una miopia della coscienza, può mascherare l’essenza della realtà tanto più quanto più questa è complessa e contraddittoria, invece che essere separata in modo così semplice e netto.
Zelensky: carisma e rischio
Putin è un sovrano monoliticamente autoritario, che appare all’opinione pubblica occidentale in tutto il suo squallore dittatoriale, nella sua sostanza dispotica, uno arrivato dal KGB, dai servizi segreti, dal peggio dell’URSS, che ha realizzato il suo progetto perverso: far diventare l’essenza di quell’apparato repressivo un sistema di governo. Se si esclude una piccola fetta di nostalgici del regime sovietico variamente visionari, questo lo priva di appeal, di carisma, di fascino politico. Viceversa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si presenta in modo brillante, è portatore di una sovranità estremamente carismatica. Prima di tutto questo leader è un attore, diventato il capo del Paese subito dopo aver recitato la parte del capo del Paese in una serie Netflix chiamata “Servitore del popolo”, vincendo le elezioni in un partito creato al momento, chiamato come la fiction “Servitore del popolo”. Zelensky in questo incarna in modo totale un certo compiere itinerari dallo spettacolo alla politica, a cui ci sta abituando l’era dei massmedia (che abbiamo visto in modo meno completo in personaggi come Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Ronad Regan o Donald Trump, solo per fare i nomi più noti).
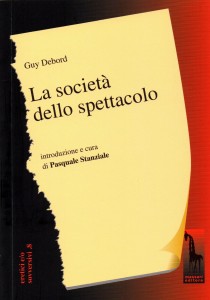 Egli concretizza in maniera perfetta quello che diceva Guy Debord nel 1967 sulla società dello spettacolo, ossia che lo spettacolo non è solo un mero insieme di immagini, ma contiene un dispositivo di costruzione di rapporti sociali attraverso le immagini. Nella società dello spettacolo le immagini producono la realtà, la rappresentazione spettacolarizzata del reale si rovescia nella realizzazione di ciò che viene messo in scena (Debord 2008). Si tratta a ben vedere di un meccanismo di profezia autoadempiente su cui occorre riflettere. In tutto ciò ad aver un peso chiave è, appunto, il carisma. Il carisma politico dovrebbe mettere sempre in guardia perché è intrinsecamente pericoloso nel suo potenziale di persuasione: il carisma seduce, affascina, ipnotizza. Induce ad adesioni in cui la componente sensibile-emozionale può soverchiare quella logico-razionale. Nel carisma il fascino della forma può distrarre dalla riflessione sui contenuti.
Egli concretizza in maniera perfetta quello che diceva Guy Debord nel 1967 sulla società dello spettacolo, ossia che lo spettacolo non è solo un mero insieme di immagini, ma contiene un dispositivo di costruzione di rapporti sociali attraverso le immagini. Nella società dello spettacolo le immagini producono la realtà, la rappresentazione spettacolarizzata del reale si rovescia nella realizzazione di ciò che viene messo in scena (Debord 2008). Si tratta a ben vedere di un meccanismo di profezia autoadempiente su cui occorre riflettere. In tutto ciò ad aver un peso chiave è, appunto, il carisma. Il carisma politico dovrebbe mettere sempre in guardia perché è intrinsecamente pericoloso nel suo potenziale di persuasione: il carisma seduce, affascina, ipnotizza. Induce ad adesioni in cui la componente sensibile-emozionale può soverchiare quella logico-razionale. Nel carisma il fascino della forma può distrarre dalla riflessione sui contenuti.
Il problema è che in Zelensky c’è sia la speranza del messia che guida il popolo verso la terra promessa sia il rischio del pifferaio magico che precipita tutti in un burrone; e su questa doppiezza è il caso di ragionare. Dovremmo chiederci se Zelensky sta solo salvando il mondo in nome della democrazia o se lo sta anche mettendo nei guai. Se antropologicamente il tempo di guerra è analogo al tempo di festa (Caillois 2001) in quanto rovesciamento radicale dei valori, delle regole e del senso della quotidianità invertita in dissipazione o distruzione rigenerativa, è opportuno ricordare la lezione di Vittorio Lanternari, che ci illustrò la relazione profonda tra carisma e apocalisse, chiarendo che per le personalità carismatiche i contesti catastrofici sono un habitat particolarmente adattivo (Lanternari 1989).
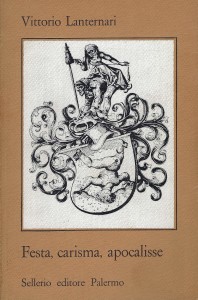 Qui va compreso che in questo scenario di guerra Zelensky deve il suo carisma al fatto che egli rappresenta una forma primordiale di legittimazione del potere: la capacità di guarigione, il dono taumaturgico come facoltà di liberare il popolo dal male (Bloch 1995). In tal senso Zelensky si presenta come redentore del suo popolo e dell’umanità intera da un male che raffigura come assoluto, rispetto al quale si contrappone come l’angelo salvatore, come il profeta condottiero da seguire. Il dubbio riguarda un rischio, ed è connesso alla possibilità nefasta che quest’atteggiamento scateni un esito paradossale dove, più che un rito di purificazione dal male della guerra, si giunga paradossalmente a un pervertimento propiziatorio che il male finisce per produrlo, in termini di contagio globale del conflitto.
Qui va compreso che in questo scenario di guerra Zelensky deve il suo carisma al fatto che egli rappresenta una forma primordiale di legittimazione del potere: la capacità di guarigione, il dono taumaturgico come facoltà di liberare il popolo dal male (Bloch 1995). In tal senso Zelensky si presenta come redentore del suo popolo e dell’umanità intera da un male che raffigura come assoluto, rispetto al quale si contrappone come l’angelo salvatore, come il profeta condottiero da seguire. Il dubbio riguarda un rischio, ed è connesso alla possibilità nefasta che quest’atteggiamento scateni un esito paradossale dove, più che un rito di purificazione dal male della guerra, si giunga paradossalmente a un pervertimento propiziatorio che il male finisce per produrlo, in termini di contagio globale del conflitto.
Eccessi osceni dell’eroismo
“Gli eroi son tutti giovani e belli” cantava Francesco Guccini, e l’immagine di Zelensky intrisa di eroismo si staglia su un piano di intoccabilità. Egli è al momento un semi-dio, un emblema di gloria, e questo gli conferisce un’aura di sacralità e di immunità (non può essere minimamente criticato senza essere accusati di filo-putinismo). Tuttavia, dovremmo essere razionali e capire che anche l’eroismo può essere eccessivo. La pulsione di ammirazione, la fascinazione per l’eroismo di Zelensky, dal momento in cui si afferma in forma illimitata non ci consente di comprendere il confine del suo eccesso osceno: il martirio evitabile. Questo soprattutto se l’atto eroico propizia ampliamenti al mondo intero dell’orizzonte sacrificale che prescrive, inquadrando certi schieramenti continuamente richiesti come imperativi morali di espiazione da una colpa attribuita a chi non interviene arruolandosi per perdere parte al massacro bellico.
Se la storia ci indica che di solito di fronte a regnanti in abiti militari ci vuole prudenza, va notato che il verde militare della mise mimetica con cui questo presidente si presenta perpetuamente al mondo è un atto doppiamente mimetico: va in direzione non solo della necessità marziale simulata (egli non va mai in battaglia ma si traveste sempre da soldato) ma anche della scelta mediatica. Sulla scorta di Girard si può affermare che Zelensky imita l’archetipo dell’eroe e in questo suscita in noi un desiderio di immedesimazione (Girard 1980). Volendo usare uno schema geertziano direi che Zelensky rappresenta un modello di realtà che, mentre descrive la situazione in cui versa la sua martoriata patria, si fa modello per la realtà (Geertz 1988) che prescrive come essere ai suoi compatrioti, comandando un’agency epica, un dovere di emulazione belligerante come onere di appartenenza.
 Il problema è che la ricetta, che Zelensky presenta reiteratamente da grande guaritore come la cura imprescindibile contro il male dell’assolutismo putiniano, può trasformarsi nel virus che contagia gli immaginari collettivi con la falsa credenza che per arrivare alla pace di tutti dobbiamo passare per la sua guerra, trasformandola nella guerra di tutti. Così questo sovrano rappresenta come tappa necessaria per arrivare alla pace non solo la resistenza armata locale ma anche la guerra mondiale contro la Russia. Egli profetizza biblicamente scenari apocalittici di guerra mondiale, sostenendo che gli ucraini starebbero combattendo non solo per la loro libertà ma anche per la nostra. Il nucleo concettuale ricorrente che struttura le sue trame narrative è che lui e il suo popolo si starebbero sacrificando per noi; e questo implica che noi Occidentali siamo degli ingrati e dei vigliacchi se non entriamo subito in guerra al suo fianco contro la Russia.
Il problema è che la ricetta, che Zelensky presenta reiteratamente da grande guaritore come la cura imprescindibile contro il male dell’assolutismo putiniano, può trasformarsi nel virus che contagia gli immaginari collettivi con la falsa credenza che per arrivare alla pace di tutti dobbiamo passare per la sua guerra, trasformandola nella guerra di tutti. Così questo sovrano rappresenta come tappa necessaria per arrivare alla pace non solo la resistenza armata locale ma anche la guerra mondiale contro la Russia. Egli profetizza biblicamente scenari apocalittici di guerra mondiale, sostenendo che gli ucraini starebbero combattendo non solo per la loro libertà ma anche per la nostra. Il nucleo concettuale ricorrente che struttura le sue trame narrative è che lui e il suo popolo si starebbero sacrificando per noi; e questo implica che noi Occidentali siamo degli ingrati e dei vigliacchi se non entriamo subito in guerra al suo fianco contro la Russia.
Tornando a Girard, direi che questo principio vittimario, questa nebulosa di sacrificio, martirio, colpa ed espiazione pervade i continui discorsi mediatici del presidente dell’Ucraina, in un’epica elementare archetipica della lotta totale del bene assoluto contro il male assoluto che si è rivelata spesso pericolosa. Questo in quanto su ciò egli ha motivato in concreto pretese come la richiesta della no-fly zone; richiesta radicale che dall’inizio del conflitto ha ripetuto ad nauseam per settimane, pur sapendo perfettamente che ciò avrebbe innescato il passaggio dal conflitto regionale a quello mondiale. In nome di questa grammatica sacrificale Zelensky ci tira per il bavero nel precipizio di un’apocalisse possibile, facendo leva su pericolosi istinti culturali primordiali sedimentati nel profondo della nostra umanità.
I quattro pattern comunicativi di Zelensky
È interessante notare come in un periodo di diverse settimane in cui è apparso in video conferenza nei parlamenti e in contesti istituzionali di molti Paesi occidentali, Zelensky ha approntato una comunicazione basata su degli schemi ricorrenti. In tal senso possono essere individuati quattro pattern narrativi: il pattern manicheo della “lotta del bene contro il male”, il pattern eucaristico del “noi come voi”, il pattern sacrificale del “noi per voi” e, infine, il pattern espiatorio del “se-allora”.
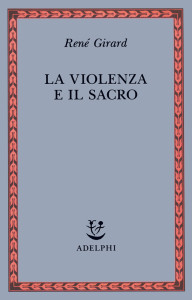 Il primo pattern, quello manicheo della “lotta del bene contro il male”, è basato sulla metafora della reductio ad hitlerum di Putin di cui dicevo all’inizio di questo testo. L’equazione “Putin=Hitler” (che in alcuni casi si espande nella forma totalizzante “russi=nazisti”) consente a Zelensky di immettere tutta la vicenda del conflitto in una struttura che è “buona da pensare” nel suo separare in modo netto il bene dal male. Ma Putin è come Hitler? No. Al netto del suo autoritarismo e della sua deprecabile violenza bellica Putin non è come Hitler. Ora no, però potrebbe diventare peggio di Hitler se lo mettessimo in condizione di soddisfare la sua pulsione di morte, pulsione che potrebbe concretizzare in forma apocalittica, premendo il bottone rosso dell’olocausto nucleare. Il punto è che più rappresentiamo Putin come Hitler più rischiamo di cadere in una profezia autoadempiente che lo farà diventare come Hitler e peggio. Il primo pattern è abbastanza generale (la reductio ad hitlerum del nemico è un dispositivo retorico già messo in scena in varie altre situazioni, anche belliche, come vari episodi di “esportazione di democrazia” a suon di bombe messi in atto per anni dagli USA in Medio Oriente), mentre gli altri tre sono più peculiari e riguardano la caratura mimetica di Zelenski, il suo trasformismo prima attoriale che politico.
Il primo pattern, quello manicheo della “lotta del bene contro il male”, è basato sulla metafora della reductio ad hitlerum di Putin di cui dicevo all’inizio di questo testo. L’equazione “Putin=Hitler” (che in alcuni casi si espande nella forma totalizzante “russi=nazisti”) consente a Zelensky di immettere tutta la vicenda del conflitto in una struttura che è “buona da pensare” nel suo separare in modo netto il bene dal male. Ma Putin è come Hitler? No. Al netto del suo autoritarismo e della sua deprecabile violenza bellica Putin non è come Hitler. Ora no, però potrebbe diventare peggio di Hitler se lo mettessimo in condizione di soddisfare la sua pulsione di morte, pulsione che potrebbe concretizzare in forma apocalittica, premendo il bottone rosso dell’olocausto nucleare. Il punto è che più rappresentiamo Putin come Hitler più rischiamo di cadere in una profezia autoadempiente che lo farà diventare come Hitler e peggio. Il primo pattern è abbastanza generale (la reductio ad hitlerum del nemico è un dispositivo retorico già messo in scena in varie altre situazioni, anche belliche, come vari episodi di “esportazione di democrazia” a suon di bombe messi in atto per anni dagli USA in Medio Oriente), mentre gli altri tre sono più peculiari e riguardano la caratura mimetica di Zelenski, il suo trasformismo prima attoriale che politico.
Il pattern eucaristico “noi come voi” è quello in base a cui Zelensky in collegamento con Londra evoca Churchill, a Berlino dice che ogni bomba è un muro, con gli USA si gioca il paragone con Pearl Harbor, per Israele mette in campo l’analogia con la Shoah (ma viene rimproverato per averne violato l’unicità storica), in Italia afferma che la città martire Mariupol è come Genova (che fu bombardata durante la Seconda guerra mondiale), e via dicendo. È una struttura metaforica che agisce a partire da un riflesso mimetico: lui imita noi con riferimenti alla Seconda guerra mondiale, noi ricambiamo il dono obbedendo a una pulsione di identificazione narcisistica. Lui si identifica in noi, noi ci identifichiamo in lui.
Il pattern sacrificale “noi per voi” è invece quello che implica affermazioni del tipo “noi stiamo combattendo per la vostra libertà!”. In base a questa visione, sostenuta fortemente da personaggi come l’analista USA Anne Applebaum, Putin deve essere fermato costi quel che costi, perché, preso da una bulimia imperialistica senza fondo, avrebbe intenzione di conquistare tutta l’Europa, se non il mondo intero. Si tratta di un’affermazione del tutto inverosimile rispetto alle dichiarazioni reali di Putin. Qui non si sta combattendo per salvare l’umanità intera dall’imperialismo della Russia putiniana; anzi, è proprio questo combattere che espone il mondo al rischio di una guerra mondiale in quanto più armiamo l’Ucraina più provochiamo la Russia. Perciò il dire “noi combattiamo per voi” allude a una poetica dell’immolazione per la causa assoluta che mira a indurre sensi di colpa e stimolare reazioni espiatorie in direzione interventista che possono tradursi in un contagio bellico.
Il pattern espiatorio “se-allora” è quello più insidioso, ed è espresso dalle formule del tipo “se non ci date le armi allora perderà tutta l’Europa”, “Se non ci date la no-fly zone allora Putin bombarderà anche voi”. Il senso di questo pattern esplicita e rafforza quello del pattern precedente, e consiste in quest’algoritmo: “se non attaccate Putin, allora Putin vi attaccherà”. Direi che questo è il più pericoloso raggiro comunicativo di Zelenski, perché in tale schema viene inserita una negazione, un “non” di troppo che per mesi ha esposto e seguita tuttora a esporre al rischio di far cadere l’opinione pubblica occidentale nella trappola peggiore, perché è più verosimile il contrario di quanto il leader ucraino afferma, ossia che se attacchiamo Putin allora Putin ci attaccherà. Questa comunicazione ha una connotazione rassicurazionistica che inverte una modalità di percezione del rischio presentando dei pericoli come se fossero delle soluzioni, e viene sorretta da un apparato di propaganda che impiega attivamente tutto il mainstream mediatico occidentale in modo continuativo. In tal senso il diritto e la scelta degli ucraini di difendersi dovrebbero essere distinti dal rischio che tale difesa assuma delle forme che possono rivelarsi catastrofiche per l’umanità intera.
In generale, è evidente che siamo di fronte a un regolare ricorso mediatico a metafore propagandistiche che rappresentano la guerra come soluzione necessaria più che come scelta problematica. In questo processo di persuasione dell’opinione pubblica, a partire dai banali schemi associativi dell’ “è come”, la collettività si rivela un po’ troppo lontana da certe consapevolezze che immaginavamo sarebbero attecchite con l’istruzione e l’emancipazione culturale, anzi pare sinistramente simile alle folle alienate del secolo scorso che descriveva Gustave Le Bon, sedotte ed esaltate da oratori abili a nutrirle di semplificazioni leggere attraverso il parlare per «associazione di cose dissimili, che detengono tra loro solo rapporti apparenti» (Le Bon 2004).
 Culto del martirio, pulsione di morte
Culto del martirio, pulsione di morte
In tutto ciò c’è un sotterraneo culto aggressivo-passivo del martirio a cui dovremmo fare attenzione, chiedendoci se questa narrazione, per cui lui e il suo popolo si starebbero sacrificando per noi perché Putin vuole invadere il mondo, non sia esagerata e dannosa. Siamo di fronte a una tentazione umana archetipica in cui il sacrificio della vita diventa testimonianza di fede e strumento di gloria. Credo che sia utile in tal senso una lettura freudiana in quanto tutto ciò rimanda a un’inversione del principio di piacere in pulsione di morte, in nome di un nucleo nevrotico-ossessivo diventa principio di realtà e comanda un godimento rovinoso fino alla morte (Freud 1977). Questo nucleo nevrotico-ossessivo è, in questo caso, inquadrabile proprio in una concezione etno-nazionalistica dei confini, in una costruzione ideologica della patria presentata come natura imprescindibile per il sé, come condizione primaria per la vita stessa.
Così si determina un’isteria collettiva in nome di un valore che viene pensato come assolutamente vitale, come precondizione per la vita stessa. Questo valore è quello della difesa assoluta del confine che diventa difesa della democrazia all’interno di una concezione di lotta del bene contro il male, di vita contro la morte. Si tratta del principio tanatopolitico del sacrificio per la patria, che è qualcosa di molto novecentesco a cui dovremmo fare attenzione perché, soprattutto in questo caso, è evitabile. Non si sa se per accordo assoluto o se per capacità di silenziare il dissenso, ma le voci dall’Ucraina cantano all’unisono di una vocazione al martirio per la patria che mi pare sproporzionata rispetto alle possibilità di concordare negoziati, in giorni dove seguita a scorrere sangue che potrebbe essere evitato. Ciò in quanto la sconfitta della Russia non è l’unica strada per evitare stermini di massa (come, all’opposto invece fu necessario sconfiggere la Germania nazista); dove, anzi, il proposito di sconfiggere la Russia si può rivelare la strada più insanguinata tra quelle percorribili.
In tal senso leggevo sui social di un utente che diceva che se lui si trovasse nella necessità di rinunciare all’appartenenza nazionale per salvare la vita dei figli, sceglierebbe di salvare la vita dei figli. Una donna ucraina ha risposto: “Allora i tuoi figli sono sfortunati”. Siamo nel pieno di una logica jihadista di sacrificio estremo per la patria intesa come divinità a cui tutto si deve: viene prima la bandiera della vita dei figli. È una concezione del mondo analoga a quella che ha portato ai disastri del Novecento. Ci dovremmo chiedere se non siamo di fronte a una pulsione di morte che ha contagiato e alienato gran parte delle coscienze individuali ucraine e che si diffonde nel senso comune europeo ben oltre il necessario. Perciò dovrebbero preoccupare l’evenienza e il rischio che la resistenza ucraina, una volta che è stata vincolata in forma bellica e orientata al fine sacro della conservazione di una configurazione etno-nazionalistica dell’appartenenza, finisca con il nascondere un alibi per tornare al passato, a quanto di peggio ci ha dato il Novecento in termini di chiusura identitarista.
Per tutto questo ritengo che alla rappresentazione dualistica invasi/invasori dovremmo aggiungere un terzo elemento trasversale, contingente rispetto ai due poli di questa opposizione mediaticamente imposta: gli invasati. Gli invasati sono le persone, i governanti – ma anche i sentimenti, i concetti, i pretesti – che finiscono con l’essere dominati da questa pulsione di morte in nome della patria. Sono invasati dall’eccesso emozionale con cui incorporano un ideale che si rappresenta come necessità imprescindibile di vita ma che può diventare fissazione nevrotica che possiede gli animi e le nazioni, arrivando a negare quella stessa vita. Bisogna stare attenti che la vita e la libertà non finiscano nel vincolo di questa possessione. Oggi negoziare non significa per gli ucraini accettare il loro sterminio, la loro morte. Invece prevale un principio maschile che immagina qualsiasi negoziato come resa mortale e vede la resistenza solo e soltanto nella belligeranza, in una poetica della lotta armata che è qualcosa di inquietante dal momento in cui trascende la necessità assoluta di difesa. Dilaga un furor bellicus (Taviani 2012) che sottende la valorizzazione culturale di un modello comportamentale militare che sarebbe il caso di disarmare, prima che i danni diventino incontenibili.
In questo va chiarito che la resistenza armata del Novecento è stata necessaria in quanto l’empietà di Hitler, le sue intenzioni di sterminio e di dominio erano assolute e assolutamente non disposte a compromessi negoziali, in quanto fondate su principi ideologici di superiorità razziale e su una concezione eliminazionista della vita che non potevano prevedere negoziazioni, dialogo. Oggi le cose non stanno così. Putin, al netto del suo inaccettabile autoritarismo imperialista, non è empietà assoluta e sete assoluta di dominio e sterminio. Per questo il conio retrotopico della Reductio ad Hitlerum è eccessivo e può essere fuorviante.
Se nella Seconda guerra mondiale la lotta per la patria era per lo più realmente lotta indispensabile per la vita, successivamente abbiamo capito che quando l’amor di patria diventa eccessivo si trasforma in nazionalismi tossici del tutto deprecabili. Abbiamo capito che la lotta per la patria non è la conditio sine qua non per un «diritto a una buona vita» (Butler 2013); diritto questo che, dopo i disastri del secolo scorso, stavamo faticosamente provando a immaginare in percorsi di lotta per la giustizia sociale non necessariamente vincolati a costrutti identitari quali quelli dati da certi apriori nazionalistici. Nella Seconda guerra mondiale prendere le armi fu necessario. Viceversa, nella Prima guerra mondiale l’interventismo – che comunque si giustifica presentandosi sempre con alti fini e come necessità imprescindibile di pace – fu una scelta tanto evitabile quanto nefasta, che fece esplodere il conflitto a livello mondiale. A quel mandare a morte milioni di giovani per la patria si legava proprio la pulsione di morte che ci indicava Freud, e che ora dovremmo riconoscere nella sua evitabile pericolosità.
 In tal senso gli invasi vanno difesi dagli appetiti imperialistici degli invasori; ma andrebbero tutelati, insieme all’umanità intera, anche dall’invasamento nazionalista che oggi è tornato improvvisamente a contagiare gli animi più del dovuto. Oggi non c’è la necessità di far finire il mondo in un bagno di sangue per liberarsi dal male assoluto. Il richiamo continuo a questo scenario di sacrificio è qualcosa che si è visto nel Novecento con la cultura dei kamikaze, è una cifra del peggiore presente storico, che abbiamo visto negli ultimi anni manifestarsi in termini essenzialmente jihadisti, e che ora si propone in forma secolarizzata in un culto nazionalista di bandiera e confini. Forse è il caso di chiederci se non stiamo piombando dentro un orizzonte pericoloso che è evitabile, anche e prima di tutto per il bene delle stesse persone che soffrono in Ucraina in questo momento. Sono le persone che vanno salvate, i corpi delle persone vengono prima delle bandiere e dei confini. Se a volte è necessario difendere i confini per salvare le vite umane, altre volte la difesa dei confini può trasformarsi in un eccesso nevrotico che finisce con l’uccidere le persone.
In tal senso gli invasi vanno difesi dagli appetiti imperialistici degli invasori; ma andrebbero tutelati, insieme all’umanità intera, anche dall’invasamento nazionalista che oggi è tornato improvvisamente a contagiare gli animi più del dovuto. Oggi non c’è la necessità di far finire il mondo in un bagno di sangue per liberarsi dal male assoluto. Il richiamo continuo a questo scenario di sacrificio è qualcosa che si è visto nel Novecento con la cultura dei kamikaze, è una cifra del peggiore presente storico, che abbiamo visto negli ultimi anni manifestarsi in termini essenzialmente jihadisti, e che ora si propone in forma secolarizzata in un culto nazionalista di bandiera e confini. Forse è il caso di chiederci se non stiamo piombando dentro un orizzonte pericoloso che è evitabile, anche e prima di tutto per il bene delle stesse persone che soffrono in Ucraina in questo momento. Sono le persone che vanno salvate, i corpi delle persone vengono prima delle bandiere e dei confini. Se a volte è necessario difendere i confini per salvare le vite umane, altre volte la difesa dei confini può trasformarsi in un eccesso nevrotico che finisce con l’uccidere le persone.
Più in generale, nel nostro presente storico, le società occidentali e soprattutto europee sono scisse culturalmente in due, in una schizofrenia derivata dal trauma della Shoah e dell’emergere del dramma del colonialismo. Da una parte, c’è un netto rifiuto progressista dei patriottismi e una venerazione dell’abbattimento dei confini che a volte è anche frettolosa, eccessiva nel suo rimandare a un rifiuto esotista che degenera in autolesionismo antioccidentale, in oicofobia (ossia in odio culturale della propria civiltà). Dall’altra parte, riemerge sempre più forte un conservatorismo nostalgico che seguita a cullarsi in ideali identitaristi di chiusura per molti versi ormai superati in quanto xenofobi prima che antistorici (Ciccozzi 2021b).
Dopo il massacro della Seconda guerra mondiale in Europa grazie a uno sforzo della cultura progressista abbiamo depotenziato l’ingiunzione a morire per la patria che invece adesso torna dall’Est in modo prepotente e ambivalente, nascondendo, sotto il profumo di libertà e democrazia con cui si presenta, un olezzo etno-nazionalistico che ricorda proprio i sentimenti fascisti di chiusura assoluta all’altro, di pretesa omogeneità culturale e identitaria di cui si dovrebbe diffidare. Dovremmo comprendere questa doppiezza. Dovremmo capire che tra Russia e Ucraina da anni crescono ardori di reciproca xenofobia; passioni che questa guerra non farà altro che far lievitare, tantopiù quanto più sarà protratta con il fine di vincerla, in luogo che fermata il prima possibile. Dovremmo capire che sia l’Ucraina che la Russia coltivano un protagonismo pericoloso, una fissazione epocalista di stare al centro del mondo, una convinzione ideologica di avere una missione storica di salvezza del mondo dal male. Si tratta di sentimenti politici che hanno sempre prodotto disastri storici.
Se riusciremo a sventare i rischi dell’escalation mondiale e nucleare del conflitto, ci sarà da lavorare in un’Europa in crisi energetica, appestata dall’etnonazionalismo che arriverà dalla palude ucraina, ammorbata da fascismi esotici di matrice jihadista che ci ostiniamo a non vedere, come non vediamo da anni l’odio antioccidentale che lievita nel mondo (Ciccozzi 2021a). Il rischio è quello di finire in un’Europa impoverita e sospesa tra banlieueizzazione delle città e balcanizzazione dei confini in un pianeta sempre più appestato dalle guerre e in crisi climatica, mentre l’umanità seguita ad aumentare di ottanta milioni di persone ogni anno dai Paesi del Sud del mondo. L’impressione è che ci stiamo allontanando gravemente dai difficili propositi di sostenibilità che ci eravamo da poco prefissati.
L’iperrealtà delle rappresentazioni di guerra
Come atto tanto reale quanto simbolico, il massacro di Bucha, emerso il primo aprile 2022, ha inaugurato la fase della spettacolarizzazione mediatica degli orrori di guerra, del sangue messo in scena come argomento di mobilitazione e schieramento dell’opinione pubblica in direzione dell’atlantismo interventista, a sostegno dell’Ucraina e contro la Russia, per favorire la diffusione dell’idea che la guerra debba essere non fermata ma vinta. In linea con l’obiettivo di sconfiggere la Russia per punirla di un’empietà imperialistica che viene raccontata alle masse come se fosse una sua esclusiva nazionale, il non limitarsi all’indignazione di fronte alle quotidiane immagini di sofferenza, il semplice richiamo alla prudenza, l’avvertire del rischio di escalation bellica, l’evocare la minaccia nucleare è finito per essere inteso come segno di cedimento e complicità filo-putiniana.
All’improvviso, dopo trent’anni di recenti conflitti censurati dallo spettacolo del dolore, di fronte al sangue di guerra con cui tutti i telegiornali hanno iniziato a condire i pasti quotidiani delle famiglie occidentali, qualsiasi disallineamento rispetto alla scelta politica dell’invio di armi a sostegno bellico dell’Ucraina, o, peggio ancora, il solo farsi venire il dubbio che siamo di fronte anche a una guerra di prossimità diretta dagli USA, viene inteso come vile atto di appoggio alla Russia. Così, una volta circondati dalle immagini di morte che affollano i palinsesti televisivi, la paura di essere additati quali sostenitori e alleati di un sanguinario dittatore tende a scoraggiare una cultura della pace che sia in grado di parlare più di negoziati che di armamenti.
In tal senso va fatta una riflessione sulle emozioni suscitate da quello che è un martellamento propagandistico senza precedenti per intensità e diffusione, a partire da una constatazione: il conflitto in Ucraina è anche un grande spettacolo globale, è la guerra più spettacolarizzata della storia dell’umanità, è la prima guerra internet dove il metaverso, come campo dell’informazione interattiva dei social, è uno dei campi di battaglia. Jean Baudrillard ci ha spiegato che nella società dell’immagine i mass media trasformano il reale in iperreale, ossia coprono il reale con una patina superficiale che lo domina (Baudrillard 1996). Le immagini delle vittime della guerra non solo sono reali, nella loro ovvietà (qualcuno pensava che la guerra non fosse questo?) diventano iperreali attraverso la loro rappresentazione mediatica. Se quel reale sia stato in qualche modo riadattato a una scena rappresentazionale non è questione dirimente: la mediazione del reale è sempre messa in scena, scelta prospettica, orientamento dello sguardo, ma questo non toglie nulla all’evidenza che quei corpi sono morti di un male che si chiama guerra, e non toglie nulla al fatto che la malattia della guerra è una malattia contagiosa.
Oggi questa patina è prodotta dallo “spettacolo del dolore” (Boltanski 2000). Lo spettacolo del dolore è un velo che comprime la realtà selezionando parte del reale e presentando tale selezione come il tutto, imponendo così alla realtà l’unico piano narrativo manicheo della lotta del bene contro il male. Atto questo che riduce tutta la complessità del reale al costrutto iperreale dell’opposizione assoluta vittima/carnefice, gesto che comanda che il corpo della vittima sia l’unico sguardo possibile verso il mondo. Il tutto nel dominio di un’empatia selettiva, in cui, nell’affollatissimo scenario delle guerre del dopo muro di Berlino, ad alcune vittime capita la ventura di essere notiziate sul piedistallo del maistream, mentre altre restano dimenticate nel cono d’ombra di guerre che forse non conviene politicamente mettere in scena.
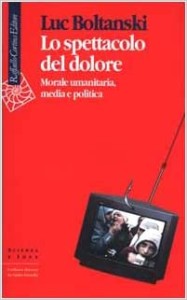 E va ribadito che, nel caso ucraino, attraverso l’iperrealtà dello spettacolo del dolore veniamo persuasi dell’idea che per salvare quei corpi sia assolutamente necessario salvare la nazione, l’identità, l’integrità territoriale, i confini, la bandiera dell’Ucraina. Ci illudiamo che quei corpi siano l’Ucraina e, proprio a partire da questa trappola metonimica, cadiamo nella trappola emozionale dell’ingiunzione a morire per la patria, in una visione intrisa di sentimenti di martirio in guerre sante che somigliano più al fanatismo che a ciò che chiamiamo Ragione; il lume che oggi rischia di spegnersi, per come si va sempre più inzuppando di un furore che stavamo storicamente cercando di superare attraverso uno sforzo prima di tutto scientifico-umanistico.
E va ribadito che, nel caso ucraino, attraverso l’iperrealtà dello spettacolo del dolore veniamo persuasi dell’idea che per salvare quei corpi sia assolutamente necessario salvare la nazione, l’identità, l’integrità territoriale, i confini, la bandiera dell’Ucraina. Ci illudiamo che quei corpi siano l’Ucraina e, proprio a partire da questa trappola metonimica, cadiamo nella trappola emozionale dell’ingiunzione a morire per la patria, in una visione intrisa di sentimenti di martirio in guerre sante che somigliano più al fanatismo che a ciò che chiamiamo Ragione; il lume che oggi rischia di spegnersi, per come si va sempre più inzuppando di un furore che stavamo storicamente cercando di superare attraverso uno sforzo prima di tutto scientifico-umanistico.
Così, nella cerimonializzazione mediatica degli eccidi, i morti non vengono tanto pianti quanto urlati in faccia a chi chiede di non mandare più armi: i loro corpi finiscono messi in scena reiteratamente in una captatio cadaveris che tradisce una pornografia della sofferenza usata per infettare le masse di una pulsione di morte che arriva ad illudere della più demoniaca delle convinzioni: l’assioma della necessità assoluta di andare in guerra come unico mezzo per la pace. In questo modo il dolore viene sistematicamente convertito in furore e confezionato in un cordoglio tanto enfatizzato quanto posticcio che chiede non redenzione ma vendetta, il cui fine non è portare a un sentimento di pietas ma alimentare invasamento, odio verso il nemico.
Occorre riflettere meglio su questa modalità in base a cui i cadaveri messi in scena nello spettacolo del dolore vengono utilizzati come trigger, come innesco che spinge a legittimare l’intervento bellico passando per l’indignazione di massa. Non a caso, subito dopo l’eccidio di Bucha – enfatizzato dal mainstream con il termine iperbolico ‘genocidio’ – su “La Stampa” Andrea Margelletti che, al lato di una foto con due cadaveri buttati su una strada, ha tuonato un solenne “ora basta. Mandiamo all’Ucraina tutti i carri armati, blindati e gli aerei di cui ha bisogno”; ossia ha invocato implicitamente un imperativo sostanziale assai chiaro che per coerenza gli interventisti dovrebbero rivelare apertamente: dichiarare guerra alla Russia.
Questo uso del sangue per rappresentare la scelta della guerra come necessità imprescindibile per la pace è falso ed estremamente pericoloso. Pertanto, c’è da stare attenti alle immagini, c’è da evitare che gli immaginari siano colonizzati dallo spettacolo del dolore finalizzato alla politica del furore. L’impressione è che ci troviamo di fronte a una surreale divisione del lavoro bellico tra chi manda armi e chi le usa, una separazione che rimanda a una dissociazione delle emozioni tra l’adrenalina del fronte davanti al nemico che si converte in dopamina dello spettatore davanti allo schermo. Questo perché sotto lo spettacolo della guerra cova un rito sacrificale dove la visione del martirio ucraino induce un senso di colpa e un furore espiatorio che si risolve nell’interpretare il ruolo virtuale dei paladini-salvatori attraverso il sostegno belligerante indiretto, e questo coinvolgimento parziale in cui noi mettiamo le armi e altri mettono i corpi finisce con il riprodurre il senso di colpa che dovrebbe lenire. Così si configura un orizzonte di debito morale in cui la vittima ucraina salvata dalle nostre armi si trasforma nel salvatore della nostra democrazia. Il “voi sparate per noi che vi diamo le armi” diventa un “noi moriamo per voi, e questo traccia un implicito “vi chiediamo obbedienza” come contropartita espiatoria per il sacrificio altrui commissionato dall’invio di armi con cui si delinea e si chiude il dramma di un Occidente colonizzato e invaso dalla simbologia etno-nazionalistica di morte della vicenda ucraina.
Mentre la distruzione prosegue, ci dovremmo chiedere se ci conviene obbedire a questo strisciante imperativo categorico di fondo che, nel mascherare la guerra con parole di pace, ci comanda di farci, più del necessario, l’Ucraina alleata e la Russia nemica. Si può condividere o meno la prospettiva per cui, intorno alla guerra d’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, vi sia una guerra di prossimità che il blocco atlantista sta combattendo contro la Russia; il punto è che, di fatto, al momento il campo delle ostilità si traduce anche in una politica di avvicinamento dell’Ucraina all’Europa (mentre scrivo arriva da Bruxelles il sì per la candidatura dell’Ucraina all’UE), e un’intenzione di allontanamento economico, energetico e culturale dell’Europa contro la Russia (subito dopo l’inizio del conflitto si è prospettata l’intenzione di un distacco totale dell’Europa dai combustibili fossili russi in nome della difesa della democrazia, a costo di legarsi a dipendenze verso Stati meno democratici della Russia). Qui va sottolineato che tutto questo dal punto di vista dei russi viene inteso come una manifestazione eccessiva, ingiustificata e provocatoria di russofobia, a cui si risponde coltivando sentimenti di odio contro l’Occidente. Non a caso, a proposito di questo uso generalizzato e assillante dalla reductio ad hitlerum, le autorità russe hanno dichiarato che l’Europa e la Nato starebbero mettendo insieme una coalizione per fare «una guerra alla Russia come provò a fare Hitler». È evidente che da entrambi i lati del fronte si sta reiteratamente brigando per costruire separazione e discordia.
Va comunque evidenziato che in questi processi di persuasione propagandistica all’invasamento di guerra si delinea una spaccatura tra la narrazione mainstream – che si propone come vera, oggettiva, giusta, attribuendo la propaganda solo alla Russia – e la risposta che viene dalla popolazione, soprattutto a livello di social media. Fa impressione in tal senso notare come i post social con cui i principali quotidiani italiani sostengono l’invio di armi siano bombardati regolarmente da commenti di utenti che in grande maggioranza dissentono fortemente dall’interventismo. Tale divisione dell’opinione pubblica trova riscontro anche in tutti i sondaggi commissionati dai talk show e dalla stampa, che attestano regolarmente che solo circa un terzo della popolazione italiana è favorevole alla politica della NATO e all’invio di armi in Ucraina. Va notato che questo svela che viviamo nel paradosso dell’alimentare una guerra dichiarando il fine di voler difendere la democrazia e il principio di autodeterminazione e sovranità popolare, mentre facciamo ciò proprio contro la volontà del popolo che eleviamo a valore sacro. La gente la guerra non la vuole, e seguita a non volerla in larga parte; ma questo non conta, non viene fatto contare, come in una autocrazia qualsiasi.
 Escalation, schismogenesi, rassicurazionismo
Escalation, schismogenesi, rassicurazionismo
L’impressione sempre più diffusa è che siamo di fronte a una matrioska bellica in cui, sopra lo strato della deprecabile guerra d’invasione della Russia all’Ucraina, il blocco atlantista sta conducendo una altrettanto deprecabile guerra glocale contro la Russia, una proxy-war che l’Occidente è disposto a combattere “fino all’ultimo ucraino”. Nel pretesto poetico della difesa della bandiera e dei confini ucraini si sta perseguendo una politica di distruzione territoriale e il sacrificio di vite umane, si sta scegliendo il rischio di una crisi sistemica globale energetico-alimentare e il pericolo che la guerra diventi un conflitto di lunga durata, continuamente esposto all’escalation mondiale e nucleare (minaccia che non è mai stata così elevata nella storia dell’umanità). Quella del rischio dell’olocausto nucleare non è una paranoia allarmistica, viceversa è pericolosamente rassicurazionistico rimuovere dall’immaginario collettivo questo rischio, ciò in quanto proprio questa rimozione disinibisce condotte pericolose che finiscono con il propiziare l’escalation. Il rassicurazionismo è rimozione del rischio, e si tratta di una reazione di difesa pericolosa. Non ci rendiamo conto che dovremmo chiederci fino a che punto vale la pena sacrificare vite umane, distruzioni e rischiare l’escalation apocalittica, non lo facciamo, quando invece dovremmo domandarci se il mantra del sacrificio per la patria ha implicitamente assunto un valore assoluto.
Con i mesi che passano appare sempre più chiaro che l’invio costante di armi all’Ucraina è finalizzato a mettere in difficoltà la Russia, a indebolirla in modo significativo (fino alla sua sconfitta, è stato più volte dichiarato). Si auspica di arrivare a ciò cercando di rimanere sotto la soglia di una reazione nucleare, ma il punto è: si riuscirà a rimanere entro questa soglia di equilibrio in una guerra di logoramento evitando l’escalation? Si riuscirà a tenere la corda alla tensione di massimo carico prima che si spezzi? Si riuscirà a fare ciò per un tempo che appare sempre più programmato verso una dilatazione indefinita? A voler usare una chiave di lettura batesoniana, ad oggi il paradosso dell’ingiunzione doppio-legante del chiedere la pace e mandare le armi, oltre al somigliare sinistramente alla contraddizione ancora troppo poco ragionata dell’esportare la democrazia con le bombe, porta a un processo di schismogenesi simmetrica, ossia a una dinamica conflittuale in cui si assiste a una scissione dove le due entità coinvolte entrano in risonanza, in un’amplificazione del tipo aggressivo-aggressivo, un processo catastrofico in cui ciascuna delle parti in causa aumenta il carico di aggressività in risposta all’aggressività della controparte, fino al collasso del sistema (Bateson 1977). È quello che nel linguaggio comune si intende con l’espressione “gettare benzina sul fuoco”. E da entrambi i lati del fronte si getta benzina sul fuoco. Questo rischio è sostenibile? Non è pericolosamente rassicurazionistico pensare di poter sconfiggere la Russia senza mettere in conto il rischio di una reazione nucleare, che peraltro i russi minacciano? Non è delirio rassicurazionistico derubricare questa eventualità da rischio concreto a bluff?
Riusciremo a fermarci prima di finire nel baratro? Qual è il limite? Al momento nessuno lo sa. Penso solo che poco più di un mese fa l’imprenditore Carlo De Benedetti aveva dichiarato che il sostegno all’Ucraina è contro gl’interessi dell’Europa, che l’Europa dovrebbe pensare a fermare la guerra anziché alimentarla inviando armi. Invece la NATO a cui l’Europa appare del tutto assoggettata, ha appena dichiarato che dobbiamo prepararci a una guerra che può durare anni, mentre Zelensky, come sempre, ribadisce che non cederà nessun territorio alla Russia, che la guerra la vincerà l’Ucraina (che significa che la Russia la dovrà perdere). Dal lato opposto, i russi dai loro talk show accusano l’Occidente di odio, di usare da anni l’Ucraina per una guerra di prossimità contro di loro. Le televisioni russe annegano in un clima di grottesca propaganda, ma tutto ciò che viene dalle televisioni russe è mera propaganda? Non vi è propaganda nei media mainstream occidentali? Il premier Mario Draghi, in ossequio al dominio cognitivo dell’opposizione invasi/invasori, ha illustrato quello che, a suo dire, sarebbero i due punti di vista, gli unici possibili, che si fronteggiano sull’Ucraina: «Uno è quello mio, l’Ucraina si deve difendere, e le sanzioni, l’invio di armi, servono a questo. L’altro è diverso: lasciamo che l’Ucraina si sottometta». Non sono d’accordo. Non sono d’accordo non solo perché credo che il proposito della difesa dei confini nazionali non sia un valore assoluto, sacro, ma una questione da mettere in relazione con il rischio che la guerra contagi il mondo fuori da quei confini e assuma una forma apocalittica. Non sono d’accordo perché penso che l’idea che la resistenza a un invasore armato che vuole imporsi come regime non possa essere nient’altro che resistenza armata sia fuorviante e pericolosa: questa concezione esclude la possibilità che la resa possa essere solo bellica e aprire a una stagione di resistenza politico-culturale sul medio e lungo termine.
Che sarebbe successo se quattro mesi fa l’Ucraina si fosse “sottomessa” militarmente alla Russia? Putin, come suggeriscono vari opinionisti, avrebbe sterminato tutta la popolazione e distrutto tutto il territorio? Non credo, e credo che convincersi di questo sia proprio cadere nella propaganda che inculca invasamento bellicista imponendo un si vis pacem para bellum eccessivo e orientato a fini meno nobili di come si presenta. Penso che se non avessimo imboccato la strada dell’escalation glocale della guerra in Ucraina in questo caso avremmo risparmiato migliaia di vite, avremmo evitato un’immane distruzione territoriale e una crisi economica dilagante, insieme a un presente di gravi rischi di contagio bellico. Sarebbe stata resa totale? No, non necessariamente: gli ucraini avrebbero potuto iniziare una resistenza politica e culturale contro il regime di Putin, magari anche insieme ai russi; a tutti i russi che avrebbero voluto un cambiamento e che invece oggi si sono riavvicinati al regime di Putin come reazione a quello che percepiscono in termini di odio russofobico occidentale. Penso che questa resistenza sarebbe potuta diventare imponente se avesse avuto solo una parte minima del colossale sostegno economico che oggi diamo alle armi (una marea di soldi che sono apparsi improvvisamente, che in questi anni non ci sono mai stati per salvare tanta gente dalla fame o certe nazioni dal default economico). Invece oggi tra ucraini e russi la morte e la distruzione portate dall’intensificazione degli scontri armati hanno prodotto un muro di odio che durerà per generazioni e che rischia di infettare l’Europa di un invasamento che poteva essere evitato.
Mentre chiudo quest’articolo leggo che gli USA si apprestano a inviare altri 450 milioni di dollari in armi in Ucraina. La sensazione è sempre di più quella per cui l’Ucraina si sia trasformata in uno Stato mercenario in cui si combatte una guerra per procura contro la Russia preparata prima del 2022, e dove, dal lato suo, la Russia combatte una guerra contro l’Occidente che covava da anni. Tutto questo per contendersi le risorse che sono in ballo in questa partita e per ridefinire equilibri energetici e geopolitici globali. Tutto questo a beneficio prima di tutto dell’industria bellica, in un mondo che rischia di andare in fiamme di fronte a una guerra che si poteva evitare mentre si è lavorato per presentarla all’umanità come necessità imprescindibile. La sensazione è che la guerra in Ucraina sia stata scelta e sembra che non si voglia far finire su un tavolo negoziale ma protrarre in modo indefinito. Tutto questo significa che si proseguirà con le distruzioni territoriali e la morte delle persone, ed è orrendo. È doppiamente orrendo perché poteva e potrebbe essere evitato.
Disclaimer
Dato il clima ideologico-propagandistico di polarizzazione e di caccia alle streghe che ha avvolto il posizionamento su questa vicenda, dove qualsiasi disallineamento rispetto all’interventismo atlantista viene derubricato a filo-putinismo antidemocratico e antioccidentale, preciso a chiare lettere che personalmente non sono a favore del sostegno bellico all’Ucraina contro la Russia attraverso l’invio di armi. Sono però anti-putiniano, penso che l’autocrazia russa sia un regime essenzialmente orrendo, e ragiono non in base a un risentimento contro l’Occidente ma, all’opposto, a tutela di interessi europei che spesso ritengo non coincidano con quelli atlantisti, prima che con quelli del nazionalismo ucraino. In questo rivendico il diritto di una posizione di neutralità negoziante, respingendo le accuse di schieramento filo-russo che vengono regolarmente affibbiate a chi si dichiara contro l’invio di armi in Ucraina. Ritengo che l’Europa dovrebbe essere neutrale, che dovrebbe stare a distanza politica dalla Russia, dall’Ucraina, dagli USA e dalla NATO; una distanza di sicurezza che gli consenta autonomia, invece della sudditanza a cui è costretta oggi. In questo condanno fermamente l’invasione Russa dell’Ucraina del 2022 ma condanno anche l’aggressione Ucraina delle minoranze russofile iniziata dall’allontanamento dalla Russia, e le pressioni geopolitiche della NATO verso Est iniziate da dopo la caduta dell’URSS.
Dialoghi Mediterranei, n. 56, luglio 2022
Note
[1] https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_192489.htm?selectedLocale=en
[2] Foreign Affairs18/08/2014.
[3] https://www.la7.it/piazzapulita/video/i-filosofi-e-il-cretino-il-racconto-di-stefano-massini-05-05-2022-437063?fbclid=IwAR2KsF-yVDGojCtxPNePsQK4e2bnQ8vYLHQ7goelA01pCS6TgRAZllImmF8
[4] Va qui notato la vicenda degli eccidi in Donbass, dopo essere stata rimossa per otto anni, inizia ad essere rovesciata in una narrazione in chiave anti-russa (a partire dalla rilettura ufficializzata dal documento del G7 del 5 maggio 2022).
Riferimenti bibliografici
Bateson, G., 1977, Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi.
Baudrillard, J., 1996, Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Bloch, M., 1995, I re taumaturghi, Torino, Einaudi.
Boltanski, L., 2000, Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Butler, J., 2013, A chi spetta una buona vita?, Roma, Nottetempo.
Caillois, R., 2001, L’uomo e il sacro, Torino, Bollati Boringhieri.
Ciccozzi, A., 2021 (a), “Il rischio dei muri degli altri. Cirese, dislivelli di cultura e rimossi antropologici”, Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio, Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-rischio-dei-muri-degli-altri-cirese-dislivelli-di-cultura-e-rimossi- antropologici/.
Ciccozzi, A., 2021 (b), “Migrazioni, cittadinanza, polarizzazioni”, Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre, Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/migrazioni- cittadinanza-polarizzazioni/
Debord, G., 2008, La società dello spettacolo, Milano, Baldini Castoldi Dalai.
Dugin, A., 2019, Teoria del mondo multipolare, Cusano Milanino, Editore AGA.
Freud, S., 1977, Al di là del principio di piacere, Torino, Bollati Boringhieri.
Fukuyama, F., 1992, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli.
Geertz, C., 1988, Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino.
Girard, R., 1980, La violenza e il sacro, Milano, Adelphi.
Huntington, S., 1997, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano, Garzanti.
Lanternari, V., 1989, Festa carisma apocalisse, Palermo, Sellerio.
Le Bon, G., 2004, Psicologia delle folle, Milano, Edizioni TEA.
Propp, V., 2000, Morfologia della fiaba, Torino, Einaudi.
Taviani, P., 2012, Furor bellicus. La figura del guerriero arcaico nella Grecia antica, Roma, FrancoAngeli.
_____________________________________________________________
Antonello Ciccozzi, è professore associato di Antropologia culturale presso Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. Si è laureato con una tesi sulla teoria ciresiana dei dislivelli di cultura. S’interessa dei processi di rappresentazione sociale della diversità culturale, di causalità culturale in ambito giuridico, di antropologia del rischio, dell’abitare, delle istituzioni, della scienza, delle migrazioni. Ha svolto ricerche etnografiche nell’Appennino rurale, in contesti di marginalità giovanile urbana, in ambito post-sismico, in luoghi di lavoro precario dei migranti.
______________________________________________________________