Da pochi mesi è disponibile il volume di Konstandinos Kavafis, Tutte le poesie (a cura di Paola Maria Minucci, Donzelli Poesia, 2019). Ne parlano in recensioni impegnate giornali e trasmissioni, con i diversi accenti che li caratterizzano: 19 ne annovera il sito dell’editore, dal dicembre 2019.
Kavafis, vissuto tra il 1863 e il 1933, è riconosciuto nel mondo come autore padre e testimone della poesia contemporanea, tema anche frequente di tesi di lauree. È un grande richiamo anche per me, nell’ambito dei due interessi cui mi dedico, quello per la poesia e quello per la storia. Qui mi limito a condividere la gioia di questo traguardo editoriale, avviando riflessioni sull’epoca di Kavafis. Ritrovo per altro situazioni d’epoca in un mio studio, su cui posso fare verifiche (Bellucci 2012).
Un libro-evento, questo presentato dall’editore Donzelli, infatti finora l’accesso in italiano a Kavafis era rimasto parziale. Se dal 1961 del poeta si leggevano per Mondadori, nella traduzione di Filippo Maria Pontani, le 154 poesie canoniche, base per molte osservazioni di intellettuali e poeti, non erano complessivamente presentate in lingua italiana le altre 111 definite “nascoste” o “rifiutate”, che, reperite dal letterato e amico dell’autore Iorgos Panu Savvidis, dal 1993 in lingua greca sono disponibili. È questa infine l’opera che risana la lacuna. Del successo gran merito va a Paola Minucci, curatrice e traduttrice, per la quale lo studio intorno a Kavafis è un filo conduttore importante.
In precedenza molti critici italiani hanno parlato dell’autore come uno dei fondamenti, per lo più però basandosi sulle letture in traduzione italiana, riconoscendovi uno o più degli “ismi” che illudono di dare fermi referenti agli snodi letterari. C’è chi insiste a fissarlo su sfondo esotico, secondo il cliché, pur se abbastanza usurato, dell’Orientalismo, chi vi riconosce l’ultimo ammiratore del tempo ellenistico, che fu antecedente e modello per l’Impero Romano, chi lo incornicia esploratore dei sensi come se fosse fermo sulla consonanza con Baudelaire, espressa, ma per un tempo limitato, nelle prove effettuate al passaggio dei due secoli, il XIX e il XX.
Al primo impatto, del ponderoso volume (714 pp., di cui 40 di apparato, comprensivo di note, saggio critico della curatrice, nota biografica, bibliografia), si apprezza il nitore, l’essenzialità. Le note, succinte e meramente critico-filologiche, si condensano dopo il testo poetico in sole nove pagine. Questo stimola come lettrice, ne ricevo quasi incoraggiamento e energia interiore. La curatrice esprime pieno rispetto per la volontà dell’autore, riportandone le sillogi così come reperite nelle carte rimaste, aggiungendo però attenzione al riferimento temporale, con un accenno, al termine di ogni brano, alla data presunta. È però in appendice, la sezione di poesie più antiche, le cui date suggerite sotto interrogativo sono fra 1877 e 1882: poesie in lingua inglese, la lingua prima usata da Kavafis, poiché ebbe cittadinanza inglese e assimilò lingua e cultura inglesi quando la famiglia, rimasta orfana del padre, dopo il 1870, si trasferì in Inghilterra per sette anni. In tutta la vita poi usò l’inglese lavorando presso il Ministero dell’Irrigazione, essendo gli Inglesi occupanti da quando, contro la rivendicazione di autonomia degli Egiziani, nel 1882 avevano bombardato Alessandria.
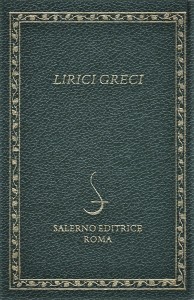 Scarni e sottili i suggerimenti di Minucci, sfogliando il libro, una lezione di sobrietà: di fronte alle pagine testuali possiamo sentirne la preziosità proprio in quanto dobbiamo pensarle scampate a cancellazioni e distruzioni. Le poesie accantonate – krymmèna poièmata – come in un’arca serbata per occasioni da avvenire, per incontri non ancora maturi, insieme con le poesie non riconosciute – apokerygmèna poièmata –, dimostrano come Kavafis fosse letterato consapevole, che del suo apporto alla cultura ebbe chiaro l’orizzonte, e il suo contributo poté dispensarlo con misura. Altri frammenti potrebbero ritrovarsi, cercando: già si sa di 30 abbozzi, avverte Minucci, che Renata Lavagnini ha già studiato, pubblicati a Atene nel 1994 e tradotti in italiano nel 2015, presso l’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici di Palermo.
Scarni e sottili i suggerimenti di Minucci, sfogliando il libro, una lezione di sobrietà: di fronte alle pagine testuali possiamo sentirne la preziosità proprio in quanto dobbiamo pensarle scampate a cancellazioni e distruzioni. Le poesie accantonate – krymmèna poièmata – come in un’arca serbata per occasioni da avvenire, per incontri non ancora maturi, insieme con le poesie non riconosciute – apokerygmèna poièmata –, dimostrano come Kavafis fosse letterato consapevole, che del suo apporto alla cultura ebbe chiaro l’orizzonte, e il suo contributo poté dispensarlo con misura. Altri frammenti potrebbero ritrovarsi, cercando: già si sa di 30 abbozzi, avverte Minucci, che Renata Lavagnini ha già studiato, pubblicati a Atene nel 1994 e tradotti in italiano nel 2015, presso l’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici di Palermo.
Kavafis e un corpus poetico, dunque, soppesato, distillato: da rivedere con mente sgombra. Ma davvero la mia sarà una “mente sgombra”? Non apprezzerei del resto un approccio casuale e immediato: è soprattutto la riflessione che libera dai pregiudizi, se pacata, senza che «sia affrettato il viaggio./ Meglio che duri a lungo»: come Kavafis dice nella celebre poesia Itaca. E la mia mente, può definirsi così? Ho avuto buoni mentori nel mio percorso di letture: come Luigi Enrico Rossi, intorno alla lirica della letteratura greca antica (essenziale e accattivante il “diamante” del 2015 di Salerno Editrice, Lirici Greci, a cura di Chiara Di Noi. Introduzione di Luigi Enrico Rossi. Appendice a cura di Enrico Cerroni).
Un’altra tappa formativa, imprescindibile pur se complessa, è il panorama di letteratura neogreca dal 1453, presentato come un intreccio complesso di fenomeni, in Mario Vitti, Storia della letteratura neogreca (Roma, Carocci, 2001). Qui molte sono le menzioni ritornanti di Kavafis. Diversa impostazione, lineare, scandita in incontri promemoria, offre nella misura dell’antologia il “Meridiano” Mondadori del 2010: Poeti greci del Novecento, a cura di Nicola Crocetti e Filippomaria Pontani (traduzioni di questo stesso letterato, nonché del padre, Filippo Maria Pontani, e di Nicola Crocetti).
A prima vista il saggio della curatrice Minucci, mi conferma sulle date cardini nel percorso di Kavafis: una è il soggiorno, concluso nel 1885, a Istanbul, vista come la soglia in cui l’autore si definisce come poeta, l’altra è il 1911 considerata come sbocco allo scavo interiore e alle scelte culturali, verso un realismo che intrama sicura introspezione su immagini desunte dalla storia: ed è questo l’esito più significativo e originale del poeta. Che nella piena maturità l’autore abbia queste piste, così da esprimere un sé riconosciuto e consapevole me lo palesò, scrivendomi, Tino Sangiglio, filologo greco che viveva e scriveva in Italia, quando per conto della rivista «Erba d’Arno» commentavo le sue plaquette per i poeti greci pubblicate per l’editore Passigli di Firenze: edizioni che ritrovo citate nella bibliografia. Sangiglio, avendo già cognizione ampia di Kavafis, coglieva la centralità della sua ispirazione storica, invece definendo “morali” (2007) i percorsi maturi della poesia più intima.
 Kavafis è letterato consapevole, secondo il saggio critico di Minucci. Egli confronta e torna a interrogare le sue intuizioni, con uno scritto di poetica del 1903, che si conferma nelle pagine del 1913 e ancora nel 1931. Quello che attiva poeticamente Kavafis è il concetto di una storia ampia, anticonvenzionale ma puntuale, quale, pur non ancora nota, era oggetto di studi in Inghilterra, e che Kavafis già conosce. Questa concezione poetica è intrisa delle trame ampie di una umanità che pur cambiando si conferma. Quel periodo-soglia, il 1911, era anche sosta per l’elaborazione profonda di sé: il poeta in modo sempre più continuo rendeva esplicita, accettandosi, la sua omosessualità. Questo, certo, contribuiva affinché l’uomo sentisse senza inibizioni il gusto del vivere, con stima di sé e degli altri.
Kavafis è letterato consapevole, secondo il saggio critico di Minucci. Egli confronta e torna a interrogare le sue intuizioni, con uno scritto di poetica del 1903, che si conferma nelle pagine del 1913 e ancora nel 1931. Quello che attiva poeticamente Kavafis è il concetto di una storia ampia, anticonvenzionale ma puntuale, quale, pur non ancora nota, era oggetto di studi in Inghilterra, e che Kavafis già conosce. Questa concezione poetica è intrisa delle trame ampie di una umanità che pur cambiando si conferma. Quel periodo-soglia, il 1911, era anche sosta per l’elaborazione profonda di sé: il poeta in modo sempre più continuo rendeva esplicita, accettandosi, la sua omosessualità. Questo, certo, contribuiva affinché l’uomo sentisse senza inibizioni il gusto del vivere, con stima di sé e degli altri.
Dicevo che Kavafis è conosciuto nel mondo. Eppure constato ancora una volta, solo della tradizione occidentale ho informazioni plausibili: non so la ricezione che ha in altre tradizioni, a partire da quella egiziana, né se ha determinato nuovi innesti. Resta comunque per me una sensazione inquietante il ritardo con cui il poeta – oggi così famoso – fu recepito in Italia. È vero che in generale la ricezione di Kavafis è stata ritardata, per il modo insolito, fuori del sistema editoriale, con cui egli impostò la produzione e la diffusione della poesia: marginale a lungo anche in Grecia, dove, malgrado un articolo entusiasta del critico G. Xenòpulos già nel 1903 (Vitti, 2001: 240) una sintonia superficiale si verificò al tempo della generazione dei poeti che vissero la delusione della guerra greco-turca, la “Catastrofe” del 1922, dopo che si era conclusa la Grande Guerra.
Infine, il significato più ampio e stabile di Kavafis è stato rilevato a metà Novecento da Iorgos Seferis, premio Nobel. Nella cultura anglosassone, però, aveva già un posto significativo, apprezzato e reso popolare in primo luogo dal romanziere inglese Edward Morgan Forster, presente a Alessandria con la Croce Rossa al tempo della Grande Guerra. Da allora il complessivo ambiente di cultura anglo-sassone si fece attento: T. S. Eliot conosce Kavafis, elaborando la prospettiva della sua poetica, il “correlativo-oggettivo”.
In Italia la ricezione è stata, si può dire, decisamente fuori tempo. Eppure, vivente Kavafis, molti erano gli italiani a Alessandria, e gli studi sempre più verificano che, come il greco era la lingua più comunemente usata, erano frequenti gli appuntamenti culturali con il poeta, ai caffè di Alessandria, specialmente intorno alla rivista «Ta Grammata». Una delle recensioni al libro, quella dell’Ansa, il 18 gennaio 2020, riferendo in sintesi di Kavafis, uomo affabile, definisce “amico” Ungaretti e viene dato merito a Marinetti di avergli reso visita e onore nel 1929, passando da Alessandria. Forse fu nel 1946 la prima attenzione poetica, dovuta a Montale con la traduzione di Aspettando i barbari: da allora altri hanno ritrovato tracce della antica amicizia, Ungaretti, Enrico Pea. Ma numerose e profonde davvero devono essere state le occasioni di contatti fra le sponde del Mediterraneo, radunando informazioni note: le armi italiane, regolari o volontarie, che approdavano a Creta o nel continente, guardando allo Stato di Grecia, nelle puntate, durate alcuni decenni, del progetto che doveva portare a confini accettabili; inoltre le traversate in mare, come quella di Scarfoglio e D’Annunzio sullo yacht “Fantasia” nel 1895, le spedizioni archeologiche, la progettazione dei teatri all’aperto, caldeggiata dal letterato Ricciotto Canudo, l’associazionismo politico, guidato da Angelo De Gubernatis e da Giuseppe Sergi, per la solidarietà Elleno-latina. In particolare ricordiamo l’istituzione a Alessandria del Museo greco-italiano, voluta da colti volontari italiani: con una prima concessione nel 1892 a Giuseppe Botti, filologo compagno di studi di Giovanni Pascoli, rinnovata nel 1903 a Evaristo Breccia. Su tali eventi ho raccolto documentazione nel saggio storico citato: dove si osservano insieme Italia e Grecia dal 1821 al 1915 attraverso documenti sulla cultura (Bellucci, 2012: 164-175).
Così, viene da considerare, se Kavafis è faro di poesia, la sua luce deve aver fatto un giro cosmico prima di palesarsi nella critica italiana. Una luce “intempestiva”, direi, che interroga la condizione delle lettere in Italia: certo, sperando che non sia né una volontà né un metodo, ma una conseguenza deprecata da collegare alle difficoltà contingenti del Novecento. Non entro nel merito: qui mi limito a sondaggi di ordine storico. È da questa prospettiva che mi sento di dire che in tale secolo a più riprese la cultura letteraria è stata collocata, e si è collocata, in una ottica di utilità pubblica, concordata nel “Ventennio fascista” con il potere politico. La letteratura pubblicata in quanto considerata importante verificava forme di funzionalizzazione verso la politica già prima del Novecento: consentiva con questa constatazione lo studioso Maurizio Bossi, che nella Presentazione, riferendosi alla rivista «Nuova Antologia», scriveva che in essa:
« … ben presto prevale il seguire e da parte sua esprimere la riscrittura della cultura nazionale italiana, e il richiamo alla Grecia porta con sé atteggiamenti critici, sempre più connotati da notevole pragmatismo di intenti, alla sua capacità di inserirsi nel contesto europeo. La sensazione italiana di essere alla periferia d’Europa … cede il passo alle ambizioni mediterranee nel concerto europeo, del quale la giovane nazione fa ormai parte come attore» (ivi: III).
Nel corso dello studio ho verificato che la Grecia, benché avesse innescato l’impegno politico e culturale dell’intera Europa quando aveva condotto la guerra di indipendenza dalla Turchia, diventò retrovia quando ciascuna delle comunità nei Balcani prese a progettare la propria indipendenza. Portare a compimento la costituzione dello Stato, anche nella complicazione dei tempi diversi, era stata la direttrice riconoscibile in Grecia, la “Megali Idea (grande idea)”, della comunità rinnovata, a costo di duri contrasti fra popolo e corona, e con sensibile incitamento da parte di altre comunità: in particolare quella degli Italiani. Ma anche l’Italia scelse, seguendo la nuova direttrice europea di fine Novecento, di isolare la Grecia. Leggendo la rivista «Nuova Antologia», le opportunità per l’Italia nei Balcani risultano cambiate in uno stretto giro, fra luglio e settembre 1901: non si sosterrà più il ricongiungimento con popolazioni che usano il greco, ma si escluderà «l’Albania meridionale, dal Golfo Ambracico al fiume Semeni» (i due autori: Francesco Guicciardini e “Victor” forse il Direttore, Maggiorino Ferraris). Lacerante fu poi la partecipazione della Grecia alla Grande Guerra, con lo schieramento divergente della corona, filotedesca, e del primo ministro Eleftherios Venizèlos, finché il re Costantino I abdicò in favore del figlio Alessandro. Infine, ne abbiamo già accennato, dalla delusione per la pace conclusa scaturì quell’aggressione alla Turchia che fu occasione della “Catastrofe” 1922, la sostituzione della popolazione turca a quella greca sulla costa anatolica.
Lungo questa linea segmentata i poeti in Grecia, disciplinati dalla élite colta in riviste accurate, mostrano un patriottismo acceso, esasperato dagli insuccessi e dai progetti incostanti delle grandi potenze. Questa cultura patriottico-nazionalista verifica una marcata divergenza da Kavafis, la cui ispirazione si apparta dalle manifestazioni prevalenti. Nella sua storia letteraria Vitti parla di Kavafis come fermo in un patriottismo non fanatico né retorico: egli – osserva riportando il giudizio del letterato G. Lechonitis – raramente ricorre all’enfasi: usa un linguaggio denotativo che evita espressioni generiche o il trasporto lirico (Vitti, 2001: 243).
La data del 1911, che ho segnato per Kavafis, è da annotare per l’Italia. Qui, dopo la morte di Carducci nel febbraio del 1907, gli ambienti più politicamente influenti incoraggiavano una letteratura, compresa la poesia, che affascinasse e esaltasse la popolazione, sì che questa si compiacesse e disponesse per una politica aggressiva. Nel 1911, celebrandosi il primo cinquantenario dell’Italia unita, tali ambienti interpretavano il nome di Roma come evocatore di conquista in direzione di quei tratti costieri dell’Africa che fossero in qualche modo consentiti: crescevano infatti le mire delle potenze europee militarmente e tecnologicamente forti. Poeti di grande livello e di grande cultura erano noti, e interessati a dialogare con la cultura europea nella ricerca espressiva: in particolare, G. Pascoli (1855-1912), cultore e innovatore nella classicità e, più esuberante, ambizioso, pronto a iniziative anche politiche individualiste e avventurose, G. D’Annunzio (1863-1936).
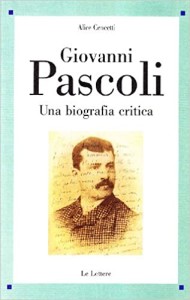 Morto Carducci, Pascoli fu protagonista di episodi in cui sembrava designato ad essere il cantore pubblico: nel 1911, cinquantenario dello Stato unitario, fu affidata a lui la celebrazione ufficiale di Roma, in lingua latina, con l’Hymnus in Romam. Pascoli era un cantore dalla voce originale, la cui immaginazione sapeva attuare nella storia documentaria innesti di personaggi d’invenzione. Il poeta evocava una umanità dimenticata cui prestava fragilità indagate dalla cultura psicanalitica contemporanea. Una tale particolare predilezione per la storia capillare, esplorata con attenzione, indica il Pascoli, fra i poeti italiani, come il più somigliante al Kavafis maturo. Per il porta italiano la storia diventa un ambito su cui può incrociare il tempo, la tradizione, lo scavo sull’essere umano: lo possiamo verificare in modo non occasionale sia nelle opere scritte in lingua latina, sia nei Poemi Conviviali del 1904 e 1905.
Morto Carducci, Pascoli fu protagonista di episodi in cui sembrava designato ad essere il cantore pubblico: nel 1911, cinquantenario dello Stato unitario, fu affidata a lui la celebrazione ufficiale di Roma, in lingua latina, con l’Hymnus in Romam. Pascoli era un cantore dalla voce originale, la cui immaginazione sapeva attuare nella storia documentaria innesti di personaggi d’invenzione. Il poeta evocava una umanità dimenticata cui prestava fragilità indagate dalla cultura psicanalitica contemporanea. Una tale particolare predilezione per la storia capillare, esplorata con attenzione, indica il Pascoli, fra i poeti italiani, come il più somigliante al Kavafis maturo. Per il porta italiano la storia diventa un ambito su cui può incrociare il tempo, la tradizione, lo scavo sull’essere umano: lo possiamo verificare in modo non occasionale sia nelle opere scritte in lingua latina, sia nei Poemi Conviviali del 1904 e 1905.
Il confronto Pascoli – Kavafis maturo ha una sua validità: per gli ambiti culturali, per la considerazione della storia, per il linguaggio personale, nuovo e denso, di originale significato. Ma i due poeti divergono molto su concetti come “patria-nazione” o “libertà”. Kavafis, direi, ridefinisce con originalità i due concetti sull’esperienza e la riflessione: pur informato della ricerca in atto nella Grecia, egli ha ideali diversi, recuperando dal passato ideale un’esperienza basata sulla convivenza attiva fra popolazioni mediterranee, che tralascia le divergenze ma verifica piuttosto lo scambio possibile. Non troviamo in lui echi del travaglio vissuto dai concittadini, cui abbiamo accennato.
In definitiva, però, se anche i due poeti avessero avuto elementi per conoscersi, è in particolare la funzione attribuita al tempo, la relazione fra cronaca e vita, che li rende palesemente divergenti. In Kavafis l’esperienza del tempo sembra costituita da attimi mobili e ritornanti, risultando proiettato su una vita scandita da intermittenza fantastica piuttosto che sulla morte. Non è così per Pascoli, in cui i critici avvertono che l’accento va sulla coscienza di ciò che, nell’evolversi, muore e si perde. Anche altri intellettuali italiani operanti in vari campi insistono sulla morte: verifichiamo, all’epoca, che ricorre il termine “esumazione”: il senso che gli si attribuiva, però, voleva proiettarsi, in una idea di vita ciclica, verso il riuso di forme, anche plaudendo ai recuperi archeologici (Bellucci,2012: 223).
Pascoli non divenne, se non marginalmente, il poeta scelto e privilegiato dal governo italiano per parlare alle masse. La celebrazione di Roma del 1911 era già pagina il cui risvolto era la guerra: a fine anno infatti fu organizzato sulla costa meridionale del Mediterraneo l’assalto a Tripolitania e Cirenaica. Pascoli fu pronto a celebrare l’evento come un passaggio glorioso e promettente in un discorso del 26 novembre 1911 a Barga, La Grande Proletaria si è mossa, che, diffuso con l’ampiezza utile, in effetti creò una prima frattura fra quanti nella popolazione avversavano la guerra. Ma, colpito allora da un male rapido e definitivo, morì nell’aprile successivo.
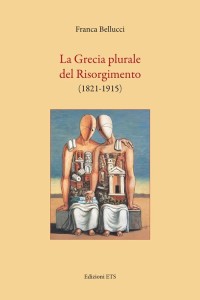 Un poeta alto la cui voce fosse utile al governo non ci fu: D’Annunzio ebbe sue linee interpretative, nel panorama culturale come in quello politico. Il governo italiano cercava la guerra: dopo le azioni del 1911, l’anno successivo operò l’incursione nel Dodecaneso. Volutamente si aprivano linee di frattura, che a partire dal Mediterraneo e dalla penisola Balcanica coinvolsero le formazioni statuali e politiche in modo ampio in quella Grande Guerra del 1914-18, le cui conclusioni non stabilizzarono affatto le relazioni, né fra i governi ufficialmente partecipi né nelle comunità dette “colonie”, con cui avevano relazioni.
Un poeta alto la cui voce fosse utile al governo non ci fu: D’Annunzio ebbe sue linee interpretative, nel panorama culturale come in quello politico. Il governo italiano cercava la guerra: dopo le azioni del 1911, l’anno successivo operò l’incursione nel Dodecaneso. Volutamente si aprivano linee di frattura, che a partire dal Mediterraneo e dalla penisola Balcanica coinvolsero le formazioni statuali e politiche in modo ampio in quella Grande Guerra del 1914-18, le cui conclusioni non stabilizzarono affatto le relazioni, né fra i governi ufficialmente partecipi né nelle comunità dette “colonie”, con cui avevano relazioni.
Di Pascoli come candidato ad essere guida poetica è raro che i nostri critici trattino: si preferisce considerare il discorso La Grande Proletaria si è mossa come una caduta occasionale. Ma si dovrà approfondire con animo sgombro, dopo che uno studio di Alice Cencetti (2009) ha documentato in modo approfondito la biografia di Pascoli. È con la relazione di questa studiosa che è stato inaugurato nel 2014 l’Archivio Pascoli (“Giovanni Pascoli nello specchio delle sue carte”). In questa biografia risulta che, prima di dedicarsi alla letteratura, egli aveva avuto esperienza politica rilevante, esercitando capacità retoriche e notevole ascendente accanto a Andrea Costa (1851-1910), uno dei fondatori del socialismo. L’attività politica dell’uomo acquista ora rilievo, in particolare constatando che nell’archivio di Castelvecchio sono conservate grandi quantità di riviste militari, che egli esaminava con interesse. Assunti questi dati, Fabrice De Poli (2016) ha studiato la relazione fra Pascoli e la guerra, rilevando che il poeta accetta la guerra anche di conquista attraverso la figura del soldato come rappresentante diretto, anche sacrificale, del popolo Come poesia esemplare De Poli propone Alle batterie siciliane, pubblicata in Odi e Inni nel 1906. Negli appunti che corredano il testo nell’Archivio Pascoli, risulta che «fu scritto per l’inaugurazione del monumento alla Batteria Masotto, avvenuta a Messina il 20 settembre 1899. La Batteria Masotto cadde eroicamente nella battaglia di Adua il 1° marzo 1896, durante la campagna d’Etiopia». Ecco una strofa (vv. 103-108): «Non odi qui l’urlo di guerra;/ qui l’orda dei Galla non vedi/ che viene e t’infrange. / No, reduce! Questa è la terra/ tua, questo è il tuo mare, ch’ai piedi/ tuoi batte e plaude e canta e piange».
Sullo schermo di vita di Kavafis passa pure la guerra, in eventi che marcano l’avvicendarsi dei periodi: non su questo il poeta indugia, ma sull’intreccio di culture che può verificarsi, secondo l’ideale della convivenza: «Accettiamo la verità una volta per tutte:/ siamo Greci anche noi – cos’altro siamo? – / ma con amori ed emozioni d’Asia, / ma con amori ed emozioni/ che a volte sono estranei all’Ellenismo» (Ritorno dalla Grecia).
 Il libro, dunque, offrirà terreno per ricerche molteplici. Un’altra possibile direzione di studio sarà quella sulla mobilità del punto di vista che Kavafis esercita: i suoi poemetti non di rado sembrano sceneggiature teatrali, o addirittura filmiche: anche in questo caso, credo, assumendo aspetti radicati in quella cultura inglese che ha assimilato. Vitti accenna a questa peculiarità: ci sono poesie in cui «parlano personaggi diversi da lui… (manifesta) quel dislivello di comprensione che è chiamato dagli specialisti ironia: una distanza che l’autore pone tra sé e il personaggio… (talora) parla in prima persona il poeta o un personaggio…segue le variazioni psichiche dell’io parlante, e che presuppone una certa azione in uno spazio ben preciso. In casi simili si ha una “imitazione” che può essere chiamata drammatica (i primi critici parlarono di “teatralità”)… il narratore pronuncia un monologo interiore che segue le proprie reazioni…» (Vitti, 2001: 242).
Il libro, dunque, offrirà terreno per ricerche molteplici. Un’altra possibile direzione di studio sarà quella sulla mobilità del punto di vista che Kavafis esercita: i suoi poemetti non di rado sembrano sceneggiature teatrali, o addirittura filmiche: anche in questo caso, credo, assumendo aspetti radicati in quella cultura inglese che ha assimilato. Vitti accenna a questa peculiarità: ci sono poesie in cui «parlano personaggi diversi da lui… (manifesta) quel dislivello di comprensione che è chiamato dagli specialisti ironia: una distanza che l’autore pone tra sé e il personaggio… (talora) parla in prima persona il poeta o un personaggio…segue le variazioni psichiche dell’io parlante, e che presuppone una certa azione in uno spazio ben preciso. In casi simili si ha una “imitazione” che può essere chiamata drammatica (i primi critici parlarono di “teatralità”)… il narratore pronuncia un monologo interiore che segue le proprie reazioni…» (Vitti, 2001: 242).
Forse potremo esplorare con più acume le tecniche di altri nostri poeti: per esempio Pavese, anche se la sua scrittura precede le ammissioni di conoscenza di Kavafis finora registrate in Italia. Ma, chissà: qualcuno potrebbe aver notato, nascostamente, il faro di Alessandria.
Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021
Riferimenti bibliografici
F. Bellucci, La Grecia plurale del Risorgimento (1821-1915), Pisa, ETS, 2012.
A. Cencetti, Giovanni Pascoli. Una biografia critica, Milano, Le Lettere, 2009
N. Crocetti, F. Pontani (a cura), Poeti greci del Novecento, Mondadori Milano 2010
F. De Poli, I soldati di Pascoli tra nazione armata ed esercito permanente, in «L’image du soldat au XIX siècle», 20, 2016: 127-138
C. Di Noi (a cura), Lirici Greci, Salerno Editrice, Roma 2015
K. Kavafis, Tutte le poesie, a cura di Paola Maria Minucci, Donzelli Roma, 2019.
M. Vitti, Storia della letteratura neogreca, Roma, Carocci, 2001.
______________________________________________________________
Franca Bellucci, laureata in Lettere e in Storia, è dottore di ricerca in Filologia. Fra le pubblicazioni di ambito storico, si segnalano Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano (Pisa, 2008), nonché i numerosi articoli editi su riviste specializzate. Ha anche pubblicato raccolte di poesia: Bildungsroman. Professione insegnante (2002); Sodalizi. Axion to astikon. Due opere (2007); Libertà conferma estrema (2011).
______________________________________________________________









