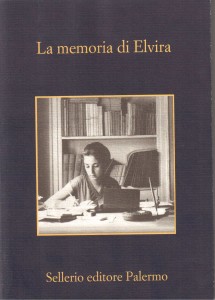«Chi non legge è un masochista» (Borges). È il ’69, a Palermo, l’anno in cui l’ex sindaco Salvo Lima viene incriminato per aver dato il via al cosiddetto “sacco” della città, l’anno della strage mafiosa di viale Lazio e del comizio del futuro golpista Junio Valerio Borghese al Cinema Smeraldo, in un pomeriggio di luglio inoltrato. Quello stesso anno, riuniti attorno a un tavolo, alcuni esponenti dell’intellighenzia cittadina decidono di fondare una casa editrice. Si tratta di uno scrittore, Leonardo Sciascia, di un antropologo, Antonino Buttitta, di un fotografo, Enzo Sellerio e di sua moglie Elvira Giorgianni. Un’impresa rischiosa, ai limiti dell’utopia, in anni in cui «fare libri a Palermo si presentava, agli occhi delle brave persone ragionevoli, come coltivare fichi d’india a Milano»[1]. Eppure, proprio nei termini di una “scommessa”, nasceva la casa editrice Sellerio.
Da allora sono trascorsi quarantasei anni. Elvira è morta nel 2010, Enzo nel 2012, alla guida c’è il figlio, Antonio, e la collana La memoria – quella dei “quadernetti” dalla copertina blu scuro divenuti, negli anni, segno distintivo della Sellerio – è giunta al numero mille. Il numero uno era Dalla parte degli infedeli, il numero cento Le cronachette, dell’85, entrambi di Leonardo Sciascia. Il numero mille è uscito da poco, si intitola La memoria di Elvira ed è dedicato alla “Signora” della Sellerio – come veniva chiamata in redazione, con la S maiuscola, come fosse un’antonomasia – che a quell’impresa così rischiosa aveva creduto al punto da investirci tutta la sua liquidazione. Un omaggio attraverso le testimonianze più o meno intime di chi l’ha conosciuta, di chi ha lavorato con lei, degli scrittori di cui ha “fiutato” il genio e ai quali ha fatto magistralmente da editor. Da Andrea Camilleri ad Antonino Buttitta, da Adriano Sofri a Piero Violante, da Santo Piazzese a Alicia Giménez-Barlett.
In quell’anno zero della Sellerio, il ’69, era stato anche scelto l’obiettivo della nuova iniziativa editoriale, riassumibile in quello che è stato poi chiamato il “riflusso”: il rifiuto cioè – in anni in cui tutto era politica, perfino l’arte, perfino la letteratura – dell’impegno esplicito. Paradossalmente, però, il libro che ne consacra il successo nazionale sarà proprio un libro politico. L’affaire Moro di Leonardo Sciascia esce nel ’78 – contemporaneamente in Italia, nella collana “La civiltà perfezionata” della Sellerio, e in Francia, per Grasset – ed è un libro «a cui è toccata la curiosa sorte di diventare famoso prima di essere stampato», come scrisse Indro Montanelli in un articolo apparso su Il Giornale il 15 ottobre 1978.
«Fu un libro importante per noi – racconta Antonio Sellerio in un’intervista al Corriere della Sera – perché ci pose per la prima volta alla ribalta nazionale e internazionale: uscì in una collana elegante, “La civiltà perfezionata”, libri con la velina sulla copertina bianca e con le pagine intonse. Qualcuno ci scrisse: va bene che siete poveri editori del Sud, ma almeno le pagine potevate tagliarle… Fu difficilissimo star dietro alle centomila copie».
Ma è anche un libro che scatena polemiche sia prima sia, a dosi rincarate, dopo la pubblicazione. Il più accanito detrattore è Eugenio Scalfari, che accusa Sciascia di servirsi de L’affaire Moro per colpire il Pci, tant’è che «potrebbe più propriamente intitolarsi “Il caso Sciascia”». Ma i biasimi arrivano indifferenziatamente da tutte le principali testate, da Il Tempo, sulle cui pagine compare un articolo di Leone Piccioni dal titolo “Cessate di uccidere i morti”, a Il Messaggero, dove con toni pesantissimi Giuseppe Saltini critica le «quattro idee rimasticate per eccesso, ridondanti e autoriproducentisi» contenute nel pamphlet.
La maggior parte delle critiche si concentra sulla tesi politica formulata da Sciascia: Moro è stato tradito dai compagni di partito – Zaccagnini in primis – che non hanno voluto trattare con i brigatisti. Solo Calvino – non a caso uno scrittore prima che giornalista – si sofferma sul valore letterario del libro in una recensione pubblicata dal quotidiano palermitano L’Ora.
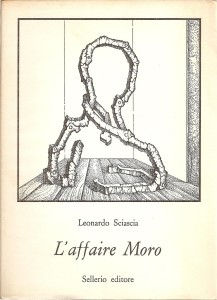 Letterario è innanzitutto l’incipit. L’affaire Moro comincia con una passeggiata nel proustiano “tempo ritrovato” della campagna dell’infanzia di Sciascia e con una scoperta, anzi con un ritorno: quello delle lucciole o canniliddi di pecuraru, come le chiamavano i contadini perché rischiaravano le notti trascorse a guardia della mandrie: «non potevo subito pensare a un ritorno delle lucciole, dopo tanti anni che erano scomparse». Il riferimento è al famoso articolo di Pier Paolo Pasolini apparso sul Corriere della Sera nel febbraio del ’75 in cui la degenerazione inarrestabile della società italiana viene associata alla scomparsa delle lucciole. “E invece – scrive Sciascia – era proprio una lucciola, nella crepa del muro. Ne ebbi una gioia intensa. E come sdoppiata”. Un messaggio di speranza ma anche un dialogo post-mortem con l’autore degli Scritti corsari, con il quale c’era stato un malinteso mai chiarito, «come un’ombra tra di noi». «Credo che mi ritenesse alquanto – come dire? – razzista nei riguardi dell’omosessualità». L’affaire Moro diventa allora una sorta di confessionale davanti al quale Sciascia si ritrova a fare i conti con la propria coscienza, con i propri sensi di colpa e i propri traumi irrisolti, in modo da stabilire un nuovo, ritrovato, accordo con lo scrittore scomparso.
Letterario è innanzitutto l’incipit. L’affaire Moro comincia con una passeggiata nel proustiano “tempo ritrovato” della campagna dell’infanzia di Sciascia e con una scoperta, anzi con un ritorno: quello delle lucciole o canniliddi di pecuraru, come le chiamavano i contadini perché rischiaravano le notti trascorse a guardia della mandrie: «non potevo subito pensare a un ritorno delle lucciole, dopo tanti anni che erano scomparse». Il riferimento è al famoso articolo di Pier Paolo Pasolini apparso sul Corriere della Sera nel febbraio del ’75 in cui la degenerazione inarrestabile della società italiana viene associata alla scomparsa delle lucciole. “E invece – scrive Sciascia – era proprio una lucciola, nella crepa del muro. Ne ebbi una gioia intensa. E come sdoppiata”. Un messaggio di speranza ma anche un dialogo post-mortem con l’autore degli Scritti corsari, con il quale c’era stato un malinteso mai chiarito, «come un’ombra tra di noi». «Credo che mi ritenesse alquanto – come dire? – razzista nei riguardi dell’omosessualità». L’affaire Moro diventa allora una sorta di confessionale davanti al quale Sciascia si ritrova a fare i conti con la propria coscienza, con i propri sensi di colpa e i propri traumi irrisolti, in modo da stabilire un nuovo, ritrovato, accordo con lo scrittore scomparso.
Ma letterari sono anche i numerosissimi paralleli che Sciascia cuce addosso alla figura di Aldo Moro, che assume le sembianze ora del Kutuzov di Guerra e pace di Tolstoj, nell’espressione «preda della più antica stanchezza, della più profonda noia», ora del Principe di Salina del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, nella comune abilità di disperdere il nuovo nel vecchio. Ma suggestivo è anche il rimando al pirandellismo – nell’accezione che ne aveva dato la critica benedettiana – insito nell’immagine di un personaggio che si discioglie creaturalmente nella forma, abbandonando la maschera a cui lo aveva votato la grigia ufficialità del suo ruolo politico. In quest’ottica, un caso di bruciante attualità ritrova la sua dimensione più autentica in una tematica cara alla tragedia classica: la solitudine di un uomo di potere di fronte alla morte. Un libro non solo politico, quindi, quello che consacra il successo di una casa editrice destinata a grandi cose, a grandi nomi, a grandi riscoperte.
L’anno dopo – siamo nel ’79 – viene fondata la leggendaria collana blu, intitolata La memoria. Titolo voluto da Sciascia e che coincide con uno dei rovelli intellettuali più urgenti, o forse con il più urgente, dello scrittore. Nelle cupe pagine di Nero su nero, c’è una figura che riluce come un barlume di speranza: è quella di un prete ottantenne che, quasi cieco, ricopia ricurvo sul tavolo della biblioteca della quale è il custode le testimonianze lasciate dall’Inquisizione a Erice. Se ne ritrova splendido ritratto ne Le parole sono pietre di Carlo Levi, e Sciascia lo descrive come «un uomo che ha fatto bene il proprio lavoro», perché grazie a lui «tutti questi fascicoli che nessuno pubblicherà mai, che pochissimi leggeranno» non sono andati distrutti. In questa immagine – quella di un vecchio prete che si adopera in modo ostinato affinché il passato non vada perduto – ci sembra possa racchiudersi la preoccupazione sciasciana di rendere perdurabile la memoria.
C’è un raccontino di Anatole France che l’autore racalmutese traduce e pubblica nell’80 e che diviene per lui emblema della damnatio memoriae, di una rischiosissima propensione alla rimozione storica. Si intitola Il procuratore della Giudea ed è la storia di un dialogo: quello tra Elio Lamia, dongiovanni ante litteram dell’epoca romana e Ponzio Pilato. I due, amici di vecchia data, si rincontrano ormai sulle soglie della vecchiaia sulle colline dell’Esquilino. Emblematico è soprattutto l’epilogo: «Si faceva chiamare Gesù il Nazareno, e fu crocifisso non ricordo per quale delitto. Ponzio, ti ricordi di quest’uomo?». Ponzio Pilato aggrottò le sopracciglia, si portò la mano alla fronte come chi vuole ritrovare un ricordo. Poi, dopo qualche istante di silenzio: «Gesù? – mormorò – Gesù il Nazareno? No, non ricordo».
La collana La memoria nasce allora con un preciso intento: quello di «non dimenticare certi scrittori, certi testi, certi fatti (…), vagando per il mal noto, il poco noto e l’ignoto». Probabilmente il nome più direttamente riconducibile alla straordinaria dote di scouting della “Signora” della Sellerio è quello di Gesualdo Bufalino. «Si disse all’inizio che fu Leonardo Sciascia a scovarlo, in realtà chi, prima di tutti, fiutò la presenza dello scrittore vero, chi ne sospettò il bislacco talento fu Elvira Sellerio»[2]. E ancora: «Le bastava sfogliare le prime pagine di un dattiloscritto per “sentire” la presenza di un autore autentico. Inseguì Bufalino come un cane da tartufi»[3].
 Era successo che, all’inaugurazione di una mostra di fotografie, Elvira fosse rimasta così colpita dai testi del catalogo da chiedere all’autore – “maestro don Gesualdo”, come lo chiamava Sciascia – se per caso non avesse un manoscritto nel cassetto. All’epoca Bufalino aveva sessant’anni suonati e una certa riluttanza a pubblicare. Eppure Diceria dell’untore, uscito nell’81 nella collana La memoria con il risvolto vergato da Sciascia, vince il premio Campiello e diviene subito un bestseller.
Era successo che, all’inaugurazione di una mostra di fotografie, Elvira fosse rimasta così colpita dai testi del catalogo da chiedere all’autore – “maestro don Gesualdo”, come lo chiamava Sciascia – se per caso non avesse un manoscritto nel cassetto. All’epoca Bufalino aveva sessant’anni suonati e una certa riluttanza a pubblicare. Eppure Diceria dell’untore, uscito nell’81 nella collana La memoria con il risvolto vergato da Sciascia, vince il premio Campiello e diviene subito un bestseller.
Quando, dopo circa otto anni dall’uscita del suo libro d’esordio, muore Sciascia, colui il quale aveva appassionatamente caldeggiato per la pubblicazione di quella storia ambientata in un sanatorio per malati di tubercolosi, Bufalino dichiara: «È come se avessi subito un’amputazione e mi svegliassi senza una gamba, senza un braccio. Oggi perdo non solo un amico, ma anche un padre, un fratello, un figlio. In tanti anni di amicizia questa è la prima scortesia che mi fa: morire»[4].
Probabilmente anche Elvira Sellerio avrà provato qualcosa del genere. Un senso di vuoto che si concretizza nella scelta – come in segno di rispetto – di rendere l’assenza anche materiale: visto che Leonardo Sciascia era morto alle soglie del numero duecento de La memoria, Elvira decide di lasciare sempre vuote le centinaia. E così della collana mancano il numero 300, 400, 500 e così via.
La scomparsa di Sciascia fa tra l’altro da ouverture a un momento buissimo nella storia della casa editrice.
Nel 1993 Elvira Sellerio viene accusata di concorso in abuso d’ ufficio e frode in pubbliche forniture, e si trova coinvolta in un processo che si risolverà definitivamente con l’assoluzione più di dieci anni dopo. L’inchiesta – avviata in seguito ad esposti presentati dalla Rete di Leoluca Orlando all’Assemblea regionale siciliana e a una formale denuncia alla Procura della Repubblica – riguardava l’acquisto di libri da parte della Regione presso la casa editrice Sellerio: secondo l’ accusa, sarebbero state vendute più copie rispetto a quelle consentite, e in alcuni casi libri diversi da quelli ordinati. L’angoscia per quell’impiccio giudiziario si univa a preoccupazioni di ordine strettamente finanziario – la cassa della casa editrice versava in acque tutt’altro che placide – e all’ansia di avere i concorrenti delle altre editrici lì dietro le spalle, come avvoltoi, pronti a cercare di sottrarle gli autori. «Fu allora – racconta Antonino Buttitta – che mi ricordai di un manoscritto portato da Sciascia che giaceva nel terzo cassetto della sua scrivania. Era Il birraio di Preston di Andrea Camilleri. La sua pubblicazione fu la salvezza della casa editrice» [5]
Siamo nel 1995 e Il birraio di Preston è la riscrittura romanzata – secondo quel modo di riscrivere la storia che fu prima di tutto manzoniano e poi sciasciano, coniugando realtà e finzione – di un avvenimento reale descritto nella Inchiesta sulle condizioni della Sicilia (1875-1876). Ma v’è anche un tocco postmoderno alla Raymond Quenau di Esercizi di stile, perché ogni capitolo racconta la stessa storia da un punto di vista diverso, tanto che l’ordine può essere cambiato senza che si perda il senso della trama, come precisa l’autore nel post-scriptum.
 Montalbano – vero e proprio fenomeno editoriale – era invece nato un anno prima ne La forma dell’acqua e l’anno scorso ha compiuto vent’anni. Vigata è nel tempo divenuta un luogo familiare, con il suo paesaggio brullo, le fabbriche in disuso, gli scogli piatti e il faro; e lui, Salvo Montalbano, un uomo «che chiunque inviterebbe a cena» – come ha detto recentemente Camilleri. Ma i nomi, inediti o riscoperti, sono molti altri. Maestri del giallo o del noir come Carlo Lucarelli – Carta bianca esce nel 1990 dando via a un nuovo genere di poliziesco italiano – o Gianrico Carofiglio; Antonio Tabucchi, che pubblica con Sellerio alcuni dei suoi più interessanti libri di viaggio come Donna di Porto Pim e Notturno Indiano fino a Racconti con figure, del 2011 (un anno prima della morte dello scrittore). E ancora Maria Messina, Luisa Adorno, la spagnola Alicia Giménez-Bartlett, che esordisce nel 2002 con Riti di morte, prima avventura della coppia Petra Delicado, ispettore della polizia di Barcellona, e del suo vice Fermin Garzón.
Montalbano – vero e proprio fenomeno editoriale – era invece nato un anno prima ne La forma dell’acqua e l’anno scorso ha compiuto vent’anni. Vigata è nel tempo divenuta un luogo familiare, con il suo paesaggio brullo, le fabbriche in disuso, gli scogli piatti e il faro; e lui, Salvo Montalbano, un uomo «che chiunque inviterebbe a cena» – come ha detto recentemente Camilleri. Ma i nomi, inediti o riscoperti, sono molti altri. Maestri del giallo o del noir come Carlo Lucarelli – Carta bianca esce nel 1990 dando via a un nuovo genere di poliziesco italiano – o Gianrico Carofiglio; Antonio Tabucchi, che pubblica con Sellerio alcuni dei suoi più interessanti libri di viaggio come Donna di Porto Pim e Notturno Indiano fino a Racconti con figure, del 2011 (un anno prima della morte dello scrittore). E ancora Maria Messina, Luisa Adorno, la spagnola Alicia Giménez-Bartlett, che esordisce nel 2002 con Riti di morte, prima avventura della coppia Petra Delicado, ispettore della polizia di Barcellona, e del suo vice Fermin Garzón.
Un altro editore, più ordinato, meno guidato dalla curiosità, avrebbe mai scoperto Diceria dell’untore o fiutato La casa sull’acqua di Penelope Fitzgerald? Probabilmente no. Se c’è un dato che emerge, leggendo i ventitré contributi che compongono La memoria di Elvira, è proprio questo: la curiositas come tratto imprescindibile di un certo modo di fare cultura. Un modo che probabilmente non esiste più, o non esiste in quei termini, di cui lei ha rappresentato l’inizio ma anche l’epilogo. Come una parabola condensata nei suoi 41 anni di attività lavorativa alla guida della Sellerio: la vita culturale di una Palermo contraddittoria, di luce e di ombre. Di una Palermo ossimorica, dove lo stesso anno in cui venivano accertati i rapporti di un sindaco democristiano con la Mafia nasceva un baluardo della vita culturale cittadina.
C’è una foto che la ritrae china, sul suo tavolo da lavoro sommerso dalle centinaia di manoscritti che quotidianamente arrivavano nella sede di via Siracusa. È forse la sua posa più rappresentativa, con il pacchetto di Benson & Hedges accanto. I libri, le sigarette: le grandi passioni della sua vita. Non avrebbe potuto fare a meno né degli uni né delle altre. «Affermava che non sarebbe sopravvissuta a lungo, se avesse smesso di fumare» [6].
Dialoghi Mediterranei, n.14, luglio 2015
Note
[1] M. Barbato, Nota introduttiva a Leonardo Sciascia scrittore editore, ovvero La felicità di far libri, a cura di Salvatore Silvano Nigro, Sellerio, Palermo, 2003: 25.
[2] S. Ferlita, Quel tarlo mai sazio, in L’intellettuale al caffé, CRicd, Palermo 2013: 57.
[3] A. Camilleri, Elvira e io, in La memoria di Elvira, Sellerio, Palermo 2015: 12.
[4] Cit. in un articolo di Attilio Bolzoni, L’addio a Sciascia, la Repubblica, 23 novembre 1989.
[5] A. Buttitta, Orizzonti della memoria. Conversazioni con Antonino Cusumano, Ernesto Di Lorenzo Editore, Alcamo, 2015: 156.
[6] S. Piazzese, La luna, le Benson, in La memoria di Elvira, Sellerio, Palermo 2015: 103.
_______________________________________________________________
Marta Gentilucci, giovane laureata in Italianistica presso l’Università degli Studi di Bologna, ha collaborato con la Cineteca di Bologna e si occupa di giornalismo ed editoria. Tra i suoi interessi di ricerca, lo studio della letteratura delle migrazioni. Ha insegnato nel laboratorio di video-giornalismo presso il Liceo classico F. Scaduto di Bagheria. Ha partecipato a stage e seminari su identità di genere, letteratura post-coloniale e scritture migranti.
________________________________________________________________