Teresa riceve una telefonata che le annuncia che Grazia, sua madre, è morta. La corsa in macchina nel paese natio e il trovarsi di fronte a quel corpo immobile e rigido scatena una tempesta di pensieri e ricordi. È questo l’incipit dell’ultimo romanzo di Giulia Alberico (Grazia, SEM, Milano 2017), insegnante di lettere in pensione, nota per avere pubblicato già diversi romanzi con Sellerio, Mondadori, Rizzoli, Sonzogno. Ed è proprio il tema della memoria e dei legami che si costruiscono nel tempo e nello spazio, quella memoria che dà continuità alla nostra identità e senza la quale non sapremmo chi siamo, il filo conduttore del libro.
È noto che ciascuno di noi tende a narrarsi e vede la propria vita come un romanzo. Mi è capitato più volte di persone che mi hanno chiesto di scrivere il romanzo della loro vita. Poiché nel nostro inconscio siamo immortali, siamo spinti a lasciare traccia di noi. Già, l’inconscio. Contrariamente a quel che si crede semplificando, l’inconscio non è soltanto un serbatoio di pulsioni ribollenti, un magma incandescente di passioni, né si esprime soltanto attraverso il sogno, pur se questo è, per Freud, “la via maestra” attraverso la quale esso si manifesta. Sicuramente i nostri sogni ci appaiono come narrazioni, come piccole storie, spesso apparentemente irrazionali, ma certamente mettono in scena i nostri vissuti, prendendo lo spunto da residui diurni. Scandagliare i sogni, sezionarli, ci fa conoscere l’altra parte di noi stessi, l’inconosciuto, dove alberga la sfera del desiderio e del non-detto, ciò su cui la ragione c’impone di tacere, quella parte della nostra autobiografia, che è rimasta inespressa, rimossa.
L’inconscio irrompe nella vita quotidiana attraverso i lapsus, gli smarrimenti di oggetti, i gesti automatici, le sviste, gli atti mancati, i motti di spirito, i silenzi e i sottintesi, le dimenticanze. Diversi linguaggi artistici, (scrittori, drammaturghi, pittori, registi) hanno messo in scena il teatro dell’inconscio. Basti pensare ai simbolisti, al surrealismo e in particolare ad André Breton, Odilon Redon e poi Magritte, Dalì, Mirò, Chagall, Kandiski, Münch, lo stesso Picasso, che hanno utilizzato molto il linguaggio del sogno e dell’inconscio, Anche il cinema, in cui Federico Fellini fu un maestro di surrealismo (Otto e mezzo, La nave va, I clown, La città delle donne), ma anche Luis Buñuel e Alfred Hitchcock e più recentemente Darren Aronofsky (Il cigno nero), hanno portato sullo schermo l’inconscio.
Dunque la scrittura, e non solo quella dichiaratamente autobiografica, qualsiasi romanzo, storia, racconto attinge all’inconscio. Molte funzioni mentali sono inconsce e non pervengono alla coscienza, ma agiscono sulla nostra memoria, sulle nostre decisioni e sulle percezioni e modificano il nostro modo di agire. Anche nella scrittura, specie quando tocca le corde delle relazioni più intime, c’è sempre un affiorare della memoria, un riattivarsi di ricordi, di eventi e luoghi che generano emozioni e nostalgia, che sono anche gli ingredienti della fantasia creativa.
Il romanzo che recensiamo, Grazia, è un viaggio nella memoria, un itinerario tra percorsi impervi e richiama alla mente il primo romanzo dell’autrice, Madrigale, edito da Sellerio nel 1999 (premio Arturo Loria), composto di tre racconti, di cui il terzo, Regina, è, per l’appunto, imperniato sulla relazione tra madre e figlia.
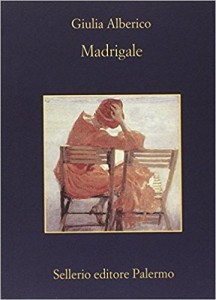 Quest’ultima percepisce la freddezza emotiva della madre, la quasi totale assenza di contatto fisico, la mancanza di tenerezza, i grandi silenzi e le battute feroci, l’ignoramento e la terribile domanda: «come può mia madre non amarmi»? Rimprovera alla madre una certa dose di narcisismo e una sorta di coazione a collezionare complimenti.
Quest’ultima percepisce la freddezza emotiva della madre, la quasi totale assenza di contatto fisico, la mancanza di tenerezza, i grandi silenzi e le battute feroci, l’ignoramento e la terribile domanda: «come può mia madre non amarmi»? Rimprovera alla madre una certa dose di narcisismo e una sorta di coazione a collezionare complimenti.
La madre, di rimando, cerca di dare il proprio punto di vista, scavando nella sua vita. Le ricorda che da bambina, non essendoci in paese la scuola materna, la portava a scuola con sé e l’emozione provata quando si accorse che la figlia scriveva le parole che lei dettava agli alunni, ma rileva anche la cocciutaggine, il suo piangere continuo da bambina, il suo essere sempre giudicante. Sottolinea, nel contempo, che la vita è stata per lei una serie di occasioni sprecate o mancate, un imbroglio. Confessa di essersi concentrata sulla seduzione, di non avere imparato i gesti della tenerezza mentre li ha conosciuti con la nipote, che ha fatto la madre come sapeva.
In sostanza, si confrontano percezioni e punti di vista diversi e si conferma che la memoria non è registrazione della realtà ma ricostruzione, in cui ciascuno tende a giustificare il proprio operato, magari spostando o trasponendo e anticipando un fatto, una parola, un gesto nella sequela delle comunicazioni.
Anche nel nuovo romanzo Grazia, dopo la telefonata ricevuta, la protagonista Teresa, tornata in Abruzzo, si trova di fronte a quel corpo immobile della madre, la sua mente viaggia all’indietro nel tempo e ripiomba nel groviglio dei ricordi che s’intrecciano come tanti cespugli di un albero in un andirivieni tra presente e passato.
L’autrice, attraverso una narrazione originale in forma diaristica, in cui si alternano storie del passato e del presente, ma anche emotivamente intensa, cattura l’interesse del lettore nel seguire la protagonista in un turbinìo della memoria tra il vissuto attuale e il riemergere di ricordi del passato, da quelli dell’infanzia a quelli dell’adolescenza, alla ricerca di verità nascoste, della sua personale identità di donna, che la porterà a comprendere anche la turbolenta vita della madre, da lei sempre vissuta non proprio come “gratia plena” come il nome che porta. Descrive l’antico rito del consòlo, attraverso il quale gli amici più intimi fanno a gara per portare cibo e vivande ai familiari della persona defunta.
Ci conduce passo-passo attraverso la laboriosa ricerca di Teresa, affiancata amorevolmente dalla sua amica e compagna di scuola Laura, il graduale riemergere dei ricordi, gli atteggiamenti di fastidio della madre per le sue compagne o amiche del liceo di modesta origine, che Grazia etichettava come “gentarella”, ma anche il ricordo del verbo più usato dalla madre in quell’epoca, “domare” e l’appellativo “cocciuta come un mulo”. E Teresa si sentiva sbagliata perché non riusciva a essere come lei la voleva, perché non lo sapeva, altrimenti avrebbe fatto qualsiasi cosa per attirare su di sè uno sguardo che non la facesse sentire inadeguata, oppure come un accessorio, come un profumo, un braccialetto, un mantello, e l’effetto era l’umiliazione e la vergogna.
 Un’incomprensione tra madre e figlia che affonda le radici in mondi diversi e in vissuti diversi: la madre, cresciuta negli anni del fascismo, vissuta nel benessere di una famiglia rispettata nel paese, con una educazione perbenista, in cui le forme sono sostanza e segnata dalle sue esperienze; la figlia, invece, nata e cresciuta in un clima di maggiore libertà, di lotte per i diritti civili e sociali, la cui adolescenza incontra i movimenti studenteschi del’68, respira un’aria di ribellismo, di rifiuto di regole rigide e formali e per di più “comunista”, come l’apostrofa la madre.
Un’incomprensione tra madre e figlia che affonda le radici in mondi diversi e in vissuti diversi: la madre, cresciuta negli anni del fascismo, vissuta nel benessere di una famiglia rispettata nel paese, con una educazione perbenista, in cui le forme sono sostanza e segnata dalle sue esperienze; la figlia, invece, nata e cresciuta in un clima di maggiore libertà, di lotte per i diritti civili e sociali, la cui adolescenza incontra i movimenti studenteschi del’68, respira un’aria di ribellismo, di rifiuto di regole rigide e formali e per di più “comunista”, come l’apostrofa la madre.
Per l’intanto, Teresa scopre anche che la madre aveva venduto o ipotecato tutte le proprietà di famiglia. Si chiede come sia potuto accadere e la sua indagine la porta a scoprire segreti che non avrebbe mai voluto sapere e che non avrebbe potuto mai immaginare, ma che la conduce infine a comprendere la vita della madre e i suoi comportamenti. Per la prima volta avverte il dolore e la pietà.
Il libro di Giulia Alberico non è soltanto lo scavo nei meandri della memoria e della diade madre-figlia, sollevando il velo della forclusione. È anche l’incursione della storia privata nella storia pubblica, un pò come La storia di Elsa Morante. Nella grande casa di famiglia dove è vissuta da bambina, si ravviva in Teresa il ricordo dei racconti dei nonni e dei loro vissuti durante il fascismo, dalla marcia su Roma dell’ottobre 1922 alle leggi razziali, dalla madre vestita da figlia della lupa a tutti i disagi dopo quel 10 giugno del 1940 in cui il duce decise di entrare in guerra: la cancellata di accesso alla casa, divelta per la requisizione di materie prime da destinare alla guerra e così per le pentole di rame, i coperchi, i tegami e le fedi nuziali e la penuria di carburanti. E ancora l’atmosfera di confusione e di smarrimento dei soldati italiani dopo l’8 settembre 1943 e poi l’arrivo degli alleati, la defascistizzazione che porterà il nonno nel campo di Gioia del Colle in Puglia, da cui ritornerà nel gennaio 1945, e infine la liberazione avvenuta il 25 luglio 1945 e la successiva nascita della Repubblica. Una carrellata dal 1922 agli anni di piombo, all’interno della quale si collocano le vicissitudini della madre e l’insospettabile segreto di cui Teresa viene a conoscenza.
Dialoghi Mediterranei, n.29, gennaio 2018
________________________________________________________________________________
Piero Di Giorgi, già docente presso la Facoltà di Psicologia di Roma “La Sapienza” e di Palermo, psicologo e avvocato, già redattore del Manifesto, fondatore dell’Agenzia di stampa Adista, ha diretto diverse riviste e scritto molti saggi. Tra i più recenti: Persona, globalizzazione e democrazia partecipativa (F. Angeli, Milano 2004); Dalle oligarchie alla democrazia partecipata (Sellerio, Palermo 2009); Il ’68 dei cristiani: Il Vaticano II e le due Chiese (Luiss University, Roma 2008), Il codice del cosmo e la sfinge della mente (2014).
________________________________________________________________








