Luca Ricolfi ha scritto di recente che il livello di preparazione medio offerto oggi da una laurea triennale è più o meno equivalente a quello che negli anni ‘60 garantiva il titolo di terza media. Il sistema scolastico italiano impiegherebbe dunque otto anni in più a produrre lo stesso tipo di «organizzazione mentale – conoscenze, padronanza di linguaggio, capacità logiche». È una provocatoria esagerazione? Di solito ci lamentiamo della licealizzazione dell’università, ma addirittura la scuola media? Eppure, insiste Ricolfi, si tratta di una valutazione persino ottimista: in particolare «la padronanza della lingua italiana […] è presente in una minoranza dei laureati, mentre ancora a metà degli anni sessanta era per così dire ‘automaticamente incorporata’ nel titolo di terza media inferiore»[1].
Vorrei pormi tre domande in proposito. Primo: si tratta di una valutazione realistica? Secondo: è un prezzo necessario da pagare per la democrazia scolastica? Terzo: cosa possiamo fare?
Intanto, il problema non è certo nuovo e viene periodicamente sollevato. Nel 2017, ad esempio, un documento del cosiddetto Gruppo di Firenze, inviato alle massime autorità dello Stato a firma di centinaia di docenti universitari, sosteneva che
«è chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente. Da tempo i docenti universitari denunciano le carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in terza elementare. Nel tentativo di porvi rimedio, alcuni atenei hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana. A fronte di una situazione così preoccupante il governo del sistema scolastico non reagisce in modo appropriato, anche perché il tema della correttezza ortografica e grammaticale è stato a lungo svalutato sul piano didattico più o meno da tutti i governi»[2].
E una discussione aperta a seguito di tale documento poneva l’accento su molti aspetti specifici dell’incompetenza linguistica, non solo quella generale degli italiani (ben nota in un Paese in cui si è sempre letto poco e che presenta vaste aree di illitterazione, primaria o di ritorno), ma quella degli studenti universitari e in particolare dei corsi umanistici e letterari[3]. Questione che si ricollega poi a una frequente denuncia del declino della scuola italiana nelle sue prevalenti funzioni di istruzione e di acquisizione delle competenze culturali di base, come nel pamphlet di Ernesto Galli Della Loggia sul quale tornerò più avanti[4]. Dunque, sì, certo, chi lavora nell’università si trova di fronte a molti casi di incompetenza linguistica, e soprattutto di padronanza attiva della scrittura. Fa parte del risaputo, del tollerato, dell’inevitabile. Lo vediamo anche nelle tesi di laurea, o nelle tesine d’esame. Ma non sarà che siamo portati a notare solo i casi negativi, adagiandoci nel peggior stereotipo da insegnante, quello per cui “i giovani d’oggi non sono più quelli d’una volta”? Aggiungendo magari che “stanno sempre sul telefonino” o analoghe banalità? Non sarà allora esagerato fare un dramma di questo problema – effetto collaterale, tutto sommato, della democratizzazione dell’istruzione superiore?
Non credo, e vorrei portare il mio piccolo granello di esperienza personale come contributo alla discussione. La didattica a distanza degli ultimi mesi, conseguente alla “sospensione della socialità” imposta dalle misure di contrasto al contagio da coronavirus, mi ha consentito di verificare più a fondo le dimensioni della incompetenza linguistica tra studenti di laurea triennale. Sono infatti stato costretto – nei miei corsi di Antropologia culturale – a una diversa interazione con le studentesse e gli studenti. In passato, mi ero accostato alle loro produzioni scritte attraverso le tesi di laurea, la redazione di “tesine” o relazioni d’esame, che riservo di solito però ai corsi di magistrale; e anche attraverso le verifiche scritte tradizionali, svolte in aula “in presenza”, come si dice ora, con gli studenti che scrivono a mano senza poter consultare testi né altrimenti “copiare” – insomma, una alternativa al colloquio che intende testare l’acquisizione di contenuti specifici e non valutare la forma espressiva. Certo, nella correzione di queste prove è capitato spesso, con colleghe e colleghi di commissione d’esame, di stupirci per una certa disgrafia degli studenti – la palese assenza di abitudine nell’uso della scrittura a mano in corsivo, con conseguenti refusi etc. Ma si sa, è una generazione digitale eccetera eccetera.
Questa volta è stato necessario proporre prove a distanza, on line: nelle quali, dunque, si doveva presupporre l’uso dei testi e della scrittura digitale. Per l’esame di antropologia culturale di base, ho organizzato una prova di prevalutazione (che dev’essere comunque integrata da un colloquio), alla quale hanno partecipato circa 180 studenti di diversi corsi di laurea triennale, umanistici e di studi sociali. Con due ore di tempo, si doveva rispondere ad alcune domande aperte, di carattere non nozionistico ma che richiedevano la capacità di organizzare un discorso e di formulare collegamenti fra diverse parti del programma (programma che consisteva in un manuale e in una dispensa sul tema dell’antropologia della violenza). Gli studenti avevano accesso a un file con le domande sulla piattaforma di elearning e dopo due ore dovevano fare l’upload del file con le loro risposte. Contemporaneamente, tutti eravamo collegati in diretta sulla piattaforma Teams, in modo da poter porre domande e risolvere dubbi di tipo tecnico. Non c’erano problemi di informazione (si potevano cercare dati e concetti sui libri, o attraverso ricerche sul web), ma di organizzazione discorsiva.
Riporto qui le 4 domande:
1) In più parti del manuale si fa riferimento critico al concetto di “identità culturale”, che l’antropologia elabora come strumento di riconoscimento della diversità degli “altri” non occidentali, ma che diviene talvolta, nell’ultima parte del XX secolo, strumento di nuove discriminazioni e persino violenze di tipo “etnico”. Si sintetizzino alcune di queste tematiche (circa 20 righe).
2) Nella storia degli studi antropologici, la nozione di “struttura” è usata sia dagli indirizzi funzionalisti che da quelli strutturalisti, ma in modo molto diverso. Si cerchi di chiarire questa differenza facendo riferimento anche ad alcuni autori rappresentativi dei due indirizzi (circa 10 righe).
3) Sia nel manuale che nella dispensa “Antropologia della violenza” si fa riferimento al concetto di “memoria divisa”. Si chiarisca il significato di questo termine, facendo riferimento anche ad alcuni esempi storici inclusi nei testi di riferimento (circa 20 righe).
4) Nella dispensa “Antropologia della violenza” si fa riferimento al concetto di “zona grigia”. Si chiarisca chi ne parla, in quale contesto, e quale significato assume quella espressione in rapporto alla comprensione antropologica della violenza (circa 20 righe).
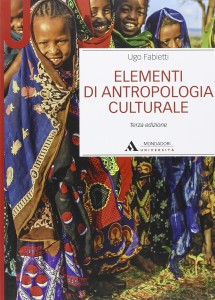 Non mi interessa discutere il grado di apprendimento dei contenuti specifici che ne è risultato, ma appunto la capacità di esprimere in modo chiaro e sintetico alcuni concetti-chiave, che erano stati trattati ampiamente durante le lezioni e che era facile rintracciare all’interno del materiale di studio. Non riporterò neppure statistiche sulle percentuali di superamento della prova e sui voti ottenuti. Sottolineo però l’alta percentuale, almeno una buona metà, di candidati che ha mostrato grande impaccio espressivo, consegnando prove caratterizzate dall’assenza di padronanza della sintassi, da scelte lessicali povere e inadeguate, da punteggiatura scorretta, da valanghe di refusi non corretti, da nomi di autori scritti in modo sbagliato, e così via. Studenti universitari, per di più di discipline umanistiche, che non padroneggiano la base stessa del sapere umanistico, vale a dire la scrittura.
Non mi interessa discutere il grado di apprendimento dei contenuti specifici che ne è risultato, ma appunto la capacità di esprimere in modo chiaro e sintetico alcuni concetti-chiave, che erano stati trattati ampiamente durante le lezioni e che era facile rintracciare all’interno del materiale di studio. Non riporterò neppure statistiche sulle percentuali di superamento della prova e sui voti ottenuti. Sottolineo però l’alta percentuale, almeno una buona metà, di candidati che ha mostrato grande impaccio espressivo, consegnando prove caratterizzate dall’assenza di padronanza della sintassi, da scelte lessicali povere e inadeguate, da punteggiatura scorretta, da valanghe di refusi non corretti, da nomi di autori scritti in modo sbagliato, e così via. Studenti universitari, per di più di discipline umanistiche, che non padroneggiano la base stessa del sapere umanistico, vale a dire la scrittura.
Sì, sono cose che si dicono sempre. Per non restare nel vago, allora, offrirò una serie di esempi di risposte alle domande sopra riportate – scelti fra quelli più problematici, d’accordo, che non sono rappresentativi di tutti gli studenti ma di una buona parte sì, e che non costituiscono dunque casi isolati. Nelle loro prestazioni grafiche si individuano anzi caratteristiche che sono largamente diffuse tra gli universitari della triennale (e tutto autorizza a credere che fra i non umanisti le cose vadano ancora peggio, con l’eccezione forse di alcuni corsi di studio “d’élite” – e il gap sempre più ampio fra le lauree d’élite, come ad esempio Medicina e per certi versi Ingegneria, e le altre sarebbe di per sé tema cruciale di discussione). Prima di leggere gli estratti, voglio chiarire che non ho inserito risposte di studenti certificati come dislessici o portatori di disabilità cognitive o “bisogni educativi speciali” (che avrebbero posto problemi diversi, ovviamente; a meno di non pensare che i casi qui presentati siano attribuibili a BES non riconosciuti, e dunque alla paradossale affermazione che i BES sono la norma).
1
Nel mondo esistono molte culture che si intrecciano tra di loro , ma ovviamente mantengono la loro identità culturale che li rende autonome e distinte . Tali culture possono essere studiate , descritte ma non in senso gerarchico in quanto non esiste una cultura meglio o peggio dell’altra.Tutti ciò si è sviluppato verso l’ottocento con l’introduzione dell’osservazione partecipante cioè la ricerca sul campo che porta uno sviluppo antropologico che viene visto come uno strumento dell’etnocentrisL’identità culturale viene affrontata con il tema del razzismo che mostra la differenza tra le razze umane ma ogni razza ha dei valori credenze che devono essere rispettate e mantenute e possono essere oggetto di studio e relazioni.Altri esempi che si formano con il razzismo sono la barbarizzazione.2 il concetto di struttura viene affrontato sia nel funzionalismo che nello strutturalismo ma in maniere differenti.Nel funzionalismo si parla di una cultura che tende a sottolineare i in senso sincronico i nessi funzionali che si trovano nelle diverse organizzazioni sociali. Il funzionalismo si vede come esponente Radcllffe-Brown che tende a specificare l’antropologia non tende a studiare gli individui astratti ma persone concrete che fanno parte di una realtà definita organica in cui i componenti sono connessi tra di loro secondo relazioni definite strutture . infatti tende a specificare che il concetto di funzione ha senso solo in rapporto alla continuità della struttura sociale.
2.
Radcliffe-Brawn appartengono al funzionalismo e quindi ritengono che tale definizione sia una “ struttura”. La funzione della culturale è il ruolo che essa svolge nella vita sociale di oogni persona/individuo intesa come totalità e perciò il contributo che da al mantenimento della continuità strutturale. Strauss nello strutturalismo studia le rete parentali, miti e racconti dai quali eslabora il principio che genera tutto, cioè il linguaggio: è un meccanismo attraverso il quale un individuo nell interagire e affrontare il mondo sociale (dove ogni campo è rilegato a precise configurazioni che cambiano da società a società), sono costruite secondo una sintassi universaleumana che se studiata si mostrano basate sulle stesse matrici o modelli generatori (detti struttura)
3.
Il funzionalismo cessa di rappresentare il paradigma teorico dominante e ricorre allo strutturalismo,che rappresenta uno stile di pensiero,legato al nome di Claude Lèvi-Strauss,figura importante nell’antropologia del 900. Strauss,negli anni 30 andò in Amazzonia per fare ricerche sulle popolazioni indigene e tornò in patria nel 1948,dopo la seconda guerra mondiale e pubblicò un’opera che rivoluzionò il tema della parentela. Lèvis-Strauss propone di trattare la cultura come un linguaggio che comunica attraverso elementi concreti dell’esperienza umana:rapporti di parentela e matrimonio,oggetti del mondo naturale come ad esempio piante e animali. Strauss chiama questi elementi strutture. Lo studioso Radcliffe-Brown, usava il termine di strutture come qualcosa che non può essere descritto o osservato ma si possono delineare i contorni attraverso un’analisi.
4.
L’identità culturale è la formazione fra il legame sociale e politico. Nella buona parte del 1900 l’antropologia ha cercato di affermare il principio che ogni gruppo umano ha una propria identità fatta di valori, che non sono ne superiori ne inferiori agli altri e hanno diritto di esistere nella stessa maniera. Con il tempo però questo concetto è cambiato ed è arrivato all’intolleranza, al neorazzismo e al conflitto etnico. Altri tipi di violenza si sono riscontati tra gli Indios Americani dove Michael de Montaigne sul saggio “Sui Cannibali” che è un resoconto etnografico in cui utilizza come informatore un francese vissuto per molti anni in una comunità indios del brasile dove si praticava una forma di cannibalismo. Il cannibalismo è una caratteristica dei selvaggi come prova della loro disumanità
5.
L’identià culturale è tutto un insieme di tradizioni, linguaggio,costumi,forma di società sistemi di parentela, religione o magia che distinguono una cultura da un’altra. Nel 2020 questa differenza di identità culturale porta però a considerare l’occidente l’identità culturale che detiene il potere sugli altri. Fin dagli inizi, si parla dell’epoca del Colonialismo,l’occidente ha cercato di predominare sulle altre culture,e si arriva fino ai nostri giorni quando “l’etnico” che secondo la definizione significa:“differenze tra gruppi umani indipendentemente dalle suddivisioni politiche degli Stati”, adesso significa diverso che deve essere predominato. Tramite una diffusione di massa si diffonde il terrore del diverso,come avvenne tramite le Leggi di Norimberga nel periodo nazi-fascista. Anche adesso nel XX tramite una violenza nascosta si descrive l’etnico come il diverso e preda degli occidentali.
6.
Il Funzionalismo,corrente antropologica che si sviluppa nei primi decenni del ‘900 grazie all’influenza dell’antropologo Derkheim, è caratterizzata,secondo Malinowsky dallo studio di certi fenomeni sociali in relazione non alla sua origine,ma piuttosto alla funzione che questa svolge all’interno di una certa struttura sociale e al contributo di questa al mantenimento di questo equilibrio. Altro antropologo che aderisce a questa corrente è Alfred Reginald Radcliffe che discute sul funzionalismo sostenendo che si debbano considerare le persone non come concetti astratti,ma come parte materiale di una struttura. Successivamente anche Pitchard aderisce a questa corrente e studia come la stregoneria influenza l’ordine sociale degli Azande. Il strutturalismo piuttosto si sviluppa grazie alle teoria di Claude Lévi-Strauss il quale è interessato a scoprire le origini dei miti e delle diverse parentele che si sviluppano in una struttura sociale. Secondo Strauss come noi abbiamo la predisposizione al linguaggio,anche in noi è presente” a priori” la capacità di creare configurazioni sociali.
7.
Nel corso degli anni ci sono stati casi in cui le discriminazioni e le violenze hanno portato a momenti storici importanti che ancora oggi ricordiamo per farsi che ciò non si ripeta. Un evento storico protagonista di queste discriminazioni e vere e proprie violenze è sicuramente il nazismo, ma ci sono altri casi di cui potremmo parlare avvenuti nel corso della storia ma anche di casi che succedono ogni giorno per quanto riguarda la discriminazione culturale e che fa parte della società di oggi verso etnie che vengono considerate “sbagliate” solamente perché non conosciute o considerate non degne rispetto a quelle di cui fa parte chi discrimina.
8.
L’antropologia è stata criticata in quanto quest’ultima può collegarsi ad un atteggiamento essenzialista ed una tendenza alla “retificazione in quanto ha mostrato un’immagine troppo estrema e statica delle diverse culture, diverse correnti possono essere ricollegate a questo tema, come il razzismo differenzialista che sostiene che ogni cultura legittima delle caratteristiche singole e uniche, riproponendo una concezione xenofoba ciò è sostenuto anche da Strauss che afferma che la differenza culturale andava tutelata in quanto bene supremo dell’umanità, il progresso per esistere ha bisogno di concezioni diverse ed esso non può svilupparsi in presenza di un cultura che esercita una supremazia sulle altre.
Un’altra corrente che legittima la concezione di identità culturale è concetto di “barbarizzazione” che si basava nella convinzione che certe categorie di umani non fossero civilizzabili. Taigueff è uno degli studiosi che si è occupò di questo argomento, affermando che essa sia il più alto grado di distanziamento e esclusione, in quanto il barbaro era visto come l’antitesi della società.
9.
- a partire dagli anni 50 il funzionalismo va sotto il nome di strutturalismo che più di un teoria rappresenta uno stile di pensiero esso in antropologia legato a Claude Lèvi-Strauss trovo questo caso negli anni 30 in Amazzonia il suo punto di partenza era l’analisi strutturale del linguaggio noi impariamo a parlare non memorizzando ma in virtù di un meccanismo generativo, secondo degli indizi strutturali non è semplice appreso dall’esperienza ma è dato a priori ed è per questo che Levi ci invita a trattare la cultura come linguaggio che non comunica attraverso il linguaggio ma attraverso all’esperienza
Durkheim invece studia la cultura come un tutto sincronico la società è studiata da un sistema complesso che in cui ogni parte svolge una precisa funzione nei confronti del tutto l’orientamento teorico di fonda giocando sotto il nome di Funzionalismo.
10.
- Eccidi nelle stragi avvenute in Toscana e nell’attribuzione delle colpe attribuite dopo dopo ai tedeschi sviluppato negli anni 90 riguardante le comunità colpite da eccidi da parte delle truppe tedesche nel tempo 1934-45 in luoghi come Monte Sole, Sant’Anna di Stazzema dai sopravissuti che vivono li non hanno avuto ancora il tempo e il coraggio con la propria memoria di andare oltre alcune comunità hanno avuto giustizia e non hanno putito avere la possibilità di integrarsi nelle più ampie narrazioni storiche della resistenza.
La memoria divisa sta all’interno di un filone di studi italiano
11.
Molte volte l’antropologia è stata criticata in quanto quest’ultima può collegarsi ad un atteggiamento essenzialista ed una tendenza alla retificazione in quanto ha mostrato un’immagine troppo estrema e statica delle diverse culture. Nonostante il concetto di etnia rimandi a superflue diversità culturali esso viene utilizzato da alcuni esponenti come strumento di legittimazione raziale, dove in ogni gruppo culturale lo scopo è quello di dominare e soppiantare le altre culture viste come inferiori e minacce.
12.
Quando l’antropologo studia fenomeni che rientra all’interno dell’ambito della violenza deve star attento a comportarsi come “un bravo antropologo” ed estraniarsi dal comfort della vita quotidiana e vivere come la popolazione sottoposta ad analisi. Essi vengono richiamati quando si devono porre a confronto diverse concezioni di memoria che fuoriescono su determinati contesti memoriali. Infatti la figura del testimone è molto preziosa ma essa è legata alla singola esperienza contorta vissuta e non ci permette di poter analizzare il fenomeno attraverso una lettura chiara ed omogenea in quanto il suo punto di vista appare naturalmente diverso rispetto a quello presentato dal “carnefice”.
13.
Il punto di vista della alterità è stato studiato da vari antropologi come Malinowski con la ricerca sul campo osservando tribù selvagge con usanze spesso ritenute barbare come il cannibalismo.[è la risposta completa]
14.
Per Primo Levi la zona grigia è come un grande territorio a cui durante la vita chiunque vi arriva. Secondo Levi, per capire il mondo e affrontare le difficoltà, gli uomini operano delle semplificazioni che portano ad avere una visione particolare: esistono i puramente buoni o i puramente cattivi. Non ci devono essere contatti tra queste due realtà anche se molto spesso questo accade
15.
-Il funzionalismo nasce prendendo riferimento dalle teorie del sociologo Durkeim in quanto affermava che proprio nella società l’individuo avesse una funzione specifica formando una vera e propria scuola dio pensiero. Un altro grande esponente di quest’ultima e Brown il quale afferma che: in una società è giusto avere una struttura che specifichi il ruolo di ogni singolo. Il funzionalismo, quindi, concepisce la cultura rapportata a risposta degli elementi sociali. Si basa sulla funzione di un tratto sociale rispetto all’esigenza dell’individuo (es. lo studio della stregoneria di Azande condotto Pitchard: la stregoneria non è irrazionale ma evidenzia il conflitto sociale). Il funzionalismo, inoltre concepisce la società per la sua natura olistica e per il presente sincronico, pertanto queste dottrine sono criticate e sostituite nel Cinquecento dallo strutturalismo.
-Lo strutturalismo, il cui maggiore esponente è Lavis-strauss […]
16.
Nel funzionalismo si fa riferimento alle strutture sociali di gruppi di piccoli dimensioni che sono caratterizzata dall’esistenza di uno stato moderno.Malinowski è un benefattore di questa scuola di pensiero assieme a Redeliffe-brown.Ques’ultimo afferma l’antropologia non si occupa di individui astratti,ma concreti.Uno studioso come Evans-Prichard va ad analizzare una popolazione nilotica di agricoltori(azande) in cui la stegoneria mantenesse all’ordine sociale.Nello strutturalismo è legato all’antropologo Lévo-Strauss,egli individua dei modelle o matrici che chiama “strutture”,hanno un valore astratto e inconscio,un esempio sono il caso delle parentale.L’antropologo deve saper scorgere la struttura che vi è nei modelli e arrivare al pensiero umano.Pensando ai sistemi di parentela essi possono variare da società a società,alla base di tutti i sistemi matrimoniali è secondo levi-Stauss,la proibizione dell’incenso,la quale impedisce l’endogamia.
Bene, il senso di riportare questi estratti non ha niente a che fare con la pratica di ridere degli strafalcioni e dei più clamorosi errori degli studenti – pratica nella quale troppo spesso i docenti si fanno trascinare e che sta alla base di un diffuso ‘folklore accademico’, talvolta mera copertura di uno scarso impegno didattico. Penso invece che leggere questi testi – se riusciamo a andar oltre lo scivolamento inorridito dello sguardo, e capisco che non è facile – serva a capire il tipo di carenze che gli studenti presentano. E che a me paiono molto profonde. Prima di tutto, per usare il termine di Ricolfi, la struttura del discorso scritto non è incorporata. Ci sono norme che dovrebbero diventare habitus dalle elementari in poi – non so, la lettera maiuscola dopo il punto o minuscola dopo la virgola, la concordanza di genere e di numero fra nomi e aggettivi; tanto che per chi le ha incorporate la trasgressione provoca quasi una scossa, un bisogno fisico di correggerle. Il fatto che anche i refusi o le ipercorrezioni automatiche del software di scrittura (e spero che con la “proibizione dell’incenso” di questo si tratti) non siano sistematicamente corrette, vuol dire che non appare “naturale” neppure la banalissima pratica della rilettura. Tanto meno incorporate sono le strutture sintattiche che organizzano il discorso. L’impressione in molti casi è che la scrittura ricalchi una basilare oralità: cioè, poniamo, il modo in cui in un colloquio orale sarebbero espressi “con parole proprie”, incerte e oscillanti, nozioni non ben assimilate sul piano concettuale, e senza la padronanza del linguaggio specifico su cui un sapere disciplinare necessariamente si fonda.
Forse ciò che rende involontariamente comiche alcune di queste scritture è l’inserimento di spezzoni presi dai testi studiati (quel che non si può fare nell’orale se non con una accurata memorizzazione) all’interno di strutture discorsive generiche e quotidiane – che so, «l’etnocentrismo sarà un’idea a portata di Lévi-Strauss». E a proposito di Lévi-Strauss, le decine di variazioni errate del suo nome che compaiono in questi scritti (ma anche in quelli migliori che hanno ottenuto buoni voti), così come dei nomi di altri autori, lasciano perplessi: bastava controllare sui libri la giusta grafia. Fatica di controllare? Sottovalutazione della rilevanza di questi aspetti, come se si trattasse di ininfluenti dettagli formali?
Il punto è che tutti questi aspetti basilari nell’uso della scrittura si presuppongono appresi fin dalla scuola primaria. E invece queste e questi giovani hanno attraversato 13 anni di cicli scolastici, più uno o due anni di università, senza aver mai realmente acquisito questo saper fare, queste competenze così elementari senza cui divengono vani i gradini superiori dell’apprendimento. Infatti, avrebbe senso dire che negli estratti citati si può distinguere un contenuto acquisito (certi concetti di storia dell’antropologia, diciamo) dal modo confuso in cui tale contenuto è espresso? Mi pare evidente che non si può: perché l’apprendimento di quel contenuto consiste esattamente nel saperlo esprimere in un linguaggio specifico, chiaro e corretto. E quindi mi devo chiedere: ha senso, in questa situazione, che io mi sforzi di far capire la differenza fra il concetto di struttura in Radcliffe-Brown e in Lévi-Strauss (o in Brown e Strauss, come preferiscono dire)? È qualcosa che si può capire, da qualche parte nella propria mente, indipendentemente dalla capacità di enunciare proposizioni corrette in proposito? È una domanda non retorica e dalle implicazioni cognitiviste, alla quale non sono capace di dare una risposta. So però di non essere in grado, nelle valutazione di simili prove, di discernere fra quella eventuale comprensione e la sua risoluzione linguistica.
Comunque, è inevitabile chiedersi, in modo un po’ sciovinista: ma com’è che queste ragazze e ragazzi hanno avuto accesso all’Università? Come hanno fatto ad acquisire il diploma di maturità? La maturità non dovrebbe presupporre come requisito minimo l’incorporazione almeno del leggere, scrivere e far di conto? Anzi, non la dovrebbe già presupporre la licenza media? È possibile che in tredici anni di scuola nessuno li abbia mai portati a fare i conti con le competenze basilari della scrittura? (E che dire della lettura e del “far di conto”?). Ne segue una questione ancor più drammatica: è giusto dare la laurea (e, in particolare, una laurea umanistica) a persone che mantengono questo tipo di difficoltà? La domanda può apparire sciovinista per due motivi. Intanto, perché porta ogni ciclo scolastico a scaricare le responsabilità sul precedente (ci torno dopo); inoltre, perché parrebbe presupporre la nostalgia di una vecchia scuola selettiva e classista. Una scuola che produce e riproduce selezione sociale “bocciando” sulla base di competenze formali (padronanza linguistica etc.) che appartengono per definizione alla cultura egemonica e dunque alle classi dominanti. La vecchia scuola media di cui parla Ricolfi produceva sì un’istruzione più profonda, ma lo faceva solo per pochi, discriminando i ceti popolari; e “incorporava” sì certi codici culturali nei suoi allievi, ma lo faceva (direbbero i foucaultiani) disciplinarmente, producendo un “assoggettamento” che passava anche attraverso le regole apparentemente neutrali della grammatica, etc. Nel frattempo non è forse passata Lettera a una professoressa? Non sono passati i movimenti di educazione democratica che hanno denunciato la selettività scolastica come pilastro del dominio di classe?
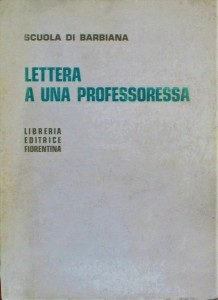 Sì, certo. Personalmente, mi sento figlio di Lettera a una professoressa (anche in virtù delle mie origini sociali), ma proprio per questo mi sembra fondamentale interrogarsi sul significato dell’eredità di don Milani, di Gramsci, di Mario Lodi etc. nel contesto dell’Italia di oggi. I primi decenni del dopoguerra hanno visto questi grandi educatori democratici battersi contro una struttura di classe che escludeva a priori dall’accesso all’istruzione i ceti popolari. La loro era una lotta per la scuola, non contro di essa: rivendicavano la possibilità per i figli degli operai e dei contadini di acquisire gli strumenti dell’alta cultura – della letteratura, della filosofia, della scienza. Vedevano l’educazione popolare come strumento cruciale per l’emancipazione dei ceti subalterni. E si contrapponevano non alla selettività della scuola in sé, ma all’ipocrisia che “promuoveva” o “bocciava” non sulla base del merito effettivo ma del bagaglio di classe di cui gli alunni erano dotati. Ritenevano ovvio che la scuola dovesse selezionare la classe dirigente, ma lottavano perché tutti potessero partire con le stesse possibilità. Per il resto, anzi proprio per questo, a Barbiana si lavorava duro, e partiti e sindacati organizzavano scuole popolari e biblioteche viaggianti per portare la cultura nei campi e nelle fabbriche, dove non era mai stata[5].
Sì, certo. Personalmente, mi sento figlio di Lettera a una professoressa (anche in virtù delle mie origini sociali), ma proprio per questo mi sembra fondamentale interrogarsi sul significato dell’eredità di don Milani, di Gramsci, di Mario Lodi etc. nel contesto dell’Italia di oggi. I primi decenni del dopoguerra hanno visto questi grandi educatori democratici battersi contro una struttura di classe che escludeva a priori dall’accesso all’istruzione i ceti popolari. La loro era una lotta per la scuola, non contro di essa: rivendicavano la possibilità per i figli degli operai e dei contadini di acquisire gli strumenti dell’alta cultura – della letteratura, della filosofia, della scienza. Vedevano l’educazione popolare come strumento cruciale per l’emancipazione dei ceti subalterni. E si contrapponevano non alla selettività della scuola in sé, ma all’ipocrisia che “promuoveva” o “bocciava” non sulla base del merito effettivo ma del bagaglio di classe di cui gli alunni erano dotati. Ritenevano ovvio che la scuola dovesse selezionare la classe dirigente, ma lottavano perché tutti potessero partire con le stesse possibilità. Per il resto, anzi proprio per questo, a Barbiana si lavorava duro, e partiti e sindacati organizzavano scuole popolari e biblioteche viaggianti per portare la cultura nei campi e nelle fabbriche, dove non era mai stata[5].
E oggi? La democratizzazione è in buona parte avvenuta, e gli insegnanti non sono più le Vestali della classe media. Scuola e insegnanti hanno però al tempo stesso perduto molto del loro prestigio sociale, anche per la concorrenza di altre agenzie culturali e di altri tipi di intellettuali, quelli che popolano l’universo della cultura di massa. La scuola si è fatta sempre più inclusiva e meno selettiva; sempre più simile a un servizio sociale che non a un’agenzia di istruzione e formazione. Il rigore dell’insegnamento è stato scambiato per repressione. I livelli dell’apprendimento si sono progressivamente abbassati, o almeno non sono cresciuti parallelamente allo sforzo di inclusione democratica. L’università l’ha in parte seguita in questa metamorfosi. I titoli che fornisce, pur mantenendo un certo prestigio (quello che spinge intere cerchie di parentela ad assistere alle sedute di laurea dei propri figli o nipoti, e a festeggiare con modalità che possono apparire di volta in volta commoventi o patetiche), sono diventati sempre meno significativi in relazione all’ingresso nel mercato del lavoro e al grado di prestigio sociale. Ci sono più “dottori” nell’Italia di oggi: ma questo la rende più democratica? C’è da dubitarne. Perché parallelamente scuola e università hanno perduto la loro reale propulsione democratica: hanno smesso di rappresentare un ascensore sociale, e una forza emancipativa per i ceti subalterni, comunque oggi vogliamo definirli. Una scuola e una università inflazionate non sono più un correttivo all’autoriproduzione interna delle classi dirigenti e dei ceti egemonici: perché il “titolo” non serve più a nulla, e si accede a professioni, a carriere dirigenziali e così via per appartenenza sociale più che per merito. Anche in questo senso l’Italia è oggi una società signorile, come sostiene Ricolfi: perché la ricchezza sta in mano a chi non lavora (e non studia), e perché la nascita è tornata a essere il perno cruciale della riproduzione del potere.
Come sopra accennato, si salvano in parte da questo meccanismo i corsi di studio d’élite, che praticano un rigoroso numero chiuso legato alle disponibilità di ruoli professionali. Ciò non significa, beninteso, che non vi sia anche in questi casi un alto livello di riproduzione di classe. Che so, c’è ovviamente un’alta percentuale di figli di medici che studia medicina. Ma esiste almeno la possibilità che alcuni giovani di diversa estrazione superino nelle prove di ammissione e nell’impegnativo curriculum i figli dei medici, semplicemente perché più bravi, realizzando così un deciso percorso di promozione sociale. Ciò non è semplicemente possibile per chi studia discipline umanistiche o sociali. Qui, una volta raggiunto l’inflazionato titolo, le cose restano come prima: e la possibilità di inserirsi nel mondo delle professioni e di far parte della “classe dirigente” dipenderà per lo più dall’influenza delle cerchie familiari. Cos’è dunque più democratica: la selettiva e arcaica Medicina, dove gli esami sono ancora una specie di ordalia basata su un durissimo lavoro mnemonico, e gli studenti ancora scoppiano a piangere sotto le rampogne dei professori, o le più “civilizzate” Lettere, Filosofia, Lingue o Scienze Politiche, dove si limita il numero di pagine da studiare per non turbare l’equilibrio affettivo degli studenti, e dove la laurea non si nega a nessuno, neppure a chi ignora i rudimenti della scrittura?
Infine: cosa possiamo fare? Nel mondo universitario tutti sono più o meno consapevoli di questi problemi. Ogni tanto se ne parla nei Consigli di corso di laurea, giusto il tempo per lamentarsi. Si fanno prove d’ingresso, anche per i corsi che non sono a numero chiuso. Ma, conformemente alla diffusa cultura docimologica, si tratta quasi sempre di test a risposta chiusa, che sono sì misurabili “oggettivamente” ma che mettono alla prova solo le competenze passive (come la comprensione di un testo, o il possesso di semplici nozioni che non richiedono una esposizione e verbalizzazione complessa). In ogni caso, raramente iniziative serie di recupero dei basic skills intellettuali vengono prese. Per motivi comprensibili. Non è compito nostro, si dice. Noi dobbiamo insegnare storia moderna, filosofia antica, antropologia, archeologia etc. Le basi della scrittura (e della lettura) dovrebbero averle acquisite prima. Ma anche nelle scuole superiori dicono la stessa cosa, rispetto alle medie; e alle medie rispetto alla scuola primaria. Persino a prima elementare ci si lamenta che i bambini non arrivano dalle materne “preparati”.
Lo scaricabarile sui cicli d’istruzione precedenti può essere in parte giustificato, ma non porta a nulla. C’è anche una paradossale circolarità in tutto questo. Infatti gli insegnanti della scuola primaria e secondaria si formano nelle università: e minore è la selettività della formazione e del reclutamento, minore sarà (statisticamente) la loro capacità e produttività. Sono tutti punti analizzati acutamente da Claudio Giunta, nel contributo sopra ricordato in dialogo con Lombardi Vallauri: assieme a un’altra fondamentale considerazione, cioè che i corsi di studio umanistici sono premiati e attraggono risorse (e pertanto anche possibilità di ricerca) sulla base di criteri di produttività che coincidono senz’altro con il numero di studenti promossi e con la rapidità dei loro percorsi di studio[6]. Per cui, se gli studenti non migliorano le loro prestazioni, basta abbassare l’asticella dei requisiti – pena tagliare il ramo su cui si sta seduti. Dunque, due soluzioni. O l’Università istituisce filtri rigorosi all’ingresso, non lasciando entrare chi non ha alcuni requisiti minimi: il che darebbe nuovo prestigio ai titoli, ma sarebbe sconsigliabile per tutta un’altra serie di motivi per gli studi umanistici. I quali dopo tutto rispondono a obiettivi di incremento della cultura generale oltre che di accesso alle professioni, e tendono a portare più persone nell’istruzione universitaria, non a escluderle. Oppure, dall’altra parte, si affronta di petto il problema, con nuovi impegni e investimenti. Si aprono laboratori, si istituiscono tutoraggi, si pianificano percorsi di recupero: ma non si laureano persone che scrivono così.
Ma perché non lo si vuole affrontare di petto? Perché la scrittura (oltre alla lettura) non emerge in primo piano come obiettivo politico-culturale. Nel momento in cui sto scrivendo (ottobre 2020) in Italia c’è grande enfasi sull’importanza della scuola, riaperta dopo la chiusura dovuta al contagio (e peraltro in procinto di chiudere di nuovo di fronte alla “seconda ondata” del coronavirus). Si parla molto e in modo vanamente retorico della contrapposizione fra didattica in presenza e didattica a distanza. Ma sulla natura e sulla qualità di questa didattica nemmeno una parola. Il documento del “Gruppo di Firenze”, citato all’inizio, parlava di disinteresse dei governi e dunque della politica; ma anche il mondo intellettuale, a parte qualche periodica lamentazione, non fa poi molto per porre il problema al centro dell’attenzione. La prevalente cultura pedagogica, poi, sembra decisamente sottovalutarlo. Anzi, peggio: la questione della scrittura (di quella degli universitari, della quale sto specificamente parlando; altri sono i problemi dell’alfabetizzazione di massa) si è trovata al centro di uno scontro ideologico-politico: per cui preoccuparsi della “bella scrittura” sarebbe di destra, mentre preoccuparsi dell’inclusione e rifiutare criteri troppo rigidi di selettività sarebbe di sinistra.
 Il dibattito sul già ricordato libro di Galli Della Loggia ci porta proprio in questo scenario. Si tratta di un libro di denuncia, che dà per scontato (“è sotto gli occhi tutti”) il declino del bagaglio di cultura che la scuola e l’università possono oggi offrire, attribuendolo (schematizzo) a tre grandi cause: a) l’influenza di una cultura politica “di sinistra”, che ha combattuto la selettività della scuola considerandola il prolungamento di un dominio di classe, e mirando a fare della scuola un dispositivo di inclusione e democratizzazione, spingendola lontano dalla sua funzione essenziale che è quella di istruire; b) le spinte della società liberista e consumista contemporanea, che tendono a svalutare lo studio rispetto alla ricchezza o al “successo”, privano i mezzi di comunicazione di massa di ogni carattere educativo e tendono a considerare la scuola un puro strumento di avviamento al lavoro; c) una cultura psico-pedagogica che lavora per skill affettivi e cognitivi, sostituendo agli obiettivi e ai contenuti tradizionali l’acquisizione di astratte competenze o “modi di essere”, sostituendo al pensare il “fare”.
Il dibattito sul già ricordato libro di Galli Della Loggia ci porta proprio in questo scenario. Si tratta di un libro di denuncia, che dà per scontato (“è sotto gli occhi tutti”) il declino del bagaglio di cultura che la scuola e l’università possono oggi offrire, attribuendolo (schematizzo) a tre grandi cause: a) l’influenza di una cultura politica “di sinistra”, che ha combattuto la selettività della scuola considerandola il prolungamento di un dominio di classe, e mirando a fare della scuola un dispositivo di inclusione e democratizzazione, spingendola lontano dalla sua funzione essenziale che è quella di istruire; b) le spinte della società liberista e consumista contemporanea, che tendono a svalutare lo studio rispetto alla ricchezza o al “successo”, privano i mezzi di comunicazione di massa di ogni carattere educativo e tendono a considerare la scuola un puro strumento di avviamento al lavoro; c) una cultura psico-pedagogica che lavora per skill affettivi e cognitivi, sostituendo agli obiettivi e ai contenuti tradizionali l’acquisizione di astratte competenze o “modi di essere”, sostituendo al pensare il “fare”.
Ci sono molti aspetti del libro con i quali ho difficoltà a consentire: in particolare una malcelata nostalgia di una vecchia scuola come la media non ancora unificata, del latino e del greco come insostituibili vertici dell’insegnamento, e un modo ingeneroso di valutare i tentativi di inclusione, di lotta alla dispersione, insomma di lavorare sui livelli di “retroguardia” più che su quelli di eccellenza. Tuttavia mi pare difficile non concordare con molti aspetti della diagnosi che propone (se non con l’eziologia): in particolare con l’osservazione che «il carattere, diciamo così, ‘leggero’ del nuovo modo d’insegnare, unito all’imperativo di scongiurare a tutti i costi il fallimento scolastico degli alunni, ha la conseguenza quasi inevitabile di mettere al bando ogni pedagogia dello sforzo, ogni esigenza cognitiva elevata a favore di quella che è stata chiamata una pedagogia della compensazione. Facendo così inevitabilmente venir meno, però, anche l’idea della scuola come ‘dovere’» [7]. Una cosa, aggiunge l’autore, che non sarebbe piaciuta al priore di Barbiana (al quale pure dedica un lungo capitolo ipercritico). Don Milani è infatti sì diventato vincente, o “egemone”, ma al prezzo della trasformazione della sua ispirazione rivoluzionaria in una «uggiosa sollecitudine paternalistica», della sua «altezzosa formazione intellettuale in disprezzo ideologico per la cultura». Torniamo a quanto osservavo sopra sulla necessità di storicizzare la “pedagogia democratica” dei grandi maestri del secondo dopoguerra. Mi pare che Galli Della Loggia abbia ragione a chiedersi se «l’espressione ‘democrazia nella scuola/scuola democratica’ non abbia cominciato a significare una cosa affatto diversa che per il passato»: vale a dire la rinuncia a «porsi in una posizione alternativa rispetto alla società, ad esempio premiando ciò che essa non premia, mirando a inculcare nei giovani valori diversi da quelli ufficialmente accreditati», e perdendo così «ogni significato progressivo per divenire solo l’alibi del mantenimento dello status quo»[8].
Colpisce allora vedere che la reazione a questo libro da parte dei più acuti e appassionati esponenti della tradizione della scuola democratica sia stata di totale rifiuto fino a giungere all’insulto, come nella stroncatura che gli dedica Christian Raimo [9]: il quale ha molti buoni argomenti a suo favore, specie riguardo l’eccessiva leggerezza con cui Galli Della Loggia tratta (anzi, non prende in considerazione) gli studi sullo schooling, e con cui liquida alcune figure storiche della scuola democratica (da Rousseau a Tullio De Mauro), ma sbaglia nel liquidare come “reazionarie” o “nostalgiche” le osservazioni critiche che il suo libro propone. Lo stesso autore, insieme a Simone Giusti, aveva già “stroncato” (l’espressione è sua) il documento del “Gruppo di Firenze” [10]. Anche qui, da un lato cercando di riportare giustamente il problema della scrittura alla più ampia dimensione della literacy (che però è qualcosa di diverso rispetto alla competenza linguistica che dovrebbero avere gli studenti universitari); dall’altra, tuttavia, derubricando semplicemente a “classismo” il fatto stesso di porre il problema. E, incredibilmente, proponendoci Les Heritiers di Bourdieu e Passeron, del 1964, come il principale riferimento che dovrebbe aiutarci a pensare l’oggi: saper scrivere bene sarebbe segno distintivo del privilegio di classe, che la scuola riproduce e amplifica, per cui invocarne l’importanza equivarrebbe ad essere servi dei padroni. Ora, Bourdieu era molto attento al mutare dei contesti storici, e il problema è come la prospettiva teorica che quel libro apre si applicherebbe allo stato attuale dei “rapporti di classe”, o per meglio dire delle relazioni fra piano egemonico e subalterno. In ogni caso, davvero dobbiamo scegliere fra la nostalgia della scuola media pre-riforma, da un lato, e dall’altro l’idea che l’insegnamento della grammatica o dell’imposizione del congiuntivo siano forme di violenza simbolica? Davvero l’inclusività e la democrazia, e il rigore dello studio e il riconoscimento del merito sono obiettivi in mutuo contrasto, come da versanti diversi Galli Della Loggia e Raimo sembrano sostenere? In modo più pacato, più sensibile alle ragioni degli altri, bisognerebbe ripartire da questo punto per affrontare la proibizione dell’incenso.
Dialoghi Mediterranei, n. 46, novembre 2020
Note
[1] L. Ricolfi, La società signorile di massa, Milano, La nave di Teseo, 2019: 58.
[2] Saper leggere e scrivere: una proposta contro il declino dell’italiano a scuola, http://gruppodifirenze.blogspot.com/
[3] C. Giunta, E. Lombardi Vallauri, Sull’utilità del saper scrivere (bene), in “Il Mulino”, 4, 2017: 657-70.
[4] E. Galli Della Loggia, L’aula vuota, Venezia, Marsilio, 2019.
[5] Beh, gli antropologi sostengono che in quei campi e in quelle fabbriche una cultura c’era sempre stata: era quella appunto “popolare”, o folklorica. Ma come ho cercato di mostrare altrove, l’interpretazione del folklore come strumento emancipativo, in opposizione o alternativa alla cultura ufficiale, è stata una disastrosa illusione dei movimenti degli anni ’60: e in ogni caso non aveva niente a che fare con le posizioni di Gramsci o, se è per questo, di Don Milani (F. Dei, Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Bologna, Il Mulino, 2018. )
[6] Sull’utilità del saper scrivere (bene), cit.: 659-60.
[7] E. Galli Della Loggia, L’aula vuota, cit.: 215.
[8] Ibid.: 220.
[9] C. Raimo, L’aula vuota di Ernesto Galli Della Loggia è un libro pessimo sotto ogni punto di vista, in Minima&Moralia, 12 giugno 2019 (http://www.minimaetmoralia.it/wp/laula-vuota-ernesto-galli-della-loggia-un-libro-pessimo-punto-vista/).
[10] S. Giusti, C. Raimo, Lo sviluppo di un paese passa per l’educazione linguistica: contro la lettera dei 600 e la nostalgia di una scuola classista, in Minima&Moralia, 9 febbraio 2017 (http://www.minimaetmoralia.it/wp/lo-sviluppo-un-paese-passa-leducazione-linguistica-la-lettera-dei-600-la-nostalgia-scuola-classista/).
______________________________________________________________
Fabio Dei, insegna Antropologia Culturale presso l’Università di Pisa. Si occupa di antropologia della violenza e delle forme della cultura popolare e di massa in Italia. Dirige la rivista Lares e ha pubblicato fra l’altro Antropologia della cultura materiale (con P. Meloni, Carocci, 2015), Terrore suicida. Religione, politica e violenza nelle culture del martirio (Donzelli, 2016), Antropologia culturale (Il Mulino, 2016, 2.a ed.), Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Il Mulino, 2018). Con C. Di Pasquale ha curato i volumi Stato, violenza, libertà. La critica del potere e l’antropologia contemporanea (Donzelli, 2017) e Rievocare il passato. Memoria culturale e identità territoriali (Pisa University Press, 2017).
______________________________________________________________









