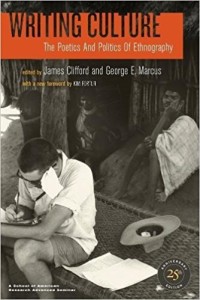di Rossana Maria Longo
James Clifford è uno dei maggiori esponenti del postmodernismo in antropologia, una figura di rilievo in campo internazionale che vale la pena prendere qui in considerazione, in questo breve saggio, per diverse ragioni, non ultima la sua attitudine a combinare insieme prospettive diverse: storiche, antropolo- giche e letterarie. Formatosi come storico, ha conseguito, nel 1977, il Ph.D. all’Università di Harvard e, dal 1978, ha insegnato all’Università della California a Santa Cruz. La sua formazione e il suo interesse per antropologia e letteratura gli hanno consentito uno sguardo più disincantato e aperto rispetto ad altri antropologi del passato con uno sguardo meno interdisciplinare del suo. Per quanto riguarda la sua formazione, lui stesso afferma, nell’intervista concessa a Gonçalves nel 1994, che, già mentre studiava per il dottorato, gli era chiaro che non sarebbe diventato né un vero antropologo, né un vero storico: era troppo interessato proprio alla letteratura e agli studi di critica letteraria e culturale [1].
I primi lavori di Clifford hanno contribuito in modo importante a innovare la storia dell’antropologia, ponendo enfasi particolare sui concetti di cultura, arte ed esotico. Il suo primo libro, Person and Myth: Maurice Leenhardt in the Melanesian World (1992), esplora i limiti e le possibilità di una comprensione interculturale nel violento contesto della Nuova Caledonia francese. Nei libri successivi, si sviluppa maggiormente il suo pensiero critico in senso interdisciplinare: Scrivere le culture: la poetica e la politica dell’etnografia (1986) e I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX (1988). Questi due testi – il primo in co-curatela con Marcus e il secondo interamente suo – si possono considerare una vera e propria svolta per l’antropologia. Infatti, nonostante egli stesso affermi, qui e lì, che questi testi non hanno introdotto nuovi paradigmi, comunque sia, essi «sono stati parte integrante di un fermento, di qualcosa che stava già accadendo, che ha [...] mutato le pratiche antropologiche in maniera significativa» [2]. Entrambi i libri sollevano domande importanti riguardo la rappresentazione interculturale e i modi di affrontarla in maniera più scaltrita, meno convenzionale.
Clifford vi espone l’idea, in sintesi, secondo la quale ci troviamo, tutti, in una condizione di modernità etnografica, caratterizzata da tradizioni culturali disgregate e diversamente riaggregate nel tempo e nello spazio. A queste opere, fanno seguito ben tre volumi. Strade: viaggio e traduzione alla fine del XX secolo (1997), il quale, rispetto al precedente I frutti puri impazziscono, s’incentra sull’idea di “viaggio”, un elemento considerato oggigiorno – proprio grazie ai suoi lavori – parte integrante del lavoro sul campo e “luogo di contatto” fra culture. Del 2003 è Ai margini dell’antropologia, una raccolta significativa di interviste in cui Clifford chiarisce i suoi rapporti con altre discipline e studiosi. Infine, Returns: Becoming Indigenous in the Twenty First Century (2013) chiude la trilogia iniziata con I frutti puri impazziscono e si presenta come una critica all’etnografia storica e al contempo un tentativo di metterla in pratica concretamente. Tra le altre cose, elemento di considerevole rilievo, James Clifford è stato anche direttore dell’UCSC (Center for Cultural Studies) e, ancora oggi, continua a lavorare su questioni legate all’indigenità, alla globalizzazione, agli studi museali, agli studi letterari e alle arti visive, tenendo conto delle interconnessioni e traduzioni interculturali.
Nonostante non si sia formato come antropologo in modo tradizionale, il contributo di Clifford alla disciplina risulta fondamentale per lo sviluppo del postmodernismo, etichetta comunque da lui rifiutata perché ritenuta troppo riduttiva. Fondamentale è la cosiddetta svolta “letteraria” promossa, tra gli altri postmodernisti, anche da Clifford che pone nuova attenzione all’etnografia e alle tecniche di scrittura. I testi etnografici, in questa chiave, non sono più considerati rappresentazioni “realistiche” della cultura di cui parlano, ma “allegorie” di carattere sia letterario sia scientifico che mettono in scena l’alterità e allo stesso tempo le relazioni di potere stabilite tra autori e soggetti rappresentati. Scrive Clifford che «I testi etnografici sono inevitabilmente allegorici: accettarlo veramente determina un mutamento nei modi di scrivere o leggere l’etnografia.» [3], infatti, se ci si concentra sugli aspetti allegorici dell’etnografia, si può notare che anche le descrizioni realiste non vanno viste in sé, in una sorta di chiusura e compostezza finalistica, ma in quanto metafore estese che rimandano ad altri significati.
Così, grazie a Clifford, l’etnografia inizia a essere considerata allegorica, sia dal punto di vita contenutistico che formale: lo stile letterario che dà forma alle sue opere – attraverso l’uso di metafore e di una forma narrativa non lineare, fatta di giustapposizioni – mette in scena strategie narrative che vogliono rappresentare, nella sua complessità, i rapporti interni ed esterni alle culture; la sovrapposizione di idee e significati che ne consegue porta alla frantumazione della loro natura apparentemente monolitica. In virtù della nuova consapevolezza acquisita nei confronti della propria scrittura, l’etnografo elabora nuove modalità testuali più “dialogiche” e “polifoniche” che danno spazio a voci Altre con cui lo studioso si rapporta: non solo quelle dei nativi, ma anche quelle provenienti da altre modalità di rappresentazione, come ad esempio quelle letterarie e artistiche. Questa polifonia, in realtà, non riguarda solamente la scrittura etnografica: secondo James Clifford, infatti, la cultura stessa – e di conseguenza anche le etnografie – non sono più dei “frutti puri”, ma dei prodotti che derivano da incroci e incontri diversi. Nell’opera I frutti puri impazziscono, per esempio, Clifford sostiene che è impossibile, per una cultura, incarnare la purezza e rappresentare l’incontaminato, soprattutto in un mondo che diviene sempre più globalizzato, ricco di scambi e contatti interculturali. Tuttavia, proprio da quella che potrebbe sembrare la perdita di autenticità e purezza, emerge la possibilità di una infinita ricomposizione, che, nei testi di Clifford, si traduce in un’opera di pastiche o – come, lo definisce lui stesso – in un collage. Afferma Clifford, riferendosi alla cultura tradizionalmente concepita:
«Ho lavorato a disarticolare la sua costellazione di luoghi comuni, concentrando l’attenzione sui processi della rappresentazione etnografica. Per liberare l’idea di cultura dai suoi lacci ho impiegato concetti allargati dello scrivere e del collage: il primo visto come interattivo, aperto e processuale, e il secondo come un mezzo per far spazio all’eterogeneità» [4].
L’impossibilità di essere ben definita che, ora, caratterizza il concetto di cultura, comunque, non riguarda solo questa. Infatti, anche i luoghi sono sempre più indefiniti e permeabili a molteplici influssi, e così anche i rapporti tra “culture” e “luoghi” sono cambiati, rendendo improponibile l’idea di una loro coincidenza assoluta e invariabile, come viene ribadito in Strade. In questo volume, Clifford collega lo studio della cultura al concetto di “viaggio” e, per l’appunto, a quello di “strade”: fondamentale diventa, così, il senso del passaggio della frontiera e del contatto con nuovi mondi, indicativi della costante ibridazione che caratterizza le culture nella contemporaneità.
 I frutti puri impazziscono: la funzione del collage
I frutti puri impazziscono: la funzione del collage
Come già detto, Clifford è uno dei primi ad accostare l’antropologia – nello specifico l’etnografia – all’arte e, in particolare, alla letteratura. In Scrivere le Culture afferma che «si sostiene da tempo che l’antropologia [...] sia anche un’“arte”, e che le etnografie abbiano qualità letterarie» [5]. La questione viene poi approfondita dallo studioso in I Frutti Puri Impazziscono, nel quale prosegue la sua ricerca sostenendo che «L’etnografia moderna si presenta in parecchie forme, tradizionali e innovative» [6]: una di queste forme innovative è il collage, dato che «i confini tra arte e scienza (specialmente nelle scienze umane) sono ideologici e mutevoli, [...] mutevoli definizioni di arte e scienza provocano necessariamente nuove unità retrospettive, nuovi tipi ideali per la descrizione» [7]. Considerata la nuova idea che si è venuta formando con il postmodernismo (secondo la quale la cultura non è più una monolitica tradizione da salvare, ma un assemblaggio di codici e artefatti che si possono combinare sempre in nuove forme creative o critiche), il collage si presenta come il perfetto strumento retorico-letterario per rappresentarla. Il collage, infatti, «apporta all’opera (in questo caso, il testo etnografico) elementi che proclamano la loro estraneità al contesto in cui sono presentati» [8].
Il collage viene visto da Clifford come lo strumento più adatto alla nuova etnografia in virtù della sua capacità di unire elementi totalmente differenti, per esempio mettendo in contatto fra di loro elementi estranei al contesto in cui sono presentati; scrivere etnografie utilizzando il collage significa evitare di ridurre le culture a totalità organiche monolitiche, ma anche rendere manifeste le procedure che contribuiscono alla conoscenza etnografica. Secondo Clifford, antropologia e arte sono legate tra loro e il collage, in etnografia, è un richiamo al movimento surrealista. Così come l’etnografia postmoderna, il surrealismo si presenta come una estetica che valorizza il frammento ed è portato a considerare la cultura e le sue norme come assetti artificiali suscettibili di un’analisi partecipativa e di ricombinazioni varie. Surrealismo ed etnografia prendono mossa, entrambe, da una realtà messa in discussione:
«La realtà non è più un ambiente dato, naturale, familiare. L’io, sciolto dai suoi legami, deve scoprire un significato dove sia possibile: una situazione [...] che è alla base sia del surrealismo, sia dell’etnografia moderna» [9].
A differenza del positivismo e dell’esotismo ottocenteschi (dove si era sicuri della propria realtà e si cercavano fugaci momenti fuori dall’ordinario), surrealismo ed etnografia mettono in discussione il proprio contesto e sono alla ricerca di una seria alternativa al modo di vivere noto e stereotipato. Allora, artisti e scrittori (ed etnografi) iniziano a mettere insieme pezzi di cultura in modi nuovi:
«Le società “primitive” del pianeta erano sempre più disponibili come risorse estetiche [...] Tali possibilità [...] richiedevano la moderna etnografia. [...] Per ogni consuetudine c’era sempre un’alternativa esotica, una possibilità di raffronto o contraddizione» [10].
La concezione di cultura come composta di codici simbolici intrecciati e al contempo imbricati, così come la perplessità relativa alla disposizione corretta di tali simboli, rendono il collage fondamentale, rendendolo mezzo utile per l’etnografo che, nel suo lavoro, si appresta a comporre e scomporre quelle che venivano considerate, una volta, le gerarchie naturali della cultura. Nell’etnografia che fa uso di questo stile di pensiero, il “momento surrealista”, si palesa quando, dice Clifford, si può fare una comparazione in un momento di tensione non mediata, nell’attimo in cui realtà culturali diverse sono costrette a una contiguità che “stona” e fa attrito. Pensare al surrealismo come etnografia vuol dire mettere in discussione il ruolo centrale dell’artista in quanto origine assoluta e propendere per una sua visione più contestualizzata, posizionata. In questo senso, umanesimo antropologico e surrealismo non si escludono, ma sono parti differenti di uno stesso contesto: il primo comincia con il diverso e lo rende comprensibile e familiare; il secondo aggredisce il familiare rivelando il suo lato inaspettato; entrambi fanno parte di un processo che genera significati culturali, processo caratteristico della postmodernità mondiale che si manifesta nei testi scritti proprio tramite forme di collage. In conclusione, il collage si costituisce come punto comune fra surrealismo e etnografia postmodernista; così, afferma Clifford, il surrealismo è il compagno segreto della nuova etnografia che si trova a essere in stretto contatto con arte e letteratura. Lo strumento del collage, essendo legato all’idea di cultura, è associato, dunque, anche alla nuova concezione di fieldwork elaborata da Clifford.
 Il fieldwork, il viaggio e la sua funzione retorica
Il fieldwork, il viaggio e la sua funzione retorica
Come già visto, Clifford introduce in antropologia un’idea di cultura più dinamica e ibrida che prende forma in luoghi dai confini poco definiti; questo nuova concezione della cultura e dei suoi luoghi influenza il modo in cui si vede il lavoro sul campo (che porta l’antropologo a prendere in considerazione anche l’idea di viaggio). Il lavoro sul campo costituisce una delle pratiche professionali più importanti quando si vogliono rappresentare le culture: «L’antropologia è sempre stata qualcosa di più che il lavoro sul campo, ma il lavoro sul campo è sempre stato qualcosa che un antropologo doveva aver fatto, più o meno bene, almeno una volta» [11]. Questo ha sempre rappresentato un metodo con specifiche caratteristiche di estensione ed interazione; tuttavia, la molteplicità delle pratiche da cui è formata rende sfocato il significato di lavoro sul campo e i suoi limiti: dove gli antropologi del passato tracciano confini, Clifford si propone di descrivere terre di frontiere e luoghi di contatto [12]; così, il lavoro sul campo inizia a essere concepito come un viaggio che «illumina attività concrete, perseguite in luoghi storicamente e politicamente definiti [...] contribuisce ad aprire nuove possibilità, ad allargare e complicare i sentieri etnografici» [13].
In pratica, secondo Clifford, le pratiche stesse di spostamento diventano costitutive dei significati culturali [14]: il viaggio produce conoscenza e nuove espressioni culturali, di conseguenza si può considerare parte integrante del fieldwork. L’etnografia del passato utilizzava “strategie localizzanti” nella costruzione e rappresentazione delle culture studiate: il fieldwork stesso veniva localizzato in “qualche posto”, all’interno di confini ben definiti. La generazione di Boas, per esempio, considerava il campo come una sorta di “laboratorio”; talvolta, il campo veniva pure visto come il luogo di un’iniziazione e rito di passaggio, soprattutto in una prospettiva malinowskiana. Clifford afferma che si considera sovente in antropologia il “campo” come un luogo concreto di attività professionale [15], un luogo lontano che “adotta” lo studioso:
«Il campo è una casa lontano da casa [...] Gli etnografi sono, tipicamente, dei viaggiatori che amano fermarsi e indagare (per qualche tempo). Diversamente da altri viaggiatori, che preferiscono attraversare un luogo dopo l’altro, gli antropologi tendono a essere gente di casa fuori casa. Il campo come pratica spaziale è dunque una forma di residenza specifica per stile, qualità e durata »[16].
Sempre secondo Clifford, il concetto di lavoro sul campo ha continuato ad evolversi: mentre prima il fieldwork richiedeva uno spostamento, un viaggio verso una terra lontana e “diversa”, oggigiorno, invece, si può considerare “campo” non solo un luogo distante ed esotico, ma anche un quartiere di una stessa città o addirittura un gruppo di persone. Scrive Clifford, infatti, che
«Di norma, il lavoro sul campo postula che si lasci fisicamente la «casa» (comunque la si definisca) per viaggiare entrando e uscendo da qualche ambiente distintamente diverso. Oggi, l’ambiente può essere l’altopiano della Nuova Guinea; o può essere un vicinato, un’abitazione »[17].
In questo modo, il lavoro sul campo non consiste più solamente in lunghi soggiorni all’estero, ma può essere anche un insieme di brevi visite. L’idea di Clifford – il campo come “incontri di viaggio” – diventa costitutiva del nuovo fieldwork compiuto vicino casa: così, il lavoro sul campo ha luogo in relazioni mondane, contingenti, di viaggio, non in siti controllati di ricerca [18]. La ridefinizione di “cosa” costituisce un campo di lavoro ha portato in parallelo allo sperimentalismo nella scrittura etnografica. La letterarietà, guardata con sospetto o ignorata in passato, viene rivalutata in etnografia e viene attribuita estrema importanza alla comunicazione retorica dei dati: questi non parlano da soli, ma devono essere introdotti ed essere credibili.
Questa crescente consapevolezza, osserva Clifford, si manifesta in un più concreto senso testuale della posizione dell’etnografo [19]; elementi della narrativa che erano stati esclusi tornano a essere ora in primo piano, fra cui i percorsi del ricercatore per arrivare al campo e al suo interno – da qui l’idea postmoderna che la scrittura è fondamentale per capire in che modo (processualmente) l’antropologo è giunto ad una determinata conoscenza. In conclusione, afferma Clifford, il lavoro sul campo in passato è consistito in definite pratiche spaziali; le varie pratiche spaziali sono cambiate adesso e continuano a cambiare, ma il tentativo di regolare il lavoro sul campo rimane una scelta critica per mantenere il più intatta possibile l’identità dell’antropologia: resta un marchio distintivo della disciplina mentre il viaggio, seppur ridefinito, rimane costitutivo del lavoro sul campo.
Il contrasto con Malinowski
Il tipo di ricerca sul campo propugnato da Clifford si pone in contrasto con il fieldwork tradizionalmente concepito da Malinowski e dai suoi allievi. È necessario però ribadire che, già la visione di Malinowski, all’epoca, si presentava come altamente innovativa; infatti, in passato, gli antropologi (gli evoluzionisti) non lavoravano sul campo, ma mandavano altri sul posto a raccogliere dati che poi loro avrebbero rielaborato nei loro studi: interazione con i nativi e residenza sul campo non erano elementi fondamentali. Con l’intervento di Malinowski, ciò cambiò radicalmente: egli promosse l’idea di osservazione partecipante che rifiutava lo stile di ricerca precedente ed esigeva che si vivesse a tempo pieno nel villaggio, rivendicando quindi una visione olistica della cultura studiata.
L’antropologo rappresentato da Malinowski è un uomo che agisce in modo determinato ed è indefessamente dedito al proprio lavoro. Clifford, da parte sua, elabora ulteriormente il concetto di fieldwork, adattandolo ai mutamenti storico-politici che hanno portato alla globalizzazione, cambiando il significato di “vicino” e “lontano” e di “Sé” e “Altri”. Per Clifford, il lavoro sul campo è privo di confini precisi, non può fornire una conoscenza totale dell’altro ed è fatto di dialogo, essendo il campo il luogo in cui le culture entrano in contatto proprio “dialogando” fra loro. Inoltre, il lavoro sul campo è anche viaggio, ed è proprio il ruolo che quest’ultimo assume nel fieldwork ad essere una delle differenze fondamentali fra Malinowski e Clifford. Malinowski, nel narrare in Argonauti del Pacifico occidentale la sua esperienza di fieldwork nelle isole Trobriand, taglia fuori il viaggio: iniziando l’opera con la scena del naufragio, considera il campo come un ritaglio temporale e spaziale ben preciso al di fuori da ciò che lo precede. Al contrario, in Clifford, il concetto di campo viene visto nelle sue ambiguità: come qualcosa ormai difficile da circoscrivere, dovuto alla proliferazione dei contatti, delle ibridazioni e delle compressioni spazio-temporali caratterizzanti l’epoca postmoderna. Il fieldwork viene, dunque, rielaborato in virtù di questi mutamenti; fondamentale importanza assume il viaggio e la continuità che esiste tra esso e il lavoro sul campo.
«Se, allora, per Clifford il viaggio è già ricerca in quanto funzione instabile del contatto tra culture in perdurante viaggio, per Malinowski, la ricerca è invece all’insegna della durata inquadrata da un inizio e una fine precisi; se per Clifford la ricerca è dell’ordine dell’imperfettivo (non concluso, durativo, incompiuto e iterativo), per Malinowski è all’insegna del perfettivo (concluso, puntuale, compiuto)» [20].
Per questo motivo, i testi etnografici dei due antropologi appaiono così differenti: mentre Clifford parla di collage, «passando, nei suoi volumi, da uno scritto di storia a un’esperienza vissuta in un’aula di tribunale, saltando da un testo di epistemologia dell’antropologia a una riflessione su un museo» [21], Malinowski «trasuda invece pianificazione in tutto il testo degli Argonauti [...] mettendo in primo piano l’intenzionalità esplicita presente nelle sue decisioni e la vita concreta sul campo» [22].
Per riassumere, Malinowski, con gli Argonauti, crea un testo scientifico in cui l’inizio della ricerca coincide con l’inizio di un testo: un testo in cui lo studioso, armato di forza di buona volontà, non guarda al viaggio che ha intrapreso e alla vita lasciatasi alle spalle, ma dedica solo uno sguardo nostalgico al mezzo che lo ha condotto sul posto. Clifford, al contrario, non solo pone l’accento sul viaggio (e, addirittura, anche sul mezzo di trasporto), ma non si lascia affatto alle spalle la vita precedente il fieldwork; anzi, Clifford – come ribadisce Montes – nel suo ultimo volume (Returns: Becoming Indigenous in the Twenty First Century) afferma «il valore dei ritorni in tutta la loro importanza, parlando pertanto di storie di trasformazione» [23].
Dialoghi Mediterranei, n.30, marzo 2018
Note
[1] Clifford 2003: 11.
[2] Ibidem: 20.
[3] Clifford 1997: 146.
[4] Clifford 1999: 9.
[5] Clifford in Clifford-Marcus 1997: 29.
[6] Clifford 1993: 21.
[7] Ibidem: 144-145.
[8] Ibidem: 175.
[9] Ibidem: 145.
[10] Ibidem: 147.
[11] Clifford 1999: 82.
[12] Ibidem: 15.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem: 9.
[15] Ibidem: 30.
[16] Ibidem: 31.
[17] Ibidem: 75.
[18] Ibidem: 87.
[19] Ibidem: 86.
[20] Montes 2018.
[21] Ibidem: 19.
[22] Ibidem
[23] Ibidem: 20.
Riferimenti bibliografici
Clifford J., I frutti puri impazziscono, Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.
Clifford J., Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
Clifford J., Ai margini dell’antropologia. Interviste, Meltemi, Roma, 2003.
Clifford J., Marcus G. E., a cura di, Scrivere le culture. Poetiche e politiche dell’etnografia, Meltemi, Roma, 1997.
D’Agostino G., Clifford Geertz: l’antropologia dei margini, in Discorso sugli uomini, a cura di V. Matera, Utet, Torino 2008: 149-164.
Malighetti R., Clifford Geertz. Il lavoro dell’antropologo, Utet, Torino 2008.
Montes S., “Aspettare e aspettualizzare. Uno sguardo semioantropologico su esistenza e fieldwork”, in Dialoghi Mediterranei, 29, gennaio 2018.
________________________________________________________________________________
Rossana Maria Longo, laureanda in Lingue e Letterature Moderne e Mediazione Linguistica all’Università degli studi di Palermo, si interessa di antropologia, in particolare dei rapporti tra concetti e formazione storica, ma si dedica anche allo studio delle lingue straniere, della letteratura e della traduzione.
________________________________________________________________