Seguendo l’evoluzione che i processi e le forme della comunicazione politica hanno registrato negli ultimi anni possiamo notare quanto oggi l’oratoria politica punti sempre più, per portare l’opinione pubblica dalla sua parte, a provocare un surriscaldamento percettivo che sia capace di stimolare partecipazione, reazione, discussione, interesse. Per raggiungere questo obiettivo viene sfruttata in molti casi la dicotomia tra modello\antimodello, basata sulla figura dell’antitesi, in cui, a prescindere dai contenuti, uno dei due poli è contrassegnato sempre positivamente e l’altro all’opposto negativamente, in modo che il primo escluda per definizione il secondo. Questa strategia si è sempre più affermata nella comunicazione politica contemporanea, almeno degli ultimi vent’anni, e si manifesta secondo tre principali modalità.
La prima oppone al campo semantico del “nuovo” quello del “vecchio”: è una contrapposizione immediata, non soltanto perché il nuovo è tale in quanto non è vecchio, ma anche perché nella sostanza dell’azione politica la dialettica nuovo/vecchio è, innanzitutto, contrapposizione tra modi di fare politica, tra fazioni e concezioni politiche. In questa direzione si muove la metafora della “rottamazione” utilizzata da Renzi.
La seconda modalità è rappresentata dalla contrapposizione Noi/Loro in cui è l’individuazione del nemico che permette la costruzione di un’identità politica altrimenti assente (Mori 2009: 234). È la strategia seguita da Berlusconi con il nemico rappresentato dal comunismo, o quella adottata da Renzi in cui il “Loro” identifica tutte le forze politiche che si sono succedute in questi anni al Governo (compresa la vecchia guardia del Pd), e che gli ha permesso di presentarsi come l’uomo del rinnovamento che parla dei bisogni e dei sentimenti delle persone come se fossero i suoi, puntando a far riconoscere tutti in quel ritratto.
La terza è data dalla retorica del cambiamento costruita sull’antitesi innovazione\conservazione: lo slogan usato a suo tempo da Renzi è stato “Cambiare verso”. Il claim, ideato dall’agenzia barese Proforma, che aveva già lavorato alle campagne di Monti e Vendola, si presta ad una duplice interpretazione: il “verso” può essere considerato l’oggetto del verbo cambiare, o semplicemente un avverbio di luogo lasciato in sospeso volontariamente per indicare un movimento verso una direzione che, proprio perché non precisata, può risultare più suggestiva. Ad ogni modo il messaggio è centrato sul “cambiare”. Una variante è rappresentata dallo slogan – utilizzato recentemente da Salvini, ma ricorrente anche nelle campagne politiche di Berlusconi e Renzi – sull’“Italia dei Sì” (sempre positiva) contro “l’Italia dei No” (sempre negativa).
Queste tre modalità hanno in comune il fatto di basarsi su una forma di ragionamento scorretto o fallacia argomentativa che, pur essendo manchevole dal punto di vista della cogenza del ragionamento, o da quello della correttezza delle premesse, risulta psicologicamente efficace e fa presa sul pubblico: la fallacia di presupposizione (D’Agostini 2010: 124-28) nella quale si dà per scontato ciò che si intende dimostrare, senza portare alcuna prova al riguardo e senza mai entrare nel merito delle questioni, permettendo al soggetto politico di non rendere conto del proprio operato. Ad esempio, per rispondere alle numerose critiche rivolte dai cittadini e anche da alcuni commentatori alle riforme promosse dal governo Renzi (prima fra tutte la riforma costituzionale, ma anche quelle sul lavoro, sulla scuola, sulla pubblica amministrazione ecc.), gli esponenti della maggioranza hanno detto in più occasioni che un’innovazione era comunque necessaria, che la riforma è sinonimo di cambiamento, e un cambiamento è sinonimo di miglioramento, evoluzione, progresso. Il messaggio proposto è che la situazione andava modificata, chi critica il rinnovamento è allora un conservatore che vuole mantenere le cose così come sono e la conservazione è di per sé un fattore negativo da stigmatizzare. Invece di analizzare i contenuti delle riforme e di confrontare ciò che si intende eliminare con ciò che si vorrebbe sostituire, ci si limita a declamare uno slogan sul cambiamento in quanto tale che dal punto di vista argomentativo non ha alcun valore (Travaglio, Truzzi 2016).
La presupposizione che sta dietro all’affermazione in questione è che il nuovo che interrompe la continuità di una tradizione vale in quanto tale come positivo e che l’essere conservatore di qualcosa abbia aprioristicamente una qualifica negativa, a prescindere da quale sia in concreto il contenuto che si intende preservare. Si cerca di convincere l’opinione pubblica che le riforme siano di per sé sinonimo di miglioramento della società; oppure che l’intraprendere delle opere, il “fare” (si veda il caso del TAV) sia sempre segno di azione positiva, mentre il “non fare” è in ogni caso negativo. Questa strategia, pur essendo del tutto ingannevole, sembra convincente perché in un Paese senza memoria come il nostro quasi nessuno penserà a come la situazione generale sarebbe oggi migliore se in passato la politica e i media avessero respinto scelte come la privatizzazione delle autostrade, il Mose, i mondiali di calcio del 1990, le olimpiadi invernali di Torino nel 2006 e tanti altri eventi e opere inutili che hanno sperperato ingenti quantità di denaro pubblico senza conseguire quei benefici che allora venivano tanto sbandierati.
Le fallacie di presupposizione sono insidiose perché falsano le regole del dibattito e lo svuotano dal suo interno: si chiede al pubblico di accettare una tesi in modo del tutto acritico senza esaminare mai l’oggetto del contendere; in questo modo la discussione si riduce alla proposta di slogan fine a se stessi. Ci troviamo di fronte in questo caso a una retorica assertiva, che è tipica dei sistemi propagandistici sviluppatisi nel corso del Novecento, non solamente nei regimi dittatoriali, ma anche negli organismi politici democratici (Bernays 1928).
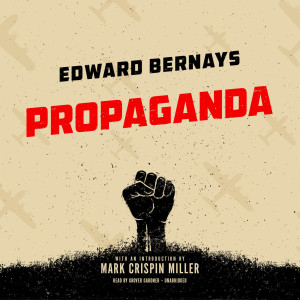 La retorica assertiva prevede anche l’uso dell’argomento di autorità – una delle forme di esplicazione della fallacia ad hominem (Frixione 2007: 33-38) – in cui a garanzia della fondatezza delle tesi non ci sono tanto gli elementi di tipo argomentativo, quanto il valore e la qualità della persona che le sostiene. Gli aspetti enunciativi che riguardano il contenuto del discorso sono messi in secondo piano rispetto a quelli enunciazionali che si riferiscono, invece, alla presenza di chi pronuncia il discorso, con la conseguenza che non è tanto importante cosa si dice, quanto chi sta parlando in questo momento (Manetti 2018: 23-25).
La retorica assertiva prevede anche l’uso dell’argomento di autorità – una delle forme di esplicazione della fallacia ad hominem (Frixione 2007: 33-38) – in cui a garanzia della fondatezza delle tesi non ci sono tanto gli elementi di tipo argomentativo, quanto il valore e la qualità della persona che le sostiene. Gli aspetti enunciativi che riguardano il contenuto del discorso sono messi in secondo piano rispetto a quelli enunciazionali che si riferiscono, invece, alla presenza di chi pronuncia il discorso, con la conseguenza che non è tanto importante cosa si dice, quanto chi sta parlando in questo momento (Manetti 2018: 23-25).
In questa maniera si verificano due conseguenze negative: la prima è la rottura dell’equilibrio nell’uso delle tre argomentazioni di matrice aristotelica, l’ethos, il pathos e il logos, dove il primo diventa elemento privilegiato dell’argomentazione, in modo da relegare il logos a svolgere una funzione decisamente più limitata e secondaria. La seconda conseguenza consiste nell’ignorare il fatto che in linea di principio gli elementi dell’ethos non dovrebbero essere confusi o soprapposti al logos e viceversa; è vero che entrambi partecipano alla costruzione del discorso, ed è vero che il fattore personale svolge una funzione persuasiva da non sottovalutare, ma ciascuno di essi dovrebbe partecipare all’organizzazione del discorso secondo le proprie prerogative e specificità che andrebbero tenute distinte.
La retorica assertiva risulta efficace nei contesti elettorali perché è funzionale al fenomeno noto come “personalizzazione della politica” (Vaccari 2007) che ha assunto sempre più una notevole rilevanza. Una conseguenza di questo fenomeno è il fatto che diventa fondamentale quel meccanismo definito come storytelling (Bertetti 2017), dove i personaggi politici diventano degli eroi al centro di una narrazione che coinvolge sempre più la sfera della vita privata, per cui sono i dettagli delle loro esperienze personali e delle loro abitudini a influenzare la pubblica opinione, più che le loro idee e le loro scelte politiche. Non deve sorprendere allora la sempre più ampia diffusione sui social e sui media di immagini che ritraggono esponenti importanti della politica italiana, come Monti, Renzi o Salvini, in scene di vita quotidiana, ad esempio con gli animali domestici, durante i pasti, nei momenti di svago ecc. (Segreto 2018: 123-28). Scene che sono perlopiù insignificanti o irrilevanti, ma che risultano utili per la costruzione di quel meccanismo di fiducia irrazionale che, se è accettabile nell’ambito del discorso pubblicitario, dovrebbe essere invece fortemente stigmatizzato per il discorso deliberativo.
 Lo storytelling è sempre più utilizzato nella comunicazione politica perché si rivela adatto a indirizzare la gente verso le cose superficiali della vita, il consumo, lo spettacolo, lo sport, il gossip, evitando che si interessi delle questioni importanti della vita economica e sociale del proprio Paese e che partecipi in modo attivo alla sfera pubblica. Questa è la strategia della distrazione perseguita dall’industria dell’intrattenimento (della quale fanno parte la pubblicità, la televisione spazzatura, il cinema commerciale ecc.), che consiste appunto nel distogliere l’attenzione del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle élites politiche ed economiche utilizzando la tecnica del diluvio o dell’inondazione di distrazioni continue e di informazioni insignificanti. Il pubblico in questa maniera resta prigioniero della “filosofia della futilità” (Lasch 1979: 88) che rende le persone prigioniere del consumismo, dicendo loro qual è lo stile di vita da seguire, quali oggetti possedere, che cosa fare per la propria salute, promuovendo il consumo come alternativa alla ribellione, al fine di plasmare consumatori disinformati che fanno scelte irrazionali addirittura spesso contro i loro stessi interessi (Chomsky 2017: 122-27).
Lo storytelling è sempre più utilizzato nella comunicazione politica perché si rivela adatto a indirizzare la gente verso le cose superficiali della vita, il consumo, lo spettacolo, lo sport, il gossip, evitando che si interessi delle questioni importanti della vita economica e sociale del proprio Paese e che partecipi in modo attivo alla sfera pubblica. Questa è la strategia della distrazione perseguita dall’industria dell’intrattenimento (della quale fanno parte la pubblicità, la televisione spazzatura, il cinema commerciale ecc.), che consiste appunto nel distogliere l’attenzione del pubblico dai problemi importanti e dai cambiamenti decisi dalle élites politiche ed economiche utilizzando la tecnica del diluvio o dell’inondazione di distrazioni continue e di informazioni insignificanti. Il pubblico in questa maniera resta prigioniero della “filosofia della futilità” (Lasch 1979: 88) che rende le persone prigioniere del consumismo, dicendo loro qual è lo stile di vita da seguire, quali oggetti possedere, che cosa fare per la propria salute, promuovendo il consumo come alternativa alla ribellione, al fine di plasmare consumatori disinformati che fanno scelte irrazionali addirittura spesso contro i loro stessi interessi (Chomsky 2017: 122-27).
La televisione si è dimostrata un mezzo estremamente efficace per rappresentare la politica attraverso le persone e i loro confronti spettacolari, in questo modo la politica viene rivista e costruita come uno spettacolo, in cui agiscono delle personae, cioè delle maschere teatrali, nelle quali gli spettatori possono ancora una volta proiettarsi e identificarsi (Manetti 2018: 23). Se, come aveva acutamente intravisto Debord (1967), ciò che viene consumato come spettacolo tende a sostituirsi a ciò che viene vissuto nella realtà, al punto da sostituirlo del tutto, allora possiamo dire che questo grado di spettacolarizzazione ha coinvolto oggi in massimo grado la politica, fino ad arrivare a quella forma che Mazzoleni e Sfardini (2009) definiscono politica pop. La televisione ha cambiato il modo di fruizione della politica che viene ricevuta in una dimensione privata e come funzione di personalità singole. La mediatizzazione della politica richiede la presenza sulla scena di leader che siano da una parte ben identificabili e dall’altra in perenne scontro con i loro avversari, in un “corpo a corpo” basato sulla concezione della retorica come strumento di mera affabulazione.
Un’altra strategia molto usata è la captatio benevolentiae che enfatizza il fattore identificativo ed il contatto con il destinatario, sfruttando in modo sistematico la cultura feticistica dell’immedesimazione così rilevante nell’ideologia del mondo contemporaneo. L’intento è quello di annullare la distanza tra l’uomo politico e i suoi elettori, aumentando il più possibile il grado di fiducia e l’elemento di riconoscimento. Il senso dell’azione politica si basa così su una forma di illusione molto efficace: prendersi cura degli altri vuol dire caricarsi addosso i loro problemi, viverli come se fossero i propri, costruendo una reale identificazione empatica con qualunque cittadino tirato in ballo. Si veda il caso emblematico del video sulla scuola in cui Renzi assume il ruolo del maestro che con lavagna e gessetti spiega la sua riforma come se fosse un insegnante che tiene una lezione. La strategia non è nuova, visto che era stata già utilizzata da Berlusconi con l’immagine del presidente\operaio e continua ad essere sfruttata da Salvini con l’immagine del ministro che indossa a seconda dei casi la divisa da poliziotto o da guardia forestale. L’elemento critico sta nello squilibrio tra il detto e il fatto, tra i discorsi e i comportamenti, a sua volta essenza del populismo.
 La retorica assertiva si sviluppa mediante l’uso di luoghi comuni accettati dalla maggior parte dei protagonisti del discorso pubblico e dai media mainstream, la cui validità è data per scontata senza mai essere messa in discussione. Uno dei più diffusi riguarda il processo della globalizzazione economica definita come un aumento, mai sperimentato prima, dell’interdipendenza tra le economie nazionali. Questa definizione è inaccettabile perché da una parte è antistorica, visto che già nel 1914 l’economia nazionale aveva raggiunto un notevole grado di integrazione che è crollato a causa della guerra e dei conseguenti trattati di pace, dall’altra è tautologica perché non spiega l’origine, le modalità e le conseguenze del fenomeno (Gallino 2012: 38-62). Per spiegarli bisogna tenere presente che dal punto di vista economico la globalizzazione ha comportato il trasferimento di imprese nei Paesi in via di sviluppo allo scopo di conquistare meglio i mercati locali producendo sul posto. Allo stesso tempo le imprese si sono accorte che conveniva produrre lì anche le merci richieste dai loro Paesi di origine. La conseguenza è che ormai da molti anni le merci vengono prodotte a basso costo nei Paesi emergenti da imprese controllate dalle multinazionali americane ed europee, per poi essere esportate in America e in Europa. Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti: le stime riportate da Gallino (2012: 41) dicono che circa l’80% dell’industria del tessile e dell’abbigliamento si è spostato dall’Europa e dagli Stati Uniti in India e altrove; il 95% dell’industria dei giocattoli è stato traferito in Cina; l’80-90% dei microprocessori sono prodotti in Thailandia e negli altri Paesi asiatici; la gran parte dell’industria automobilistica americana produce in Messico dove la paga oraria di un operaio è di 4 dollari, mentre in Texas e in California è di 28.
La retorica assertiva si sviluppa mediante l’uso di luoghi comuni accettati dalla maggior parte dei protagonisti del discorso pubblico e dai media mainstream, la cui validità è data per scontata senza mai essere messa in discussione. Uno dei più diffusi riguarda il processo della globalizzazione economica definita come un aumento, mai sperimentato prima, dell’interdipendenza tra le economie nazionali. Questa definizione è inaccettabile perché da una parte è antistorica, visto che già nel 1914 l’economia nazionale aveva raggiunto un notevole grado di integrazione che è crollato a causa della guerra e dei conseguenti trattati di pace, dall’altra è tautologica perché non spiega l’origine, le modalità e le conseguenze del fenomeno (Gallino 2012: 38-62). Per spiegarli bisogna tenere presente che dal punto di vista economico la globalizzazione ha comportato il trasferimento di imprese nei Paesi in via di sviluppo allo scopo di conquistare meglio i mercati locali producendo sul posto. Allo stesso tempo le imprese si sono accorte che conveniva produrre lì anche le merci richieste dai loro Paesi di origine. La conseguenza è che ormai da molti anni le merci vengono prodotte a basso costo nei Paesi emergenti da imprese controllate dalle multinazionali americane ed europee, per poi essere esportate in America e in Europa. Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti: le stime riportate da Gallino (2012: 41) dicono che circa l’80% dell’industria del tessile e dell’abbigliamento si è spostato dall’Europa e dagli Stati Uniti in India e altrove; il 95% dell’industria dei giocattoli è stato traferito in Cina; l’80-90% dei microprocessori sono prodotti in Thailandia e negli altri Paesi asiatici; la gran parte dell’industria automobilistica americana produce in Messico dove la paga oraria di un operaio è di 4 dollari, mentre in Texas e in California è di 28.
La stessa dinamica si è verificata per i servizi: le tecnologie informatiche hanno permesso infatti che la manutenzione dei software, la contabilità delle carte di credito, la prenotazione delle linee aeree e tanti altri servizi potevano essere tranquillamente gestiti all’estero sempre per ragioni di convenienza economica. I costi sociali di questo fenomeno sono enormi – con buona pace della maggior parte dei media che continuano a presentare la globalizzazione in modo positivo – e hanno comportato la deindustrializzazione di ampie regioni dell’Europa e degli Stati Uniti, per non parlare dell’Italia in cui i governi, gli amministratori e molti intellettuali hanno commesso il grave errore di sottovalutare l’importanza di mantenere una solida base industriale (Gallino 2003).
L’altro luogo comune che imperversa nel discorso politico consiste nel presentare la competitività dei cinesi e dei Paesi asiatici in generale come se fosse derivata dalla loro grande abilità di sviluppare le proprie industrie, nascondendo invece il fatto che questa competitività è stata largamente costruita e incoraggiata dalle imprese e dai governi degli Stati Uniti e dell’Unione europea attraverso lo stanziamento di notevoli investimenti. Qui emerge un altro elemento molto importante: la globalizzazione viene presentata spesso come un fenomeno di natura essenzialmente economica mentre in realtà ha una dimensione politica di grande rilievo. L’interpretazione corrente della globalizzazione che vede la politica sopraffatta dall’economia e costretta ad adeguarsi ad essa è insomma del tutto ingannevole e si è affermata solo perché costituisce un frame (Forgione 2018) utile a nascondere all’opinione pubblica la vera dimensione del fenomeno. In realtà è stata proprio la politica, attraverso delle normative specifiche che rispondono agli interessi delle multinazionali, a favorire in ogni modo il loro predominio, in ragione del fatto che le forze politiche e il sistema dei media si muovono essendo influenzati dai gruppi di pressione economica piuttosto che dagli interessi del pubblico.
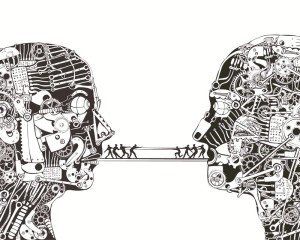 Lo stile del discorso politico oggi è molto reader-friendly, con una espressività iperinformale vicina al colloquialismo, dove la semplificazione viene spacciata per semplicità. Non a caso la scelta ricade sempre su parole brevi e frasi semplici che per loro stessa natura puntano a fare breccia nell’attenzione degli interlocutori. Grazie a questi parametri l’indice di leggibilità dei discorsi, che si basa sulla lunghezza delle parole e delle frasi, ha superato la soglia minima; questo sta a significare che risulta comprensibile ad un adolescente così come ad un adulto con una bassa scolarizzazione. In questo contesto, trovano terreno fertile anche le metafore calcistiche utilizzate moltissimo perché risultano sempre comprensibili dato che sono vicine agli interessi della gran parte degli italiani. Renzi, ad esempio, ha usato la metafora sportiva della squadra e dei giocatori coordinati da un capitano per presentare l’organizzazione stessa del suo partito. Un altro elemento predominante è l’enfasi sull’aspetto concreto, visuale del linguaggio: invece di esprimere concetti astratti come “istruzione, “disoccupazione” e “lavoro”, si parla di “chi quotidianamente va nelle nostre classi” per riferirsi ai docenti o di “chi non ha neanche la possibilità di avere i soldi per mangiare una pizza e bere una birra” per descrivere i giovani apprendisti. Un linguaggio così pragmatico ha il chiaro scopo di aiutare la comprensione dei concetti e di renderli più facili da ricordare e più persuasivi.
Lo stile del discorso politico oggi è molto reader-friendly, con una espressività iperinformale vicina al colloquialismo, dove la semplificazione viene spacciata per semplicità. Non a caso la scelta ricade sempre su parole brevi e frasi semplici che per loro stessa natura puntano a fare breccia nell’attenzione degli interlocutori. Grazie a questi parametri l’indice di leggibilità dei discorsi, che si basa sulla lunghezza delle parole e delle frasi, ha superato la soglia minima; questo sta a significare che risulta comprensibile ad un adolescente così come ad un adulto con una bassa scolarizzazione. In questo contesto, trovano terreno fertile anche le metafore calcistiche utilizzate moltissimo perché risultano sempre comprensibili dato che sono vicine agli interessi della gran parte degli italiani. Renzi, ad esempio, ha usato la metafora sportiva della squadra e dei giocatori coordinati da un capitano per presentare l’organizzazione stessa del suo partito. Un altro elemento predominante è l’enfasi sull’aspetto concreto, visuale del linguaggio: invece di esprimere concetti astratti come “istruzione, “disoccupazione” e “lavoro”, si parla di “chi quotidianamente va nelle nostre classi” per riferirsi ai docenti o di “chi non ha neanche la possibilità di avere i soldi per mangiare una pizza e bere una birra” per descrivere i giovani apprendisti. Un linguaggio così pragmatico ha il chiaro scopo di aiutare la comprensione dei concetti e di renderli più facili da ricordare e più persuasivi.
Questi elementi dovrebbero essere positivi visto che si pongono il problema della comprensibilità del discorso (fondamentale per la comunicazione politica che rientra nell’ambito del discorso pubblico, potenzialmente fruibile da tutti i cittadini) e sottolineano l’esigenza per chi è protagonista del discorso pubblico di mettersi nei panni del destinatario, tenendo conto delle sue esigenze. Il problema è però che se il discorso pubblico sul piano linguistico è molto concreto, è invece caratterizzato da un certo grado di genericità sul piano dei contenuti: le azioni proposte sono solo accennate e non approfondite. La semplicità dell’eloquio serve insomma a mascherare la debolezza argomentativa; nella stessa direzione va la velocità del discorso che serve a non lasciare mai spazio per una possibile riflessione su quello che si sta dicendo. Un esempio emblematico è la retorica “tutta speranza e cambiamento” (Chomsky 2017: 129) seguita da Obama durante la campagna presidenziale che, applicando le regole del marketing (Creamer 2008), non promette nulla di concreto. La vaghezza è utile per nascondere il fatto che le politiche pubbliche sono rivolte in buona parte agli interessi privati di chi finanzia le campagne elettorali e i cittadini sono messi ai margini.
Lo stile più utilizzato è assolutamente metadiscorsivo, prefigura – attraverso parentesi, prolessi e analessi – il discorso che sta per fare; discorso che spesso non ha niente di sorprendente, ma viene talmente caricato di attesa e di enfasi che pare sempre di essere un punto di approdo definitivo, risolutorio, di un ragionamento. L’obiettivo fondamentale è evitare il merito della questione. Ad esempio, in un’intervista del 2014 a Che tempo che fa, Fazio – non certo un intervistatore aggressivo – chiede ben cinque volte a Renzi la ragione effettiva della proposta di cancellazione dell’articolo 18. Renzi per cinque volte parla d’altro, e anche di fronte a Fazio che gli ripete: “Questo è chiaro, ma…”, non si scompone e ricomincia ricorrendo a metafore, avversative, accelerazioni, indice e pollice ravvicinati, vocine. Nell’eludere le domande di Fazio Renzi utilizza un’altra strategia retorica scorretta che prende il nome di ignoratio elenchi (Prato 2017: 168-69): consiste nell’ignorare, appunto, l’argomento sollevato dalla domanda, rispondendo con elementi non pertinenti al contesto discorsivo, distraendo il pubblico dal merito del discorso e confidando sul fatto che non si accorga di questa mancata coerenza tra la domanda e la risposta.
 I casi che abbiamo finora esaminato mettono in evidenza gli elementi critici che riguardano sia il discorso pubblico, in particolare la sua qualità e la sua attendibilità, sia la stampa che, malgrado abbia perso molti lettori, conserva una funzione rilevante dato che rimane il principale produttore di contenuti, poi ripresi e irradiati da tv, radio e siti web. La credibilità della stampa è attualmente messa in discussione dalla sua mancanza di coerenza e imparzialità nella gestione delle informazioni. Ad esempio, i quotidiani a più ampia diffusione nazionale che nel 2012 avevano plaudito al “No” del governo Monti alle Olimpiadi di Roma 2020, quattro anni dopo hanno massacrato la sindaca Raggi per il “No” a Roma 2024. Gli stessi giornali che per anni avevano chiesto il blocco della prescrizione addirittura al rinvio a giudizio, hanno duramente criticato il ministro Bonafede perché l’ha bloccata alla sentenza di primo grado. Lo stesso si può dire per la trattazione degli scandali giudiziari: da dieci anni la stampa tenta di dimostrare che il movimento 5Stelle ruba come gli altri, presentando questo, con la fallacia del tu quoque, come una consolazione per noi o un alibi per gli altri e presentando, in modo del tutto irrazionale, un eventuale elemento aggravante (la diffusione dell’appropriazione indebita) come se fosse un attenuante. Tuttavia nessun esponente del movimento è mai stato arrestato o inquisito per corruzione o reati simili, infatti le inchieste sulle giunte 5Stelle riguardano bilanci fallimentari ereditati dai predecessori, storie di nomine, l’alluvione a Livorno, la tragedia di piazza San Carlo a Torino, dirigenti comunali imputati per fatti di anni prima.
I casi che abbiamo finora esaminato mettono in evidenza gli elementi critici che riguardano sia il discorso pubblico, in particolare la sua qualità e la sua attendibilità, sia la stampa che, malgrado abbia perso molti lettori, conserva una funzione rilevante dato che rimane il principale produttore di contenuti, poi ripresi e irradiati da tv, radio e siti web. La credibilità della stampa è attualmente messa in discussione dalla sua mancanza di coerenza e imparzialità nella gestione delle informazioni. Ad esempio, i quotidiani a più ampia diffusione nazionale che nel 2012 avevano plaudito al “No” del governo Monti alle Olimpiadi di Roma 2020, quattro anni dopo hanno massacrato la sindaca Raggi per il “No” a Roma 2024. Gli stessi giornali che per anni avevano chiesto il blocco della prescrizione addirittura al rinvio a giudizio, hanno duramente criticato il ministro Bonafede perché l’ha bloccata alla sentenza di primo grado. Lo stesso si può dire per la trattazione degli scandali giudiziari: da dieci anni la stampa tenta di dimostrare che il movimento 5Stelle ruba come gli altri, presentando questo, con la fallacia del tu quoque, come una consolazione per noi o un alibi per gli altri e presentando, in modo del tutto irrazionale, un eventuale elemento aggravante (la diffusione dell’appropriazione indebita) come se fosse un attenuante. Tuttavia nessun esponente del movimento è mai stato arrestato o inquisito per corruzione o reati simili, infatti le inchieste sulle giunte 5Stelle riguardano bilanci fallimentari ereditati dai predecessori, storie di nomine, l’alluvione a Livorno, la tragedia di piazza San Carlo a Torino, dirigenti comunali imputati per fatti di anni prima.
Un altro esempio di questa parzialità della stampa nel raccontare al pubblico le notizie risale al marzo del 2019 quando finisce in carcere il presidente del consiglio comunale di Roma De Vito. Tutta la stampa (da Il Giornale, al Corriere della sera, a La Repubblica) ha intitolato, in modo del tutto improprio, sulla Raggi anche le cronache sull’arresto di De Vito, come se il presidente del Consiglio comunale lo nominasse il sindaco. Subito dopo si è scoperto che, nella vecchia indagine sulle mazzette trasversali di Parnasi per lo stadio di Roma – chiusa da tempo con 19 richieste di giudizio (anche per tre politici: due di FI e uno del Pd) – non era stata ancora chiesta l’archiviazione per l’assessore allo Sport Daniele Frongia, indagato per corruzione perché Parnasi gli aveva chiesto qualche giornalista per una sua azienda e lui ne aveva avvertiti tre. L’archiviazione era scontata e imminente, tuttavia i giornali hanno fatto credere che il caso De Vito coinvolgesse la Raggi tramite il “fedelissimo” Frongia che dominava tutte le prime pagine. Quando pochi giorni dopo i pm hanno archiviato Frongia, tutti i giornali che giorni prima avevano messo Frongia indagato in prima pagina hanno nascosto o ignorato del tutto la notizia. Nello stesso periodo la Procura di Milano ha chiesto di condannare a 2 anni di carcere per turbativa d’asta il leghista Massimo Garavaglia, che non fa l’assessore comunale allo Sport, ma il viceministro dell’Economia, e non è indagato in attesa di archiviazione, ma imputato in attesa di sentenza: tuttavia la notizia è stata ignorata o comunque largamente sottovalutata da tutti i media.
Riconoscere queste forme di manipolazione ingannevole è importante perché è in questo modo che il pubblico può tornare ad essere soggetto attivo e non solo passivo del discorso pubblico, esercitando il proprio diritto di critica, fondamentale per il buon funzionamento di una democrazia che dovrebbe essere fondata su una cittadinanza informata che prende delle decisioni in modo razionale. Oggi siamo molto lontani da questo obiettivo e l’impressione è che ci stiamo dirigendo nella direzione opposta. Lo sviluppo e l’affinamento del senso critico possono allora servire a invertire questa tendenza e ad eliminare il veleno che tanto infetta la comunicazione pubblica.
Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019
Riferimenti bibliografici
Bernays, L.B. (1928), Propaganda. Della manipolazione dell’opinione pubblica in democrazia, Milano, Lupetti, 2008.
Bertetti P. (2017), “Storytelling o della narrazione”, in Masini, Pasquini, Segreto (2017): 129-52.
Chomsky, N. (2017), Le dieci leggi del potere, Milano, Ponte alle Grazie.
Cosenza, G. (2007), a cura di, Semiotica della comunicazione politica, Roma, Carocci.
Creamer, M. (2008), “Obama wins! Ad Age’s marketer of the year”, in Advertising Age, 17.10.2008.
D’Agostini, F. (2010), Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico, Torino, Bollati Boringhieri.
Debord, G. (1967), La societé du spectacle, Paris, Gallimard.
Forgione, L. (2018), “Il concetto di frame: tra scienze sociali e scienze cognitive”, in Prato (2018): 33-46.
Frixione, M. (2009), Come ragioniamo, Roma-Bari, Laterza.
Gallino, L. (2012), La lotta di classe dopo la lotta di classe, Roma-Bari, Laterza.
Gallino, L. (2003), La scomparsa dell’Italia industriale, Torino, Einaudi.
Lasch, C. (1979), La cultura del narcisismo, Milano, Bompiani.
Manetti, G. (2018), “Brevi cenni su fasi evolutive e modelli della comunicazione politica”, in Prato (2018): 13-32.
Masini, M., Pasquini, J., Segreto, G. (2017), a cura di, Marketing e comunicazione. Strategie, strumenti, casi pratici, Milano, Hoepli.
Mazzoleni, G. e Sfardini, A. (2009), Politica pop. Da “Porta a porta” a “L’isola dei famosi”, Bologna, Il Mulino.
Mori, L. (2009), Il consenso. Indagine critica sul concetto e sulle pratiche, Pisa, Edizioni ETS.
Prato, A. (2018), a cura di, Comunicazione e potere. Le strategie retoriche e mediatiche per il controllo del consenso, Roma, Aracne.
Prato, A. (2017), “Retorica e comunicazione politica. Per una fenomenologia della persuasione ingannevole” in Blityri, VI, 2: 161-77.
Segreto, G. (2018), “La narrazione della politica al tempo del web e dei social media”, in Prato (2018): 113-34.
Travaglio, M. e Truzzi, S. (2016), Perché no, Roma, PaperFirst.
Vaccari, C. (2007), “Personalizzazione della politica, competenza del leader e negoziazione della fiducia”, in Cosenza 2007: 73-87.
______________________________________________________________
Alessandro Prato è ricercatore del Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena dove insegna Retorica e linguaggi persuasivi e Teoria e tecniche della scrittura. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: Comunicazione e potere (a cura di), Aracne, Roma, 2018; “La teoría lockiana del lenguaje”, in De Signis, 25, 2017, pp. 107-116; La retorica. Forme e finalità del discorso persuasivo, Pisa, Edizioni ETS, 2012; Linguaggio e filosofia nell’età dei lumi. Da Locke agli idéologues, Bologna, I libri di Emil, 2012.
______________________________________________________________








