dialoghi intorno al virus
13 aprile
Viviamo nell’illusorietà della permanenza della nostra società e del mondo così come lo conosciamo. È difficile oggi da credere, ma l’Impero Romano era una civiltà solida e dinamica. Probabilmente i romani non avrebbero mai immaginato che saremmo stati qui a guardare le loro rovine. L’idea che la loro civiltà non fosse permanente era qualcosa che non avrebbero mai compreso. Duemila anni dopo siamo nella stessa situazione. Crediamo che il mondo in cui viviamo sia eterno. Eppure, la storia insegna che tutto è destinato a mutare; tutto è transitorio. E, talvolta, il cambiamento è repentino e ingente.
Viviamo in un tempo ricco di eventi inattesi. Talvolta essi assumono le sembianze dell’emergenza. L’evento inatteso può confondere, urtare, sconvolgere, destare meraviglia, eppure, nell’istante in cui viene percepito, comporta una momentanea sospensione del giudizio. In queste situazioni, ciò che permette di proteggersi dalla paura dell’ignoto, dal dolore che ne può derivare, è dare un nome alle cose, un processo complesso – che, tuttavia, per sua natura semplifica – in grado di rafforzare il senso di controllo e la capacità di gestione. Eppure, non sempre diamo un nome alle cose sulla base di uno scrupoloso esame di realtà. Sovente, lo si dà a partire da reazioni impulsive, da automatismi. «Gli uomini sono macchine» (Ouspensky, 1974: 104) diceva Gurdjieff – uno dei grandi mistici del XX secolo che ha ispirato, con i suoi insegnamenti, migliaia di persone nel mondo – intendendo con ciò l’esigenza dell’essere umano di ridestarsi dal sonno dell’inconsapevolezza, che induce, per l’appunto, ad agire per automatismi, piuttosto che a partire da un “centro di gravità permanente” [1]. Se, dunque, è importante chiamare le cose con il loro nome, questi dovrebbero essere generati da un attento e complesso esame di realtà.
In queste ultime settimane l’evento inatteso è certamente costituito dalla pandemia del coronavirus la quale, in pochissimo tempo, ha prodotto profonde crisi individuali, familiari, comunitarie, nazionali ed internazionali. Le epidemie non sono certo qualcosa di nuovo nella storia dell’umanità. Da sempre l’essere umano si confronta con l’infinitamente piccolo. Tuttavia, le attuali strumentazioni e conoscenze scientifiche permettono oggi di conoscere più da vicino la natura degli agenti patogeni che minacciano la nostra salute. I protocolli della comunità scientifica e le attuali tecnologie riducono le probabilità di mortalità portando ad una forma di razionalizzazione del fenomeno. Ciò nonostante, imperversa la paura e il timore del contagio.
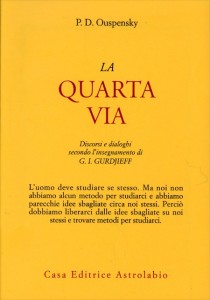 Il virus, infatti, rappresenta una forma di alterità irriducibile, invisibile e intangibile, che può – seppur in modo latente – abitare nell’estraneo, nel conoscente, nell’amico, nel parente e in se stessi. Come proteggere e proteggersi? Abbiamo ricevuto numerose prescrizioni sui comportamenti da adottare per contenere la diffusione del virus. Molte abitudini vengono messe in discussione, mentre inedite paure emergono. Nel sentire comune, infatti, la percezione del rischio aumenta ogni qual volta il nostro quotidiano viene fortemente destabilizzato. La minaccia che deriva dall’inquinamento, dalla deforestazione e dai cambiamenti climatici, ad esempio, procura una percezione del rischio ridotta rispetto a quella determinata dalle limitazioni della libertà fisica imposte dalle autorità per arginare i contagi da coronavirus. Cosa fare? Dal mio punto di vista, smettere di attribuire un nome a ciò che accade è essenziale poiché la capacità di osservare le sensazioni che si provano, senza attribuir loro etichette, permette di accedere ad una dimensione riflessiva più profonda che può, nella migliore delle ipotesi, trasformarsi in una vera e propria esperienza meditativa. La meditazione, infatti, non è mai stata una fuga dalla realtà, ma esattamente il contrario: è una profonda immersione in essa, qualunque sembianza assuma dentro e fuori di noi. Paura, sgomento e confusione possono diventare porte di accesso ad una comprensione dell’esistenza, se solo gli si permette semplicemente di esistere.
Il virus, infatti, rappresenta una forma di alterità irriducibile, invisibile e intangibile, che può – seppur in modo latente – abitare nell’estraneo, nel conoscente, nell’amico, nel parente e in se stessi. Come proteggere e proteggersi? Abbiamo ricevuto numerose prescrizioni sui comportamenti da adottare per contenere la diffusione del virus. Molte abitudini vengono messe in discussione, mentre inedite paure emergono. Nel sentire comune, infatti, la percezione del rischio aumenta ogni qual volta il nostro quotidiano viene fortemente destabilizzato. La minaccia che deriva dall’inquinamento, dalla deforestazione e dai cambiamenti climatici, ad esempio, procura una percezione del rischio ridotta rispetto a quella determinata dalle limitazioni della libertà fisica imposte dalle autorità per arginare i contagi da coronavirus. Cosa fare? Dal mio punto di vista, smettere di attribuire un nome a ciò che accade è essenziale poiché la capacità di osservare le sensazioni che si provano, senza attribuir loro etichette, permette di accedere ad una dimensione riflessiva più profonda che può, nella migliore delle ipotesi, trasformarsi in una vera e propria esperienza meditativa. La meditazione, infatti, non è mai stata una fuga dalla realtà, ma esattamente il contrario: è una profonda immersione in essa, qualunque sembianza assuma dentro e fuori di noi. Paura, sgomento e confusione possono diventare porte di accesso ad una comprensione dell’esistenza, se solo gli si permette semplicemente di esistere.
Mi ha molto colpito, in questi concitati giorni, leggere una recente nota di Cesare Moreno, presidente e portavoce dell’associazione Maestri di Strada [2] di Napoli, intitolata: “Sono confuso” [3]. È un grande insegnamento, da parte di coloro che hanno grande esperienza nel proprio campo di pertinenza e da cui ci si aspetta una guida, ammettere di essere confusi. In questo specifico caso, la confusione a cui fa riferimento deriva dalle regole restrittive sulla mobilità personale imposte ai cittadini dal governo italiano. Le autorità richiedono obbedienza al fine di evitare una tragedia di proporzioni ingovernabili. Eppure, quanta confusione per chi è abituato a stare sul campo! Cosa fare? Riflettere? Sì, dal mio punto di vista, la riflessione – non soltanto intesa come analisi razionale – è imprescindibile. Ma come spiegarne l’importanza a coloro i quali vivono al di sotto della soglia di povertà, impegnati a trovare risorse per sopravvivere o costretti a convivere con i propri aguzzini? Se i ricchi possono permettersi di riflettere, gli altri devono comunque trovare un modo per sopravvivere. I virus attaccano entrambi in egual modo, ma i meno abbienti hanno statisticamente meno strumenti per difendersi. Molti esempi ci arrivano dalle esperienze pregresse, peraltro recenti. Nel 2015, negli Stati del Rajasthan e del Gujarat (India), molte persone appartenenti ai ceti più poveri vennero colpite dalla febbre suina a causa del sovraffollamento, della scarsa igiene, della mancanza di risorse e della malnutrizione. Per gli stessi motivi, in molti Paesi dell’Africa occidentale (Guinea, Sierra Leone, Liberia e Nigeria), le frange più povere vennero duramente colpite dall’ebola fra il 2014 e il 2016. Morirono moltissime persone, e tra queste anche diversi operatori sanitari e volontari delle organizzazioni non governative (ONG).
L’inasprimento delle disuguaglianze sociali causate da una politica globale neoliberista oggi inizia a mostrare il suo lato più oscuro. I subalterni, gli esclusi, i marginali, sono tali fintanto che si abbandonano alla narrazione dominante la quale, anche di questi tempi, viene utilizzata per ‘naturalizzare’ lo status quo. A tal proposito sono paradigmatiche le parole di Trump il quale, in una recente intervista, ha affermato che negli Stati Uniti si potranno curare solo coloro che dispongono di risorse economiche sufficienti, lasciando intendere che questa è la dura ma inevitabile realtà. Questo tipo di narrazione è subdola e pericolosa poiché tende a normalizzare una disfunzione cronica del sistema attirando peraltro a sé il consenso dei cittadini. Per il potere, infatti, il miglior modo per mantenere la stabilità è quello di non scoprirsi, di mescolarsi al tessuto sociale, di naturalizzarsi, così da non diventare oggetto di contestazione politica. Ma, naturalmente, il consenso è sempre il frutto di una costruzione e, nell’insegnamento di Gramsci, tale fabbricazione è una importante responsabilità a cui sono chiamati tutti gli intellettuali impegnati nella società civile a vari livelli. Il richiamo all’impegno e alla responsabilità, dentro e fuori le istituzioni, è imprescindibile per riuscire a superare la sfida imposta alla comunità internazionale dall’attuale pandemia. Nessuno vince solo, se di vittoria comunque si vuol parlare. Serve una comunità di adulti che si assuma la piena responsabilità delle proprie scelte, affrontando la complessità del reale senza rimozioni o negazionismi.
Il fenomeno della negazione, come insegnano gli psicologi, interviene quando la psiche non è in grado di sostenere eventi e situazioni di una certa portata. È un meccanismo di difesa che paralizza la psiche quando si sente di avere perso il controllo. Come afferma Cesare Moreno, è chiaro che l’inasprimento delle misure di contenimento è stata indotto dai comportamenti di massa basati su questa peculiare forma di disagio psichico. Il meccanismo è, difatti, il medesimo nel singolo individuo e nelle collettività. L’abbiamo visto innumerevoli volte in questi giorni, in Italia e all’estero. Si nega l’esistenza di un fenomeno quando, ad esempio, ci si “assembra” nonostante le disposizioni di distanziamento sociale indotte dal Covid19. In Francia, il raduno dei giovani travestiti da “puffi” (3500 persone che si abbracciano festosamente “puffandosene” [4] del coronavirus) è stato uno dei casi più lampanti e inquietanti di tale fenomeno. Le misure repressive di controllo, dunque, hanno motivo di esistere, ma restano comunque forme di contenimento provvisorie e discutibili, imposte dall’alto e pensate per una comunità che non si ritiene sufficientemente matura. Regole che difficilmente un individuo adulto e responsabile è ben disposto ad accettare. D’altronde, tra i due concetti contraltari – ragione e controllo da una parte, caos e irrazionalità dall’altra – vi sono innumerevoli strade intermedie animate dal buon senso, vie che il governo italiano sta effettivamente dimostrando di voler indagare attraverso la costruzione di un programma articolato e organico di rientro dalla fase acuta della crisi.
La stessa necessità di chiudere le scuole mostra, secondo Cesare Moreno, come quest’ultime non siano in grado di funzionare come comunità. Come dissentire?! Ma, allo stesso tempo, come insegnare ai bambini la distanza fisica di un metro se anche gli adulti, dinanzi ad un pericolo invisibile, tendono a dimenticarsene? E come rimproverare alla scuola una mancanza di questo tipo? La struttura stessa delle aule è difficile da rimodulare per garantire questa distanza di sicurezza. Uno degli obiettivi dell’istituzione scolastica è sicuramente quella di disciplinare i corpi, oltre che impartire un certo grado di istruzione. Ma come può, un’istituzione che si è così poco rinnovata negli ultimi anni, fare fronte ad una emergenza di tale portata? Neanche la famiglia sembra essere in grado di assumersi questo ruolo. D’altronde la logica comunitaria che sta alla base dell’istituzione familiare è stata fortemente minata dalle politiche neoliberiste che hanno decretato una frattura del tessuto sociale ai più ampi livelli. E questo, a sua volta, è dovuto al fatto che gli assunti su cui si fonda la logica neoliberista sono stati narrati, applicati, interiorizzati e ‘naturalizzati’.
Come fare, dunque, affinché la famiglia, la scuola e l’intera umanità, funzionino come una comunità? Non si tratta infatti, dal mio punto di vista, di ricostruire. Tornare al passato significherebbe pensare ad una forma ristretta di comunità. Ciò che, invece, mi sembra oggi interessante è la possibilità di costruire un nuovo senso di comunità fondato su orizzonti e mete condivise, piuttosto che ancorato al riconoscimento di presunte radici o bisogni comuni. La cooperazione funzionale non diventa automaticamente strutturale. La logica funzionale, infatti, se non è frutto di un sentire comune, di un’empatia, di una comprensione dell’interdipendente, della naturale gioia della condivisione, se nasce esclusivamente dalla comune necessità, implica un usarsi a vicenda. È quello che accade dinanzi ad un pericolo comune. Si collabora e si instaura una dimensione cooperativa funzionale a sconfiggere il nemico o a risolvere il problema, e dopo? Si entra nuovamente in concorrenza la quale, in realtà, non si è mai spenta, ma solo attenuata. La cooperazione funzionale da sola non basta. Essa deve fondarsi su un tipo di cooperazione che potremmo definire strutturale, ovvero fondata sulla consapevolezza dell’interdipendenza di tutti gli esseri umani e degli ecosistemi entro cui vivono.
Il tipo di rivoluzione che io mi auspico è quella dell’empatia. Etimologicamente il termine è formato dal greco antico ἐν ossia “in” e da -patia (dal greco -πάϑειαal ovvero “sofferenza”); può dunque essere tradotto come “mettersi in sofferenza” (e con un significato traslato “mettersi nei panni di qualcuno”). In psicologia, e nel sentire comune, per empatia si intende la capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona, in modo immediato e talvolta senza far ricorso alla comunicazione verbale. Siamo nella sfera della percezione e del ‘sentire’, dei sentimenti. La comprensione di cui si parla non è squisitamente razionale, tutt’altro. Empatia è il frutto di un ascolto profondo, di una condivisione. E chiaramente non si parla solo delle infinite sfumature della sofferenza, ma anche della gioia e dell’amore. Tuttavia, sovente si utilizza in relazione alla sofferenza. Perché? Il motivo principale, in primo luogo, risiede nel fatto che la sofferenza è insita nella natura umana. Non a caso le dottrine filosofiche e le religioni, da sempre, cercano di rispondere ad un duplice quesito: come si genera il dolore e come superarlo; da una parte, si intende spiegarne la natura e, dall’altra, si cerca il modo di trascenderla. In secondo luogo, perché il dolore è una delle dimensioni emotive dell’esistenza umana che ha la capacità di strapparci a noi stessi, di destabilizzarci, di legarci agli altri ponendo in risalto la vulnerabilità del corpo, la sua finitezza e imperfezione, la sua incredibile interdipendenza dal contesto.
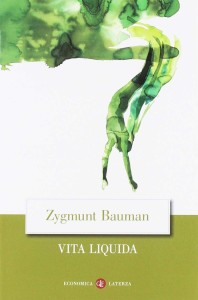 Nel riconoscimento del dolore, proprio ed altrui, vi è una grande possibilità di trasformazione per gli esseri umani. L’homo consumens dovrà fare i conti con il suo bisogno spasmodico di anestetizzarsi ricercando, nel consumo, la gratificazione di un desiderio che, nella logica indotta dalla società dei consumi della modernità liquida, deve solo illusoriamente essere soddisfatto. Dovrà continuamente colmare un “vuoto”, al pari di un tossicodipendente, negandone addirittura l’esistenza, se serve. Anzi, è stato educato proprio a mostrare la sua insana “felicità”, mai compiuta e solo apparente. Tuttavia, anche il suo contraltare, l’homo sacer, il povero che è stato estromesso dal gioco in quanto consumatore difettoso o “avariato”, dovrà aspirare al consumo. La sua miseria è solo una condizione che deriva da una colpa individuale, da un’incapacità di integrarsi nel sistema, non è considerata un’ingiustizia da sanare: così le prigioni si sostituiscono alle politiche del welfare. È, invece, fondamentale che la politica si occupi dei più vulnerabili, che cerchi di sanare le disfunzioni strutturali interne al sistema. Condivido, dunque, le scelte attuali del governo italiano di aiutare indistintamente tutti i lavoratori, comprese le categorie più fragili dei lavoratori “in nero”; mi domando tuttavia quanto tali scelte, più che da una reale attenzione nei confronti delle fasce deboli, siano motivate dal timore che la frustrazione e la rabbia di quest’ultime possano trasformarsi in una concreta minaccia al sistema. In ultimo, bisogna comunque riconoscere che, se la politica ha il dovere di prendersi cura di tutti i cittadini, nessuno escluso, ognuno di noi ha la responsabilità d’imparare a prendersi cura di sé. Su questo assunto si fonda la via adulta.
Nel riconoscimento del dolore, proprio ed altrui, vi è una grande possibilità di trasformazione per gli esseri umani. L’homo consumens dovrà fare i conti con il suo bisogno spasmodico di anestetizzarsi ricercando, nel consumo, la gratificazione di un desiderio che, nella logica indotta dalla società dei consumi della modernità liquida, deve solo illusoriamente essere soddisfatto. Dovrà continuamente colmare un “vuoto”, al pari di un tossicodipendente, negandone addirittura l’esistenza, se serve. Anzi, è stato educato proprio a mostrare la sua insana “felicità”, mai compiuta e solo apparente. Tuttavia, anche il suo contraltare, l’homo sacer, il povero che è stato estromesso dal gioco in quanto consumatore difettoso o “avariato”, dovrà aspirare al consumo. La sua miseria è solo una condizione che deriva da una colpa individuale, da un’incapacità di integrarsi nel sistema, non è considerata un’ingiustizia da sanare: così le prigioni si sostituiscono alle politiche del welfare. È, invece, fondamentale che la politica si occupi dei più vulnerabili, che cerchi di sanare le disfunzioni strutturali interne al sistema. Condivido, dunque, le scelte attuali del governo italiano di aiutare indistintamente tutti i lavoratori, comprese le categorie più fragili dei lavoratori “in nero”; mi domando tuttavia quanto tali scelte, più che da una reale attenzione nei confronti delle fasce deboli, siano motivate dal timore che la frustrazione e la rabbia di quest’ultime possano trasformarsi in una concreta minaccia al sistema. In ultimo, bisogna comunque riconoscere che, se la politica ha il dovere di prendersi cura di tutti i cittadini, nessuno escluso, ognuno di noi ha la responsabilità d’imparare a prendersi cura di sé. Su questo assunto si fonda la via adulta.
Andrea Laudadio nell’introduzione al testo Valutare la resilienza ci induce ad una interessante suggestione. Partendo dall’assunto che le problematiche dell’uomo moderno sono rappresentate dalla pretesa di invulnerabilità e indipendenza dalle imponenti e invasive forze della società, e domandandosi in che modo gli esseri umani possano proteggersi e liberarsi dalle grinfie della loro stessa creazione, egli afferma che la grande battaglia si consuma sul piano delle Tecnologie del Sé, richiamando Michel Foucault. Risale al 1988 la celebre categorizzazione delle quattro tipologie di tecnologie che gli esseri umani storicamente hanno utilizzato per comprendere se stessi. Esse sono: le tecnologie della produzione, dei segni, del potere e del Sé. Le prime tre fanno riferimento alla possibilità di manipolare e trasformare gli oggetti, i significati, i simboli, i segni o la condotta delle persone, mentre le Tecnologie del Sé «permettono di eseguire – con i propri mezzi o con l’aiuto altrui – operazioni sul proprio corpo e sulla propria anima – dai pensieri al comportamento, al modo di essere – e di raggiungere uno stato caratterizzato da felicità, purezza, saggezza, perfezione o immortalità» (Foucault, 1992: 13).
 Nell’analisi degli strumenti, delle Tecnologie del Sé, che gli individui utilizzano per compiere la loro formazione spirituale, Foucault identifica come fondamentale lo studio della cura di sé nell’età tardo antica quando l’epimeleisthai heautoù si era allontanata dalle motivazioni pedagogiche e politiche ed era diventata, scollegata ormai dalla ricerca della verità, un’arte del vivere che poteva essere praticata da tutti. Prendersi cura di sé nell’antica Grecia significava esercitarsi e allenarsi (l’etimo del termine epimeleisthai rinvia ad una serie di termini il cui significato è quello di allenarsi o esercitarsi) e, contemporaneamente, dotarsi di un equipaggiamento per affrontare l’esistenza, quest’ultimo costituito da logoi (ragionamenti, pensieri) che si sarebbero dovuti trasformare in ethos (comportamento). Prendersi cura di sé per Foucault implicava, dunque, una forma di attenzione costante e vigile sul proprio pensiero in grado, infine, di portare ad una trasformazione, ad una trasfigurazione.
Nell’analisi degli strumenti, delle Tecnologie del Sé, che gli individui utilizzano per compiere la loro formazione spirituale, Foucault identifica come fondamentale lo studio della cura di sé nell’età tardo antica quando l’epimeleisthai heautoù si era allontanata dalle motivazioni pedagogiche e politiche ed era diventata, scollegata ormai dalla ricerca della verità, un’arte del vivere che poteva essere praticata da tutti. Prendersi cura di sé nell’antica Grecia significava esercitarsi e allenarsi (l’etimo del termine epimeleisthai rinvia ad una serie di termini il cui significato è quello di allenarsi o esercitarsi) e, contemporaneamente, dotarsi di un equipaggiamento per affrontare l’esistenza, quest’ultimo costituito da logoi (ragionamenti, pensieri) che si sarebbero dovuti trasformare in ethos (comportamento). Prendersi cura di sé per Foucault implicava, dunque, una forma di attenzione costante e vigile sul proprio pensiero in grado, infine, di portare ad una trasformazione, ad una trasfigurazione.
Andrea Laudadio, sulla scia delle dissertazioni di Foucault, considera le Tecnologie del Sé come competenze di ordine superiore, metacompetenze trasversali rispetto ai contesti, e ritiene centrale in questo complesso mix il costrutto di resilienza, prodotto del trinomio individuo-contesto-tempo. Per Laudadio, la resilienza è nello specifico il risultato di un uso attento delle Tecnologie del Sé e rappresenta sia il processo che il prodotto, in quanto capacità di agire sul proprio sé o sul proprio ambiente per produrre un adattamento migliorativo, riducendo la dipendenza dal proprio contesto. Questo non significa esserne indipendenti, ma – a partire dal riconoscimento delle influenze che ci legano ad esso, in un’ottica di interdipendenza – imparare a ridisegnare la relazione, valorizzando se stessi e il proprio contesto. Questo significa ambientarsi, competenza che – secondo Laudadio – caratterizza profondamente il costrutto di resilienza. Ambientarsi, infatti, non implica un adeguamento passivo al contesto ma, piuttosto, la capacità di progettare il proprio Sé e di mettere in atto il proprio progetto (Laudadio, 2019).
Cosa possiamo fare, in questo momento, se non essere resilienti? Cosa possiamo fare, se non adattarci e provare a trasformare, ognuno in base al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, un nuovo percorso di vita, individuale e collettivo, che non rimuovi la sofferenza, ma al contrario la usi come propulsore per affrontare le difficoltà in modo costruttivo? Il dolore – sia esso sofferenza fisica, psicologica o spirituale – nella prospettiva della resilienza, non viene negato o rimosso; esso viene vissuto, attraversato, integrato con gli elementi-risorse presenti nel percorso di vita della persona. La capacità di riconoscere, accettare e indagare il proprio dolore è uno degli aspetti fondamentali su cui si costruisce il proprio essere adulti. L’adulto è infatti, per antonomasia, l’indipendente. Ha imparato a sopravvivere da solo nel proprio ambiente, a prendersi cura di sé e ad interrogarsi sul proprio dolore. Cos’é? Come sorge? Da dove nasce? Qual è il suo messaggio? Scrutando in profondità nel proprio dolore vi è la possibilità di una comprensione. Come ricorda David Richo, il vero sforzo eroico è l’attraversamento del dolore e la spontanea trasformazione che avviene grazie a questo.
 Ma per imparare ad attraversare la sofferenza è necessario, in primo luogo, imparare ad accettare e a riconoscere l’alterità dentro di noi; successivamente si impara il dialogo, a discernere. Si tratta di fare un esercizio di esame di realtà, dentro e fuori di sé. Questo allenamento forgia e insegna la grande arte della disidentificazione. Quando si prende coscienza dell’alterità dentro di noi diventa più semplice dialogare con l’Altro da sé. Byungh-Chul Han, in modo provocatorio, denuncia la scomparsa dell’alterità: «il tempo in cui c’era l’Altro è passato. L’Altro come mistero, l’Altro come seduzione, l’Altro come Eros, l’Altro come desiderio, l’Altro come inferno, l’Altro come dolore scompare» (Byungh-Chul Han 2017: 7). È proprio l’alterità, per Byungh-Chul Han, a costituire il perno su cui si fonda il concetto di esperienza in senso enfatico e trasformativo. Richiamando le parole di Martin Heidegger, l’autore scrive che «fare esperienza di qualcosa significa che quel qualche cosa per noi accade, che ci incontra, ci sopraggiunge, ci sconvolge, e trasforma, e che la sua essenza è il dolore» (Byungh-Chul Han 2017: 10). Dunque, appare chiaro nel suo pensiero, come il concetto di dolore diventi la chiave di volta per decostruire l’Uguale, ridestarci dall’anestesia emotiva e riscoprire l’Altro.
Ma per imparare ad attraversare la sofferenza è necessario, in primo luogo, imparare ad accettare e a riconoscere l’alterità dentro di noi; successivamente si impara il dialogo, a discernere. Si tratta di fare un esercizio di esame di realtà, dentro e fuori di sé. Questo allenamento forgia e insegna la grande arte della disidentificazione. Quando si prende coscienza dell’alterità dentro di noi diventa più semplice dialogare con l’Altro da sé. Byungh-Chul Han, in modo provocatorio, denuncia la scomparsa dell’alterità: «il tempo in cui c’era l’Altro è passato. L’Altro come mistero, l’Altro come seduzione, l’Altro come Eros, l’Altro come desiderio, l’Altro come inferno, l’Altro come dolore scompare» (Byungh-Chul Han 2017: 7). È proprio l’alterità, per Byungh-Chul Han, a costituire il perno su cui si fonda il concetto di esperienza in senso enfatico e trasformativo. Richiamando le parole di Martin Heidegger, l’autore scrive che «fare esperienza di qualcosa significa che quel qualche cosa per noi accade, che ci incontra, ci sopraggiunge, ci sconvolge, e trasforma, e che la sua essenza è il dolore» (Byungh-Chul Han 2017: 10). Dunque, appare chiaro nel suo pensiero, come il concetto di dolore diventi la chiave di volta per decostruire l’Uguale, ridestarci dall’anestesia emotiva e riscoprire l’Altro.
Se non fossimo anestetizzati sentiremmo il dolore non soltanto degli altri esseri umani, ma anche dei tanti altri esseri viventi che soffrono, si ammalano, muoiono a causa di decenni di politiche di sfruttamento irresponsabile del territorio. Siamo superbi, crudeli e irresponsabili, dovremmo riconoscerlo. Se veramente sentissimo il grido di disperazione che si agita, dentro e fuori di noi, ne saremmo sconvolti. Dovremmo riflettere, fermare questo folle gioco di cui siamo responsabili, e chiedere perdono per tutta la sofferenza causata, direttamente e indirettamente. Dovremmo apprendere la lezione più importante che il coronavirus può insegnarci: la necessità di una rivoluzione empatica per la costruzione di una cooperazione strutturale.
È evidente che per evitare le peggiori conseguenze dovremmo sensibilmente modificare il nostro modo di vivere su questo pianeta. Se non lo facciamo, in fretta e in modo radicale, risponderemo comunque delle nostre azioni pagando un prezzo molto alto. Le attuali difficoltà potrebbero essere emergenze irrilevanti dinanzi a quelle che potremmo essere chiamati a vivere. Questo non significa necessariamente fare previsioni, ma, sulla base dell’inferenza – per induzione e deduzione – imparare dalle esperienze già vissute, come singoli individui e come umanità.
Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020
Note
[1] Centro di gravità permanente è il titolo di una famosa canzone del cantautore Franco Battiato, i cui testi – non molti sanno – sono ricchi di riferimenti alla cultura sufi, agli insegnamenti di Gurdjeff e alla scuola della Quarta Via. Il “centro di gravità permanente” è un centro di consapevolezza, una sorta di bussola, a partire dal quale è possibile costruire un’integrità e una stabilità interiore che aiutano a vivere nell’equilibrio.
[2] Associazione costituita da educatori e professionisti che si occupano di dispersione scolastica nelle aree a rischio marginalità di Napoli. Sito: http://www.maestridistrada.it/
[3] https://www.facebook.com/notes/cesare-moreno/sono-confuso/10158305462192608/
[4]https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/03/10/pufferemo-coronavirus-francia-raduno-delle-polemiche_zNXBMJxcNjl6Y8k5s6tBMM.html
Riferimenti bibliografici
Bauman, Z., 2008, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi, Erickson, Torino (ed. or. 2006).
Bauman, Z., 2011, Vite di scarto, Laterza, Bari (ed. or. 2004).
Foucault, M., 2018, Tecnologie del Sé, Bollati Boringhieri, Milano, (ed or. 1992).
Governa, F., Memoli, M., 2011, Geografie dell’urbano. Spazi, politiche, pratiche della città, Carocci, Roma
Gramsci, A., 1975, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino.
Laudadio, A. – Mazzocchetti, L. – Pérez, F. J. F., 2011, Valutare la resilienza. Teorie, modelli e strumenti, Carocci, Roma.
Ouspensky, P. D., 1974, La Quarta Via. Discorsi e dialoghi secondo l’insegnamento di I. Gurdjieff, Astrolabio, Roma (ed. or. 1972).
Han, B., 2017, L’espulsione dell’Altro, Nottetempo, Milano (ed. or. 2016).
Richo, D., 2016, Come essere adulti, Astrolabio, Roma, (ed. or. 1991).
______________________________________________________________
Cristina Siddiolo, laureata presso l’Università degli Studi di Palermo in studi storici, antropologici e geografici, è antropologa, formatrice, educatrice e insegnante di yoga. Da più di dieci anni lavora con minori stranieri non accompagnati presso il gruppo appartamento “La Vela Grande” fondato dall’associazione Apriti Cuore onlus, diretto dal 2018 dall’Istituto Don Calabria.
______________________________________________________________










