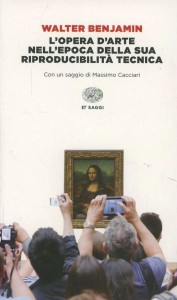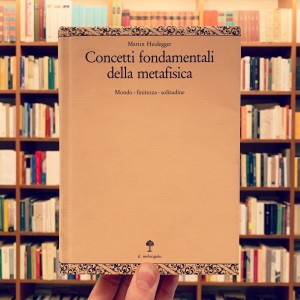di Enrico Palma
«Questo processo di assimilazione, che si svolge nel profondo, richiede uno stato di distensione che diventa sempre più raro. Se il sonno è il culmine della distensione fisica, la noia è quello della distensione spirituale. La noia è l’uccello incantato che cova l’uovo della esperienza. Il minimo rumore lo mette in fuga. I suoi nidi – le attività intimamente collegate alla noia – sono già scomparsi nelle città, e decadono anche in campagna. Così si perde la facoltà di ascoltare, e svanisce la comunità degli ascoltatori»[1].
Un approccio benjaminiano
Inserirsi con cognizione nel dibattito contemporaneo ma più in generale nel contemporaneo in quanto tale, con le sue orde spasmodiche di complessità, incomprensione e anche banalità, costituisce tanto per lo studioso che per il cittadino del villaggio globale uno sforzo non scontato. La valanga di stimoli e di sollecitazioni a cui siamo chiamati a rispondere, o a ignorare, è diventata di una forza tale da disorientare profondamente ogni tentativo di breccia. La baraonda regna sovrana, immersi come ci troviamo nel flusso dell’assolutamente nuovo e sotto ogni profilo, tanto che le prove compiute per stare al passo divengono sempre più ardue.
Se nei secoli precedenti le figure della geometria piana risultavano corrette per la descrizione della realtà, adesso abbiamo bisogno di piani e di coordinate più articolati, che tengano conto delle sovrapponibilità, delle divaricazioni e anche delle totali sfasature tra tradizione e innovazione. Piuttosto dunque che tentare come un ubriaco che brancola nel buio, o un passeggiatore solitario in cammino su una strada principale subissato dalle luci e dalle innumerevoli possibilità comunicative e di interazione, preferisco, per mettere un po’ di ordine, fare un passo indietro, esercitare il distacco necessario a una messa a fuoco.
 Un discorso complesso per essere efficace ha infatti bisogno di una guida affidabile e io scelgo Walter Benjamin. Figura poliedrica e per certi versi divenuta ormai paradigmatica per l’originalità del suo approccio integrato e critico-filosofico al reale, nonché per l’assoluta acutezza delle sue indagini e delle sue riflessioni, il filosofo berlinese ci aiuta in questa occasione non tanto con i contenuti delle sue opere, sulle quali esiste ormai un’opinione ermeneutica consolidata e una bibliografia innumerabile, bensì per il suo metodo. Sia negli studi critici che in quelli di teologia e di teoria dei media, mi sembra che Benjamin sia riuscito a fornire un modello non ancora interamente esplorato di risoluzione dei problemi filosofici: concettualizzare e impiegare un medium o una determinata forma sociale per accedere in modo dirompente al cuore della realtà. Per quello di cui parlo sono esemplari i saggi filosofici e di critica letteraria su Leskov, Goethe o Kafka, dai quali, riducendo all’osso le questioni trattate, emergono sia ipotesi critiche ma soprattutto, come li ha definiti esplicitamente, gli ideali del problema. Intendo dire che Benjamin scorge in un’opera, un autore o un medium (e penso alle capitali analisi sulla fotografia, i giocattoli e soprattutto il cinema) la rappresentazione sensibile di un problema, in altri termini il farsi della realtà più perspicua concentrandosi in un punto specifico di accumulazione. Individuare cioè in un fenomeno ben preciso la condensazione di tipi della realtà che altrimenti sarebbero rimasti sparsi e difficilmente comprensibili.
Un discorso complesso per essere efficace ha infatti bisogno di una guida affidabile e io scelgo Walter Benjamin. Figura poliedrica e per certi versi divenuta ormai paradigmatica per l’originalità del suo approccio integrato e critico-filosofico al reale, nonché per l’assoluta acutezza delle sue indagini e delle sue riflessioni, il filosofo berlinese ci aiuta in questa occasione non tanto con i contenuti delle sue opere, sulle quali esiste ormai un’opinione ermeneutica consolidata e una bibliografia innumerabile, bensì per il suo metodo. Sia negli studi critici che in quelli di teologia e di teoria dei media, mi sembra che Benjamin sia riuscito a fornire un modello non ancora interamente esplorato di risoluzione dei problemi filosofici: concettualizzare e impiegare un medium o una determinata forma sociale per accedere in modo dirompente al cuore della realtà. Per quello di cui parlo sono esemplari i saggi filosofici e di critica letteraria su Leskov, Goethe o Kafka, dai quali, riducendo all’osso le questioni trattate, emergono sia ipotesi critiche ma soprattutto, come li ha definiti esplicitamente, gli ideali del problema. Intendo dire che Benjamin scorge in un’opera, un autore o un medium (e penso alle capitali analisi sulla fotografia, i giocattoli e soprattutto il cinema) la rappresentazione sensibile di un problema, in altri termini il farsi della realtà più perspicua concentrandosi in un punto specifico di accumulazione. Individuare cioè in un fenomeno ben preciso la condensazione di tipi della realtà che altrimenti sarebbero rimasti sparsi e difficilmente comprensibili.
È con questa chiave ermeneutica che ritengo che vada letto il celeberrimo saggio sulla technische Reproduzierbarkeit [2], ovvero scorgere nella riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, fenomeno tecnico e di per sé neutro, uno dei caratteri distintivi del secolo scorso. Si tratta quindi di intercettare un fenomeno in cui si concentra il mondo contemporaneo e spiegarlo a partire da esso. Benjamin scorgeva la possibilità di una nuova teoria dell’arte in senso marxista, che avrebbe dovuto incoraggiare gli ambienti intellettuali comunisti verso una radicale riconsiderazione del rapporto delle masse con le nuove forme estetiche e di intrattenimento seriale, spersonalizzante e illimitatamente accessibile.
Detto ciò, l’intuizione che mi sembra sorreggere il metodo benjaminiano merita di essere ripresa e rimessa potentemente in azione. Ciò che bisogna fare è captare nel flusso indefesso della contemporaneità un fenomeno che, come suggerito dal filosofo berlinese, possa suggerirci l’ideale del problema sociale oggi, quando per problema si intenda in quali forme il modus vivendi della società occidentale consista e si esplichi. Credo allora che la forma mediale, l’ariete che possa consentirci di penetrare nel nostro problema, siano le serie-tv, in quanto spicco dell’habitus esistenziale delle società ultra-soddisfatte, ma non per questo meno angosciate, tanto da ritenere adeguata questa formula: facendo un calco da Benjamin, potremmo parlare infatti non solo dell’opera d’arte nell’epoca della sua serializzazione, ma anche della società intera nel tempo delle serie-tv.
Le presenti riflessioni vogliono essere un tentativo di analisi della serie-tv sia come genere presuntivamente artistico che come abitudine di intrattenimento. L’idea è che, suggerendo allo stesso tempo una prospettiva sia mediatica che sociologica, quindi esistenziale e filosofica, argomentare in maniera non banale su ciò che genera una serie-tv in uno spettatore comune possa consentire di rilanciare la questione, per dir così, su larga scala, in modo da intendere il fenomeno in oggetto come il condensato delle dinamiche sociali ed esistenziali che intramano il nostro tempo ormai da anni, cercando alla fine di trarne tutte le dovute conseguenze.
Innanzitutto, dobbiamo circoscrivere il problema tentando una definizione quanto più semplice e precisa del nostro argomento. Si potrebbe definire una serie-tv come una narrazione diacronicamente distribuita volta al totale assorbimento dello spettatore al suo interno. Rispetto ai prodotti televisivi tradizionali o cinematografici, le serie-tv riducono la durata della loro unità minima (la puntata) per rilanciare il numero delle parti (le stagioni). Ciò che dunque accade per lo spettatore è la maggiore sostenibilità di ogni singola parte e la possibilità per gli autori di dilatare la narrazione. Rispetto al cinema, infatti, la sensazione che si ha nel guardare una puntata di qualunque serie è di un’interruzione nel momento esatto in cui si sarebbe rimasti ancora a seguire. La sospensione del contatto tra chi guarda e cosa è guardato favorisce con ciò la ripresa della visione con la puntata successiva.
Come si sa, del resto, è notorio che nella struttura di ogni singola puntata la storia è organizzata in modo tale da avere il più delle volte una rivelazione, oppure un brusco coup de théâtre che aumenta in maniera esponenziale l’attesa. Credo quindi che il gioco in atto sia la frustrazione per l’attimo presente e la conclusione di ciò che c’è adesso, tale da ingenerare una mancanza di informazione o, più semplicemente, una genuina curiosità per il seguito, e la riparazione della frustrazione occorsa con l’inizio della nuova puntata che risolve il conflitto. E così di puntata in puntata, di stagione in stagione.
Una sensazione assai comune riportata dai consumatori seriali di serie – la ripetizione è voluta – unitamente all’attesa, alla frustrazione e al ripianamento della mancanza, e che indica l’essenza del problema, è inoltre lo spreco del tempo. Nonostante la frequente e chiara consapevolezza della perdita di tempo, si continua a guardare. Perché si parla di perdita, di spreco, quando ogni meccanismo mentale legato alla sfera del piacere e del godimento viene attivato, generando così un paradosso apparentemente irrisolvibile? È come se una volta entrati nella ragnatela, non si riesca a venirne fuori pur essendo liberi di farlo e vedendo il ragno divorarci inesorabilmente. Perché accade, qual è la dinamica che interviene?
Ritengo che la struttura che soggiace alla serie-tv sia questa: inizio a guardare; la prima puntata sembra interessante ma percepisco il bisogno di ottenere ancora qualche conferma; guardo la seconda puntata e mi sento intrigato; aggiungo la terza e la quarta e sono già arrivato a metà stagione; il gioco di attesa, frustrazione e riparazione della mancanza ha preso intanto pieno possesso di me; sono comunque consapevole che magari la storia non è un granché ma il fatto di essere arrivato a metà comporterebbe, se interrompessi adesso il contatto, sprecare il tempo impiegato nella visione delle puntate precedenti; devo arrivare alla fine per evitare questo senso spiacevole di spreco; giungo alla conclusione ma provo imbarazzo per aver perso tempo comunque.
Quella che ho declinato mi pare la descrizione più esatta della dinamica della visione di una serie-tv, ma ciò non esclude ovviamente che se ne possano affiancare delle altre, anche in totale opposizione [3]. La serie può anche rientrare nel cosiddetto prodotto tv di qualità [4], ma dubito fortemente che possa sfuggire alla dinamica descritta. Come non nego la possibile estetica che la serie in sé può contenere e rappresentare, e mi riferisco alla presenza di interpreti di successo e di comprovata bravura, o a un elaborato comparto tecnico. A prescindere dal gusto individuale e dai singoli casi, uno degli obiettivi della serie, per avere successo e inchiodare in modo stupefacente lo spettatore al divano di casa propria, annullando il più delle volte quantità consistenti del suo tempo della vita, non è molto distante dal concetto di dipendenza.
La serie-tv è una storia che ci afferra, che ci tiene compagnia, che ci solleva dalla responsabilità e dall’impegno gravoso di cercare qualcosa da fare. È la più perfetta realizzazione dello «scacciatempo» [5] come rimedio alla noia esistenziale. Si dirà tuttavia che esistono molte strategie contro il passare noioso del tempo, anche meno articolate delle serie, dalla lettura di libri, all’ascolto di musica o alle carte da gioco. Ma se si ha contezza degli esempi addotti risulta innegabile che le serie-tv possiedono ben altra potenza. Inoltre, dovrebbe suscitare interesse il fatto che se sono così seguite, riuscite e acclamate, se provocano un plauso così largo, vuol dire che qualcosa di significativo è stato certamente raggiunto. Non si dovrebbe infatti salutare il fenomeno con allegrezza, se è in grado di suscitare stati d’animo positivi e di averci sollevato dal peso esistenziale delle scelte quotidiane, dei dolori, delle angosce, regalandoci per diverse ore una sincera piacevolezza artistica? Se non fosse per le sensazioni di spreco e di vuoto di cui ho parlato, sarei disposto a rispondere positivamente.
Le grandi storie che emozionano e che riescono in virtù della loro alta dignità a fungere da consigliere per il nostro vivere – quella che un tempo si sarebbe chiamata letteratura di consiglio – non servono proprio a questo, a darci un contatto nutriente, quell’immedesimazione in cui brucia il fuoco stesso della vita, che ci fa comprendere e che nel metabolismo della conoscenza trasforma il nostro In-der-Welt-sein? Nessuno obbliga nessun altro a esecrare tutto questo, né per lo meno a provare un qualche rammarico se un’esperienza di questo genere avviene con una serie in particolare piuttosto che con Barry Lyndon o la Recherche. E nemmeno è in questione una certa ritrosia o vetustà intellettuale tali da respingere le cosiddette novità dei tempi. Ma è forse legittima una qualche perplessità non solo di metodo ma anche di sostanza.
L’importante, ai nostri fini, è aver distinto le fasi di composizione della serie come possibile fenomeno rivelatore della nostra epoca, e poi spostare l’analisi verso l’eventuale applicabilità di quanto isolato sull’argomento, ovvero la società contemporanea nella sua massima riproducibilità seriale. Voglio dire che se possiamo prendere per buone queste premesse il passo successivo da compiere è tentare di congetturare le ragioni profonde per cui le serie come fenomeno estetico e sociale hanno tanto successo e compiono una presa così efficace sugli utenti dello spettacolo.
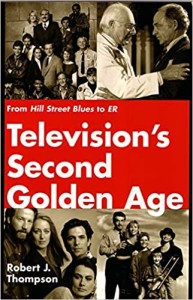 La conclusione a cui pervengo è che le serie sono ciò di cui abbiamo bisogno, rappresentano la metafora, pur imprecisa e giocoforza escludente alcuni elementi, della prassi esistenziale che appartiene all’umano contemporaneo. Per rendersi conto di ciò, basta spostare gli elementi della dinamica appena delineata al nostro agire quotidiano. Quello che emerge, tracciando un disegno al compasso, è la seguente tipologia esistenziale: frustrazione; vuoto; bisogno spasmodico di un riempitivo che si concretizza nell’attesa continua di una novità; consapevolezza dello spreco del tempo impiegabile altrimenti; inettitudine a farlo poiché immotivatamente impegnativo. La tesi che adduco è che questo sia il prevalente fondo esistenziale della contemporaneità e che le serie-tv lo rendano più di ogni altra cosa visibile.
La conclusione a cui pervengo è che le serie sono ciò di cui abbiamo bisogno, rappresentano la metafora, pur imprecisa e giocoforza escludente alcuni elementi, della prassi esistenziale che appartiene all’umano contemporaneo. Per rendersi conto di ciò, basta spostare gli elementi della dinamica appena delineata al nostro agire quotidiano. Quello che emerge, tracciando un disegno al compasso, è la seguente tipologia esistenziale: frustrazione; vuoto; bisogno spasmodico di un riempitivo che si concretizza nell’attesa continua di una novità; consapevolezza dello spreco del tempo impiegabile altrimenti; inettitudine a farlo poiché immotivatamente impegnativo. La tesi che adduco è che questo sia il prevalente fondo esistenziale della contemporaneità e che le serie-tv lo rendano più di ogni altra cosa visibile.
Il fatto che si rimanga in casa propria, che, dico meglio, si riescano a vedere in qualunque luogo provvisto di accesso alla rete, quindi potenzialmente ovunque, le rendono inoltre sempre accessibili. Se il cinema viene ancora visto come un’esperienza estetica da condividere in gruppo, in famiglia o tra amici, come preludio allo stare insieme e a occasioni di convivialità, la serie-tv con il suo carattere ricorsivo pregiudica una prassi simile, anche in considerazione della significativa distensione temporale che costringe l’utente a ritagliare il suo tempo sacrificando le proprie esigenze di vita.
Colgo una pericolosa erosione delle relazioni sociali causate dal carattere strutturale delle serie stesse, le quali vengono spesso preferite anche a una serata da trascorrere in compagnia, ma più in generale dell’alterità in quanto tale. La domesticizzazione dell’esperienza estetica, già imponente con la riproducibilità di quasi ogni esperienza sulle più diverse piattaforme, sta diventando dominante con le serie-tv, determinando un cambiamento nei comportamenti come anche nell’approccio al tempo libero, a quello che in altri momenti si sarebbe chiamato senza esitazione il tempo dell’edificazione del sé. E ciò perché più appaganti, avviluppanti e costruite per abbattere la noia.
Tuttavia, attraverso il fine che vogliono raggiungere, il totale intrattenimento, esse ci rivelano anche il male da cui saremmo affetti: una profondissima, conturbante e disagevole mancanza d’altro. Viviamo nell’epoca del massimo dispiegamento della ricchezza eppure il nostro disagio è palpabile, è dipinto sui nostri volti ogni volta che guardiamo e veniamo guardati. La tristezza esistenziale e la sofferenza ontologica al nostro essere si sono tramutati in un malessere cronico difficilmente guaribile. Il divertissement pascaliano si sta manifestando sotto altre forme, le quali, messe da canto per un momento, possono rivelare attraverso l’epoché dell’intrattenimento seriale la verità del disagio del nostro tempo. Siamo soli, illusi, persino disperati, assetati di dominio, avidi di attenzioni e di successo, proiettati dal desiderio nella lungimiranza di un orizzonte sempre vagante, bramosi come non mai di avere accanto una persona da amare in quanto redenzione da tutto questo. Possono essere queste alcune tracce, pur universali poiché tipiche dell’umano in generale e della sua negatività esistenziale, alcune motivazioni di un’auto-strategia di dissoluzione della gravità che ci opprime. Non è un concetto ben preciso di altro a importarci, bensì l’efficacia con la quale le serie-tv fanno letteralmente sparire il problema: è la serializzazione dell’esperienza il punto decisivo della questione. Ciò che affermo è che la tipizzazione della già evocata prassi esistenziale della contemporaneità sia quella tecnicamente organizzata e mostrata con le serie. Quello che nella vita vediamo diluito, le serie riescono a concentrarlo. Ma qual è tale prassi esistenziale? Cosa mostrano?
Mai come nell’epoca attuale si consuma il reclamo, quasi la pretesa, a fare esperienze sempre nuove e appaganti sotto ogni aspetto, professionale, affettivo, sentimentale. Si va alla ricerca di esperienze in cui a importare non sia tanto l’esperienza in sé, ma il grado di appagamento della frustrazione e del vuoto che riescono a offrire, il loro piccolo ma essenziale contributo versato alla noia giornaliera. Parlo delle esposizioni controllate a cui ci si abbandona, come per la visione di una puntata, che siano all’inizio intriganti per noi e che poi, purché ci continuino a soddisfare, proseguano fino alla loro conclusione naturale, scoprendo però al termine quanto siano state inutili. Sono comprensibili sotto questo aspetto la serializzazione dello sport, delle uscite dei prodotti dei colossi informatici, e persino del calendario solare scandito da festività o programmi di sorta. Il principio resta sempre uguale: trovare qualcosa che ci intrattenga, che abbia ragione del tedio e che non scomodi l’inerzia a compiere attività troppo impegnative.
Ma la domanda che potremmo porci, anche come possibile obiezione a ciò che si è tentato fin qui di argomentare, è: cosa dovremmo fare altrimenti? Oppure: quale può essere una soluzione alternativa e migliore di questa? Affrontare il mondo con questo spirito critico porta a qualcosa o si sta scambiando un disagio dato per assoluto con un appagamento sociale mai visto prima nella storia della civiltà globale? Il genere di esperienza esemplato dalla serie-tv come modello estetico di successo mi sembra inadeguato da un punto di vista sia artistico che esistenziale. Ma inadeguato a chi? Inadeguato all’umano. E allora cosa sarebbe all’altezza delle possibilità spirituali ed esistenziali dell’umano, quando, formulando stavolta un categorico giudizio di valore, le serie non sono per nulla viste come tali?
Tracciando velocemente la storia dei grandi generi artistici, le attuali serie-tv non sono poi molto distanti da quello che nell’Ottocento era il feuilleton, il romanzo d’appendice, genere molto in voga e che ha dato alla storia della letteratura capolavori unici (uno su tutti, Il conte di Montecristo) [6]. È allora il capolavoro di Dumas da considerarsi, proprio perché seriale, un risultato degenere? E con lui i vari Dostoevskij, Dickens e Flaubert? Lo stesso Benjamin, nel mirabile saggio sul narratore e sull’opera di Leskov, saluta il romanzo come genere uccisore della narrazione orale, della favola e del racconto del vissuto come condivisione di esperienze individuali da parte di una persona abile a farlo e che condensa in se stesso le storie della propria comunità di appartenenza. Immaginando una possibile appendice alle considerazioni benjaminiane, ciò che ha compiuto il romanzo con il racconto orale, e successivamente il cinema e la fotografia con la letteratura e le arti figurative, adesso tocca alla serializzazione dell’opera d’arte, al trionfo, forse irreversibile, dell’homo videns su tutte le altre manifestazioni dell’umano.
Oggigiorno sarebbe impossibile proporre al grande pubblico pensieri così complessi in forma letteraria. Mi sembra infatti che le serie-tv, pur pervenendo a livelli come detto di qualità, fino a poco prima impensabili e di esclusivo appannaggio delle grandi produzioni cinematografiche, non raggiungano per niente risultati di questo genere, mantenendo nei casi da me consultati esiti alquanto superficiali e imparagonabili, ad esempio, ai citati romanzieri [7]. Importano esclusivamente l’intrattenimento, suscitare l’attesa e il bisogno di continuare, senza tuttavia ritenere che con il risveglio di simili sensazioni sia stato raggiunto un risultato nutriente. Ciò risulta evidente nella sensazione di continua diluizione della trama, la costante impressione di brodo allungato che attraversa ogni serie nonostante l’eccitazione che riesce a provocare [8]. Sono convinto che le serie siano una truffa alle possibilità autentiche d’esistenza, autenticità presentita e confermata da parte di chi conosce la grande arte e quella cultura che si radica davvero e rende fertile il terreno in cui attecchisce, e di chi riesce a percepire e ad appurare la differenza abissale che intercorre, quello scarto che si ha la responsabilità di mediare e di comunicare.
Al netto delle annate Covid la Cappella Sistina brulica di visitatori, la Divina Commedia è ancora letta, la Nona di Beethoven ha ancora milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ma nonostante ciò, a parte le visite da parte di turisti, lettori o ascoltatori svagati che compiono queste esperienze più per il dovere di farlo, le manifestazioni dell’umanesimo storico si stanno perdendo nei meandri di pochi cultori che, pensando Mahler alla rovescia, custodiscono ceneri piuttosto che ravvivare un fuoco. Forse però bisogna prendere atto, anche da parte di umanisti e studiosi di mestiere di filosofia, arte e letteratura, di un cambiamento epocale a cui ci si ostina a resistere, insensibili al fatto che la società è mutata e con essa il vivere che le appartiene, profondamente modificata dal progresso tecnologico e dalle pressoché infinite possibilità comunicative e interattive.
 È proprio questo, infatti, il nodo centrale della questione. A parte qualche raro episodio di letteratura impegnata, cinema d’autore o arte da galleristi, ogni forma estetica sembra essere votata all’intrattenimento e al perfezionamento di stimoli fisiologici, con un grado di qualità e soddisfacimento che nemmeno i re di secoli fa avrebbero mai immaginato. Parlo di un mondo in cui chiudono le librerie e aprono al loro posto centri per l’estetica della persona o di scommesse, altra forma della serializzazione esperienziale qui discussa, e in cui il teatro o il cinema sono solo occasioni per provare il ristorante appena aperto della strada accanto.
È proprio questo, infatti, il nodo centrale della questione. A parte qualche raro episodio di letteratura impegnata, cinema d’autore o arte da galleristi, ogni forma estetica sembra essere votata all’intrattenimento e al perfezionamento di stimoli fisiologici, con un grado di qualità e soddisfacimento che nemmeno i re di secoli fa avrebbero mai immaginato. Parlo di un mondo in cui chiudono le librerie e aprono al loro posto centri per l’estetica della persona o di scommesse, altra forma della serializzazione esperienziale qui discussa, e in cui il teatro o il cinema sono solo occasioni per provare il ristorante appena aperto della strada accanto.
A che serve lo studioso che si occupa di cose che non riescono più da tempo a fare presa sul tessuto sociale, talmente cambiato da avergli causato un’allergia inguaribile e che nel frattempo è diventato per lui illeggibile? Il testo letterario o il grande dipinto non comunicano più come una volta, fatta eccezione per qualche appassionato che continua a riconoscervi il valore intramontabile e il fine ultimo della speculazione. Che significa tutto ciò, che è divenuta necessaria una totale riformulazione del pensatore, che sono mutati i bisogni e che l’arte nel suo complesso sia diventata di conseguenza la loro soddisfazione e un mero intrattenimento per farci opprimere di meno dal peso del tempo che abbiamo per scambiarci calore, conoscere ed evitare il rischio del dolore? Non ho maturato una risposta a questi interrogativi ma mi sembra che non ci siano dubbi sul fatto che l’incredibile accelerazione impressa al tempo esistenziale, sempre più alta e feroce, ci abbia portato con maggiore crudeltà al cospetto di noi stessi, talché il pensiero dell’umanità precedente forse ci spaventa, ci pare troppo complesso, ci annoia. Eppure, quando ci accomodiamo a guardare l’ennesima serie per il non sapere che fare, potremmo per un attimo pensare a cosa ignoriamo: forse i resti, pur gloriosi, di un tempo finito, ma da cui poter pretendere una rinascita.
Con un concetto mirabile, quasi un secolo fa e con un rarissima prova di slancio profetico, il Walter Benjamin dell’epigrafe che ho inserito come bussola di questo testo ci avverte del pericolo e ci invita caldamente a riappropriarci della noia, la quale, leggendo tra le sue righe, è la migliore premessa alla riflessione, quella che ci rimette a noi stessi e ci fa pensare veramente, spingendoci, diversamente da una deriva ipertrofica della narrazione volta all’intrattenimento e non al trattenimento dell’esistenza in forme di comprensione attiva, a riottenere il tempo che non fuorvia dalla durata autentica ma si concentra su se stesso, ovvero il tempo della vita.
Dialoghi Mediterranei, n. 55, maggio 2022
Note
[1] W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, trad. di R. Solmi, Einaudi, Torino 2014: 255. Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows, in Medienästhetische Schriften, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2018: 134.
[2] Cfr. ovviamente Id., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in Medienästhetische Schriften, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2018: 351-383. Trad. di F. Valagussa, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 2014.
[3] Per un’intelligente tipologia ermeneutica della serialità televisiva contemporanea, una mappatura metodologica e una bibliografia approfondita sull’argomento, cfr. I. A. De Pascalis, Cartografie della complessità: modelli di interpretazione della serialità contemporanea, in «SigMa. Rivista di Letterature comparate, Teatro e Arti dello spettacolo», III, 3, 2019: 643-678.
[4] Per alcuni criteri di definizione del prodotto televisivo di qualità, anche non strettamente seriale, cfr. R.J. Thompson, Television’s Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER, Continuum, New York 1996.
[5] M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo – finitezza – solitudine (Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, 1983), trad. di C. Angelino, Il Melangolo, Genova 1992: 129.
[6] Su questi temi rimando alla bella sintesi di E. Piga Bruni: «La produzione, la distribuzione e la ricezione delle serie televisive sono determinate dalla struttura della serialità, che se affonda le sue radici nelle antiche tradizioni orali e nelle saghe medievali, si sviluppa in senso moderno con i processi di industrializzazione che coinvolgono l’occidente a partire dal diciannovesimo secolo», in Id., Mediamorfosi del romanzo popolare: dal feuilleton al serial TV, in «Between», IV, 8, 2014: 2. Nel suo studio incentrato sulla comparazione e sull’analisi di due esempi di serie e di feuilleton (Lost e Les Mystères de Paris), l’autrice sottolinea la costanza della forma del romanzo e la sua riformulazione nel contemporaneo Serial TV. Per un’approfondita bibliografia sull’argomento e sulle serie tv in generale rimando ancora a questo testo.
[7] A tal proposito è interessante ma non risolutiva la definizione che spesso si dà delle serie-tv di romanzi audiovisivi.
[8] Su eccitazione e sensazione nella società contemporanea cfr. C. Türcke, La società eccitata. Filosofia della sensazione (Erregte Gesellschaft. Philosophie der Sensation, 2002), trad. di T. Cavallo, La società eccitata. Filosofia della sensazione, Bollati Boringhieri, Torino 2012. Per un’analisi critica e in senso anarchico, anche sulla scorta delle riflessioni di Türcke, sulla televisione e la contemporaneità e sul loro rapporto con il potere rimando a A. G. Biuso, La società videocratica, in L. Lanza (a cura di) L’anarchismo oggi. Un pensiero necessario, Mimesis, Milano 2013: 67-71.
___________________________________________________________________________
Enrico Palma, attualmente dottorando di ricerca in “Scienze dell’Interpretazione” presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, il suo progetto verte su un’ermeneutica filosofica della Recherche proustiana (tutor: Prof. A.G. Biuso; coordinatore: Prof. A. Sichera). Ha pubblicato saggi, articoli e recensioni per varie riviste, con contributi di filosofia ed ermeneutica («Vita pensata», «Discipline filosofiche», «InCircolo», «Il Pequod», «E|C»), letteratura («Diacritica», «SigMa», «Siculorum Gymnasium», «Oblio») e fotografia («Gente di fotografia»). Fondatore e redattore della rivista culturale «Il Pequod», le sue aree di ricerca sono la filosofia teoretica e l’ermeneutica letteraria.
______________________________________________________________