Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’operazione quanto mai utile e necessaria, quella di ricostruire e scrivere la storia generale delle discipline che in Italia sono chiamate demo-etnoantropologiche. Come si sa, questa definizione è di conio abbastanza recente (1975), perché negli anni precedenti esse erano indicate in vari modi, spesso approssimativi e non senza ambiguità ed equivoci.
Alla fine dell’Ottocento in Italia l’antropologia era quella fisica, intesa come una scienza capace di definire un popolo, la sua razza, le sue caratteristiche fisiche ed anche quelle intellettuali. Era l’epoca in cui gli antropologi andavano negli ossari dei cimiteri a misurare la volumetria dei crani e la lunghezza delle tibie.
Maestro indiscutibile di questa disciplina era allora Paolo Mantegazza che aveva colleghi non sempre alla sua altezza e che spesso cadevano in semplicistiche tesi scientiste come succedeva a Cesare Lombroso; d’altra parte, anche lui non era esente, come vedremo, di queste debolezze teoriche. Esisteva poi un’altra corrente che si occupava di alcuni aspetti dell’espressività cosiddetta popolare, come canti proverbi e fiabe: “tradizioni popolari” era la sua definizione fino a quando dall’Inghilterra non arrivò il termine “folklore” e poi con Giuseppe Pitrè quello di “demopsicologia”.
Fino ad adesso le ricostruzioni storiche avevano privilegiato lo studio di quelle personalità nelle cui opere si possono intravedere le radici delle discipline odierne e i primi germi di quei concetti che sono alla base della demologia, dell’etnologia e dell’antropologia moderne. Sono ormai molti gli studi che riguardano i primordi delle discipline DEA e gli studiosi e i ricercatori che ne sono stati i fondatori, ma spesso queste ricostruzioni si sono occupate solo dei grandi nomi e lasciato in ombra le attività di meno importanti autori di ricerche e di monografie che, se non hanno prodotto esiti rilevanti, hanno però contribuito a costituire l’ambiente culturale in cui hanno lavorato tutti.
Di questi aspetti minori e di altre questioni che riguardano anche i maggiori, si è occupato Enzo V. Alliegro nel volume Il filo e la cruna. Saggi di storia dell’antropologia italiana (Ed. Museo Pasqualino, Palermo 2021). Si tratta, come si può desumere dal sottotitolo, di saggi scritti in epoche e per occasioni diverse e qui riuniti con l’intento di offrire una nuova, completa e definitiva storia dell’antropologia italiana, dai primordi fino agli statuti disciplinari odierni. L’Introduzione è caratterizzata, per sottolinearne l’originalità degli intenti, da un tono un po’ declamatorio e una certa enfasi che, per fortuna, nelle pagine successive si manifestano soltanto episodicamente.
In parte questo tono è giustificabile perché Alliegro si occupa di autori e di antropologi che le precedenti ricostruzioni storiche si sono limitate a delineare in poche righe; solo qualche studioso, infatti, negli ultimi decenni ha condotto ricerche approfondite su tali questioni, come Sandra Puccini che ha dedicato molto della sua attività di antropologa a personaggi dell’Ottocento/Novecento come Cattaneo, Mantegazza e Loria. Questi autori sono, comunque, anche oggetto dell’indagine di Alliegro che, per eccesso di originalità, affronta la lettura non delle loro opere principali, ma di alcuni scritti secondari, in cui ritiene di poter meglio individuare la loro teoria e la loro metodologia.
 Dopo un capitolo introduttivo, quasi una sintesi delle pagine successive, sulla situazione generale degli studi di tradizioni popolari in Italia tra Ottocento e Novecento, Alliegro esamina un testo alquanto peregrino di Paolo Mantegazza: Upilio Faimali. Memorie di un domatore di belve (Firenze 1901), in cui l’autore racconta il suo interesse a seguire la carriera di un domatore di animali selvatici e feroci. Lo muove in questa vicenda la volontà di dimostrare come l’evoluzione delle specie abbia creato un animale, l’homo, capace di dominare tutti gli altri e di saperne addomesticare alcuni per i propri interessi. Ovviamente per Mantegazza tutti gli animali che sfuggivano al potere dell’uomo potevano essere eliminati con noncuranza e quelli pericolosi per gli uomini potevano essere addirittura sterminati. Lo stesso comportamento si poteva tenere nei confronti di tutta quell’umanità che a Mantegazza appariva condannata ad una condizione inferiore (neri e donne in genere). In ciò si poteva vedere l’accettazione totale del colonialismo contemporaneo che non si poneva problemi di razzismo e della presunta supremazia dell’uomo sulla donna. Ma – è appena il caso di precisarlo – anche lo sterminio degli animali pericolosi aveva in sé qualcosa di inaccettabile: Mantegazza non poteva sapere allora che la vita sulla Terra, anche quella dell’uomo, dipendeva dal rispetto della biodiversità. Lo scienziato positivista non poteva saperlo, ma l’antropologo che ne analizza oggi le opere lo sa, per questo sarebbe stato opportuno ricordarlo, invece di presentare senza commento (per neutralità scientifica, suppongo) il fatto che Mantegazza assumesse come paradigmatico dello studio dell’uomo e della sua civile evoluzione il modo con cui Faimali addomesticava le bestie feroci.
Dopo un capitolo introduttivo, quasi una sintesi delle pagine successive, sulla situazione generale degli studi di tradizioni popolari in Italia tra Ottocento e Novecento, Alliegro esamina un testo alquanto peregrino di Paolo Mantegazza: Upilio Faimali. Memorie di un domatore di belve (Firenze 1901), in cui l’autore racconta il suo interesse a seguire la carriera di un domatore di animali selvatici e feroci. Lo muove in questa vicenda la volontà di dimostrare come l’evoluzione delle specie abbia creato un animale, l’homo, capace di dominare tutti gli altri e di saperne addomesticare alcuni per i propri interessi. Ovviamente per Mantegazza tutti gli animali che sfuggivano al potere dell’uomo potevano essere eliminati con noncuranza e quelli pericolosi per gli uomini potevano essere addirittura sterminati. Lo stesso comportamento si poteva tenere nei confronti di tutta quell’umanità che a Mantegazza appariva condannata ad una condizione inferiore (neri e donne in genere). In ciò si poteva vedere l’accettazione totale del colonialismo contemporaneo che non si poneva problemi di razzismo e della presunta supremazia dell’uomo sulla donna. Ma – è appena il caso di precisarlo – anche lo sterminio degli animali pericolosi aveva in sé qualcosa di inaccettabile: Mantegazza non poteva sapere allora che la vita sulla Terra, anche quella dell’uomo, dipendeva dal rispetto della biodiversità. Lo scienziato positivista non poteva saperlo, ma l’antropologo che ne analizza oggi le opere lo sa, per questo sarebbe stato opportuno ricordarlo, invece di presentare senza commento (per neutralità scientifica, suppongo) il fatto che Mantegazza assumesse come paradigmatico dello studio dell’uomo e della sua civile evoluzione il modo con cui Faimali addomesticava le bestie feroci.
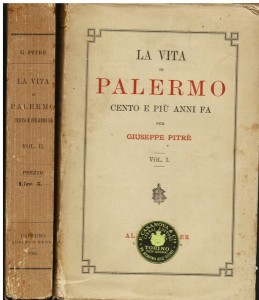 Anche per tratteggiare il tipo di approccio con cui Giuseppe Pitré studiava la cultura popolare, Alliegro si serve di un’opera minore tra quelle composte dal demologo siciliano: La vita in Palermo cento e più anni fa (1904). Dall’analisi dell’opera emergono due aspetti fondamentali dell’opera di Pitré; innanzitutto il suo ancorarsi tenacemente alla storia: di tutto ciò che viene raccolto dalla cultura popolare niente è metafisico, ogni cosa ha origini e radici nella storia concreta delle genti che sono portatrici delle tradizioni; altro aspetto importante è dato dall’uso delle fonti scritte, sia quelle di cronisti locali o di viaggiatori stranieri, sia quelle depositate negli archivi storici. Importante nell’analisi del Pitré la rivalutazione degli scritti degli stranieri: è vero che questi si lasciano entusiasmare dal pittoresco e che si limitano, spesso, a trascrivere le proprie emozioni, ma il loro occhio è imparziale e l’acume del ricercatore sta nel sapere individuare i fatti storici dalle fantasie degli osservatori.
Anche per tratteggiare il tipo di approccio con cui Giuseppe Pitré studiava la cultura popolare, Alliegro si serve di un’opera minore tra quelle composte dal demologo siciliano: La vita in Palermo cento e più anni fa (1904). Dall’analisi dell’opera emergono due aspetti fondamentali dell’opera di Pitré; innanzitutto il suo ancorarsi tenacemente alla storia: di tutto ciò che viene raccolto dalla cultura popolare niente è metafisico, ogni cosa ha origini e radici nella storia concreta delle genti che sono portatrici delle tradizioni; altro aspetto importante è dato dall’uso delle fonti scritte, sia quelle di cronisti locali o di viaggiatori stranieri, sia quelle depositate negli archivi storici. Importante nell’analisi del Pitré la rivalutazione degli scritti degli stranieri: è vero che questi si lasciano entusiasmare dal pittoresco e che si limitano, spesso, a trascrivere le proprie emozioni, ma il loro occhio è imparziale e l’acume del ricercatore sta nel sapere individuare i fatti storici dalle fantasie degli osservatori.
Il terzo autore, considerato tra gli antesignani delle discipline DEA di oggi è Lamberto Loria. Le pagine dedicate a questa singolare figura di etnografo, di collezionista e di viaggiatore non sembrano aggiungere nulla a quanto scritto da altri. Nemmeno le cause della morte di Loria vengono individuate, pur se lo studio di Alliegro parte proprio della notizia del suo improvviso e misterioso decesso. Piuttosto inquietante il fatto che, dopo la sua morte, nessuno ha ripreso i temi della sua ricerca e delle sue teorie; e comunque il suo nome è inseparabile da quelle collezioni fatte conoscere all’opinione pubblica nel 1911 con la Mostra dell’Etnografia Italiana e che confluirono successivamente nel Museo Nazionale delle Tradizioni Popolari di Roma.
Se i primi capitoli del libro non sembrano apportare innovative considerazioni relative ai tre studiosi che riteniamo antenati degli studi demologici in Italia, molto più interessanti sono gli argomenti successivi che trattano di autori ed opere che in qualche modo dovettero fare i conti con il fascismo, il suo populismo (si pensi ai circoli dopolavoristici, alle organizzazioni delle sagre e dei gruppi folkloristici) e alla sua ideologia sfociata poi nel razzismo. È proprio su quest’ultimo punto che è imperniata la parte centrale del libro, dove si ragiona a lungo su Giuseppe Cocchiara e di Raffaele Corso, due protagonisti degli anni 1930-1950.
Il primo, insieme con altri studiosi, sembra avere un atteggiamento di acquiescenza nei confronti del regime; è probabile però che questo atteggiamento sia dovuto al fatto che gli studiosi di allora si sentivano al di sopra delle questioni politiche, economiche e sociali, in quanto ritenevano la scienza come attività spirituale superiore ad ogni altra. E ciò forse per influsso del filosofo Giovanni Gentile, per non parlare di quello ancora più forte del maggiore intellettuale di allora, Benedetto Croce che snobbava il fascismo con la giustificazione che questo non era altro che una malattia dello Spirito. D’altra parte anche oggi spesso l’antropologia fa finta di non vedere i rapporti tra cultura e politica e tra cultura e condizioni materiali di vita delle persone.
 Cocchiara, dunque, si adegua e dimostra, con l’opera Leggenda dell’ebreo errante (1941), che in Italia in fondo il razzismo era stato ed era un aspetto della cultura popolare. Subito dopo, però, avvertendo che le teorie fasciste non avevano rispondenza nella realtà delle culture umane, cominciò a prendere le distanze dal regime, come si può leggere dall’articolo Invito allo studio dei popoli (1942). Forse in questo ripensamento c’è l’influenza tardiva della sua precedente formazione inglese con Marrett.
Cocchiara, dunque, si adegua e dimostra, con l’opera Leggenda dell’ebreo errante (1941), che in Italia in fondo il razzismo era stato ed era un aspetto della cultura popolare. Subito dopo, però, avvertendo che le teorie fasciste non avevano rispondenza nella realtà delle culture umane, cominciò a prendere le distanze dal regime, come si può leggere dall’articolo Invito allo studio dei popoli (1942). Forse in questo ripensamento c’è l’influenza tardiva della sua precedente formazione inglese con Marrett.
Raffaele Corso fu tra i primi a rispondere alla chiamata della nuova rivista «Difesa della Razza»; già nel primo numero comparve un suo testo in cui, come scrive Alliegro, proponeva «una rifondazione radicale degli studi demologici da porre a sostegno della politica ufficiale di esaltazione della civiltà italiana». Questa presa di posizione, tuttavia, probabilmente derivava dalla sua visione astorica del folklore; per lui, infatti, le tradizioni popolari erano immutabili nel tempo, non si erano mai modificate nel corso della loro plurisecolare esistenza. Tra gli studiosi sembra quello più asservito al regime non tanto perché esplicitamente fascista, ma perché naturalmente portato ad un certo tradizionale conservatorismo ideologico. Forse era un po’ nazionalista e colonialista, come si può vedere anche dalla sua rivendicazione dell’italianità di Malta, tanto da allinearsi alla politica espansionistica dell’Impero invocandone l’annessione allo Stato italiano.
Seguono poi pagine con cui Alliegro ci racconta le vicende di quegli anni, come la discussione tra Sergio Sergi e Alberto Blanc, cui si deve la scoperta dell’«uomo» del Circeo, sulle origini del popolo italico (africane o asiatiche?); sulle ricerche e le teorie di Giovanni Marro, tutte «al servizio della patria», cioè del regime, che ovviamente lo premiò dandogli incarichi prestigiosi. L’idea sua più originale fu quella secondo la quale le razze umane non si fondano sulle caratteristiche biologiche e fisiche ma su quelle spirituali (anche qui l’influenza del Gentile?).
 Per onestà e compiutezza scientifica Alliegro riporta poi tutte le teorie deliranti di altri antropologi fascisti; fino ad arrivare alle pagine sull’opera di Renato Biasutti, con cui si apre una nuova stagione per le ricerche demologiche ed etnologiche italiane. Un intero capitolo è dedicato, quindi, a quegli studiosi del mondo agricolo che, sulla scorta di quanto era avvenuto alla fine del secolo precedente, avviarono inchieste di natura sociologica con questionari (riportati da Alliegro) alquanto ingenui; ma l’aspetto più importante di queste inchieste fu che per la prima volta, almeno in Italia, come strumento di documentazione venne usata la macchina fotografica.
Per onestà e compiutezza scientifica Alliegro riporta poi tutte le teorie deliranti di altri antropologi fascisti; fino ad arrivare alle pagine sull’opera di Renato Biasutti, con cui si apre una nuova stagione per le ricerche demologiche ed etnologiche italiane. Un intero capitolo è dedicato, quindi, a quegli studiosi del mondo agricolo che, sulla scorta di quanto era avvenuto alla fine del secolo precedente, avviarono inchieste di natura sociologica con questionari (riportati da Alliegro) alquanto ingenui; ma l’aspetto più importante di queste inchieste fu che per la prima volta, almeno in Italia, come strumento di documentazione venne usata la macchina fotografica.
Prima di arrivare all’ultima parte del volume, il punto più interessante della ricostruzione storiografica di Alliegro è la presentazione del Convegno di Torino del 1961 che vede insieme per la prima volta riuniti a discutere antropologi fisici, etnologi e folkloristi. È interessante notare come il convegno fu organizzato, chi vi fu invitato e chi no, chi furono i relatori principali delle cinque giornate dell’incontro. Scrive, giustamente, Alliegro: «Torino ’61, con le logiche e le strategie sottese di annessione e di esclusione, di integrazione e di estromissione, rappresenta una tappa emblematica di quel processo evolutivo che ha condotto tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta le discipline dedicate allo studio dell’uomo verso la definizione di un nuovo assetto». E cioè la nascita di Antropologia culturale (Memorandum del 1958 di Tentori, Seppilli e Tullio-Argan), di Etnologia (Grottanelli) e Tradizioni popolari (Toschi, da cui si allontaneranno successivamente alcuni giovani studiosi, suoi discepoli diretti o indiretti, attratti dalle teorie storicistiche e marxiste).
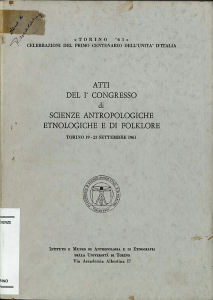 Nell’ultima parte del volume, dedicata a de Martino e a Cirese, affronta l’esame di alcuni concetti teorici dei due maggiori studiosi dell’etnoantropologia del Novecento italiano; vediamoli uno per volta.
Nell’ultima parte del volume, dedicata a de Martino e a Cirese, affronta l’esame di alcuni concetti teorici dei due maggiori studiosi dell’etnoantropologia del Novecento italiano; vediamoli uno per volta.
Le pagine dedicate a De Martino appaiono più meditate di quelle riguardanti gli altri studiosi esaminati precedentemente. In esse si mettono in ordine e si chiariscono quei nessi argomentativi e quei concetti che de Martino non ha mai esplicato. Per cercare di giungere a convincenti definizioni, sono chiariti i rapporti di de Martino con le opere di Macchioro (che aveva attirato la sua attenzione sulle pratiche cerimoniali e sul «rito in azione») e di Mircea Eliade, di Károly Kerényi e Claude Lèvi-Strauss. Ancora una volta Alliegro nella sua analisi privilegia un solo testo di de Martino, il lungo saggio Mito, scienze religiose e civiltà moderna, che, per essere stato incluso nel volume Furore Simbolo Valore, è passato quasi inosservato perché messo in ombra dagli altri testi. Qui lo studioso napoletano affronta il tema del simbolismo mitico-rituale, che «funziona come un piano metastorico di riassorbimento della proliferazione storica del divenire … Un simbolo in cui tutto, in illo tempore, fu deciso da numi o da eroi, onde poi ora non si tratta che di rendere ritualmente efficace l’origine mitica esemplare».
Altro concetto rimasto non del tutto esplicitato, oltre quello di “simbolismo” (secondo Alliegro il fatto che molti antropologi si siano allontanati da de Martino è dipeso proprio da questa mancanza di chiarezza concettuale), è quello di “efficacia simbolica”, che aveva ripreso dal lavoro sui Cuna di Panama di Lévi-Strauss; anche questo, però, rimane difficile da spiegare, forse de Martino intuiva il suo significato ma non ne ha dato mai una definizione chiara e convincente: lo stesso Alliegro cerca di arrivare ad una spiegazione ricorrendo ad una vasta bibliografia e alla fine crede di aver trovato la soluzione in un volume di 120 anni fa di Guglielmo Ferrero, I Simboli in rapporto alla Storia e Filosofia del Diritto, alla Psicologia e alla Sociologia (1895). Ho l’impressione, tuttavia, che de Martino avesse un’altra idea del simbolismo, perché per Ferrero esso è solo una “scorciatoia” della mente che, non riuscendo a districare un nesso difficile, cerca corrispondenze allegoriche più o meno accettabili, saltando qualsiasi argomentazione razionale.
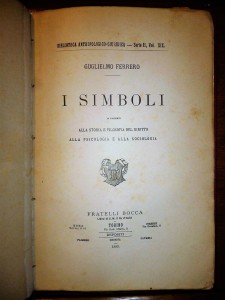 Anche Alberto Mario Cirese, come de Martino, è stato un teorico notevole, felicemente più chiaro e, diciamo così, meno problematico, dell’etnologo napoletano. I suoi “dislivelli di cultura” hanno influenzato, per lunghi decenni, buona parte del folklorismo e dell’antropologia italiani e sono stati messi in discussione da poco, dopo l’avanzata impetuosa di una “globalizzazione” che ha investito tutti i campi delle attività umane e dopo una radicale rivoluzione epistemologica che ha interessato tutti i rami della scienza.
Anche Alberto Mario Cirese, come de Martino, è stato un teorico notevole, felicemente più chiaro e, diciamo così, meno problematico, dell’etnologo napoletano. I suoi “dislivelli di cultura” hanno influenzato, per lunghi decenni, buona parte del folklorismo e dell’antropologia italiani e sono stati messi in discussione da poco, dopo l’avanzata impetuosa di una “globalizzazione” che ha investito tutti i campi delle attività umane e dopo una radicale rivoluzione epistemologica che ha interessato tutti i rami della scienza.
Per farci capire meglio l’iter formativo di Cirese, Alliegro si è preso l’impegno di spiegare le motivazioni che hanno spinto lo studioso ad addentrarsi nel terreno della demoantropologia. In un’intervista Cirese aveva detto: «Se penso agli inizi del mio itinerario culturale, io dico: mio padre, il Musèe de l’Homme di Parigi e i contadini socialisti della Piana di Rieti» (Tra cosmo e campanile, 1994). Alliegro, riprendendo e svolgendo questi temi così sintetizzati dallo studioso, segue meticolosamente la formazione di Alberto M. Cirese, fissando date, analizzando i contenuti dei primi scritti, evidenziando i rapporti tenuti con altri studiosi (Toschi, De Martino, in primis, ma poi anche Pettazzoni, Lèvi-Strauss, Rivet, ecc.). Alliegro fa notare come la lamentazione funebre sia stata un argomento centrale nella ricerca di Cirese, che lo avrebbe impegnato dalla sua tesi di laurea (a.a. 1943-44), riguardante i Canti popolari del Molise, in cui un capitolo è dedicato proprio alle tradizioni funerarie del reatino, fino al 1958, anno della pubblicazione dell’opera di de Martino, Morte e pianto rituale, che suggerirà all’antropologo molisano di desistere dalla sua ricerca e dalla relativa trattazione.
La ricerca sul pianto funebre, tuttavia, consente a Cirese di travalicare i confini del folklore e di interconnettere i temi delle tradizioni popolari con quelli etnologici e con quelli di pertinenza della storia delle religioni. Dopo la pubblicazione dell’opera di de Martino, Cirese torna alle tradizioni popolari, torna ai contadini socialisti della piana di Rieti; studiando la loro espressività, le loro credenze, la loro ritualità arriva a superare la concezione crociana di folklore come espressione di una psicologia minore, cogliendone invece «il valore di simbolo di un cambiamento politico possibile».
Nel 1973 Cirese dà alle stampe un’opera che tanta influenza avrebbe avuto sugli studi demoantropologici italiani. Edito a Palermo da Palumbo, Cultura egemonica e culture subalterne avrebbe avuto svariate ristampe ed edizioni, di cui l’ultima risale al 2006. Di questo manuale ciresiano Alliegro fa un’attenta lettura, evidenziandone le caratteristiche e indagando sulla sua probabile genesi. Secondo il suo parere, su cui non si può non concordare, il manuale è un’«opera ispirata ad una progettualità rifondatrice finalizzata al consolidamento disciplinare … capace di mostrare in antitesi a de Martino la bontà della demologia quale scienza autonoma», e, poi aggiunge Alliegro, «non è soltanto un manuale dall’evidente mission (ri)fondativa della demologia, ma anche un volume molto chiaro che non elude il tema del confronto epistemologico circa le fondamenta del sapere e i processi di costruzione della conoscenza». Nell’ultima parte della sua attività didattica e teorica, fino a suoi ultimi giorni Cirese si dedicò, senza tralasciare lo studio del mondo popolare, ad una «serie di sperimentazioni con l’aiuto dell’impiego delle nuove tecnologie digitali». A chiusura del volume, l’autore ricostruisce infine i rapporti, a volte burrascosi, tra De Martino e Cirese, lungo «un percorso di studio che prima fu parallelo e poi si fece sempre più convergente e inevitabilmente implosivo e conflittuale».
In conclusione il lavoro di Alliegro, per molti aspetti esauriente e definitivo, colma molte lacune ed è ricco di notizie ignorate e, forse, considerate superflue da altri studiosi che si sono impegnati a scrivere la nascita e l’evoluzione delle discipline demologiche in Italia. Il filo del titolo del libro, tuttavia, sembra non sufficientemente lungo da poter ricucire tutti i temi discussi nei vari capitoli fino a formare un volume coeso e compatto; e talora anche la cruna è troppo stretta per far passare tutti gli argomenti in modo equilibrato. Resta tuttavia utile e interessante il contributo scientifico che il libro offre alla conoscenza di tanta parte dell’antropologia custodita nella documentazione d’archivio e di tanti autori e testi spesso troppo sbrigativamente ritenuti minori.
Dialoghi Mediterranei, n. 52, novembre 2021
______________________________________________________________
Mariano Fresta, già docente di Italiano e Latino presso i Licei, ha collaborato con Pietro Clemente, presso la Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di espressività popolare, di alimentazione, di allestimenti museali, di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, Giovanni Pascoli e il mondo contadino, Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è occupato di identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Ha scritto anche sui paesi abbandonati e su altri temi antropologici.
______________________________________________________________








